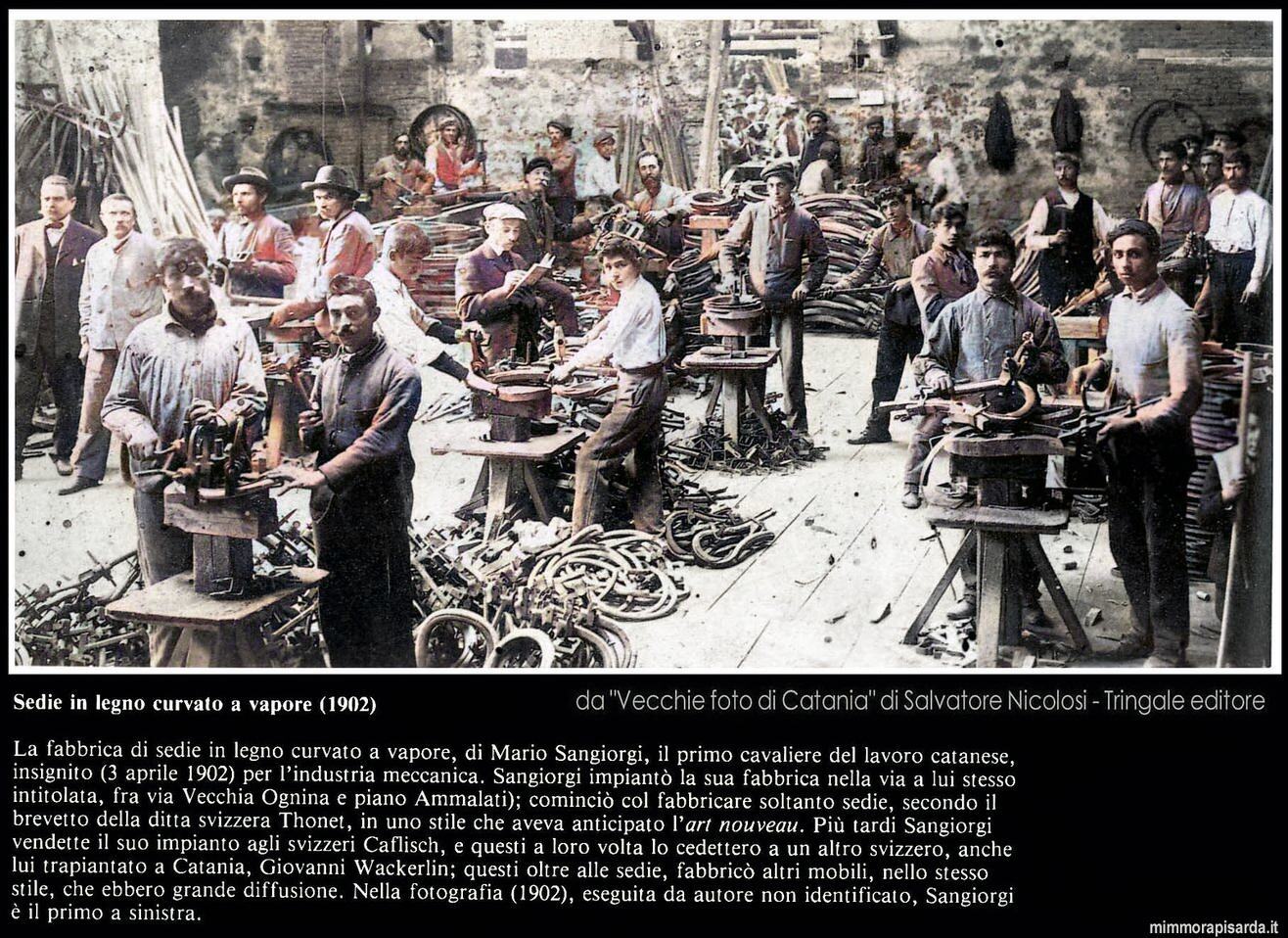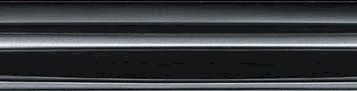|
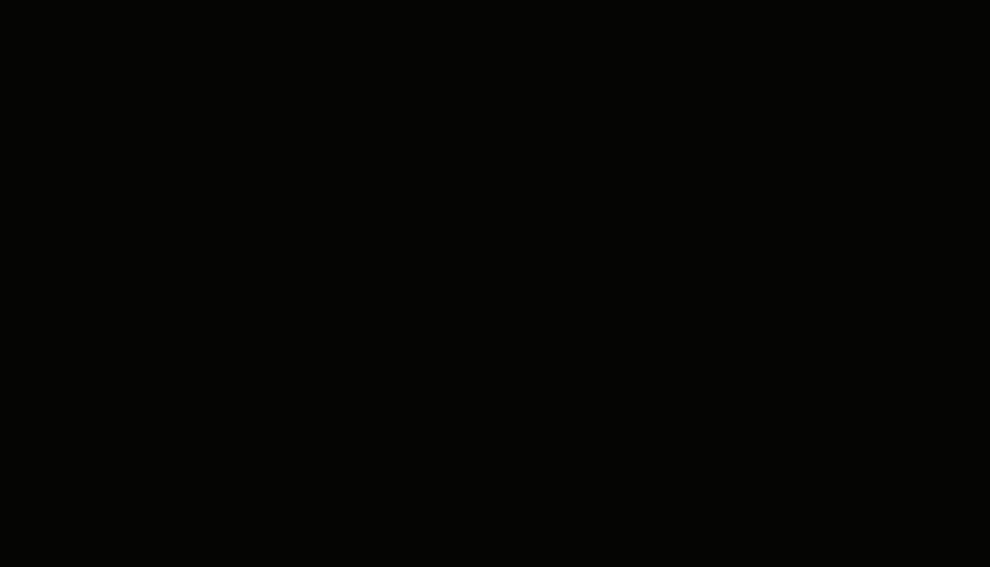

|
Una
piccola carrellata dedicata agli ultimi Maestri catanesi. Gli ultimi
"mastri" rimasti, che dell'artigianato hanno fatto una ragione
di vita da generazioni e che, ancora oggi, sentono il bisogno di creare
con quel "prurito" che hanno sempre avuto in testa, da padre
in figlio. E di manifestarlo sotto forma di legno, di terracotta, di
zucchero, di spade e burattini.
Due
righe sono da dedicare a beneficio di quell’eventuale giovane
lettore che non avesse mai sentito i termini “stazzuni”, “minicuccu”
o “mauru” e non avesse mai sentito suo padre, timoroso di
apparire un fossile, raccontare come era la vita nella sua
giovinezza. Non immagina neppure che si potesse vivere in
assenza di questa società dei consumi che gli stiamo lasciando
in eredità, ma sappia che, quelli di noi che hanno coscienza,
al consumismo abbiamo sacrificato la vita semplice, a misura d’uomo,
di questa non andiamo fieri e di quella vita siamo un poco
nostalgici.
Quando la mattina, all’alba, incominciava il nuovo giorno e le
strade si animavano per il viavai degli uomini diretti al
lavoro, le attività cominciavano di buon mattino perché si
insegnava che é “’a matinata fa ‘a jurnata”. A quell’ora
passava la vecchia o la giovanissima pastora che, con le sue
caprette al seguito, portava il latte di casa in casa, dove ci
si apprestava a fare colazione: La massaia usciva sull’uscio
con una ciotola o lo stesso pentolino che avrebbe messo sul
fuoco a bollire e assisteva la pastora che “mungeva” la sua
capretta, che belava infastidita dalle frequenti palpazioni.
Questi pastori non provenivano da lontano; nello stesso
quartiere, in delle vie o dei cortili interni, attaccate alle
case di “civile abitazione”, vi erano le stalle con le
caprette, le pecorelle ed anche le mucche. Se i pastori con le
bestiole più piccole andavano per le case a distribuire il
latte, i pastori con le mucche lo distribuivano in stalla per
cui bisognava andare attrezzati di bottiglia per attingere dai
classici bidoni di alluminio il latte fumante, talvolta più
caldo della temperatura corporea della mucca (la sofisticazione
é antica). Era bello il latte appena munto, chi c’era in quei
tempi, ne ha un bel ricordo, specie se l’ha vissuto da una
posizione comoda e serena.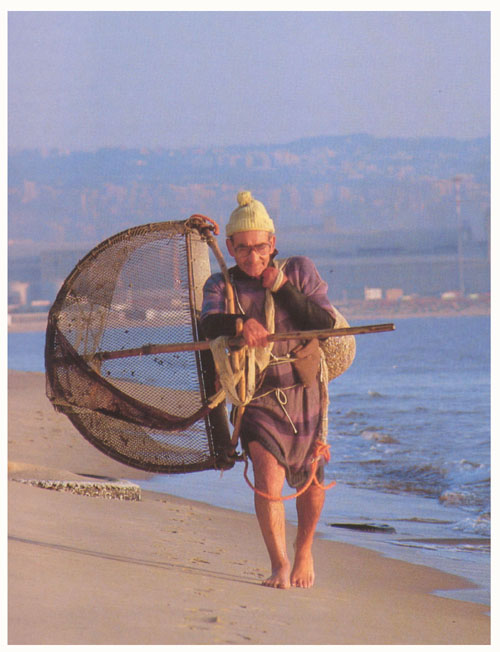
Ma prima di questi, che sembravano i lavoratori più mattinieri,
c’erano quelli che andavano in campagna (‘a chiana), perché
lavoratori agricoli, sensali, commercianti, o “cicuniari”.
La cicoria é la verdura nota, ma il personaggio che da essa
trae il nome é quel lavoratore instancabile che, nel corso dell’anno,
ciclicamente andava per terre incolte a raccogliere erbe e
prodotti spontanei, omaggi della madre terra. Questi
raccoglievano e vendevano, oltre le verdure spontanee (“ciconia”,
“scalora”, “vurranii”, ”caliceddi” “seghili
salvaggi”, etc.), anche i “carduni”, i “cacucciuliddi”,
i “vaccareddi”, i “crastuni” che dovevano essere saputi
cercare in relazione agli eventi meteorologici e alla
collocazione, in ciò consisteva la loro professionalità (mastranza).
Oltre alle stalle che ospitavano le graziose pecore, le cornute
capre e le mansuete mucche, vi erano pure quelle dove i “carritteri”,
i trasportatori dell’epoca, tenevano il “mezzo” che, a
quel tempo, era il mulo o il cavallo, “motrice” con l’annesso
carretto o “carramattu”, che, in seguito, hanno passato la
mano ai camionisti, eredi naturali della professione con “tecnologia”
avanzata. C’erano le stalle di quegli altri che tenevano il
cavallo come hobby per attaccarlo al calesse e scorazzare per le
strade del quartiere nel tempo libero, oggi sostituito dalle
potenti moto e dalle fiammanti automobili. C’erano i “malazzeni”,
dove venivano selezionati gli agrumi e la frutta per l’esportazione
o ripuliti ortaggi e frutta per la conservazione, c’erano le
concerie dove venivano essiccate le pelli degli animali, c’erano……
tanti altri posti che producevano rifiuti sgradevoli, e c’erano
i ”fumirara”, i raccoglitori del “fumeri”, il prodotto
delle stalle e ogni genere di rifiuto, destinato a concimare i
vicini orti e le campagne più distanti. Una professione che
surrogava il servizio pubblico della “nettezza urbana”,
allora carente “poco più” che oggi. I “fumirara”
raccoglievano nelle stalle, negli stabilimenti, nelle botteghe e
per le strade il materiale organico di risulta che, venduto a
chi ne poteva trarre utilità, era fonte di reddito per quelle
famiglie, che da questo traevano sostentamento. Un giorno, dopo
lunghe battaglie, partite dalla Salette, con in testa quel “capopopolo”
di don Bonomo (S.d.B.), un lungo corteo di carrettini sporchi
quanto mai, mezzi di lavoro di questi antesignani dei moderni
operatori ecologici, sfilò per il quartiere fino ad un punto di
raccolta dove vennero dati alle fiamme. Questo segnò la fine di
una “professione” (?), i “reduci” passarono a libro paga
del comune per una collocazione più sicura e dignitosa.
Antesignano dei moderni testimonials, si vedeva circolare per il
quartiere, in epoca antecedente al popolarissimo Carosello
televisivo, era il banditore. Un uomo caratteristico nel suo
vistoso abbigliamento da clown che, con il suo tamburo, agli
angoli delle vie richiamava l’attenzione (e non era difficile)
dei passanti e dei residenti per procedere con la sua voce
stentorea, aiutata da un tradizionale megafono, a fare la
reclame (oggi pubblicità) a qualsiasi cosa gli venisse proposto
di “vanniari”. Informava che la tale o tal’altra
macelleria aveva una buona partita di carne per un’occasione
determinata da un incidente occorso ad un vitello(“carni
sdurrubbata”), che il pastificio, necessitato a smaltire le
scorte, proponeva delle offerte speciali, che il negozio di
tessuti si era approvvigionato di una buona partita di stoffa e
voleva parteciparlo ai cittadini perché ne approfittassero. In
parole povere era la promozione delle vendite fatta in forma
artigianale che, con la sua audience amplificata dal
passaparola, come in altra forma e dimensione succede oggi, era
già l’anima del commercio.
Altre attività, connesse con la vita marinara, sono scomparse o
si sono ridimensionate, ma erano presenti nel quotidiano della
nostra giovinezza. Si vedeva, in tutte le stagioni, passando dal
litorale della Playa, sulla riva un uomo dentro l’acqua dalla
cintola in giù che, con movimenti lentissimi e procedendo come
un gambero, trascinava un attrezzo, era il pescatore di telline,
i “cozzuli da Playa”, che si raccolgono nelle rive sabbiose,
al contrario, i mitili, i “cozzuli di Missina” che, con
immersione integrale, vengono raccolte fra gli scogli, dove, chi
va prende pure “rizzi”, “occhi di voi”, pateddi” ed,
infine, “u mauru”. Anche queste cose sono andate via via
scomparendo, non si può dire che non si vedano più, ma la
frequenza non è quella di una volta, allorché il marinaio che
aveva un po’ di tempo libero, ma soprattutto necessità di
intascare qualche spicciolo, nella buona stagione in
particolare, si immergeva e tornava con il “pescato” che
vendeva direttamente. Fra queste la cosa che si è persa del
tutto è “u mauru”, un’erba marina “citrigna” dall’inconfondibile
gusto di mare che veniva proposta per le strade e servita in
cartocci di carta paglia con succo di limone e una spolverata di
sale. Erano lavori poveri, da fare a tempo perso perché non
redditizi, forse per questo scomparsi, c’é da dire, però,
che l’inquinamento delle coste ha fatto il più.
Tornando alle usanze e ai sapori perduti meritano di essere
commemorati i “ceusa” bianchi e neri, quest’ultimi
specialmente caratterizzavano le albe estive quando ti svegliava
il grido del venditore : “ceusa bbelli, ma niuri!” e i
genitori li raccomandavano, ma non ce ne era necessità, ai
figli perché erano rinfrescanti, in particolare “’u
sciroppu di ceusu”. Nonostante il gusto lievemente aspro,
andavano a ruba, diversi erano i ”ceusa janchi” con quel
gradevole gusto e l’odore delicatissimo. Crescendo ho capito
che i gelsi erano un residuato del periodo della Catania
produttrice della seta che, finita da un pezzo, ha portato con
sé la presenza di questi alberi che hanno ceduto il passo alla
cementificazione selvaggia ed è anche scomparsa la generazione
di contadini, disposti a sporcarsi per raccoglierli, i miei
nipoti ignoreranno che cosa fossero, come gia i miei figli non
hanno conosciuto i “pira jalofuru”, i “piricedda di S.
Giuvanni”, i “sorvi”, i “’nzalori” e i “minicucca”………
Quando lo snack bar non era diffuso e non c’erano né
merendine né gelati industriali, ma c’era sempre la voglia di
fare uno spuntino, per le strade trovavi chi ti proponesse
qualche rimedio “ppi ‘ntuppari ‘nvuridduzzu”. Nelle
mattinate d’estate per le strade c’erano certamente i
carrettini dei venditori di “minnulata” che si accompagnava
splendidamente “ccu ‘na bella mafadda cca giugiulena” o d’inverno
uno che con lo stesso carrettino ti proponeva “u pani di
napuli”, ancora caldo, a forma di filoncini monodose o a fette
se la forma era di pancarré, un pane nel cui impasto erano
inframmezzati i “ficu sicchi” oppure “’nmunzeddu di
ficurinnia” che venivano sbucciati e consumati sul posto. Un
menzione merita “’u sanceli” e “’a quarumi” che agli
angoli delle vie era lo snack dei pomeriggi e delle sere fredde
che, possiamo non avere apprezzato, ma facevano parte delle
caratteristiche dei quartiere popolari, erano appannaggio degli
operatori dei macelli che, invece di “ittari ‘u sangu” e
disponendo delle interiora degli animali macellati, li cuocevano
a beneficio degli estimatori che accorrevano alle ”quarare”
per consumare sul posto. Dietro c’era sempre una “putia”
(bottega del vino) per “rifarsi” la bocca dopo questi
bocconi inevitabilmente grassi.
“Pallini e carboni!” – Così si annunciava l’uomo nero,
“u carvunaru”, come il nordico spazzacamino, che, con il suo
carretto altrettanto nero, andava di strada in strada ad offrire
la sua mercanzia. Negli anni della nostra infanzia si cucinava a
carbone nelle cucine in muratura o nei focolari mobili (“i
fucuni di crita”), non esistevano le cucine a gas, e il
combustibile usato era la legna o il carbone nelle sue varietà:
“carvuni”, “carvuneddu tenniru” e “pallini”, un
impasto con polvere di carbone. Lo stesso vendeva pure i
detersivi: “sapuni”, “leva macchi”, “varichina”. Per
la “liscìia” (per fare il bucato più bianco) vigeva il fai
da te, le donne dell’epoca sapevano come, utilizzando la
cenere “du fucularu” o “da conca”(braciere).
Il barbiere lo conosciamo come estetista, un operatore di
bellezza, ma questa sua attuale specializzazione viene da
lontano se ricordiamo che, oltre a fare tagli di capelli e
radere barbe, ha collaborato, nei tempi, con il chirurgo per
asportare arti, per incidere “craunchi”, per asportare
denti, ma quando ero piccolo, sulla porta delle sale da barba
spesse volte si leggeva “si applicano sagnetti”. Era l’ultima
risorsa del barbiere come operatore sanitario: applicare
sanguisughe su chi aveva necessità di un salutare salasso a
scopo terapeutico.
Nel secondo dopoguerra gli americani portarono, tra l’altro,
le calze di nylon, un indumento chic destinato a promuovere le
gambe e la sensualità femminile, fino ad allora mortificata
dalle gonne lunghe e dalle opache calze di seta. Ma la
delicatezza del nuovo materiale e la scarsa dimestichezza nel
maneggiarlo procurava frequenti “smagliature” dell’indumento
e il costo non consentiva un frequente rinnovo del parco-calze.
Nacque una attività per venire in soccorso alla vanità delle
donne non abbienti, la “rimagliatrice” di calze di nylon.
Era la parente povera della sarta, la professione femminile per
eccellenza, che aveva il vantaggio di essere esercitata nel
proprio domicilio, senza “fari parrari a nuddu”. Dello
stesso genere era pure il lavoro della “macchinista” che,
restando in casa, poteva cucire la partita di tomaie che il
fabbricante di calzature le andava affidando. Diverso era per
quelle che, costrette dal bisogno, uscivano di casa: il lavoro
femminile non autonomo si svolgeva in casa d’altri per chi
andava “a servizio”, nei “malazzeni” per quelle che
lavoravano alla trasformazione dei prodotti agricoli e nelle “fabbriche”
in pericolosa promiscuità che metteva a repentaglio la
onorabilità, se non la virtù. Nel quartiere, posto alla
periferia della città, sorgevano i luoghi in cui si svolgevano
quelle attività manifatturiere con carattere industriale dove
la manodopera femminile era preferita. Si ricordano per tutte le
“sucarrara”, che, già dall’inizio del secolo ventesimo,
prestavano la loro opera presso la vecchia caserma borbonica,
divenuta per i catanesi “’a manifattura” dei tabacchi e le
“pusparara” della “fabbrica de’ prospiri” di via “uttanta
pammi”(via della Concordia).
Quando eravamo bambini, andando a scuola, lungo le strade, meno
trafficate di oggi, si vedevano davanti alle porte e sui
marciapiedi degli stecchi gialli messi ad asciugare su dei teli
di “sacco” che prendevamo furtivamente per succhiarne il
gusto. Erano le radici che le donne, su commissione, ripulivano
spellandole con un coltello e li mettevano ad asciugare al sole
per poi riconsegnarle alla “fabbrica di niculizia” che
avrebbe fatto quel decotto che, essiccato, forma i bastoncini di
liquirizia.
Erano i tempi in cui esistevano gli “stabilimenti” della
liquirizia che, per i loro fumi e gli odori che sprigionavano
erano allocati fuori dalla cinta urbana. Nella mia prima
giovinezza ne ho registrati due, ai margini di questa, che era
una vera e propria industria, c’era l’attività delle misere
donne che, con un lavoro a domicilio di pochissimo valore
aggiunto, preparavano la materia prima:, quelle, appunto, che
ripulivano le radici.
Un altro opificio, allocato fuori dalla città, era “u
stazzoni”, l’azienda produttrice di laterizi come “madduni,
canali, e quatretti (piastrelle)” e altri oggetti di uso
comune quali “tiani, rasti, quartari, bummuli” e “fuculari”,
dei quali materia prima è la creta, che, asciugata al sole,
veniva cotta nella “carcara” (fornace).
--------------------------------------------------------------------------------
Posted by Mile on
aprile 27th, 2009 :: Filed under Catania com'era..,Sociologia
 |

|
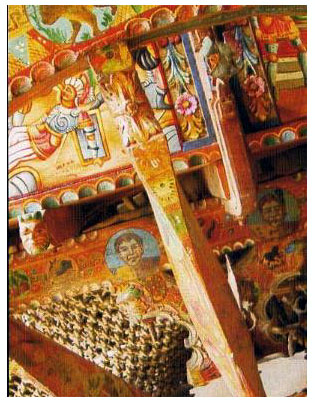 Fra
l'ottocento e la prima metà del novecento, si sviluppò nella vivace
Catania e nell'area etnea una fiorente attività artigianale: quella
dell'allestimento e della decorazione artistica del carretto. Fra
l'ottocento e la prima metà del novecento, si sviluppò nella vivace
Catania e nell'area etnea una fiorente attività artigianale: quella
dell'allestimento e della decorazione artistica del carretto.
Abili
artigiani con passione ed impegno si superarono sino ad elevare quegli
umili mestieri a vere e proprie scuole d'arte, falegnami, scultori,
fabbri e pittori si distinsero per l'alto livello artistico raggiunto.
In
questo periodo storico, Aci Sant'Antonio diventò il centro più
importante della cosiddetta "Scuola d'Arte del Carretto" buona
parte dell'economia del paese si basava su queste attività, pensate
c'erano più di 16 botteghe che aggregavano centinaia di persone tra
artigiani, carrettieri ed apprendisti. Grazie a loro quasi
inconsapevolmente con estrema semplicità, oggi è nato il
"Mito" del Carretto di Sicilia.
LA
TRADIZIONE ARTISTICA DI UNA FAMIGLIA
In
questo contesto, tra intensi profumi di zagara e di vino, tra suoni di
legno scolpito e di ferro rovente battuto, che prende colore e vita,
nasce e cresce la tradizione artistica nella nostra famiglia.
Infatti
ancora ragazzini i cugini Micio Puglisi e Minicu Di Mauro
imprimono le loro prime pennellate seguendo a loro volta l'esperienza
degli zii, Vincenzo e Salvatore, già affermati artigiani.
Ancora
oggi Minicu Di Mauro, nostro grande maestro, insieme ad Antonio
Zappalà
(figghiu do soddu - della celebre putia), passano le loro giornate
immortalando con antiche cadenze, le. gesta di eroici paladini e dei
personaggi della Cavalleria Rusticana.
 Testimone
ne è il suo "Museo del Carretto Siciliano" a Bronte, che
racconta in fondo anche la storia della sua famiglia. Il padre, don
Affiu Gullotti, era infatti "Carrettiere di linea", un odierno
autotrasportatore, che all'epoca portava vino, frumento, frutta e
carbone, dalle campagne ai centri abitati e così in tutta l'Isola.
"Il mio primo viaggio da solo - racconta don Cammelu -, lo ricordo
come fosse ieri, lo feci ad otto anni andando col carretto a Pedara per
trasportare vino. Per caricare non c'erano problemi poich‚ vi erano
gli appositi carricaturi i carrettu". E poi in viaggio, con il lume
del carrettiere e il paracqua appesi fra le due ruote alla preziosa
"cascia i fusu" (copri asse ricco di piccole sculture in ferro
battuto decorato). Testimone
ne è il suo "Museo del Carretto Siciliano" a Bronte, che
racconta in fondo anche la storia della sua famiglia. Il padre, don
Affiu Gullotti, era infatti "Carrettiere di linea", un odierno
autotrasportatore, che all'epoca portava vino, frumento, frutta e
carbone, dalle campagne ai centri abitati e così in tutta l'Isola.
"Il mio primo viaggio da solo - racconta don Cammelu -, lo ricordo
come fosse ieri, lo feci ad otto anni andando col carretto a Pedara per
trasportare vino. Per caricare non c'erano problemi poich‚ vi erano
gli appositi carricaturi i carrettu". E poi in viaggio, con il lume
del carrettiere e il paracqua appesi fra le due ruote alla preziosa
"cascia i fusu" (copri asse ricco di piccole sculture in ferro
battuto decorato).
Questo
singolare museo si trova in contrada Cantera, fra l'Etna e i Nebrodi, a
due passi dal Simeto, con una preziosa collezione di ben 50 carretti
siciliani, una decina di calessi, carrozze per lieti eventi e poi giare
e anfore decorate, pupi siciliani e i vari ornamenti del cavallo,
adibito al traino: pennacchi, testiere, pettoriere e altro. D'epoca
anche il salottino dove ci ha fatto accomodare per spiegarci anche cosa
rappresentano le decorazioni, sui mascillari (sponde) o nella cascia i
carrettu (pianale) o nei gambotti (raggi della ruota), raffiguranti
scene epiche: "Il trionfo di Bacco"; poemi cavallereschi:
"Duello di Ruggiero e Rinaldo"; saghe nostrane: "Turi
Malacorda e i mafiosi di Palermo"; personaggi come: "Turi
Giuliano"; e poi i passionali intrecci amorosi di "Cavalleria
Rusticana" di Verga, con "Compari Affiu e Compari
Turiddu". "Questa è una storia vera - si appassiona don
Cammelu - accaduta in Sicilia, oltre un secolo fa: compari Turiddu,
fidanzato con Lola, si allontanò per il servizio militare. Al ritorno
la trova promessa a compare Affiu il carrettiere, con il quale si
maritò. Compari Turiddu nel frattempo si fece assumere come campiere da
massaro Cola il vignaiolo, che abitava di fronte alla Lola, e cominciò
a corteggiarne la figlia Santuzza. Mentre lui la sera gli parlava da
sotto la finestra, Lola osservava da dietro un vaso di basiricò. In
sostanza anche in lei si risvegliava l'antica passione, portandola
finanche al punto di richiamare Turiddu. Lo rimproverò perch‚ non
salutava più e gli disse che se avesse voluto "salutarla"
sapeva dove abitava. Però i frequenti "saluti" ingelosirono
Santuzza inducendola a complimentarsi con compari Affiu, per la moglie
che gli "adornava" la casa. Questo raggiunse compari Turiddu
all'osteria, e lo sfidò a duello. L'indomani, giorno di Pasqua, fra i
ficodindia della Canziria dei due duellanti alla siciliana (con il
coltello) ad avere la peggio fu compari Turiddu". Questa è una
delle scene storiche che l'anziano pittore Domenico Di Mauro di
Aci Sant'Antonio con dipinti, sculture e intarsi ha raffigurato, in
questi carretti siciliani caratterizzati proprio dall'abilità degli
artigiani e dal gusto e sentimento popolare. Peculiarità che rendono
questo patrimonio storico e culturale fiore all'occhiello della Sicilia.


Aci
S. Antonio e il carretto siciliano
Un
occasione davvero speciale durante la visita di Aci S. Antonio è
rappresentata dalla possibilità di visitare le poche botteghe, rimaste
ancora attive, dedite al carretto.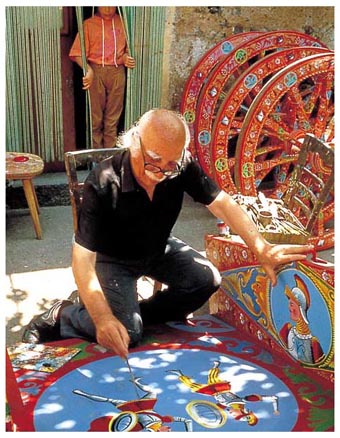
Una
lunga procedura quella della costruzione del carretto, che chiama in
causa diverse maestranze e un tempo il paese contava numerosi artigiani
del carretto, il " carradore" è il vero costruttore del
carretto composto da cassa, fiancate, stranghe, portello e ruote, mentre
ad incidere, con motivi che vanno dal floreale all’antropomorfo, è lo
scultore. Segue la fase della pittura con colori diversi a seconda della
bottega in cui viene effettuata l’opera. Sull’intera anatomia del
carretto vengono riportate scene appartenenti alla tradizione
cavalleresca anche se non mancano temi mitologici e religiosi: Carlo
Magno, Orlando , Rinaldo, i Vespri siciliani, Sant’Alfio
e i suoi fratelli, San Giorgio Cavaliere, Sant’Agata e Santa Rosalia.
Completato il carro si passa al lavoro del sellaio che in concordanza
con le scene e i colori assegnati al carretto, fabbrica e ricama con
nastri, specchietti e sonagli la bardatura del cavallo.
Oggi
ad Aci S. Antonio la pittura del carretto sopravvive grazie ai maestri Domenico
Di Mauro e Nerina Chiarenza. Lammittenza tende a non essere più
quella di una volta, lo stesso carretto si smembra in più parti le
quali diventano oggetto per le esigenze più raffinate dei
collezionisti. Le richieste di fiancate, assi, ruote e casse, oltre alla
cassa di ferro battuto, " Cascia di fusu", diventano richiesta
di pezzi di radici di una cultura che tende a scomparire. Chiunque
giunto qui ha apprezzato questo pezzo di Sicilia mobile, Guy de
MAUPASSANT NEL VOLUME LA VIE ERRANTE DEL 1890 COMMENTA IL CARRETTO COSÌ:
" PICCOLE SCATOLE QUADRATE POSTE IN ALTO A DELLE RUOTE GIALLE, SONO
DECORATI CON PITTURE INGENUE E BIZZARRE CHE RAPPRESENTANO EVENTI STORICI
O DETTAGLI, AVVENTURE D’OGNI TIPO, PUGNE SANGUINOSE, INCONTRI DI
SOVRANI MA SOPRATTUTTO LE BATTAGLIE DI NAPOLEONE E DEGLI ESERCITI
CRACIATI.
………….
QUESTI CARRI DIPINTI TRAVERSANO LE VIE, CURIOSI E DIFFERENTI, ATTIRANO L’OCCHIO
E LA MENTE, SI MUOVONO COME REBUS CHE VIEN NATURALE TENTARE DI RISOLVERE
!!!
la
tradizione santantonese si chiama soprattutto "Carretto
siciliano". Aci Sant'Antonio d'altronde ha una prerogativa
veramente unica in Sicilia perché merita di essere considerata la
capitale del "carretto siciliano". Vanta, infatti, eccezionali
maestri decoratori del tipico carro isolano con artisti come Francesco
D'Agata già nell'Ottocento, e ai nostri giorni con Domenico Di
Mauro, Nerina Chiarenza, Raimondo Russo, Anzonio Zappalà. Saprà
sfruttare la cittadina questo immenso patrimonio che potrebbe elevarla
all'apice del turismo isolano?
MUSEO
DEL CARRETTO DI CATANIA

E’
aperto su prenotazione per visite guidate - Via
Luigi Capuana 38 - Catania - TEL.
095 525342
Il
museo comprende circa 150 pezzi unici di parti di carretto: Mascìddari,
Purteddi, Chiavi di Carretto, Ruote, Casse di fuso (rabeschi), oggetti
in vetro ed in terracotta, autentiche opere d'arte, realizzate e
decorate nel corso di 4 generazioni, con la passione e la competenza
tramandate da più di un secolo.
L'ambiente
è caratteristico ed è contraddistinto da uno stile inconfondibile,
impareggiabile e apprezzato da sempre nel mondo lo stile siciliano, che
ha elevato il carretto, umile mezzo di trasporto ad opera d'arte,
rendendolo simbolo di questa terra ricca d'arte e vitale di
temperamento, a ragione definita Perla del Mediterraneo.
Alice Valenti, l'ultima donna che
dipinge i carretti
di Danila Giaquinta
Si laurea in Conservazione dei Beni
Culturali a Pisa, torna confusa a Catania e si ritrova, per caso, a fare
quello che faceva suo nonno. O quasi, perché lui era un “carradore”,
lavorava con il legno e i carretti siciliani li costruiva; lei, invece,
macina colori e li dipinge. Dalla scena, che definisce il tema
principale, ai decori su sponde, traini o finimenti dei cavalli,
l’artista Alice Valenti, a un passo dagli “anta”, pratica l’arte “du
carrettu” ormai da quasi 15 anni e si diverte pure a raffigurarne i
motivi su elementi di arredo, oggetti d’uso quotidiano e altri mezzi di
trasporto. Da quella suggestione la sua arte non si stacca ma nel tempo
è arrivata a inglobare tanti altri soggetti di sicilianità. È stata
allieva del maestro Domenico Di Mauro, grande custode di questa
tradizione, e tutto è cominciato a partire da un libro.
Quando il carretto è entrato nella
sua vita?
«Mi ero appena laureata e brancolavo
nel buio. Sapevo solo di voler fare qualcosa di artistico e artigianale.
E avevo voglia di riappropriarmi delle mie radici. Stavo leggendo “Il
carretto siciliano”, un volume a edizione limitata del 1967, quando vidi
il nome di mio nonno nell’elenco degli artigiani. Mio padre mi raccontò
della collaborazione con il maestro Di Mauro che a 17 anni andava a
dipingere da lui a Scordia. Il giorno dopo andai a trovarlo ad Aci
Sant’Antonio e in quella bottega, sua e del cognato Antonio Zappalà, ci
rimasi cinque anni. Ricordo ancora quel momento: mi ritrovai come in una
situazione antica, su quel basolato di pietra lavica, tra Sant’Agata e
storie di paladini, con tutti quei carretti smembrati e accatastati, e
loro due, curvi, con i capelli bianchi, in mezzo a tutti quei colori».
Com’è stata quell’esperienza in
bottega?
«Il maestro mi diceva: “Ti sei
laureata in via Tito 8”, l’indirizzo della bottega, perché avevo sempre
disegnato ma è stato lui a insegnarmi la pittura a olio, come dipingere
le scene, lo sbozzo del quadro mentre da Antonio ho imparato a decorare
tutte le altre parti del carretto. Di solito ci sono due figure, il
maestro, che si occupa delle parti più importanti, veri e propri quadri
sul tema principale solitamente scelto dal committente; e ‘u giuvini che
decora l’interno delle casse, il traino, le ruote, le aste. Ed io ho
imparato a fare sia l’uno che l’altro. Oggi Domenico Di Mauro ha 102
anni e lavora ogni mattina. Vado spesso a trovarlo e la nostra è
un’amicizia bella e forte».
Un breve racconto della storia del
nostro carretto?
«È simbolo di un’epoca della Sicilia.
I primi risalgono al 1830 e le fonti sono diari di viaggiatori che
scrivono di aver visto buffi mezzi a due ruote con immagini sacre e
tocchi di colore. Fino ad allora il trasporto avveniva via mare o a
dorso di mulo. Man mano le tematiche vanno arricchendosi ma all’inizio
prevaleva quella religiosa perché chi affrontava un lungo viaggio era
solo, con il suo cavallo, andava incontro a rischi di briganti o piogge,
e quelle figure lo consolavano. Nel tempo si sono sedimentate pratiche
decorative le cui origini sono ancora argomento di studio. Dal punto di
vista artistico e tecnico, il carretto è tutto una regola, un insieme di
codici da rispettare e richiede una certa dose di preparazione. Non si
può improvvisare. E tra la Sicilia orientale e quella occidentale, e
persino tra provincia e provincia, ci sono differenze cromatiche,
tematiche. Come pure di misura se si considera che il veicolo deve
adeguarsi alle asperità del terreno pianeggiante piuttosto che montuoso.
È il risultato del lavoro di tanti artigiani: in ordine di tempo il
pittore è l’ultimo mentre il primo è il “carradore” che organizza anche
il lavoro dello scultore. Poi c’è il fabbro che si occupa delle parti in
ferro mentre il sellaio dei finimenti dei cavalli».
L’arte del carretto resiste o è
giunta al capolinea?
«Non è morta anche se un tempo
c’erano 30-50 pittori a provincia, oggi ce ne sono 1-2. Anche le altre
figure si contano sulle dita di una mano. Come donna sono l’unica della
mia generazione».
Il carretto è il suo lavoro
quotidiano?
«Nel tempo ho acquistato credibilità
dinanzi agli occhi di questi uomini che di solito non hanno a che fare
con le donne. Dalla richiesta di piccole cose, si è passati alle scene
fino a un carretto per intero, a Randazzo dove facevo spola tutti i
giorni. Ne ho dipinti tanti di media taglia e da circa un anno sono alle
prese con i finimenti di tre carretti. Tempi e costi? Dipendono da tante
cose, da quanto vuole spendere il committente: per dipingerlo dai 4000
euro in su e da 3 mesi in poi. Oggi sono riconosciuta come pittrice di
carretti ma per vivere faccio anche altro».
Carretti a parte…?
«Vivo in una casa laboratorio.
Dipingo quadri, decoro ceramiche e da un po’ ho cominciato a provare
delle eccezioni alla regola mescolando elementi decorativi orientali e
occidentali su tavoli, sedie, testate di letto come pure su oggetti di
uso quotidiano e Vespe. In realtà lo avevano già fatto artisti
all’inizio del Novecento, se si pensa ai banchi dell’acquaiolo decorati
con gli stilemi del carro. O più recentemente alle motoapi. Questo
perché il carretto era stato scavalcato da altri mezzi e i carrettieri
erano diventati camionisti o guidatori di Ape ma continuavano a farsi
dipingere quelle iconografie. Oggi il committente medio lo percepisce
come un oggetto d’arte e da collezione. E mentre in altri casi si può
rielaborare in chiave contemporanea quel sapore, quando si tratta di
carretto tradizionale inventare è un sacrilegio. Dipingo anche altro ma
si tratta sempre di iconografie popolari e tradizionali, come dolci
tipici, cavalli bardati».
Nel 2001, quando è cominciata la sua
avventura, il digitale stava per esplodere. Oggi c’è questo trend dell’handmade
e la voglia di spostare le mani da mouse e touch screen per tornare alla
materia e ai mestieri.
«L’arte è sempre stata la mia
passione ma non sapevo che veste dare. Mi occupo anche di grafica al pc
ma fare le cose con le mani dà ben altra soddisfazione. Qualcosa di
terapeutico, salvifico. Un valore ritrovato per le nuove generazioni».
Progetti futuri?
«La copertina del cd di Giada
Salerno, una cantante di brani folkloristici dell’800. In generale mi
definisco “in cerca” perché vorrei scoprire altre frontiere e tentare
nuovi strumenti».
http://www.siciliainrosa.it/alice-valenti-lultima-donna-che-dipinge-i-carretti/
 |


(foto Giusepe Santapaola)
Ci sono barche che sono cariche di anni. E tutti i soli, tutte le
lune, tutta l’acqua di mare, tutte le tempeste, tutti i venti ci
sono passati sopra.
(Fabrizio Caramagna)
|
LE
BARCHE TRADIZIONALI CATANESI "Palummedde 'cù speruni"
a
cura di Giordano Baroni (www.modellismo-navale.it)
Barche,
varchi, varchi ‘i sarde, varchi tartarunare, conzulari, nassari,
cuzzulare, ‘i sciabbica, ‘i fiscina, ‘i focu, … varchi … varchi
‘i riatteri,
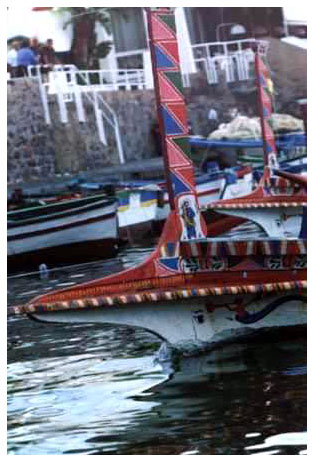 d’a ‘ncannata, ‘i ciumi, varchi… e si potrebbe
continuare ancora nell’elenco in quanto era abitudine del siciliano
nominare il tipo di barca non in base alle sue caratteristiche
costruttive, ma all’uso che se ne faceva.
d’a ‘ncannata, ‘i ciumi, varchi… e si potrebbe
continuare ancora nell’elenco in quanto era abitudine del siciliano
nominare il tipo di barca non in base alle sue caratteristiche
costruttive, ma all’uso che se ne faceva.
..
I tipi di pesca praticati e gli attrezzi usati erano altrettanto numerosi
e diversificati così come è diversificata la morfologia della costa
catanese e i suoi habitat marini.
Dai
fondali ghiaiosi e ripidamente fondi di Fiumefreddo, caratterizzati da
cicliche correnti fredde e presenza di sorgive d’acqua dolce, si confina
immediatamente con la costa frastagliata, lavica, ricca di insenature e
rocce affioranti di Torre Archirafi, Pozzillo, Stazzo, Acitrezza fino a
Ognina e Catania per poi ritrovarsi in fondali bassi e sabbiosi quali
quelli della Plaia a sud di Catania o fangosi della foce del Simeto
Una
costa disseminata da una miriade di insenature, piccole baie e porticcioli
impreziositi da paesini dalle caratteristiche case dei pescatori locali
quali le graziose Santa Maria la Scala, Santa Tecla, Acicastello. Il tutto
visionato da quel "gigante buono" da secoli chiamato
semplicemente "’a muntagna", l’Etna: il più grande ed
attivo comprensorio vulcanico europeo. Le campagne etnee, produttrici di
agrumi, vini, frutta e miele, necessitavano di validi trasporti delle
merci verso Catania, Siracusa e spesso anche fuori isola, e tale trasporto
non poteva che avvenire per via marittima proprio da quei porticcioli
sopra menzionati di cui il maggiore, come traffico e possibilità di
attracco era Riposto, patria dei più famosi capitani della marina
mercantile ed ancora oggi sede di un prestigioso Istituto Nautico.
I n
questo contesto, come già accennato, lo sviluppo della piccola
cantieristica tradizionale fu notevole ed i tipi di imbarcazioni
innumerevoli. Classificare questo vasto patrimonio culturale è compito
arduo soprattuto per la mancanza di documentazioni storiche dal momento
che l’arte costruttiva si tramandava di generazione in generazione in
modo esclusivamente artigianale. n
questo contesto, come già accennato, lo sviluppo della piccola
cantieristica tradizionale fu notevole ed i tipi di imbarcazioni
innumerevoli. Classificare questo vasto patrimonio culturale è compito
arduo soprattuto per la mancanza di documentazioni storiche dal momento
che l’arte costruttiva si tramandava di generazione in generazione in
modo esclusivamente artigianale.
Le
varie barche adibite ad uso da pesca erano, in ogni caso, molto similari
avedo tutte la caratteristica di presentare sia la poppa che la prora a
punta, derivavano dai classici gozzi mediterranei. Gli elementi che le
diversificavano erano il prolungamento della ruota di prora definito
"palummedda", palombella, lo sperone sempre di prora e le
tipiche decorazione degli scafi di origine arabo-normanna.
Le
"varche ‘i sarde" e le "tartarunare" erano
praticamente identiche, le prime adibite alla pesca delle sardine, alici o
"masculini", utilizzavano una rete definita "tratta" o
"minaita", le seconde adibite alla pesca varia utilizzavano una
rete non di profondità definita "tartaruni". Tutte e due non
superavano i dieci metri di lunghezza, erano armate di vela latina e
spesso di fiocco detto "latineddu" più sei remi. La palombella
era poco pronunciata, massimo raggiungeva i 30-40 cm di altezza ed era a
forma curva allungata verso avanti, detta "a pappagliaddu", a
becco di pappagallo. I decori erano sobri, arabeggianti, variopinti con
rappresentazioni spesso votive e religiose, a prora venivano disegnati le
classiche sirene e i due occhi scaramantici detti "scacciaguai".

Le
"varche ‘i conzu" o "conzulari", "’i
nasse" e "’i cuzzulari" erano adibite rispettivamente
alla pesca con il conzo, con le nasse e alle perline o telline della plaia
(specie di vongole). Erano simili alle precedenti, potevano essere armate
fino a otto remi, ma la loro caratteristica dominante che le distingueva
era "’u speruni", lo sperone di prora che si allungava minimo
di un metro e la palombella che raggiungeva anch’essa l’altezza minima
di un m etro. Erano riccamente decorate in modo similare ai carretti
siciliani e rappresentavano le barche sicuramente più prestigiose. Molto
slanciate, simili ad un pesce spada, armate di vela latina o "vela al
carro" con l’aggiunta del fiocco e di un piccolo albero di
bompresso, poppa e prora ampiamente pontate, venivano chiamate anche
"varchi cù speruni". etro. Erano riccamente decorate in modo similare ai carretti
siciliani e rappresentavano le barche sicuramente più prestigiose. Molto
slanciate, simili ad un pesce spada, armate di vela latina o "vela al
carro" con l’aggiunta del fiocco e di un piccolo albero di
bompresso, poppa e prora ampiamente pontate, venivano chiamate anche
"varchi cù speruni".
 Le
"varche ‘i conzu" o "varche cù speruni e palummedda"
di Santa Maria della Scala e di Ognina, sicuramente le più complete
e fedeli in quanto costruite dal maestro maestro d’ascia detentore
dell’antica arte Ignazio Garozzo presso il cantiere navale situato in
Piazza Mancini Battaglia CT nell’anno 1982. Riportati agli antichi
splendori nello stesso cantiere nell’anno 2009 dallo stesso Mastro d’ascia
e decorati dal prof. Salvatore Finocchiaro, decoratore di Aci Trezza. Le
"varche ‘i conzu" o "varche cù speruni e palummedda"
di Santa Maria della Scala e di Ognina, sicuramente le più complete
e fedeli in quanto costruite dal maestro maestro d’ascia detentore
dell’antica arte Ignazio Garozzo presso il cantiere navale situato in
Piazza Mancini Battaglia CT nell’anno 1982. Riportati agli antichi
splendori nello stesso cantiere nell’anno 2009 dallo stesso Mastro d’ascia
e decorati dal prof. Salvatore Finocchiaro, decoratore di Aci Trezza.
Attualmente
ne esistono quattro esemplari dislocati a Ognina e Santa Maria La Scala
prive dell’armo velico ed adibite ad uso folcloristico. Le due di Ognina
sono di proprietà del Santuario di Santa Maria di Ognina e vengono
utilizzate durante i festeggiamenti patronali per una regata remica nelle
acque dell’omonimo golfo. Le due di Santa Maria La Scala, decisamente in
migliore stato di conservazione ed amorevolmente curate dalla comunità
locale, sono di dimensione maggiore tale da imbarcare otto rematori più timomiere ed anch’esse vengono utilizzate per una analoga regata remica
in onore della Madonna della Scala festeggiata l’ultima settimana di
Agosto.
L’assenza
dello sperone prodiero, una corta palombella e scarsi decori sono le
caratteristiche delle più modeste barche "’i sciabbica"
utilizzate alla pesca a strascico ritirata direttamente dalla riva, "’i
fiscina" per la pesca con fiocina tra gli scogli, "’i focu"
con la lampara. Tutte quest’ultime barche modeste, di piccole dimensioni
che spesso lavoravano in gruppo. Potevano contare massimo di quattro remi
e saltuariamente di una modesta vela "al carro".
Tra
le barche invece definite "minori" e chiaramente non provviste
né di sperone e palombella accenniamo alle "’varchi ‘i riattieri"
adibite esclusivamente al piccolo trasporto locale, alle "varche da‘ncannata"
usate esclusivamente per la pesca dei cefali, e le "varchi ‘i ciumi"
per la pesca nei fiumi in particolar modo del Simeto e del Fiumefreddo.


Il cantiere peschereccio di Acitrezza nasce verso la fine del 1800 grazie
a Salvatore Rodolico
che insieme al figlio Sebastiano
cominciano a costruire barche a remi e a vela per i committenti di
Catania. L'originario cantiere era stanziato nella zona denominata "stagnitta",
ne è memoria una piccola via che porta il nome di: "Via Rodolico". Gli strumenti utilizzati al tempo, per dar
vita alle barche di legno, erano l'ascia, la sega a mano, il chianozzo
(pialla a mano), il chiano (pialla lunga) e i virrina (i trapani a mano).
Gli anni '60 segnano l'inizio di una stagione florida per il cantiere che,
passato nelle mani di Salvatore Rodolico (figlio di Sebastiano), comincia
a costruire imponenti pescherecci di legno. Le commesse erano tantissime:
arrivavano dalla Toscana, dalle isole Eolie e dall'isola D'Elba. Intanto
il cantiere si era stanziato all'interno del porto di Acitrezza,
di: "Via Rodolico". Gli strumenti utilizzati al tempo, per dar
vita alle barche di legno, erano l'ascia, la sega a mano, il chianozzo
(pialla a mano), il chiano (pialla lunga) e i virrina (i trapani a mano).
Gli anni '60 segnano l'inizio di una stagione florida per il cantiere che,
passato nelle mani di Salvatore Rodolico (figlio di Sebastiano), comincia
a costruire imponenti pescherecci di legno. Le commesse erano tantissime:
arrivavano dalla Toscana, dalle isole Eolie e dall'isola D'Elba. Intanto
il cantiere si era stanziato all'interno del porto di Acitrezza, 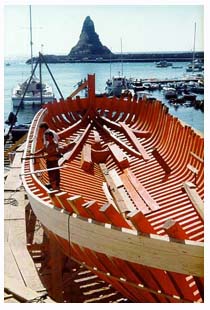 proprio
dirimpetto all'isola Lachea, mentre andava sviluppandosi la pesca con i
pescherecci anche a Trezza. Grazie alla gran quantità di commesse, anche
da Acitrezza, il cantiere diede in quegli anni lavoro a più di 20
persone. Oggi non costruisce più imponenti pescherecci, l'ultimo risale
al 1989, ma continua ad esistere grazie ai lavori di manutenzione e
costruzione di piccole barche di legno. Passato in mano al giovane
Sebastiano Rodolico
(figlio di Salvatore) continua nella sua secolare arte
di dar vita alle barche a legno. La tecnica, seppur con qualche variante
dovuta alla nuova tecnologia, è sempre la stessa: "il fasciame di
legno viene attaccato con la chiodatura zincata, poi il comento (le
fessure tra un legno e l'altro) vengono chiuse con la stoppa catramata e
quindi con la lanata (un pennellone) si passa, sul fasciame esterno, la
pece per proteggere lo scafo (oggi sostituita con stucchi e
pittura)". Le barche che solcano il mare di Trezza sono resistenti
come una volta e l'arte dei maestri d'ascia attira, oggi anche, tantissimi
turisti che percorrendo il Lungomare dei Ciclopi rimangono estasiati nel
vedere quegli artigiani al lavoro. proprio
dirimpetto all'isola Lachea, mentre andava sviluppandosi la pesca con i
pescherecci anche a Trezza. Grazie alla gran quantità di commesse, anche
da Acitrezza, il cantiere diede in quegli anni lavoro a più di 20
persone. Oggi non costruisce più imponenti pescherecci, l'ultimo risale
al 1989, ma continua ad esistere grazie ai lavori di manutenzione e
costruzione di piccole barche di legno. Passato in mano al giovane
Sebastiano Rodolico
(figlio di Salvatore) continua nella sua secolare arte
di dar vita alle barche a legno. La tecnica, seppur con qualche variante
dovuta alla nuova tecnologia, è sempre la stessa: "il fasciame di
legno viene attaccato con la chiodatura zincata, poi il comento (le
fessure tra un legno e l'altro) vengono chiuse con la stoppa catramata e
quindi con la lanata (un pennellone) si passa, sul fasciame esterno, la
pece per proteggere lo scafo (oggi sostituita con stucchi e
pittura)". Le barche che solcano il mare di Trezza sono resistenti
come una volta e l'arte dei maestri d'ascia attira, oggi anche, tantissimi
turisti che percorrendo il Lungomare dei Ciclopi rimangono estasiati nel
vedere quegli artigiani al lavoro.
Il
testo e le foto provengono da: www.acitrezzaonline.net

|
Legno, martello, chiodi e passione.Nel regno
delle barche fatte a mano.
Ignazio Garozzo, l'ultimo dei Mastri d'ascia.
«La
mattina andavo a scuola, di pomeriggio un amico
di mio papà, uno che era stato suo compagno
d'armi quando facevano "il soldato", mi propose
di andare nel suo cantiere». Così ha iniziato
Ignazio Garozzo, l'ultimo maestro d'ascia che
opera ancora a Catania. Era il 1944, Garozzo
aveva 7 anni e adesso che di anni ne compirà 78
tra sei mesi, parla del suo lavoro come di «un
mestiere per il quale ci vuole passione e che si
impara seguendo un "maestro"».
«Il mio si chiamava Pasqualino Vitale e il primo
lavoro che mi diede da fare al cantiere fu
quello di raddrizzare i chiodi usati per
riutilizzarli su altre barche. Una volta i
chiodi non si compravano nuovi, "s'addrizzavano"
e si riutilizzavano due-tre volte per formare
gli "ordinati" (le "costole" della barca sul
fondo dello scafo ndr) alla base delle barche».
Mentre racconta, sta completando l'ultima sua
creazione, nel cantiere di Ognina, suo quartier
generale, proprio sotto piazza Mancini
Battaglia, una «lancia» di 5 metri e 60. Per
realizzarla, in due, ci si mette un mese scarso
e la spesa, remi in mano, è di circa 4.000 euro.
È fatta con legno di quercia, abete e pitch-pine
(una qualità di pino). «Io ho cominciato con una
barca che costava 40mila lire - ricorda Garozzo
- Oggi di barche di legno se ne fanno poche, il
vetroresina chiede molta meno manutenzione ed è
più facile da gestire anche se costa di più. Una
volta si costruivano barche durante tutto
l'anno, sia durante l'estate, la "stagione", sia
durante l'inverno quando si procedeva alle
riparazioni. Poi si è bloccato tutto negli Anni
Novanta, con il 50% di lavoro in meno - quando
la Comunità europea stabilì che per lo specchio
d'acqua che ha l'Italia, c'erano troppe
imbarcazioni da pesca e così non si è potuto più
costruire barche nuove ma solo demolire le
vecchie per sostituirle con altre che
mantenessero le stesse caratteristiche. In più,
molti
 pescatori sono passati al vetroresina e tutto il
lavoro è diminuito tantissimo. ».
pescatori sono passati al vetroresina e tutto il
lavoro è diminuito tantissimo. ».
Il laboratorio di Ignazio Garozzo sta ad Ognina
dal 1959. Un mondo a parte rispetto alla città.
Ci sono ogninesi doc che ancora oggi dicono
«vado a Catania».
«Quando sono arrivato io, dagli Angeli Custodi,
la gente dell'Ognina era tutta una famiglia.
Vedevi donne che vestivano a lutto per
cinquant'anni, perché c'era sempre qualcuno che
nel giro di sei mesi moriva e siccome erano
tutti parenti, a quella poveretta ci toccava
sempre vestirsi di nero. Qui tutti vivevano con
il mare, erano pescatori, poi pian piano i figli
hanno cominciato ad andare a scuola, e altri
hanno preso i posti al Comune o in banca. Ora di
pescatori veri non ce n'è più, sono solo
dilettanti. C'è chi ha ancora qualche
peschereccio, ma le barche piccole da pesca sono
rarissime».
Sposato nel ‘65, due figli (un maschio e una
femmina), l'eredità da maestro d'ascia potrebbe
essere raccolta proprio dal figlio Giuseppe, 40
anni, geometra. «Mi piacerebbe fare il lavoro di
mio padre - confessa - ma finora mi sono
dedicato ad altro. La mia giornata, comunque
trascorre qui, mi occupo di mettere in mare i
motoscafi. Mio padre è fantastico, perché si
dedica al legno con passione. Se cade una tavola
per terra mi urla dietro che «il legno si deve
trattare bene, perché è un'arte! ».
«Ogni barca, a seconda del cantiere nel quale si
costruisce, ha le sue caratteristiche - spiega
Garozzo padre - A Catania «‘a palummedda di
prua» (il dritto di prua) ha una certa forma, a
Siracusa un'altra e a Palermo un'altra ancora.
Oggi il modello più richiesto è la lancia con lo
specchio piatto. Nelle barche che costruiamo noi
non c'è un goccio di colla, è tutto legno e
chiodi. Ci sono barche mie a Spadafora e Avola,
una volta anche ad Acitrezza dove c'è un altro
maestro d'ascia in attività, Salvatore Rodolico,
che fa anche barche grosse».
Il futuro del mestiere? «Mah, non saprei. Una
volta venivano qui i ragazzi del Nautico a
vedere come si faceva, ma restavano un paio
d'ore e non imparavano niente. Questo non è
lavoro che si può apprendere così, io ci ho
messo 17 anni per imparare dal mio maestro, ma
erano altri tempi. È un lavoro che puoi imparare
solo da piccolo quando la testa è ancora
disposta ad apprendere».


|
Pupi
(dal latino pupus, i, che significa bambinello) sono le caratterische
marionette armate di quel teatro epico popolare che, venuto
probabilmente dalla Spagna di Don Chisciotte, operò a Napoli e a Roma,
ma sopratutto, dalla prima metà dell’Ottocento, in Sicilia, dove
avrebbe raggiunto il suo massimo sviluppo.
I
pupi sono espressione "splendente" di quello spirito epico,
eroico e cavalleresco, che dalla Chanson de geste medievale ai grandi
poemi del Boiardo e dell’Ariosto, a tutta una tradizione letteraria,
musicale, figurativa, e in particolare teatral popolare, segna lo
sviluppo di un’educazione sentimentale e di una visione etica e
poetica del mondo.
I
pupi esprimono la volontà di continuare a battersi in quella che è
stata definita "la più invisibile delle guerre invisibili"
che, con i nostri ideali, sosteniamo dentro di noi più che fuori. Non a
caso i pupi costituiscono un umile ma tenace segno di contraddizione e
di resistenza rispetto alla logica della rassegnazione e del peggio, che
è di tanta cultura e letteratura di "vinti".
I
pupi ci aiutano a capire il Gran Teatro del Mondo, dove si è fin dalla
nascita "agiti", giusta l’idea pirandelliana secondo la
quale "siamo tutti pupi" (marionette, burattini, maschere,
ombre), animati—stando alla Bhagavad Gita—dall’ onnipotente
Spirito divino, che è nel cuore di tutti gli esseri e tutti agita al
ritmo incalzante del tempo, col potere della meraviglia".
Con
i pupi possiamo aprirci un varco verso quel pò di libertà che si può
conseguire nella recita "a soggetto" del sacro canovaccio del
destino, e affrontare il pathos dell’ esistenza in un
"catartico" gioco di arte e di poesia. In tal senso, un teatro
come quello dei pupi può essere "necessario, … essenziale come
il pane".
E'
opportuno distinguere il burattino, la marionetta, il pupo. Il burattino
è animato dal basso, direttamente da pollice, indice, medio della mano
o da asticelle. La marionetta è animata dall'alto, esclusivamente per
mezzo di fili. Il pupo è anch'esso animato dall'alto, ma, al posto dei
fili, ha per muovere la testa e il braccio destro due sottili aste di
metallo. I pupi portano in scena l'epica dall'Iliade e dalla Bibbia alla
Chanson de Roland e ai romanzi dell'epopea cavalleresca. Si ritiene che
l'epopea carolingia sia arrivata in Sicilia con i Normanni, nel sec. XII.
Che essa sia stata fatta propria dalla gente fin da allora o che sia
diventata epopea popolare successivamente, poco importa; è certo che ha
trovato in Sicilia uno straordinario favore per cui si è conservata fin
ai giorni nostri.
All'inizio
furono soprattutto i cantastorie a tramandarne il ricordo. A partire dal
sec.XIX il racconto popolare dell'epica cavalleresca franco normanna
utilizzò il pupo già conosciuto rivestendolo di foggie che si
rifacevano alla iconografia cinquecentesca. Gli eroi paladini,
rappresentati nel teatro dei pupi, unitamente alla esalazione dei valori
morali di cui sono campioni, mettono in risalto il confronto tra la
civiltà europea ed islamica, del cui urto la Sicilia è stata teatro:
per questi valori i paladini lottano e muoiono, rimanendo cosi nella
cultura popolare tra il mito e la storia vera.
Ogni
singola rappresentazione veniva preannunciata da un "cartello"
con la scena principale della serata e con una sintetica descrizione del
programma. Il commento musicale, quando c'era, era affidato a musicanti
di mestiere (generalmente un violino, un mandolino, una chitarra) che,
su indicazione estemporanea del "parlatore", eseguivano brani
in voga, veloci o lenti, a seconda dell'azione scenica.

LA
FAMIGLIA NAPOLI DI CATANIA
La
Compagnia della famiglia Napoli rappresenta la più antica tradizione di
pupari catanesi. Fondata nel 1921 da Don Gaetano Napoli, oggi è gestita
da Fiorenzo, direttore artistico, "parlatore" principale e
maestro costruttore dei pupi. Lo affiancano Giuseppe, capo "maniante"
e scenografo, Salvatore, ideatore e curatore delle musiche, e tutti gli
componenti della famiglia, che collaborano attivamente affinchè la
tradizione continui intatta, passando di padre in figlio.
I
Napoli propongono spettacoli con recita a soggetto, basati sugli antichi
canovacci, rispettando le caratteristiche fondamentali dell'Opera dei
Pupi: le scene, le armature, i costumi, i suoni e soprattutto quella
"improvvisazione" che rappresenta il momento artistico per
eccellenza, poichè crea quel particolare rapporto con il pubblico che
rende "magiche" queste rappresentazioni teatrali.
Oltre
al classico repertorio cavalleresco la Compagnia ha allestito spettacoli
su testi di diversa natura, da quelli tratti dal NÔ giapponese a
Shakespeare, a scritti in versi siciliani di Salvatore Camilleri.
Fra
i numerosi riconoscimenti avuti dalla Compagnia si può annoverare il
Premium Erasmianus, ricevuto dai Reali d'Olanda nel 1978.
I
Napoli custodiscono inoltre una vasta collezione di pupi, alcuni dei
quali risalgono alla fine dell'Ottocento o ai primi del Novecento,
scene, cartelli ed attrezzature teatrali.
L'attività
artigianale della famiglia è svolta nella casa-bottega di via Reitano,
aperta al pubblico, costituito per lo più da scolaresche e appassionati
dell'Opra, per svelare le tecniche e i segreti di questa antichissima
tradizione.
 "L'oro
dei Napoli". Su testi di Salvatore Zinna, la storia di questa
straordinaria famiglia, nota in tutto il mondo, applaudita in ogni parte
ma, spesso ed ancora oggi, dimenticata proprio a Catania "L'oro
dei Napoli". Su testi di Salvatore Zinna, la storia di questa
straordinaria famiglia, nota in tutto il mondo, applaudita in ogni parte
ma, spesso ed ancora oggi, dimenticata proprio a Catania
(di
Maurizio Giordano)
Sulla
scena, con i loro ferri del mestiere, con il loro fedele armamentario e
soprattutto con gli eterni pupi (Agramante, Subrino, Gradasso,
Suddateddu a'n'coppu, Soldato cinese, Arturo di Macera, Luneide, Ideo,
Peppenino, Rinaldo, Carlo Magno, Gano, Orlando, Clarice, Papa Martino,
Vescovo di Patti, Oliviero, Brandimarte) i protagonisti sono proprio
loro: Fiorenzo Napoli, Salvatore e Giuseppe Napoli, Italia Chiesa
Napoli, Agnese Torrisi, Alessandro Napoli, Davide, Dario e Marco Napoli.
La
Marionettistica dei Fratelli Napoli, figli, nipoti, moglie
dell'indimenticabile Natale Napoli, raccontano attraverso le gesta dei
loro pupi, gli ultimi cinquant'anni culturali, sociali di Catania. Viene
quindi narrata, in parallelo, la storia di questa straordinaria
famiglia, nota in tutto il mondo, applaudita in ogni parte ma, spesso ed
ancora oggi, dimenticata proprio a Catania. Una famiglia, una
Marionettistica che ha dato vita al "miracolo dell'eredità",
a quel mito fatto di baruni, scamappoggiu, martelli, punteruoli,
copioni, tecniche, ma anche di cervelli, forza, braccia. Fiorenzo, il
più piccolo dei figli di Natale Napoli, è q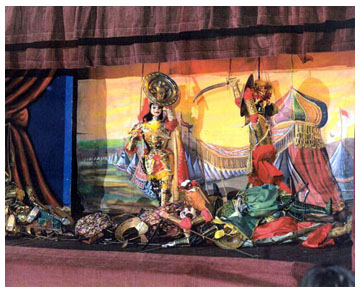 uello che narra la storia,
che rappresenta e che muove le fila di questa famiglia e che, durante lo
spettacolo, apre lo scrigno dei ricordi e da vita ad una pièce che
emoziona, che interessa grandi e piccini. uello che narra la storia,
che rappresenta e che muove le fila di questa famiglia e che, durante lo
spettacolo, apre lo scrigno dei ricordi e da vita ad una pièce che
emoziona, che interessa grandi e piccini.
Il
lavoro immagina un "naufragio culturale" e la famiglia Napoli
viene vista, dall'autore e dal regista, come una sorta di
"scialuppa", carica di un tesoro di inestimabile valore. Una
scialuppa che viene a contatto con gli abitanti del luogo e che cerca di
offrire loro qualcosa di questo tesoro. Si tratta del dramma di una
famiglia di pupari, conduttori di un vascello fantasma. La loro storia
inizia nel 1921 dal "mastru siddunaru" Gaetano Napoli, il
capostipite, che acquista il suo "mestiere" di un centinaio di
pupi e mette su una compagnia, con il fratello e i figli, distinguendosi
perchè non si limita alla rappresentazione, ma si occupa anche della
progettazione e costruzione degli elementi necessari allo spettacolo
(pupi, fondali, cartelloni).
Una
famiglia segnata da una anomalia straordinaria, un destino che si compie
nell'affrontare il "naufragio' nelle culture tradizionali,
soppiantate dal consumismo di massa. I figli di Gaetano, Natale e Pippo,
affrontano il momento difficile con un'altra anomalia: se gli altri
chiudono, loro aumentano il raggio d'azione, portando la tradizione
fuori dai confini nazionali. Se gli altri dichiarano morta
"l'Opra" loro innovano la rappresentazione ed i suoi elementi
nel folle tentativo di tenerla al passo coi tempi, se gli altri
dimenticano loro tramandano l'eredità ai figli di Natale ed Italia:
Fiorenzo, Giuseppe e Salvatore e ad un nipote Alessandro.
Quando
l'Opra dei Pupi muore dappertutto nasce il mito della famiglia Napoli,
gli ultimi pupari del mondo. Ora fanno ingresso tra i
"personaggi", tra quelli che non moriranno mai, malgrado le
difficoltà da affrontare, primo fra tutti l'indifferenza della Catania
culturale di oggi, quella degli s pettacoli senza cuore, solo commerciali
e poi la mancanza di una sede istituzionale per una famiglia che ha già
conquistato un posto tra i miti. Lo spettacolo, prodotto da Arcana, si
avvale delle musiche di Third Earl Band, Gonzales, Comelade, Salvi,
Mahler, Jarret, Martens, Verdi e Bregovic. Uno spettacolo da vedere, un
viaggio nella nostra storia, nei nostri ricordi, grazie ad una
straordinaria famiglia da proteggere gelosamente e che custodisce il
segreto delle tradizioni e di un mestiere eterno, quello dei miti.
"Il nostro è un lavoro corale - spiega Fiorenzo Napoli - e questa
tradizione vive in quanto è supportata dal lavoro di tutti. Il presente
sono io, i miei fratelli, Salvatore e Giuseppe, mia moglie Agnese, mio
cugino Alessandro. Il futuro è rappresentato dai miei figli, Davide,
Dario e Marco". pettacoli senza cuore, solo commerciali
e poi la mancanza di una sede istituzionale per una famiglia che ha già
conquistato un posto tra i miti. Lo spettacolo, prodotto da Arcana, si
avvale delle musiche di Third Earl Band, Gonzales, Comelade, Salvi,
Mahler, Jarret, Martens, Verdi e Bregovic. Uno spettacolo da vedere, un
viaggio nella nostra storia, nei nostri ricordi, grazie ad una
straordinaria famiglia da proteggere gelosamente e che custodisce il
segreto delle tradizioni e di un mestiere eterno, quello dei miti.
"Il nostro è un lavoro corale - spiega Fiorenzo Napoli - e questa
tradizione vive in quanto è supportata dal lavoro di tutti. Il presente
sono io, i miei fratelli, Salvatore e Giuseppe, mia moglie Agnese, mio
cugino Alessandro. Il futuro è rappresentato dai miei figli, Davide,
Dario e Marco".
Ma
come è nato lo spettacolo "L'oro dei Napoli"?
"Questo
spettacolo - racconta orgoglioso il regista Elio Gimbo - ha avuto una
lunga gestazione. Coltivo da otto anni l'idea di uno spettacolo sul
mondo dei pupi e sulla famiglia Napoli, dal '94, l'anno di Sud il mio
primo spettacolo con dei pupi accostati agli attori. Da allora non ho
mai perso di vista la famiglia Napoli ed il mio desiderio di arrivare ad
una forma compiuta dell'accostamento fra pupi ed attori. L'oro dei
Napoli è una riflessione sulla storia contemporanea di Catania.
Immagino gli ultimi cinquant'anni di storia catanese come la descrizione
di un naufragio, un inconsapevole "naufragio culturale" di cui
noi cittadini siamo stati vittime ed artefici allo stesso tempo".
Ma
come si può raccontare la storia di una famiglia così?

"Lasciando
parlare loro - aggiunge il regista Gimbo - la famiglia, il gruppo, la
Marionettistica. Con gli anni la famiglia si è allargata, loro non sono
più soli, "loro" sono centinaia di Pupi, grandi e piccoli,
antichi e recenti, sono fondali dipinti cento, cinquanta, venti o anche
pochi anni fa. Oggi tutto questo è la Famiglia Napoli, i principi di un
regno fantastico. Perciò raccontare la famiglia equivale a
"far" raccontare la famiglia, a chiedergli di raccontare
l'ultimo mezzo secolo di storia catanese, la storia di una forma d'arte
nobile e preziosa, troppo fragile per combattere il
"progresso" e troppo profonda per esserne sconfitta, fragile e
profonda come i sogni o come uno spettacolo".
Maurizio
Giordano

La
famiglia Napoli
Sergio
Corona
Le
luci si spengono, si apre il sipario e i pupi entrano in scena. Orlando,
Rinaldo, Angelica, Clarice, Carlo Magno, Gano di Magonza, Papa Martino,
Subrino, Brandimarte: ci sono tutti. Le loro storie si intrecciano con
la vita della famiglia dei pupari, i Napoli, che arrivano su una
scialuppa in balia dei marosi: stanno cercando di mettere in salvo l’Opera
dei Pupi, riconosciuta nel 2001 dall’Unesco patrimonio culturale
immateriale dell’umanità. Il pubblico segue rapito le gesta dei
paladini e assiste al naufragio culturale di un Paese incapace di
salvaguardare e valorizzare un tesoro di inestimabile valore.
Stasera la compagnia Fratelli Napoli mette in scena L’oro dei Napoli:
la storia di una delle più antiche e famose famiglie di pupari
raccontata dagli stessi protagonisti.
Prima che il regista convochi gli attori nei camerini per dare loro le
ultime indicazioni, approfittiamo di un momento di distrazione del
nostro nuovo amico e andiamo a salutare due protagonisti dello
spettacolo: la signora Italia Chiesa, una delle più apprezzate
interpreti catanesi, e suo figlio Fiorenzo Napoli, direttore artistico
della compagnia, nonché principale parlatore e maestro costruttore dei
pupi.
L’idea di un reportage sui Napoli ci era venuta in mente un paio di
mesi fa, dopo una mattinata trascorsa con Fiorenzo nel laboratorio della
compagnia. Ci aveva tenuti incollati alla sedia per tre ore con i suoi
racconti straordinari, che ci scorrevano davanti quasi come un film. E
lo stesso effetto ci avevano fatto le storie di Italia Chiesa, che
quello stesso pomeriggio ci aveva accolti nella sua casa alle porte di
Catania. Tutto ha inizio nel 1921, quando Gaetano Napoli decide di
abbracciare il teatro popolare fondando la Marionettistica Napoli. Il
successo è immediato. Una prima crisi però arriva nel 1934, in seguito
alla scomparsa del figlio diciannovenne Rosario. Don Gaetano si defila,
ma l’attività della compagnia continua grazie agli altri due figli,
Pippo e Natale. Con lo scoppio della guerra tutto diviene ancora più
difficile. Ma la vita va avanti. Natale conosce Italia Chiesa, figlia di
attori, e se ne innamora. Dal loro matrimonio nascono Gaetano,
Salvatore, Giuseppe e Fiorenzo.

Gli
anni del dopoguerra sono i più duri. Ma anche dopo, con l’avvento
della televisione e il successo dei cinematografi, non è facile. Ci si
mettono anche i proprietari di alcuni cinema che, preoccupati perché l’Opera
dei Pupi toglie loro spettatori, boicottano gli spettacoli della
compagnia. La scelta di andar via da Catania si rivela vincente: dai
primi anni Cinquanta fino al 1970 i fratelli Napoli girano senza sosta
tutta la Sicilia, e fanno anche tantissime tournée in Italia e all’estero,
raccogliendo ovunque successo e popolarità. A Misterbianco e a Paternò
i cinema sono costretti a chiudere perché i Pupi fanno ogni sera il
tutto esaurito (non avevano tutti i torti, i poveri proprietari di
cinema, a boicottare la Marionettisca Napoli…). Poi però i gusti del
pubblico iniziano a cambiare e negli anni Settanta e Ottanta l’Opra
viene snobbata anche dal popolo. La signora Italia ci rivela la storia
che sta dietro il nome del figlio minore: la passione di Natale per il
ciclismo. Fiorenzo si sarebbe dovuto chiamare Fausto, ma la storia d’amore
tra Coppi e Giulia Occhini, la “dama bianca”, aveva destato così
tanto scalpore in quell’Italia bigotta e intollerante che alla fine
Italia e Natale decidono di optare per Fiorenzo, in onore di un altro
grande campione di quegli anni: Fiorenzo Magni. E nei primi anni del
dopoguerra come si sposta la compagnia? In bicicletta, naturalmente. Poi
arrivano la Vespa e quindi, in pieno boom economico, la Fiat 1100.

L’appartamento
di Italia Chiesa non sembra la casa di un’artista: non c’è traccia
di locandine, poster o ritagli di giornale. C’è solo qualche
fotografia che nulla però ha a che fare con l’Opera dei Pupi o con il
Teatro. Ma quando la signora ci racconta, con un misto di orgoglio e
malinconia, di aver recitato negli anni Sessanta e Ottanta nel musical
di Garinei e Giovannini Rinaldo in campo, uno dei più grandi successi
teatrali italiani di tutti i tempi, allora vengono fuori le fotografie
che la ritraggono accanto a Domenico Modugno, Delia Scala, Paolo
Panelli, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Massimo Ranieri, Laura
Saraceni, Carlo Croccolo. Parliamo anche della malattia di suo marito
Natale e delle sofferenze che dovette affrontare durante una tournée,
prima di morire di aneurisma cerebrale nel 1984. Ma torniamo allo
spettacolo. Tutto è pronto. Giuseppe, capo maniante, e Fiorenzo,
parlatore principale, sono ai loro posti. Così come i figli di
Fiorenzo: Davide, maniante e secondo parlatore, e Marco, maniante.
Salvatore, che si occupa delle luci e delle musiche, è accanto al
regista Elio Gimbo. La moglie di Fiorenzo, Agnese Torrisi, direttore di
scena, è dietro le quinte con l’altro figlio Dario, assistente di
palcoscenico. Forse avremmo dovuto raccontare la storia di questa
straordinaria famiglia di artisti parlando di pupi, fondali e
cartelloni. Ma abbiamo preferito fare un viaggio in un’Italia che non
c’è più, per ricordare a tutti da dove veniamo. E poi un libro sui
pupi catanesi è già stato pubblicato qualche anno fa. Lo ha scritto un
antropologo siciliano. Si chiama Alessandro Napoli, è cugino di
Fiorenzo, e anche lui fa il maniante in questo spettacolo.
http://www.dirittinegati.eu/?p=440

Tutti
i membri della famiglia Napoli prendono parte alla messinscena degli
spettacoli ricoprendo con maestria i ruoli tipici dell'Opera: Italia
Chiesa Napoli parratrici, Fiorenzo direttore artistico della compagnia,
parraturi principale e maestro conduttore dei pupi; Giuseppe capo
manianti e scenografo; Salvatore ideatore delle luci e fonico; Gaetano
parraturi; Davide manianti e secondo parraturi; Dario assistente di
palcoscenico; Marco manianti; Alessandro antropologo, manianti e addetto
al fabbisogno degli spettacoli; Agnese Torrisi, direttore di scena.
Antica
Bottega del puparo: Via Reitano, 55 - 95121 - Catania (zona
Castello Ursino) Tel. (+39) 095 34 10 52 http://www.fratellinapoli.it/



l
primo teatro dei Pupi ad Acireale risale al 1870 quando Giovanni
Grasso, figlio di Angelo, grande puparo catanese, venne ad
Acireale per farsi conoscere. Ma colui che ha lasciato
un'impronta molto più profonda nella tradizione dei Pupi di
Acireale, fu don Mariano Pennisi (1867 - 1934) detto
"Nasca", il quale creò un teatro stabile prima in via
Tono e poi in via Alessi, dove ancora oggi si trova. La passione
per i Pupi, questo grande puparo la trasmise al figlio adottivo
Emanuele Macrì.Attivo
sulla scena, geniale nell'improvvisazione, Macrì riusciva a
trasformare ogni rappresentazione in un avvenimento scenico
degno della più completa ammirazione.
 Il
teatro-museo dei pupi dell'Opera di Acireale, realizzato interamente dal
puparo Turi Grasso e dalla sua famiglia, ha rappresentato in questi
decenni un grande patrimonio storico-culturale per la città di
Acireale. Il
teatro-museo dei pupi dell'Opera di Acireale, realizzato interamente dal
puparo Turi Grasso e dalla sua famiglia, ha rappresentato in questi
decenni un grande patrimonio storico-culturale per la città di
Acireale.
Unico
nel suo genere, il teatro-museo raccoglie in esso le migliori opere
realizzate da Turi nei suoi cinquant'anni di attività, insieme a
preziosi pupi e cimeli di fine ottocento, di fondali stile catanese,
teste e scenografia teatrale del teatro dei pupi di Acireale.
Visitato
da migliaia di turisti, studenti, ed appassionati delle tradizioni
siciliane, il teatro dei pupi del maestro Turi Grasso è certamente da
considerare un angolo di storia e di vera arte, nonché una finestra
sulla nostra sicilianità.
Le
grandi scene teatrali, i cartelloni di presentazione degli episodi della
Storia dei Paladini, i pupi, il sipario del palcoscenico, il palco con
il suo banco di manovra, tipico della tradizione di Acireale, il grande
affresco di San Michele Arcangelo, rendono pienamente e viva l'opera ed
il lavoro che l'unico puparo operante in Acireale, ha voluto realizzare
per sè, per la sua famiglia e per la sua Acireale. il
Teatro-Museo resta aperto al
pubblico tutto l'anno nei
giorni di Mercoledì,
Sabato, Domenica. Nel
periodo estivo ore
9/12 - 18/21, nel
periodo invernale 9/12
- 15/18. Ingresso
Libero
http://www.operadeipupi.com/
 Solo
un paese resiste ancora all´impeto rinnovatore del gusto:
Acireale. Ed il merito di aver salvato una tradizione
antichissima spetta alla popolazione del luogo, capace di
balzare irritata sul palcoscenico per afferrare alla gola il
traditore Gano di Maganza (in genere dipinto con colori forti,
torvi, dominati dal nero), ma soprattutto alla pressione dei due
pupari (si chiamano così), rispettivamente Mariano Pennisi ed
Emanuele Macrì Solo
un paese resiste ancora all´impeto rinnovatore del gusto:
Acireale. Ed il merito di aver salvato una tradizione
antichissima spetta alla popolazione del luogo, capace di
balzare irritata sul palcoscenico per afferrare alla gola il
traditore Gano di Maganza (in genere dipinto con colori forti,
torvi, dominati dal nero), ma soprattutto alla pressione dei due
pupari (si chiamano così), rispettivamente Mariano Pennisi ed
Emanuele Macrì
Il
nostro Teatro dei Pupi Siciliani Macrì è stato fondato nel
1887 da Mariano Pennisi, ultimo discendente d´una famiglia di
pupari vaganti, che pur essendo analfabeta, sapeva recitare a
memoria tutto l´Orlando furioso e tutta la Gerusalemme
liberata.
Sotto
le sue mani abilissime, lo stanzone che accoglieva ogni sera
centinaia di spettatori urlanti, divenne un teatro vero e
proprio, ed il numero dei pupi passò dalla trentina al
centinaio. Ma Pennisi, oltre al teatro ed ai Pupi, ha regalato
al folklore siciliano anche il suo successore, Emanuele Macrì.
Nel 1908, infatti, non appena seppe del disastro di Messina,
partì con una squadra di operai che l´aiutarono per due giorni
e per due notti sotto una pioggia battente, a disseppellire la
sua famiglia del suo vecchio amico Macrì.
continua...
Solo
un paese resiste ancora all´impeto rinnovatore del gusto: Acireale. Ed
il merito di aver salvato una tradizione antichissima spetta alla
popolazione del luogo, capace di balzare irritata sul palcoscenico per
afferrare alla gola il traditore Gano di Maganza (in genere dipinto con
colori forti, torvi, dominati dal nero), ma soprattutto alla pressione
dei due pupari (si chiamano così), rispettivamente
Mariano Pennisi,
Turi Grasso ed
Emanuele Macrì
Il
nostro Teatro dei Pupi Siciliani Macrì è stato fondato nel 1887 da
Mariano Pennisi, ultimo discendente d´una famiglia di pupari vaganti,
che pur essendo analfabeta, sapeva recitare a memoria tutto l´Orlando
furioso e tutta la Gerusalemme liberata.
 Sotto
le sue mani abilissime, lo stanzone che accoglieva ogni sera centinaia
di spettatori urlanti, divenne un teatro vero e proprio, ed il numero
dei pupi passò dalla trentina al centinaio. Ma Pennisi, oltre al teatro
ed ai Pupi, ha regalato al folklore siciliano anche il suo successore,
Emanuele Macrì. Nel 1908, infatti, non appena seppe del disastro di
Messina, partì con una squadra di operai che l´aiutarono per due
giorni e per due notti sotto una pioggia battente, a disseppellire la
sua famiglia del suo vecchio amico Macrì. Sotto
le sue mani abilissime, lo stanzone che accoglieva ogni sera centinaia
di spettatori urlanti, divenne un teatro vero e proprio, ed il numero
dei pupi passò dalla trentina al centinaio. Ma Pennisi, oltre al teatro
ed ai Pupi, ha regalato al folklore siciliano anche il suo successore,
Emanuele Macrì. Nel 1908, infatti, non appena seppe del disastro di
Messina, partì con una squadra di operai che l´aiutarono per due
giorni e per due notti sotto una pioggia battente, a disseppellire la
sua famiglia del suo vecchio amico Macrì.
Purtroppo
sotto le macerie del terremoto era rimasto vivo soltanto il piccolo
Emanuele di tredici mesi, salvato dai corpi dei genitori tra i quali si
era addormentato. Data sepoltura a tutti quei poveretti, Mariano Pennisi
portò con sè il bambino e lo allevò come se fosse suo figlio. Solo
che invece di farne un puparo, cominciò a sognare di farne un
professionista. Ma fu un sogno di breve durata, perchè il piccolo
Emanuele aveva già preso il virus del teatro, ed invece di stare sui
banchi di scuola, preferiva sostare incantato davanti alla fucina dei
pupi.
Pur
avendo la testa di legno, confessava quando ritornava con il pensiero
agli inizi i pupi mi hanno sempre capito, e fin dai tempi in cui non
riuscivo quasi a camminare, hanno rappresentato il mio mondo ideale
" Non aveva ancora sedici anni che già assumeva la direzione
tecnica delle manovre, e quando nel 1936 Pennisi morì d´idropisia, lo
fece chiamare per chiedergli "Giurami che i miei pupi non moriranno
con me".
L´esordio
avvenne nel mese di dicembre con un brano tratto dalla Storia dei
Paladini di Francia di Giusto Lo Dico, e più precisamente con il
trentaseiesimo episodio del primo volume; dove appare Mambrino che ruba
la fidanzata a Rinaldo. Fu un grande successo, e da quella sera ogni
volta che i bambini di Acireale vedevano spuntare la figura massiccia e
bonaria di don Emanuele , correvano a farsi narrare le imprese di Carlo
Magno e dei suoi paladini. Anzi fu questo entusiasmo infantile a
convincerlo che valeva la pena di affrontare altri pubblici.
Così,
tre anni dopo, i Pupi di Acireale apparivano nei loro costumi sgargianti
e fastosi sul palcoscenico allestito nel grande Salone dedicato a Bianca
di Navarra in quel di Taormina. Stavolta il successo assunse i toni del
trionfo, ed allora Emanuele Macrì si convinse che l´unica strada per
salvarli, era di farli conoscere "nel continente". Prima però
nell´angusta officina ricavata in un angolo di teatro costruì altri
cinquanta pupi fra cui Alessandro Magno, il Guelfo di Negroponte e
Trabalzio e dopo essere arrivato al numero di 200, cominciò a
viaggiare. La prima tappa fu a Roma, dove al palazzo dell´Esposizione
incantò sia il pubblico che la critica, e poi uscì addirittura
d´Italia, toccando Salisburgo Bruxelles e tutte le principali città
della Germania. Sospinta dall´onda dell´entusiasmo, la sua fama,
varcò addirittura l´oceano. Prova ne sia che il figlio maggiore ha
potuto impiantare un teatro dei pupi a Stony Creeck, nel Connecticut,
con il quale ha partecipato, vincendolo, al Festival teatrale di
Indianapolis.
I
successi vennero con la partecipazione ai film: I GIROVAGHI, ARIA DI
TAORMINA, TURI E I PALADINI; a riprese televisive: Australia, Giappone,
Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Germania Occidentale, Stati Uniti,
Canada, Inghilterra, Olanda ed anche la Rai. Sono seguite molto tournée
in Europa ed in America senza tralasciare gli spettacoli per le scuole e
per il pubblico ad Acireale. Per queste accettiamo sempre le
prenotazioni per effettuare recite sulla Chançón de Roland per gruppi
turistici e scuole; periodicamente invece facciamo delle recite . Mostre
di pupi, cartelloni e scene antiche dipinte a mano, queste si
organizzano sia in loco che in altre città italiane ed in paesi esteri
. Inoltre il Teatro E. Macrì di Acireale, quest´anno mette in vendita
una piccola parte di materiale antico non utilizzabile per gli
spettacoli, fra cui pupi armati e non , scene, teste e cartelloni
dipinti su carta a tempera.
(sito
ufficiale)
 I
Pupi Siciliani sono patrimonio dell'umanita'. L'Unesco ha ricosciuto il
valore di questa forma d'arte di cultura popolare e nella primavera
dello scorso anno il teatro dei pupi siciliani e' stato dichiarato
"Capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanita'"
dall'Unesco, insieme ad altre 18 espressioni culturali popolari di tutto
il mondo. I
Pupi Siciliani sono patrimonio dell'umanita'. L'Unesco ha ricosciuto il
valore di questa forma d'arte di cultura popolare e nella primavera
dello scorso anno il teatro dei pupi siciliani e' stato dichiarato
"Capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanita'"
dall'Unesco, insieme ad altre 18 espressioni culturali popolari di tutto
il mondo.
E'
la prima volta che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'istruzione, la scienza e la cultura, ha voluto dare un
riconoscimento non a statue, a monumenti o a siti storici, ma a
creazioni culturali e tradizioni, inserendole nel patrimonio mondiale
piu' degno di protezione.
Una
giuria di 18 membri, presieduta dallo scrittore spagnolo Juan
Goytisolo, ha dovuto esaminare 32 candidature. Determinante per il
buon esito della candidatura italiana, e' stato il contributo del
Museo Internazionale delle Marionette "Antonio Pasqualino" -
Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari -,
presieduto dalla Sig.ra Marianne Vibaek, il cui personale si e'
adoperato per fornire, in tempo breve, tutto il materiale documentario
necessario.

La
Scuola Palermitana
Il
pupo palermitano e' alto da 80 cm a 100 cm, pesa circa 10 Kg e ha le
gambe articolate di modo che possa inginocchiarsi per pregare o davanti
ad una dama. Puo' estrarre e riporre l'arma nel fodero grazie ad un
filo, che passa attraverso il pugno destro del pupo ed e' fissato al
pomo della spada, tirando il quale si fa in modo che la stessa possa
essere impugnata facilmente. La visiera dell'elmo puo' essere abbassata
prima di un combattimento e alcuni pupi possono muovere gli occhi e la
bocca. La corazza puo' avere decorazioni a sbalzo o arabeschi in ottone
saldati a stagno, che rendono piu' pregiata l'armatura. Secondo le
esigenze di rappresentazione, la testa del pupo o il pupo stesso possono
cadere in pezzi: si pensi allo squartamento di Gano o ad un moro diviso
in due da un fendente. La manovra del pupo avviene di lato, chi muove il
pupo, quindi, si trova disposto parallelamente alla scena.
La
Scuola Catanese
Il
pupo catanese e' alto da 110 cm a 140 cm, pesa circa 30 Kg e ha le gambe
rigide, motivo per cui non puo' inginocchiarsi. Non puo' estrarre e
riporre l'arma nel fodero: la spada e' permanentemente fissata alla mano
destra, anche quando abbraccia una dama. La visiera dell'elmo non puo'
essere chiusa. La corazza e decorata con l'aggiunta di piastre
articolate come cosciali pendenti e i vestiti sono piu' raffinati
rispetto quelli dei pupi palermitani. La manovra del pupo avviene
dall'alto, chi muove il pupo, quindi, si trova disposto su di un piano
rialzato dietro la scena. Per ultimo, tra i pupi catanesi vi sono alcuni
personaggi, come Pulicani o Uzeda, che non si trovano tra i pupi
palermitani.
PUPARI
IN ATTIVITA'
MIMMO
CUTICCHIO - Palermo - (Associazione Figli d'Arte Cuticchio) - via B.
all'Olivella 95 - 90133 Palermo - Tel. 091 323400 Fax 091 6815707 www.figlidartecuticchio.com
FRATELLI
NAPOLI - Catania - via Madonna di Fatima 14 - 95030 Gravina di Catania -
Tel. 095 416787
TEATRO
IPPOGRIFO - diretto da NINO CUTICCHIO - Palermo - vicolo Ragusi 6 -
90133 Palermo - Tel. 0347 0676368 - oppure 091 329194
COMPAGNIA
MACRI' - Acireale - via Galatea 89 - 95024 Acireale (CT) - Tel. 095
669998 Fax 095 575976
COMPAGNIA
MANCUSO - Palermo
GIROLAMO
CUTICCHIO - Palermo
OPERA
DEI PUPI PUGLISI - Sortino, SR - Via Catullo, 2 96010 - Sortino
(Siracusa) - Telefono 0931-956163 - e-mail: info@operadeipupi.it
FRATELLI
PASQUALINO - Roma - via Gregorio VII 292 - 00165 Roma - Tel. 06-58231066
(anche fax) e-mail: Teatro@PupiSiciliani.com
TEATRO
DELLE MARIONETTE AURORA - Canosa - via Conte Cavour 12 - 70053 Canosa di
Puglia - Tel. 0833 965496
TEATRI
DEI BURATTINI IN SICILIA
Teatro
Manomagia - Dott. Francesco Fazio - Via Salvatore Paola 15 - 95125
Catania CT - Tel. +39 095509561 - Cell. 03386289544 - Fax. +39 095509867
La
Casa di Creta - Steve Cable - Antonella Caldarella - Via Umberto
134 - 95131 Catania - Tel. - Fax 095539312 - Cell.0338 2044274
Compagnia
Marionette Don Ignazio Puglisi - Via Catullo 2 - Sortino - Siracusa -
Tel. +39 0931956163
Compagnia
dei Pupari Vaccaro Mauceri - Ernesto Puzzo - Via Giudecca, 5 -
96100 Siracusa - Tel/fax 093 146 5540
Figli
D'Arte Cuticchio - Via Bara all'olivella 95 - 90133 Palermo - Tel.
091.323400 - Fax 091.335922
Ass.
Culturale Teatro delle Beffe - Via De Spuches 7 - 90141 Palermo (PA)
Opera
dei Pupi di Vincenzo Argento e figli - Via Vittorio Emanuele, 445 -
Palermo PA - Tel. 091.6113680 - 0333.2935028
Compagnia
Carlo Magno di E.Mancuso - Via La Rosa, 2 - Trabia (Palermo) - Tel.
091 814 6971 - 0347 5792257
Museo
Internazionale delle Marionette A. Pasqualino - Via Butera 1 -
90133 Palermo Pa - Tel. 091.328060 / Fax 091.328276
Opera
dei Pupi di G. Canino - Via S. Ippolito, 16/c - 91011 Alcamo (TP) - Tel.
+39 0924506354
«I
pupi siciliani da Cervantes ai garibaldini»
Intervista a Mimmo Cuticchio, erede
di una prestigiosa tradizione di cuntisti che opera nel cuore di
Palermo. «Grande rispetto con i pupari catanesi» Venerdì 13 Febbraio
2015- Domenico Trischitta
Mimmo Cuticchio, figlio di Giacomo, è
l'erede naturale di una prestigiosa tradizione di cuntisti che opera nel
cuore di Palermo dal 1973, i cui pupi oggi sono iscritti tra i patrimoni
orali e immateriali dell'umanità dell'Unesco. Anche attore e regista,
nel cinema è stato diretto da Francis Ford Coppola ne "Il Padrino parte
III" e più recentemente in "Terraferma" di Emanuele Crialese. Domenica
sarà al Centro Zo di Catania con lo spettacolo "La pazzia di Orlando
ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla luna". Lo abbiamo
incontrato nella sua bottega di via Bara dell'Olivella e con lui abbiamo
tracciato i momenti più importanti della sua straordinaria carriera e
così ha iniziato il suo cunto.
Maestro, com'era la sua Palermo?
«L'ho vista cambiare. Quando da
giovane sentivo parlare gli anziani di tradizioni non riuscivo neanche a
capire perché bisognava rivolgersi a loro con un vossia, oppure baciare
la mano al padre quando commettevi una marachella, non sapevo molto,
anche se oggi con l'età mi rendo conto di essere diventato come loro,
nel senso che non riconosco più la Palermo della mia infanzia. Tutto ha
inizio con i bombardamenti della seconda guerra mondiale, finisce un
mondo di tradizioni e ne inizia un altro. Mi sono ritrovato a girare le
province siciliane assieme alla mia famiglia, dato che mio padre era un
oprante puparo girovago, prima i sobborghi palermitani e poi le zone di
Trapani, Caltanissetta, Agrigento ed Enna. Non ci spingiamo oltre, nella
zona orientale, perché là esisteva un'altra tradizione pupara e per
rispetto non pensavamo di andarci. Anche perché la gente locale si
affeziona alle proprie tradizioni e cunti e se vede qualcosa di diverso
ci rimane male. Eravamo sette figli, tutti nati in giro per la Sicilia».
Quali sono le differenze tra l'opera
dei pupi palermitana e quella catanese?
«Ogni volta che mi sono incontrato
con i pupari catanesi c'è stato sempre un grande rispetto. Personalmente
penso che la differenza sia un'invenzione leggendaria e voglio
raccontarle un episodio cui sono stato testimone alla fine degli anni
Cinquanta. Eravamo a Macchia di Giarre per un incontro con la famiglia
Macrì, i nostri teatrini messi accanto per gli spettacoli e il pubblico
attorno che assisteva. A un certo punto iniziò una conversazione e la
gente chiedeva informazioni, intervenne un signore che sostenne che i
pupi catanesi sono più alti di quelli palermitani, lo interuppe Macrì:
"Lei gli esseri umani li misura a peso o ad altezza?... C'è differenza
tra un nano e una persona normale? ". Macrì proseguì: "Se gli uomini
vengono valutati per intelligenza, generosità o sensibilità l'aspetto
fisico non conta più". Pupi piccoli o pupi grandi, Orlando sempre
Orlando è, questo aneddoto mi colpì moltissimo e non l'ho mai
dimenticato. Ed è la prima volta che lo racconto».
Che ricordi ha di Catania?
«Un giorno andai con Nuccio Vara
della Rai a girare un documentario e ci fermammo a Porta Uzeda a vedere
Ignazio Puglisi che raccontava il cunto dei paladini di Francia, la
gente attorno con le sedie portate da casa. Attraversai l'arco e mi
fermai davanti a un negozio di souvenir, il titolare mi riconobbe e mi
fece entrare dentro. Mi soffermai a guardare dei bellissimi pupi e lui:
"Questi appartenevano al Cavaliere Insanguine, li vuole lei"? Io non ci
ho pensato due volte e ho acquistato questi cinque pupi che altrimenti
sarebbero andati a finire nella casa di qualche turista. Io li ho
acquistati solo per salvarli. Nella Sicilia orientale ricordo in maniera
speciale Paolo Puglisi di Sortino, mi colpì per il fatto che
interpretava tutte le voci recitanti, comprese quelle di donna, e
riusciva a dare delle emozioni fortissime. Riepilogando ho grande stima
per i Macrì, Puglisi, e la famiglia Napoli. Questo muro di differenze
per me non esiste, c'è un grande affetto tra di noi».
Se penso ai pupi catanesi penso a
Giovanni Grasso ed Angelo Musco. Se penso a quelli palermitani penso a
Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Si può fare questo collegamento?
«Franchi e Ingrassia, che provenivano
dai quartieri popolari, frequentavano spesso l'opera dei pupi a Palermo,
fa parte della loro formazione. Gireranno il film di Ugo La Rosa, "I due
pupari", Ingrassia era l'oprante e Franchi era l'unico spettatore.
Decidono di mettersi assieme, diventano soci, e alla fine la sala sarà
stracolma. Musco e Grasso appartenevano direttamente alla tradizione dei
pupari, facevano parte delle loro famiglie. Nel messinese c'erano i
fratelli Cimarosa, pupari e attori, ricordiamo che Tano fu
l'indimenticabile "Zecchinetta" de "Il giorno della civetta" di Damiano
Damiani».
Come arriva questa tradizione di pupi
in Sicilia?
«Non è facile risalire perché ci sono
vuoti nella storia ma sicuramente il riferimento letterario più evidente
è nel "Don Chisciotte" di Cervantes, anche se in Spagna non esistono
pupi, ma burattini. Cervantes partecipò alla battaglia di Lepanto, fu
ferito e si fermò a Messina, e probabilmente lì vide per la prima volta
i pupi. Invece nel Settecento a Palermo esistevano i casotti dei vastasi,
scaricatori di porto che allestivano spettacoli in baracche per fare
satira politica. I primi pupi armati si vedranno nell'Ottocento con Don
Gaetano Greco che fondò una sala in via Roma a Palermo, c'era la musica
dal vivo e l'opera dei pupi. Lo stesso Greco parteciperà alla spedizione
dei Mille di Garibaldi, e a quanto pare le rappresentazioni di opranti
servivano come attacchi mirati al potere borbonico. I saraceni come i
Borboni. Forse nel catanese nascono i primi pupi autenticamente
siciliani».
13/02/2015

A TU PER TU con MIMMO CUTICCHIO:
oprante, puparo, cuntista
Silvia Ventimiglia 9 marzo 2016
Ritratti
Mimmo CuticchioL’ultimo puparo? No,
assolutamente no…il primo di una nuova generazione!
Palermo, in un freddo ma solare
pomeriggio invernale.
Il cammino di avvicinamento che mi
porterà dall’IBIS Hotel al Teatro dei Pupi viene interrotto da una
manifestazione di protesta…una delle tante.
Teatro quel Palazzo Withaker, sede
della Prefettura, da cui quella calda sera del 3 Settembre del 1982,
uscì il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per andare incontro al Suo
destino, in quella Via Isidoro Carini dove ancora oggi risuonano i colpi
di quei vigliacchi Kalashnikov che falciarono Lui e la giovane moglie,
Emanuela Setti Carraro.
Mi sorprendo a pensare che la
protesta alla quale assisto si leghi, in qualche modo, a quei cento
difficili giorni in cui il Superprefetto provò a resistere a quella
Mafia che, ai tempi, pareva essere appannaggio solo del Sud…della
Sicilia, in particolare ma, che oggi purtroppo, sappiamo essere “bene”
comune del Nord, del Centro ed anche del Sud…non solo, e
ripeto…purtroppo.
Ma questa è un’altra storia e
meriterebbe più di qualche fugace appunto.
Odio arrivare in ritardo e quella
protesta rischia di farmi ritardare rispetto alle 15.30…orario
concordato con Elisa, moglie del grandissimo Mimmo Cuticchio.
Come spinta da una mano divina, la
macchina di Salvo Zappalà…patron di Sicilian Secrets e compagno curioso
di mille avventure…imbocca una, due, tre stradine mai esplorate e
stranamente libere da confusione concludendo la sua marcia in un
provvidenziale parcheggio, proprio a ridosso di quella Via Bara
all’Olivella che il grande puparo…completerò in seguito la
definizione..ha eletto come suo quartier generale.
Arriviamo quasi in contemporanea con
lui, di ritorno dalla canonica passeggiata con il fedele Miele, un
delizioso volpino che non si sottrarrà ai miei esperti “grattini” per
tutta la durata dell’incontro che, alle primissime battute, non promette
niente di buono: Cuticchio, che mi richiama alla mente un moderno
“Mangiafuoco” per l’imponenza fisica, lo sguardo diretto, i lunghi
capelli ad incorniciare un volto in parte arricchito da una folta barba
grigia, mi gela…a primo acchito… sottolineando la banalità di certe mie
iniziali considerazioni.
Ce ne sarebbe a sufficienza per
decidere di abbandonare il campo e battere in un’ignominiosa, ma
salvifica, ritirata ma lo sguardo complice di Salvo mi dice che posso
farcela, ricacciando indietro ogni tentazione di rispondere per le rime,
“pizzuta” come poche e, pertanto, mi appresto – diligentemente – ad
accendere il fedele registratore…amico insostituibile di tanti incontri.
Eccovi il resoconto di un pomeriggio
che rimarrà indelebile nella mia memoria.
Maestro…come posso definirla? Puparo,
attore o regista teatrale?
Perchè, per quei 4 o 5 che non
sappiamo chi è il personaggio con il quale mi ritrovo a colloquiare in
un ambiente dalle luci fioche…sulle cui pareti, quasi fossero testimoni
muti del nostro incontro, ci osservano decide e decine di pupi…di tutte
le fogge e grandezza, in un’atmosfera da antro della Sibilla Cumana,
pronta come sono ad ascoltare l’oracolo…quel personaggio, dicevo, è
Mimmo Cuticchio, classe 1948… custode di quell’arte antichissima che,
definita “Opera dei pupi”, oggi è entrata a far parte, a pieno titolo,
del Patrimonio orale ed immateriale dell’UNESCO.
Mah…mi ascolti attentamente. Quelle
che usa Lei sono… tutte parole senza senso.
Come tradizione, può definirmi
“oprante” perchè sono gestore di un Teatro dell’Opera dei Pupi…ma anche
“puparo” perchè costruisco Pupi.
In passato l’oprante era il
Capocomico e tale era mio padre, Don Giacomino Cuticchio.
Detto questo, può definirmi anche
“cuntista” perchè narro storie epico-cavalleresche.
Già nell’800, gli appassionati…i
cultori definivano così coloro che raccontavano storie.
Il “cunto” era la radio del tempo,
per intenderci…era la lettura di chi conosceva le storie…era la memoria
orale .
Il “cunto” lo potevano fare
tutti…mentre il “cuntista” non raccontava le storie di tutti…raccontava
solo le storie epico-cavalleresche, dagli antenati ai discendenti.
Basta leggere Pitrè quando racconta
del Teatro dei Pupi e della storia del “cunto”, laddove intervista un
“cuntista” che, per differenziare dal cantastorie, chiamerà
“contastorie”, con la O…eh?
Bene, questo “contastorie” che, per
il popolino, era il “cuntista”…gli dice che, per poter raccontare
l’intero ciclo dei Paladini di Francia avrebbe avuto bisogno di 9
anni…facendo un “cunto” al giorno per 2 ore. Pensi, quale patrimonio
orale…nulla di scritto!
Un tempo un “cuntista” era capace di
fare tremila “cuntate”, ci pensa?
Oggi io, da “cuntista” quale sono,
come le dicevo, posso dirle di non aver fatto più di 200 “cuntate”, in
vita mia….non ho il pubblico di strada ormai, quello adatto.
Ho molti fans, molti appassionati e
cultori del genere, è vero ma è diverso. Diverso il piacere
dell’ascolto…del riascolto. E’ diverso, insomma.
Oggi, sono collaborato da Tania
Giordano…tra gli altri
…si tratta della gentile
collaboratrice che segue tutto il nostro incontro e che il Maestro
trova, così, il modo di presentarmi.
E’ in gamba, davvero…perchè non
dirlo? A me piace riconoscere i meriti ai miei collaboratori…a tutti!
Non è un accentratore, allora! E’ uno
che ama delegare…
No, per niente. Non sono un
accentratore. A me piace il lavoro di squadra .
Certo, posso essere considerato un
capobranco…il trascinatore… ma certamente non sono un solista, un
solitario…no, per niente. Mi piace partire, in nave, per una nuova
avventura ma… non da solo.
Mi piace condividere con altri…il mio
viaggio!
Mimmo Cuticchio
Questo aspetto del suo
dire…ammorbidisce la sensazione iniziale che mi ha maldisposto nei
confronti del Maestro Cuticchio che, a primo acchito, mi era sembrato
troppo egocentrico per i miei gusti ed invece…mi appare in tutta la sua
verità di uomo egocentrato ma… generoso verso gli altri.
Maestro, Lei ha respirato, sin da
piccolo, la polvere dei teatrini dei Pupi e questo è avvenuto anche se
suo padre non aveva una tradizione familiare alle spalle…era un
“oprante” di prima generazione, insomma…
Guardi, la famiglia Cuticchio,
proveniente dal Portogallo, ha sempre gravitato nel mondo delle
Ferrovie. Ancora oggi, la maggior parte di loro fa il Capotreno…il
Capostazione….l’impiegato nelle Ferrovie dello Stato….
Anche mio nonno Girolamo, come
me…chiamato u zu Mommo (Girolamo viene, spesso, storpiato in Mimmineddu,
Mimmino…tutti nomi antichi)… anche lui lavorava nel settore ed abitava
in Piazza della Rivoluzione, che un tempo si chiamava Piazza della Fiera
antica…la piazzetta dove arrivò Garibaldi, quando entrò a Palermo, e che
da allora porta questo nome, in ricordo di un avvenimento che segnò
l’inizio della rivoluzione… per l’appunto.
A quel tempo, non c’era il cinema…i
ragazzini non giocavano, come oggi, con bigliardini e videogiochi:
andavano a scuola e lavoravano oppure lavoravano e…basta.
Mio padre, sin da piccolo…dietro
“segnalazione” di mio nonno… andò a lavorare al Teatro dei pupi di Don
Achille Greco ed esattamente con i suoi figli, Alessandro ed
Ermenegildo.
Il suo primo compito serio fu quello
di suonare il piano a cilindro.
Era quello un teatro popolare, nel
senso che ci andavano tutti ma era… un teatro colto, un teatro su cui
viaggiavano i valori universali!
Insomma, per farla breve…mio nonno
provò, prima, a far lavorare mio padre presso un fabbro.
Aveva solo 10 anni, eh? Mio padre ci
lavorò per un breve periodo tanto più che con un altro ragazzino…Ninuzzu,
stessa classe di mio padre…cioè 1917…scoprì che, fondendo il piombo,
poteva realizzare teste di pupi ma poi transitò, e lì rimase tutta la
vita, all’Opera dei pupi.
“La testa – come amava dire sua madre
– l’aveva sempre ai pupi!!!!”
Anche se non ho avuto modo di
conoscerlo Giacomo Cuticchio, intendo, mi pare di intravederlo nei lampi
che illuminano lo sguardo del figlio Mimmo…fieri ed appassionati!
Un giorno, essendosi ammalato il
pianista, Greco chiese a mio padre se se la sentiva di prendere il suo
posto. Mio padre, quando frequentava il teatro non è che si guardava lo
spettacolo tanto per guardarselo. Lo faceva per imparare…e, quindi,
quando fu messo al piano non sbagliò un colpo. Greco lo prese a cuore…e,
così… dai 10 ai 17 anni, nell’anno in cui i Greco si trasferirono a
Roma, mio padre imparò a suonare…salì, persino sulla scena e, nell’arco
di alcuni anni, si sparse la voce a Palermo che c’era sto picciutteddu
che lavorava dai Greco e che era bravo. Molto bravo!
Tutti ne tessevano le lodi a piene
mani. Io, stesso…avendolo osservato da vicino… non posso che tesserne le
lodi. Mio padre era davvero bravo. Molti a Palermo, quando sentivano che
c’era lui, currevano da ogni parte…certi di assistere a duelli epici.
Quando i Greco andarono a Roma, era
il 33 o il 34, Lui non sapeva cosa fare…certo di non voler imparare un
altro mestiere, però, tanto più che i Pupi s’insunnava a notti.
Per farla breve, successe che un
teatrinante, che aveva il teatro qui vicino…ai Cantieri navali,
quartiere Montalbo…decise di venderlo perchè non andava bene. Era poca
la gente che assisteva agli spettacoli.
Bene, mio padre riuscì a comprare il
tutto a rate…500 lire avanti e 500 lire ogni 15 giorni, si disse
inizialmente. Poi, dal momento che ebbe successo da subito, preferì
saldare il tutto prima del tempo previsto.
Quella fu la prima stagione teatrale
che allestì mio padre da solo, in Via Filippo Juvara…a Palermo.
Maestro, ed arriviamo agli anni 50.
Il problema dell’emigrazione, unito all’avvento della televisione,
sottrae spettatori dall’Opera dei Pupi e così suo padre, con moglie e
tre figli a carico, comincia a girare per la Sicilia…
Avverto, dal tono della voce, che
questa immagine che richiama un errare vagabondo non piaccia al Maestro
che, prendendo il respiro…infastidito, comincia a raccontarmi che… nel
42/43 a Palermo…il quartiere Brancaccio, oggi tristemente noto per fatti
di mafia…dove insiste il Castello di Maredolce, per essere più
precisi…allora, dicevo, Brancaccio era una borgata fuori città e dai
primi anni 40 c’era il nuovo Teatrino dei Pupi di suo padre.
Nel 43 mio padre aveva sposato mia
madre, sedicenne già incinta di mia sorella, la più grande di noi. La
città venne bombardata e mio padre fu richiamato alle armi…la sua nave
era ad Augusta.
Ci fu una licenza e venne a Palermo
ma, mentre era in giro a comprare cibo, bombardarono la Ferrovia e mia
madre rimase avvolta da una nuvola di polvere di quello che restava del
teatrino.
Descrive l’immagine alla perfezione,
il Maestro Cuticchio…come se egli stesso ne fosse stato testimone e
riesce a farla rivivere anche ai presenti, come se l’avessimo vista in
presa diretta…
Mio padre, tornato in mezzo a
quell’infernooooooo, trovò mia madre seduta su un muretto ad aspettarlo
e la portò con sé ad Augusta. Certo, di condurla… sulla nave non se ne
parlava ma le trovò alloggio in una grotta, lì vicino. La prima notte,
raccontava mia madre, dovette scappare perchè le cimici le saltavano
dappertutto su quel pagliericcio lasciato, chissà da chi…forse da
qualche pecoraio.
L’indomani arrivò mio padre e bruciò
tutto ciò che era presente in quella grotta in modo da uccidere le
cimici…insomma, questa è un’altra storia che andrebbe raccontata.
Ma comunque, come finiu? Mia madre
stette lì per 15 giorni e mio padre, ogni giorno, le portava il rancio
che riusciva a recuperare, poi un bombardamento su Augusta – durante il
quale venne distrutto quello che veniva usato come aeroporto – e…si
salvi chi può!!!! Scapparono tutti.
I miei ripresero la strada per
Palermo ed anche qui ci sarebbe tanto da raccontare sul periglioso
viaggio verso la città, durante il quale nacque la mia prima sorella,
ma… faremmo notte.
Per farla breve, ritornati a Palermo,
ritrovarono il teatrino, malmesso sì ma in piedi…senza che nessuno, per
rispetto, avesse pensato di rubare niente così come nessuno avrebbe
rubato i ferri ad un fabbro. Insomma, gli strumenti di lavoro non
venivano toccati ed i Pupi ERANO uno strumento di lavoro.
Anzi, siccome c’era la porta mezza
bruciata, quelli del vicinato avevano pensato di applicare delle tavole.
Dopo essere stati un po’ a
Palermo…era un periodo in cui si pensava a ricostruire la città…i
giovani andavano in altri posti…al Nord…in Belgio…con la classica
valigia di cartone, mio padre propose a mia madre di andare via.
“Che facciamo, Pina? Andiamo anche
noi?”
La risposta di mia madre fu negativa
“ Ma sei pazzo? Qui ci corichiamo in mezzo ai Pupi, almeno! Lì dove ti
corichi?”
Ma allora, sua madre era ancor più
innamorata di suo padre dei Pupi…
“Mia madre era giovane…entusiasta.
Per mio padre è stata fondamentale. Anche quando lui aveva pensato di
vendersi i pupi e di aprire una trattoria, lei…che aveva conosciuto in
mio padre il principe azzurro, l’uomo dei suoi sogni…”Ma sì fuodde? Tu
che ti sogni i Pupi anche di notte, Tu ca m’arrispunni come fossi
Orlando…ora tu stesso mi chiedi di aprire un ristorante? Per avere a che
fare con gli ubriaconi? No! Non se ne parla!”
Mio padre era un timido, parlava ed
abbassava gli occhi ma credo che, in fondo, facesse così perchè voleva
che fosse mia madre a decidere in quel senso… senza che lui dovesse
imporre niente.
Palermo era distrutta,
ventrata…dicevo ed i giovani andavano via in cerca di fortuna.
I miei pensarono, allora, di recarsi
dove erano rimasti i vecchi e così, caricati i Pupi su un carretto,
partirono ed iniziarono la loro avventura da “camminanti”.
Mio padre divenne un “oprante
camminante”…quello che oggi viene chiamato “itinerante”.
E qui il Maestro Cuticchio, con una
capacità evocativa senza pari, comincia a descrivere quel mondo che
trova spazio ne “L’uomo delle stelle” del Premio Oscar Peppuccio
Tornatore, un mondo fatto di miseria ma anche di inventiva, di
sacrificio…un mondo che non esiste più.
Ai tempi, “camminanti” erano quelle
persone che andavano in giro per i paesi con su in spalla i
“matapolli”…le stoffe insomma. Compravano scampoli in città, per pochi
spiccioli, e poi li rivendevano nei paesi alle donne che ne facevano o
vestitini per sé o pantaloncini per i picciriddi.
“Camminanti” erano, anche, coloro che
giravano comprando e vendendo capelli.
Si, capelli…ha sentito bene. Non…
cappelli.
Certo, i capelli lunghi avevano più
valore ma anche quelli che rimanevano nelle spazzole, nei pettini non
scherzavano…
Erano anche i tempi, aggiunge, di
quei tizi che andavano in giro con un bastone, alla cui estremità c’era
uno spillo…serviva per raccogliere i mozziconi di sigaretta per farne
trinciato e rivenderlo
Questo dal 43 o giù di lì fino al
1960, circa…lui lo ricorda benissimo.
E continua
Andando per paesi, con il carretto,
veniva individuato il posto dove montare il teatrino e, siccome
l’operazione durava almeno 2 settimane, nel frattempo per creare
aspettativa si poneva un cartello, nella piazza principale, con su
scritto “Prossima apertura”.
D’estate sceglievamo i posti di
montagna, d’inverno…quando c’era il fermo dei pescatori…ci fermavamo nei
posti di mare. Si seguivano le stagioni, la natura…il seminato ed il
raccolto. Quando una stagione teatrale era andata bene e si pensava,
quindi, di tornare in quel dato paese…allora ni purtavamo solo i Pupi
dappresso, lasciando le strutture altrimenti smontavamo tutte cose e
via.
Maestro, mi regala un ricordo…un
profumo di quei “camminamenti”?
Guardi, singolare è che noi figli
siamo nati tutti in un paese diverso…a seconda di dove si era fermato il
teatrino. Noi siamo 7, eh? Ricordo anche di aver seguito la scuola
d’obbligo in vari paesi perchè oggi eravamo qui… domani lì.
Questo fino al 69, eh? La nostra
ultima piazza, prima del rientro a Palermo e dopo esserci fermati in
vari paesi della zona mare…tipo Trabia, Porticello e così via…fu Cefalù.
Lo ricordo benissimo.
Avevo già 20 anni e già alcune volte,
insieme ai miei fratelli, avevo sostituito papà: io ero già aiutante di
scena e recitante.
Maestro, ma questo girovagare
esclusivamente per la Sicilia Occidentale nasceva dal fatto che esisteva
differenza tra la vostra Scuola e quella della Sicilia Orientale o cosa?
No, affatto…allora non si parlava di
differenza: tutto era dettato da ragioni di rispetto. Noi non andavamo
ad invadere il campo dove sapevamo che c’erano altri pupari, loro non
venivano qui. Era una regola non scritta ma… osservata.
Certo, la differenza esisteva ed
esiste. Una differenza di dimensioni tra i Pupi della Scuola Occidentale
e quelli della Scuola Orientale c’era e c’è, tanto per cominciare ma,
allora, era solo il rispetto per il lavoro altrui, per l’altrui
territorio che dettava legge.
Il pubblico era, inoltre, abituato ad
un determinato tipo di spettacolo…diverse dimensioni di Pupi…si… ma
anche diversa recita: insomma ai palermitani non sarebbe piaciuto lo
spettacolo dei Pupi siciliani così com’era quello della Scuola catanese
e viceversa.
I Pupi palermitani erano e sono più
vicini alla marionettistica …a Catania sono più grandi ed articolati.
Ognuno, ripeto, si muoveva nel proprio territorio. La recitazione
palermitana, poi, è più narrata…quella catanese più declamata, recitata
ed anche la struttura del teatrino è diversa.
Ricordo che, avrò avuto 13/14 anni, e
con mio padre ci trovavamo a Macchia di Giarre, in provincia di Catania,
ad un Festival dei Pupi…anzi no, era proprio una Rassegna che metteva in
contrapposizione i due tipi di teatri.
Da una parte quelli della Scuola
catanese, capeggiati dal grande Emanuele Macrì, acese, (ricordo che
c’era anche Pepe di Caltagirone) e dall’altra quelli della Scuola
palermitana con mio padre in testa.
In quell’occasione Macrì portò “La
morte di Orlando”…mio padre “Zuffa infernale tra i maghi Malagiggia e
Tuttofuoco”. Io rimasi affascinato dai Pupi catanesi da subito e pensai
che il nostro, quello palermitano, intendo…fosse un teatro “a passo
ridotto” e quello catanese in “cinemascope”. Ero ragazzo, io. Ricordo
che seguì un dibattito durante il quale un tale evidenziò la supremazia,
secondo lui, dei Pupi catanesi…più grandi e perciò più belli di quelli
palermitani.
Mio padre, giocando fuori casa,
stette zitto ma ricordo che Macrì, anch’egli a buon ragione “Cavaliere”
come mio padre, zittì il tale con forza “Ma senti, secunnu Tia quando
incontri un uomo più piccolo di statura… sicuro ca è megghiu di uno più
ranni? Appoi, senti…Orlando è sempre Orlando…o grande o nico! Chiddu ca
cunta sono i valori che trasmette…la testa che ha!”
Maestro, Lei mi parlava poc’anzi
dell’importanza che ha avuto sua madre nella vita di suo padre e
dell’intera famiglia Cuticchio. So che è morta ormai da due anni, dopo
aver seguito suo padre per ben 86 anni, e mi sovviene quel detto
abusato…ma sempre attuale… che “Dietro un grande uomo ci sta sempre una
grande donna”, mi racconti chi sta dietro a Mimmo Cuticchio…
Lo sguardo del Maestro si illumina di
una luce particolare. Una luce che parla di Amore e di Gratitudine.
Certamente mia moglie Elisa! Lei,
così come fatto da mia madre con mio padre, mi ha sempre…e continua a
farlo…seguito con amore e grande professionalità. Un incontro destinico
il nostro. Le racconto, mi segua.
Era il 1979. Mi trovavo a Sciacca e
venne trovarmi un gruppetto di studenti universitari che aveva in mente
di mettere in scena una commedia che parlava di Pupi e di Pupari, dei
primi del 900 e che era stata scritta da un vecchio pescatore del luogo,
con la passione per la poesia. Questi era Vincenzo Licata…conosciuto,
per l’appunto, come il “poeta pescatore di Sciacca”.
La storia proposta mi
piacque…raccontava di un “oprante” saccense che aveva un proprio
teatrino proprio nella parte bassa dove abitavano i pescatori. Il
protagonista era Don Liberto Canino la cui moglie…giovane e bella…
veniva importunata dal suo aiutante di palcoscenico e che, pertanto, Don
Liberto considerava un grande traditore. Il titolo della commedia era
“Don Turi e Gano di Magonza”.
Accettai, entusiasta, l’invito degli
studenti: lo spettacolo sarebbe stato presentato dalla compagnia
“Teatro13” di Sciacca…
Fu quella l’occasione in cui
incontrai Elisa, mia moglie. Era Lei che avrebbe interpretato…con grande
successo, tra l’altro…la figura della moglie di Don Liberto.
Noi della compagnia “Figli d’arte
Cuticchio” avremmo portato il teatrino, l’avremmo montato ed avremmo
fatto “muovere” i Pupi al momento giusto, quello dell’azione, dentro il
piccolo “boccascena” del palco. Insomma, a recitare avrebbero pensato
loro. Gli studenti, intendo.
Io accettai, ripeto, perchè mi
piacque la storia ed anche l’idea di sperimentare un nuovo modo di fare
teatro, coinvolgendo anche mio fratello Guido e due miei piccoli
allievi, Salvatore ed Enzuccio.
Il risultato? Grande successo, di
pubblico, con il pienone per tutt’e tre le serate preventivate e largo
consenso da parte della critica.
La conoscenza con Elisa non si esaurì
in quell’occasione ma continuò anche a Palermo dove lei frequentava, con
profitto, la Facoltà di Architettura.
Continuammo a vederci dal momento che
lei veniva spesso in teatro a seguire le nostre iniziative, i nostri
spettacoli…appassionata come me di Pupi e di Opera dei Pupi.
E così, piano piano…lei piacque a me,
io a lei e ci innamorammo nonostante gli undici anni di differenza che
intercorrono tra noi!
All’inizio, il padre che – essendo
imbarcato sulle grandi navi – spesso era in giro per il mondo…protestò.
Non concepiva che la figlia potesse frequentare un Puparo ma, poi,
grazie all’intercessione amorevole di Nonna Sabbetta…sua madre, si
convinse e, dopo il nostro matrimonio, trovò in me un altro figlio e mi
seguì, con entusiasmo, nella mia attività…apprezzando i grandi sforzi
che facevo per mantenere viva un’arte così antica. Un po’ come faceva
lui con la pesca!
Elisa, nonostante fosse moglie e
madre di un bambino di pochi mesi, riuscì a laurearsi con il massimo dei
voti. Ho ancora vivo il ricordo di me, seduto in prima fila con Giacomo
tra le braccia, che assisto alla discussione della sua tesi…grande
emozione, grande partecipazione, grande ammirazione!
Quando, poi, fu il momento di
decidere il proprio futuro professionale, Elisa non ebbe dubbi e decise
di darmi una mano nell’organizzazione degli spettacoli per le scuole…per
le svariate iniziative che portavano il nostro Teatro in giro per tutta
Italia e per mezzo mondo in occasione del “Festival de La Macchina dei
sogni”, ad esempio…Mia moglie è stata fondamentale, e continua ad
esserlo, nell’organizzazione di mostre…di rassegne e quant’altro: è
certamente la più brava e preparata organizzatrice delle nostre
iniziative.
Devo dire che, all’inizio, una grande
mano l’ebbe da mia madre…Pina Patti…che l’amò al pari delle sue figlie e
le trasferì la sua esperienza a fianco di mio padre. Le raccontò di come
lo avesse seguito nel suo percorso di “camminante”, di come fosse
riuscita a partorire otto figli dietro le quinte di un teatro, tra i
Pupi, e di come fosse riuscita a tirarli sù sani e forti! Insomma, le
infuse coraggio…
Bene, oggi se il nostro Teatro è
conosciuto e se io riesco a fare spettacoli, sempre più colti…raffinati
e poetici…è, senza tema di smentita, grazie all’impegno intellettuale e
professionale della mia Elisa. Indispensabile…non solamente utile.
Davanti a questa dichiarazione
d’amore, va da sè che una romantica come me…accenni ad un cedimento ma,
riavutami subito…riprendo il discorso laddove l’avevo lasciato.
Mimmo Cuticchio
Maestro, continuando sulla scia dei
ricordi…suo padre ebbe la grande intuizione e merito di sdoganare il
Teatro dei Pupi facendolo uscire dai confini del folklore isolano. Ciò
avvenne in occasione della Sesta edizione del Festival di Spoleto…dove
grandissimo successo ebbe l’Opera dei Pupi. Ci vuole regalare qualche
ricordo di quel momento?
Guardi, io ai quei tempi avevo 15
anni…suonavo il pianino mentre l’aiutante preferito di mio padre era un
tale Arini, bravissimo. Fu una magnifica edizione del Festival che, poi,
negli anni è cresciuto in maniera esponenziale. Bene, tutti i
giornali…in quell’occasione, parlarono del fascino dell’Opera dei pupi e
della grande valenza sociale di questo tipo di teatro.
Pensi che dovevamo rimanere solo
qualche giorno ed invece fummo invitati a restare per tutto il mese di
svolgimento della manifestazione.
Un ricordo indelebile per me anche
perchè segnò il mio debutto come aiutante e per me si aprì, inoltre, una
finestra sul mondo. Un mondo diverso. Non era solo più il teatro dei
Pupi…non era solo più Sicilia per me…conobbi la lirica, la prosa, il
teatro impegnato…varie altre forme di arte…ripeto, mi si aprì un mondo
nuovo. Straordinario!
So che grande attenzione aveste da
personaggi del calibro di Zeffirelli, Visconti…
Come no! Io ero caruso a quei tempi,
sapevo che erano personaggi importanti ma quanto lo fossero…lo capì solo
dopo. Negli anni.
Menotti, ad esempio…iddu amava
mangiare con mio padre “Mi piace stare a tavola con Te…sei autentico,
Tu”. Mio padre era, infatti, spontaneo come tutti i siciliani e questo
piaceva moltissimo.
Cuticchio è un fiume in piena…prodigo
di ricordi di quel Festival e lo fa con un piglio fanciullesco…con gli
occhi pieni delle meraviglia di quel mondo che vedeva per la prima
volta!
Per me fu come leggere
un’enciclopedia quando, al massimo, io liggeva Topolino! Bei tempi! Poi,
venne… Parigi dove non recitammo in teatro ma direttamente
all’Ambasciata italiana dove i giornalisti intervenuti erano direttori
di testata, eh? Presenti anche tutti i Ministri che, volendo, si poteva
fare una seduta di Governo…c’erano tutti, eh? E, poi, cosa dire delle
tante autorità, dell’aristocrazia intervenuta? Anzi, taliassi, Le
racconto un aneddoto divertente:
Mio padre, facendo saltare una
testa…non la indirizzò dove doveva, sotto il palco insomma, ma ai piedi
di una Principessa…e tutti sappiamo che fine ficiru i nobili durante la
Rivoluzione francese! Grandi risate e grandi titoli sui giornali
dell’epoca!
Maestro grande successo anche perchè
raccontavate le gesta dei Paladini di Francia nella loro Patria o no?
Ma no…non gliene fregava niente, mi
creda. Il mondo della cavalleria già non aveva più senso. Poi, oggi…
Basta andare su un autobus e vedere cosa succede!
Valori anacronistici, dice?
Guardi, a me non interessa. Neppure
dovrei rispondere a ‘sta domanda. E’ la sua mancanza di conoscenza che
le fa fare ‘sta dumanna…
Se non fosse che ormai il Maestro
Cuticchio mi ha conquistato e che mi senta legata indissolubilmente a
quello sguardo senza fondo…mi alzerei e toglierei il disturbo ma seguito
ad ascoltarlo ammirata e certa che, da quell’incontro, ne uscirò diversa
e migliore.
Guardi anche in Indonesia, una volta,
titolarono “I Pupi di Cuticchio vengono a fare le Crociate…” come se
fosse stato quello il momento giusto, tra le bombe, per andare a fare le
Crociate! Ca quali…Ho dovuto spiegare, in Conferenza stampa, che quello
che portiamo in giro non è uno spettacolo politico ma culturale,
storico…E’ arte, come la pittura…la scultura. E’ una lezione vivente
della memoria. E’ epica…punto e basta!
Maestro, la mia non voleva essere una
sottolineatura polemica, mi creda…
Ma no…sempre con ‘sta storia dei
valori…finiamola. L’Opera dei Pupi è un fatto storico e culturale.
Insomma, il nostro non è un teatro politico. E’ un fatto culturale…punto
e basta!
Il tono di voce…lo sguardo ancora più
penetrante, severo, mi dice che è il caso di una ritirata onorevole,
pena una fine da Opera dei Pupi…ne sono certa!
Chiarito il suo punto di vista, che
gli vieta di considera l’Opera dei Pupi portatrice, esclusiva, di
valori..il viso del Maestro si rilassa ed anche il tono di voce cambia
registro…si fa più morbido e conciliante così che io possa continuare
nella mia intervista…
E quindi…come arriviamo ai giorni
nostri?
Ora, dopo i tanti episodi simili che
sono successi in Marocco, in Egitto ed in vari teatri di guerra…dove a
due passi da noi…scoppiavano bombe…ho deciso di cambiare il mio modo di
fare teatro. Ho pensato che fosse ora di farlo! Ma questo più di 10 anni
fa, eh? Io non porto in scena più le lotte tra saraceni e
cristiani…proprio per evitare strumentalizzazioni…fraintendimenti. Ad
esempio ora, quando racconto dell’Orlando…tralascio le parti di
battaglie e quant’altro…insomma quelle parti da Orlando “furioso”… e mi
concentro su quelle più romantiche…oppure su quelle “meravigliose” tipo
l’arrivo di Astolfo sulla luna oppure ancora la lotta contro i giganti
prepotenti che rapiscono le fanciulle o i deboli…Ho cambiato registro,
insomma.
Neppure a me interessano più le
chansons des gestes…non ho più manco il pubblico tradizionale! A chi
dovrei convincere…educare?
Quando lei torna sui valori
universali…si vede che non ha seguito i miei spettacoli degli ultimi
vent’anni (questa sarà l’ultima stoccata del Maestro…per fortuna!!!!)…io
lavoro ad esempio sul femminicidio…parola oggi tanto usata ma quando, 18
anni fa, feci “Carlo Gesualdo, principe di Venosa”…nessuno ne parlava
ancora!
Quindi, possiamo definire il suo… un
teatro di denuncia?
Certo…di denuncia. Un teatro a sfondo
sociale, politico si ma non nel senso tradizionale…insomma, io non alzo
bandiere!
Il penultimo spettacolo, ad esempio,
è “Aladino di tutti colori”…una favola tratta da “Le mille ed una notte”
nata dalla constatazione che, andando nelle scuole, mi trovavo sempre
tra bambini dalle facce di vari colori…e volevo che ‘sti bambini, che
vivono qui, non tornassero a casa dicendo
“Ci ha parlato di Madonne, crocefissi
e blabla” e così ho raccontato loro di Aladino che viene
dall’Oriente…che proviene dalle loro parti…dove non ci sono lotte per la
Fede, ad esempio. Aladino, come sappiamo, è un bambino puro di cuore e
si trova a combattere con il mago cattivo sempre pronto ad approfittare
della sua ingenuità.
Una favola che inneggia ai diritti
del bambino, del fanciullo!
Diritti…di questo parlo oggi, io!
L’ultimo spettacolo, ad esempio,
verte sulla figura di Garibaldi…e mi mostra i vari Pupi che
rappresentano l’Eroe dei due mondi…Bixio…Vittorio Emanuele…e tutti gli
altri che animano lo spettacolo e che sono testimoni muti della nostra
chiacchierata…insieme a decine di altre facce, appartenenti a spettacoli
differenti.
Vede, io racconto la Storia… cosa ca
manco più si racconta nelle scuole. Racconto la Storia dell’Unità
d’Italia dalla partenza di Quarto: è un’operazione storico-didattica, la
mia…completa di luoghi, date…nomi e quant’altro.
E, quindi, per concludere: la mia
Opera dei Pupi oggi è questa…è contemporanea, non m’interessa più quella
di una volta.
Per mantenere viva la tradizione, c’è
mio figlio Giacomo…32 anni…figlio d’arte autentico, cresciuto come me in
mezzo ai Pupi.
Lui… vedendo che io mi allontanavo da
quel mondo…museale quasi…affascinante quanto vuoi ma sempre museo
è…ecco, Lui prova a resistere.
Il mio teatro è ora ad un più ampio
respiro…curo molto la scenografia anche perchè, ora, frequento i grandi
teatri e non posso proporre piccole scene…non funzionerebbero.
Mio figlio, invece, maestro di
pianoforte, compositore ecc. , visto che io sono portato per
l’innovazione, ha deciso di portare avanti la tradizione dell’Opera dei
Pupi classica…quella che era di suo nonno Giacomo….di cui porta
orgogliosamente il nome.
Io gli do consigli, idee…a volte
salgo in scena con Lui…ma nient’altro. Fa tutto Lui.
Io, ormai, cammino su ‘sto doppio
binario nel fare teatro…io mi occupo ormai di problemi che guardo con
gli occhi…in presa diretta.
Maestro, da quello che
vediamo…l’Opera dei Pupi gode di ottima salute, basti pensare che è
stata riconosciuta bene immateriale ed orale dall’Unesco, ma secondo lei
qual è il suo futuro? E’ nell’innovazione che porta avanti lei o nella
tradizione che difende, a denti stretti, suo figlio Giacomo?
E’ nella mia lotta per far
sopravvivere la mia passione… i miei sogni…ma è anche nell’apertura dei
giovani che, oggi, sono più sensibili e curiosi.
Io vedo messi bene i giovani d’oggi,
sa? Ho fiducia in loro. Facendo un passo indietro, invece, vedo qualche
generazione che ha disatteso il suo compito ed ha creato quel gap che
oggi invece le nuove generazioni cercano di recuperare.
Ed io sono qui per
aiutarli…nell’ottica dell’innovazione.
L’Opera dei Pupi che, un tempo, è
stato considerato un mondo perduto a causa dell’avvento della
televisione…del cinema…è oggi, grazie all’innovazione, più viva che
mai…per questo io riempio il mio teatro di più gente di quanto ne possa
contenere.
Sento che sono sulla strada giusta!
La gente che viene qui…viene perchè sa che Cuticchio fa l’Opera dei Pupi
che ha imparato dal padre ma sa anche… che è andato oltre. Si, quindi,
alla tradizione ma soprattutto…sì all’ innovazione.
In tutta Europa sono riconosciuto
come l’innovatore dell’Opera dei Pupi…e mi pare che Lei, in tal senso,
sia venuta sufficientemente preparata oggi. Gliene do atto mentre spesso
si viene qui, ancora, con domande tipo “Signor Cuticchio, ma suo padre
faceva il puparo?”…insomma, oggi siamo riusciti ad articolare. Le do
merito della cosa. Ha dimostrato umiltà e curiosità di sapere. Brava!
Incasso il complimento, non credendo
alle mie orecchie e continuo.
Maestro…di Lei, Ferdinando Taviani ha
detto, tra le altre cose, “Cuticchio non è un baule di Beni Culturali, è
un bene culturale vivente”. Bellissima ma anche impegnativa come
definizione…no? Come la vive? Più onore o onere?
Ma guardi. Cuticchio non è colui che
continua…Cuticchio è colui che ha iniziato. E’ diverso. Guardi, se le
facessi leggere i tanti ritagli di giornale di quando avevo 25/26/27
anni, tutti a dire “L’ultimo puparo…l’ultimo puparo!” Ma u vuliti
finire? Io sono il primo di una nuova generazione…basta con ‘sta
camurria!
Ora,poi, c’è un piccolo vivaio e la
tradizione continua…a braccetto con l’innovazione.
Maestro, di recente, la Fondazione
del Banco di Sicilia…per volontà del suo Presidente Gianni Puglisi, tra
l’altro referente UNESCO Italia, ha acquistato la collezione dei Pupi
della sua famiglia, dandole un’ottima collocazione tra i suggestivi
spazi lignei dell’Ex Monte dei Pegni Santa Rosalia sito a Palazzo
Branciforti…un’ ulteriore dimostrazione di interesse per questo
particolare ed antico teatro di figura che unisce semplicità della
comunicazione con la complessa lavorazione artigianale…
Guardi, mia mamma è morta due anni
fa, ad aprile. Finchè padre e madre sunu vivi, fanno in modo di
mantenere le radici della famiglia ben solide. Poi, di 7 figli che siamo
solo due siamo interessati…gli altri 5 fanno altro.
Non essendo una famiglia ricca,
quello che rimaneva di valore erano i Pupi…io non avevo interesse ad
acquistarli dal momento che ho i miei (trecento tradizionali, che vanno
dall’800 ai giorni nostri, più 400 che ho creato, dal 73 in poi, per i
miei nuovi spettacoli) quindi, se lei dovesse fare un giro a casa mia,
troverebbe Pupi appizzati dappertutto… anche sutta u letto ed in cucina,
persino!
Ride di gusto, il Maestro Cuticchio
ed io con lui…la tensione, che mi ha accompagnata per tutta la durata
dell’intervista, sparisce del tutto…lasciando spazio ad una sana e calda
complicità.
Sono talmente tanti che abbiamo
pensato di lasciarne qualcuno qui, nel laboratorio, a prendere aria così
che i ragazzi, prima di accedere a teatro, possano vederli…sentire la
loro storia dalla nostra viva voce. Qui, abbiamo creato una sorta di
sala espositiva, sempre in movimento.
Tornando alla questione della vendita
della collezione storica dei Pupi della famiglia Cuticchio:
Chi diceva…”Dividiamoli”…Chi
“Vendiamoli”. Io e mio fratello non eravamo d’accordo…però io, siccome
guardo avanti non con i paraocchi…ho pensato”Noi ci semu! Ma quanto
putemu campari? E quando io moro…i Pupi che fine faranno?”
Un patrimonio che si sarebbe
disperso, non c’è dubbio. Magari… non nel corso di questa generazione,
ma alla prossima…alla prossima ancora, certamente.
Da qui, l’idea di venderli in blocco
ma non ad un Museo statico…volevo qualcosa di diverso per i miei Pupi,
qualcosa di vivo. Come loro!
Mi sarebbe piaciuto, anche in onore
alla memoria di mio padre, che adorava quella città…che andassero a
dimora a Parigi. Lì c’è un palazzetto dove sono conservati
personaggi…capolavori del teatro di figura. Un posto magnifico, una
sorta di fortezza. Il neo? Che le collezioni sono appannaggio solo degli
studiosi…insomma non sono fruibili al pubblico e ‘sta cosa non mi
piacque.
Ci fecero un’ottima offerta ma io
prendevo tempo finchè un bel giorno mi trovai a parlare con Puglisi,
Presidente Unesco d’Italia… che ebbe l’idea di ridare nuova vita all’Ex
Monte di Pietà, come diceva Lei. Uno spazio magnifico, suggestivo ma
carente di un tesoro…vuoto, insomma. Si propose di acquistare la
collezione e voilà…per un prezzo equo per i tempi ca currunu, abbiamo
venduto la collezione di Pupi.
Lì ho sistemati, io stesso, in metà
dell’intero spazio espositivo. Il progetto, però, non è ultimato…quello
delle luci è “work in progress” perchè attendiamo lo “sta bene” della
Soprintendenza. Al momento i miei Pupi sono un po’ al buio ma quando
tutto sarà ultimato, quella che li illuminerà sarà la luce della mia
infanzia…quella suggestiva dei lumi a petrolio.Voglio che la luce sia
quella. Quella mostra è un racconto della mia infanzia, della mia
famiglia, della mia vita con i Pupi!
E mentre, una smorfia impercettibile
del viso, mi dice che il Maestro…così sicuro di sé…abbia toccato un
tasto che gli ha fatto vibrare le corde più profonde dell’anima…mi avvio
a concludere l’intervista con l’ultima domanda.
Maestro, siamo in chiusura…un Pupo è
qualcosa di diverso, e più complesso, di una marionetta. Il grande
Pirandello ne “Il berretto a sonagli” fa dire al protagonista “Pupi
siamo. Lo spirito divino entra in noi e si fa pupo. Pupo io, pupo Lei,
pupi tutti!”…
Tra tutti i pupi ai quali ha dato
vita, a quale si sente più vicino? Quale si avvicina di più al suo…
spirito divino?
Guardi, la grandezza di mio padre
consisteva nel fatto che non parteggiava, sul palco, per nessuno dei
suoi Pupi…non era né pubblico accusatore né avvocato difensore.
E così, anche io! Sono Gano di
Magonza, il traditore… ma anche Orlando, l’onesto o, ancora… il ribelle
Rinaldo….a seconda dei casi. Sul palco non parteggio per nessuno. E’
giusto così…ogni personaggio è a sé…ha una sua dignità, un suo perchè!
Poi di nascosto, certo…ho le mie
preferenze. Ad esempio, ai Pupi seriosi….che sono la maggior
parte…preferisco quelli spiritosi come Astolfo o il saraceno Ferraù ma,
ripeto, è una debolezza per loro che non porto sul palcoscenico. E’
giusto che sia così, Giacomo Cuticchio…mio padre docet!
Ed ora mi faccia tornare a
travagghiari…
A fine intervista, anche Miele…che
per tutto il tempo…ha elemosinato carezze ed attenzioni, si acquieta ed
io e Salvo, dopo aver salutato grati, rifacciamo a ritroso Via Bara
all’Olivella e, come ci succede sempre dopo un’intervista che ci ha
fatto crescere culturalmente ed umanamente, non diciamo nulla, coscienti
del privilegio vissuto.
Il silenzio, in casi come questo,
dice più di mille parole.
Il silenzio, in questo caso, è
d’obbligo…grazie, Maestro Cuticchio e ad majora semper!
Silvia Ventimiglia, lì 9 marzo 2016
http://blog.siciliansecrets.it/2016/03/09/a-tu-per-tu-con-mimmo-cuticchio-oprante-puparo-cuntista/


|
“Rossa e' Donn'
angilu!"
espressione dialettale dove
'rossa e' una forma contratta per grossa". L'intera frase si puo'
rendere in Italiano con la locuzione: "Senti amico, con chi credi
di avere a che fare forse con un gonzo?, L' hai sparata troppo
grossa e lo sai!".
Occhiate da cinque chili come
quelle che dici di aver pescato non ne esistono in nessun posto al
mondo men che mai nel nostro mare mangiato! Non esistono 'neppure
nel mondo di Quark. La foto che mi hai fatto vedere l'hai rubata su
internet.
Cosa c' entra tutto con questo con
Donn' Angilu? Don Angelo Rapisarda fu il più famoso puparo di
Catania nel secondo dopoguerra. Aveva il suo teatrino in via
Plebiscito vicino al Fortino.In quei tempi grami quando i cinema
popolari che avevano avuto un momento di fortuna durante il fascismo
ai tempi dei filmati sul duce dell' Istituto Luce e del filone dei
telefoni bianchi,tipo Amedeo Nazzari. Quando qualche ragazzotto che
importunava gli spettatori veniva richiamato a suon di ceffoni dalla
milizia volontaria fascista presente nel cinena. Ebbene nel
dopoguerra i cinema languiivano per mancanza di pubblico e cio'
perche' non c' erano soldi disponibili per lussi come appunto il
cinema. Allora, ragazzotti e padri di famiglia la domenica
pomeriggio affollavano il teatrino dei pupi di Don Angelo Rapisarda
che costava meno del cinema, calia nuciddi e semenza a parte, anche
se le donne per ovvi motivi non potevano mettervi piede: alla prima
parola di troppo che venisse loro rivolta altro che ceffoni!,
sarebbero volati i coltelli. Comunque non accadeva nulla di tutto
questo e gli spettatori ridevano a crepapelle. Infatti le parole di
troppo poteva dirle solo don Angelo.
Appena il sipario si alzava e si
mostravano i pupi dei paladini e dei saracini c'era sempre qualche
intoppo e donn' Angelo faceva ai suoi collaboratori: cunnuti ca siti
tutti pari vi fazzu lanciari e mi farciti fari sta gran mala
cumparsata mi .u lazzu do brazzu di Orlandu s' incudduriau cu
chiddu do pedi e ora stu cunnutu di Orlandu paladinu mancu si movi
n'avanti o arreri.o circatimi n' pezzu di spagu ca l' haiu a
birsari annunca stasira non si mancia e a genti ni pigghia a
Afrisca e pìrita che sono le ben note pernacchie. Appena effettuata
alla melio la riparazione del pupo Don Angilu faceva: " U Paladinu
Orlandu tantu era stancu di camminari suttal' armatura di ferru e
lu suli ca u faceva vugghiri comu un pisci nta na pignata ca s'
addumisciu sutta n' arvuru. Annunca comu 'ntisi u sgrusciu de
tambura saracini ca attaccavvunu u campu cristianu acchianau a
cavaddu, pigghiau la Durlidana e s'allanzau n'contru alli turchi
niuri comu diavuli e Cun sulu colpu tagggiau tricentu testi di
mammalucchi. Al che il pubblico ridendo faceva: " Rossa e' Don
angilu! Calamu" Troppo grossa e' Don Angilu abbassiamo! E Don
Angelo poi: " Annunca Orlando cu'n sulu colpu tagghiau trenta testi
di saracini.
E il pubblico: "Ancora rossa e',
cala ancora" e donn' Angilu "Anunca Orlamdu cu' un sulu colpu di
Durlindana tagghiau tri testi di saracini. "Ancora Rossa e' Don'
Angilu calamu ancora e Don Angelo a quel punto u sapìti chi fazzu
scinnu di ca supra cu la Durlindana e Cun colpu sulu vi tagghiu i
vostri coppuliddri di.. e stasira ci dugnu a manciari ai iattareddi
ca stanno murennu di fami e così finiva la serata alcuna testa
tagliata.
by Giuseppe Vazzana.

|
I
SAVIA
Città golosa e raffinata nei gusti, Catania non può certo
ignorare una così importante ricorrenza: la Pasticceria Savia incarna
i fasti della dolcezza tra cannoli invitanti e cassate variopinte, tra
frutta mandorlata e l'esplosione di colori del marzapane
caleidoscopico.
 Com'è
consuetudine cittadina, da ormai un secolo, dal caffè all'aperitivo,
dall'arancina al pasticcino, a seconda dell'ora e degli impegni, Savia
è la meta preferita da giovani e da eleganti signore, ragazzine e
nonni, commendatori azzimati, impiegati e commesse frettolose nel
break lavorativo di mezzogiorno. Com'è
consuetudine cittadina, da ormai un secolo, dal caffè all'aperitivo,
dall'arancina al pasticcino, a seconda dell'ora e degli impegni, Savia
è la meta preferita da giovani e da eleganti signore, ragazzine e
nonni, commendatori azzimati, impiegati e commesse frettolose nel
break lavorativo di mezzogiorno.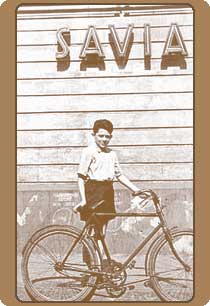
Arrivano
da ogni parte per gustare, vedere e farsi vedere, per lasciarsi
tentare da un bocconcino dolce o da un assaggino salato mischiandosi
in un insieme veramente festoso.Si può sicuramente dire, senza falsa
modestia, che Savia è, ed è sempre stata, la "Vetrina dei
Catanesi".
Per
i pochi che non lo sapessero, la pasticceria Savia si trova
incastonata ad angolo tra la Via Etnea e la via Umberto, di fronte la
Villa Bellini; fu fondata nel 1897 dai coniugi
Angelo ed Elisabetta
Savia
in quella zona periferica anticamente denominata Piano Nicosia.
Da li mosse i primi passi, accrebbe la  sua
esperienza, maturò il suo mestiere grazie all'intuito e alla sagacia
di Alfio e Carmelina Savia, trovò degna sistemazione nel cuore della
città, proprio in quella via Etnea che Federico De Roberto aveva
battezzato col nome prestigioso di "Salotto di Catania". sua
esperienza, maturò il suo mestiere grazie all'intuito e alla sagacia
di Alfio e Carmelina Savia, trovò degna sistemazione nel cuore della
città, proprio in quella via Etnea che Federico De Roberto aveva
battezzato col nome prestigioso di "Salotto di Catania".
In
quell'illustre angolo si perpetua grazie ad
Angelo Savia, la
tradizione dolciaria che trova il suo punto forte forte nell'acquisto
di materie prime di eccelsa qualità, nella magistrale
professionalità del suo personale, nella confezione dei prodotti
sempre fragranti e, se questo non bastasse, nella proverbiale cortesia
con la quale questi ultimi vengono offerti alla gentile clientela.
Forte
di questi capisaldi Savia inizia un nuovo capitolo della sua storia:
da oggi, grazie ai nipoti
Alessandro e Claudio, si presenta al gentile
pubblico in una veste completamente rinnovata; ma con una ferma
convinzione che l'impegno e la dedizione all'affezionata clientela
sarà sempre permeata sull' "Antico" spirito che ha
contribuito a fare di Savia "la Pasticceria" per antonomasia
(da Savia.it).

GLI
SVIZZERI A CATANIA
Gli
svizzeri Alessandro Caviezel e Ulrico Greuter
giunsero a
Catania nei primi del '900, dove aiutati economicamente dalla ditta
Fratelli Caflish, fondarono la Pasticceria Svizzera "A.
Caviezel & C." con sede in via Etnea.
Dopo
le prime difficoltà, comincio la espansione della produzione
svizzero-tedesco-austriaca ad opera di valenti pasticceri provenienti
da quelle nazioni. La
sede di via Etnea fu restaurata nel 1949 diventando punto di ritrovo
della migliore società catanese.
Ceralacca
rossa su un foglio bianco, una scritta sfumata a confondere un ricordo
d'infanzia... un'immagine, incontrata per caso, a stimolare un
riflesso di sapori e di ricordi lontani... vaghe sagome di un passato
che solo in parte mi appartiene tornato così a ricomporsi, come per
magia...
....l'albero
di Natale, sotto, una cesta colma di doni ... una scatola trasparente
profanata dalle mani di un bambino dentro cui compare una scritta
ancora poco leggibile: "cotognata"Caviezel"...
Mio
padre, ancora giovane, zii lontani, borselli in mano, maggiolini e
fiat 127 circolano per le strade di una città, di campagna, di paste
prese da Caviezel...
La
tv in bianco e nero, il volto di Mina, ancora reale, le sue canzoni,
...il campanile del borgo a ripassare le ore, lente e infinite ...e ti
accorgi che forse basta poco per colorare di ricordi l'infanzia fugace
ed effimera come tutte le cose destinate a cambiare o a sparire...
...così cambiò il volto di una città nobile, a diventare grigia,
violenta deserta...
...così
cambiarono le abitudini, fatte di fughe da un centro invivibile,
...così cambiarono i gusti ancora accecati da un ricordo stordito
dalla nostalgia per un epoca bella e confusa......così sparì
Caviezel...un giorno la città si sveglia torna il sole dopo una lunga
notte buia.
Timidi
ricordi fanno capolino e trovano spazi in angoli nuovi ed antichi che
mutano in progressive certezze......"è vero Catania vive"
par di sentire dire ai residui passeggeri già adulti all'epoca dei
miei ricordi d'infanzia, ...spazzati i resti grigi di anni bui e
deserti, l'orgoglio di chi ama la nostra città torna prepotente a
farla rivivere......infine una scatola trasparente a custodire il
profumo delle cotogne di Sicilia, ...un foglio di carta con la
ceralacca rossa,
...il
miracolo di un ricordo che si fa presente... ...odori, sapori unici,
l'insegna più nobile di una città che opera torna
a
brillare nel cuore dei catanesi... ...e sembra dire ...ben tornati a
Catania...ben tornato Caviezel...
Marcello
Gulisano 31/10/1998 (da caviezel.it)
da
Lucacaviezel.com
Ho
curato per oltre quarant'anni il settore produttivo della nostra
Pasticceria Svizzera, A.Caviezel & C. in Catania che contava nei
momenti di maggiore fioritura in laboratorio oltre 70 fra pasticcieri
e aiutanti. Tutta l'azienda, composta da tre pasticcerie ed un
ristorante, contava oltre 200 collaboratori.
Insegno
da oltre 30 anni nel settore della gelateria avendo iniziato
l'attività con Corsi professionali per gelatieri al Politecnico del
Commercio di Milano dove ho introdotto per la prima volta in Italia
per gelatieri artigiani la tecnica della formulazione delle ricette
attraverso il bilanciamento degli ingredienti.
Da
allora mi dedico alla formazione professionale per inizianti ed
all'aggiornamento continuo per gelatieri avanzati.
Ho
collaborato alla costituzione della Scuola Europea del Gelato presso
il CAPAC in Milano alla quale presto il mio contributo in qualità di
esperto. Insegno anche presso CAST ALIMENTI, sede della Accademia dei
Maestri Pasticcieri Italiani in Brescia, dove si svolgono in
particolare Corsi di specializzazione per pasticcieri e gelatieri
avanzati in occasione dei quali vengono rilasciati i Diplomi Master.
Dedico il mio tempo disponibile alla conduzione di brevi Corsi di
formazione, di aggiornamento e di specializzazione per gelatieri sia
in Italia che all'estero.
Collaboro
da anni con varie riviste del settore come "Il Gelato
Artigianale", "Pasticceria Internazionale" e "Bar
Giornale" e ho pubblicato due testi di base su "Scienza e
Tecnologia del Gelato Artigianale " e "Scienza e Tecnologia
del Semifreddo Artigianale", pubblicati da Chiriotti Editore di
Pinerolo.
Mi
sono stati assegnati numerosi premi e riconoscimenti tra i quali uno
dei primi "CONO D'ORO" dal Comitato Nazionale dei Gelatieri
Italiani, una MEDAGLIA D'ORO dalla Accademia dei Maestri Pasticcieri
Italiani quale "Riconoscimento per avere comunicato ed insegnato
l'arte del gelato artigianale in Italia e nel Mondo" ed una
MEDAGLIA D'ORO dalla Accademia della Gelateria Italiana e dalla
rivista Gelato Artigianale per "l'opera di didattica e diffusione
della cultura del gelato artigianale profusa nella crescita
professionale dei colleghi".
Ho
collaborato con l'Istituto della Enciclopedia Treccani in Roma per la
ricerca e la stesura di documentazione relativa alla storia del
gelato.

SPINELLA
L'
Azienda fu fondata negli anni trenta dal maestro pasticciere Gaetano
Spinella,
che volle allocarla nel "salotto buono" di Catania in via
Etnea, 300 di fronte al giardino Bellini.
La
maestria del fondatore, rispettoso dei canoni della migliore
tradizione dolciaria siciliana, ne determinò un immediato successo.
Dal
1996 la società "Pasticcerie Siciliane Riunite" ha rilevato
l'Azienda, introducendo nella gestione moderni criteri manageriali che
si sono integrati ai sapienti insegnamenti del fondatore.

CAV. CONDORELLI,
E' STATO UN PIACERE
A
Belpasso, suo paese natale, il cavaliere del lavoro Francesco Condorelli
rappresentava una istituzione, cosi come la sua industria dolciaria, che proprio
lo scorso anno ha festeggiato trenta anni di attività e di successi, derivati,
in rnassima parte, dai torroncini commercializzati in tutto il mondo.
La
notizia della scomparsa di
Francesco Condorelli, ha offerto l'occasione per scoprire un
personaggio che con i suoi 91 anni di esistenza pienamente vissuta, ha
contrassegnato una pagina positiva dell'imprenditorialità siciliana sin da
quando, ventunenne, nel 1933, divenne proprietario della pasticceria di Borrello.
Spirito
irrequieto e curioso, Condorelli conobbe anche l'esperienza dell'emigrazione.
Per un breve periodo della sua vita, su sollecitazione di un conoscente, decise
di trasferirsi in Istria e nel 1939 giunse a Pola. L’avventura istriana fu
breve, cosi come quella che lo portò, dopo la guerra, a Malta. Tornato
definitivamente in Sicilia, nonostante fosse provato dai combattirnenti e dalla
prigionia patita, mostrò tutta la sua tempra e si fece protagonista della
locale vita imprenditoriale. La sua pasticceria cominciò ad essere frequentata
dalle numerose comitive di gitanti che passavano da Belpasso, per salire a fare
escursioni sull'Etna. Con le sue granite Francesco Condorelli fece ancora più dolci gli
anni della- dolcevita- come rivelano le foto che lo ritraggono, sempre
elegantissimo e sorridente, accanto ai personaggi famosi dell'epoca, spesso
appartenenti al mondo dello spettacolo. Aneddoti, racconti, episodi e ricordi
biografici furono raccolti dal Condorelli in un volume di ricordi, "La mia
vita", pubblicato recentemente da Maimone. Nelle pagine autobiografiche,
con la memoria prodigiosa che lo contraddistingueva, il cavaliere ci permette di
entrare nel suo mondo più intime, in quello dei suoi affetti, ma anche nella
vita sociale ed economica della provincia etnea. Significativi, per i dettagli e
gli spunti di riflessione, le pagine che egli dedica agli anni del boom
economico, quando la vita della zona etnea, pur tra gli alti e bassi dovuti alle
difficoltà del la ripesa post bellica, fece di Catania la Milano del Sud. "La mia
vita", pubblicato recentemente da Maimone. Nelle pagine autobiografiche,
con la memoria prodigiosa che lo contraddistingueva, il cavaliere ci permette di
entrare nel suo mondo più intime, in quello dei suoi affetti, ma anche nella
vita sociale ed economica della provincia etnea. Significativi, per i dettagli e
gli spunti di riflessione, le pagine che egli dedica agli anni del boom
economico, quando la vita della zona etnea, pur tra gli alti e bassi dovuti alle
difficoltà del la ripesa post bellica, fece di Catania la Milano del Sud.
A
questo processo di sviluppo contribuii anche l'attività imprenditoriale di
Condorelli. Ma il vero salto di qualità egli lo fece  negli anni Settanta,
quando inventò un prodotto - il torrone morbido monodose con glassa - che ha
conquistato il mercato mondiale per la stia bontà e per merito di una abile
campagna pubblicitaria, affidata a personaggi siciliani che hanno avuto successo
nel mondo dello spettacolo. 1 messaggi promozionali e innovativi - celebre gli
spot con i Re Magi - identificano immediatamente ed efficacemente i "Torroncini
CondorelIi". Ma forse non tutti sanno che l'ìdea del morbido monodose
maturò in seguito ad una cena in casa di una vedova a Venaria Reale in
provincia di Torino. Quella sera il dolce era proprio una stecca di torrone che
venne rotto con un grosso coltello in parti disegnali. A Condorelli, che era
l'ospite, fu dato il pezzo più grosso e questo non gli sembrò giusto, per non
parlare dei problemi di masticazione che, a causa della durezza, creava
soprattutto alle persone anziane Gli balenò l'idea di un torrone morbido, dal
gusto delicato, incartato in porzioni singole. E da qui anche il salto di
qualità perché il marchio Condorelli divenne presto sinonimo di torroncino.
Oggi nell'industria dolciaria Condorelli si trasformano ogni giorno settemila
chili di mandorle per confezionare 15 mila chili di torrone morbido ricoperto in
sette glasse diverse, L'industria dà lavoro a 54 dipendenti fissi, a 66
stagionali e a 96 agenti, che coprono tutto il territorio nazionale. Sono cifre
imponenti e - siamo certi - destinate ad accrescersi con la istituzione della
Fondazione, nata per ricordare uno dei più importanti imprenditori siciliani
nel settore dolciario. negli anni Settanta,
quando inventò un prodotto - il torrone morbido monodose con glassa - che ha
conquistato il mercato mondiale per la stia bontà e per merito di una abile
campagna pubblicitaria, affidata a personaggi siciliani che hanno avuto successo
nel mondo dello spettacolo. 1 messaggi promozionali e innovativi - celebre gli
spot con i Re Magi - identificano immediatamente ed efficacemente i "Torroncini
CondorelIi". Ma forse non tutti sanno che l'ìdea del morbido monodose
maturò in seguito ad una cena in casa di una vedova a Venaria Reale in
provincia di Torino. Quella sera il dolce era proprio una stecca di torrone che
venne rotto con un grosso coltello in parti disegnali. A Condorelli, che era
l'ospite, fu dato il pezzo più grosso e questo non gli sembrò giusto, per non
parlare dei problemi di masticazione che, a causa della durezza, creava
soprattutto alle persone anziane Gli balenò l'idea di un torrone morbido, dal
gusto delicato, incartato in porzioni singole. E da qui anche il salto di
qualità perché il marchio Condorelli divenne presto sinonimo di torroncino.
Oggi nell'industria dolciaria Condorelli si trasformano ogni giorno settemila
chili di mandorle per confezionare 15 mila chili di torrone morbido ricoperto in
sette glasse diverse, L'industria dà lavoro a 54 dipendenti fissi, a 66
stagionali e a 96 agenti, che coprono tutto il territorio nazionale. Sono cifre
imponenti e - siamo certi - destinate ad accrescersi con la istituzione della
Fondazione, nata per ricordare uno dei più importanti imprenditori siciliani
nel settore dolciario.

|
A mastra
Quando non esisteva ancora le
scuole materne, le mamme che doveva andare a lavorare fuori di casa
o che semplicemente volevano fare le faccende con più tranquillità,
portavano i loro figli, che non erano in età scolare, dalla mastra,
una donna che per qualche soldo li teneva in casa propria e li
accudiva dalle otto di mattina alle quattro del pomeriggio.
La donna aveva anche il compito
di insegnare ai bambini più grandicelli i primi elementi della
scrittura, come le aste, le vocali e le consonanti, e della lettura.
Una delle tante donne che
esercita a Catania la professione di mastra abitava in un quartiere
chiamato u locu posto tra le attuali vie Scaldara, Viadotto e
Bonfiglio, a ridosso della stazione Acquicella.
Nella zona, una volta, non erano
state costruite molte case e gran parte del territorio era allo
stato naturale: vi erano soltanto alcuni alberi e dei filari di
piante di fichidindia; un enorme fossato, profondo quasi sei metri,
era la caratteristica principale del quartiere; in esso ristagnava
l'acqua piovana e spesso veniva usato come discarica dei rifiuti
dalla gente che abitava nei dintorni.
Poco distante da questo logo
sorgeva uno stabilimento dove si raffinava e si confezionava la
liquirizia; a volte si potevano vedere, proprio nel bordo del
fossato, delle donne che sbucciavano le radici della liquirizia e
che le tagliuzzavano in piccoli pezzi, per poi sistemarle sopra dei
sacchi e farle asciugare al sole. Nella casa della mastra c'era
un'ampia stanza, con il pavimento di cotto di terracotta e con le
pareti bianche, dove di solito stavano i bambini; questa stanza dava
su un cortile interno dove erano sistemati gli impianti igienici: u
cantru (vaso da notte), a pila (vasca in muratura usata per lavare i
panni) con la bbàsula (piano scanalato dove veniva strofinati i
panni), a ggiarra cc'aceddu (grande giara in argilla alla quale era
stato attaccato un rubinetto di rame), nel cortile, al centro stava
u pirituri (imboccatura della conduttura sotterranea di solito
costituita da un tubo di terracotta) per lo scarico delle acque
piovane e di quelle provenienti dalla ggiarra e dalla pila.
Il fanciullo che andava dalla
mastra portava l'occorrente per studiare: nella sua cartella (a uzza),
aveva la matita (u làpisi) e i quaderni per scrivere; in un cestino
di vimini (u panareddu), aveva anche la sua merendina.
La vivacità dei bambini è segno
di intelligenza, si dice, ed anche questi bambini che vanno dalla
mastra vengono spesso in contrasto tra loro. La mastra deve a questo
punto dimostrare la sua abilità di educatrice e con una certa
autorità invita i bambini al silenzio perché adesso si deve giocare
a …………
________________
Questo brano e' tratto da "Giocalant
giochiamo con la tiritera" scritto da "Gaetano Calogero", stampato
da "Tipolito Anfuso - Catania". Non e' mia intenzione violare i
diritti di copyright. Se l'autore del libro volesse cancellare la
pubblicazione e' pregato di inviare una e-mail e l'articolo sarà
tolto entro 48 ore
Giovane sarta si innamora di un
sarto, e porta la moda a Catania. 60 anni fa
Maria Caruso ha studiato da
artista e imparato a lavorare da grande artigiana. Dopo aver aperto
un suo laboratorio ha fatto conoscere le sue creazioni, pensate per
una donna moderna, in tutta Italia. Accanto a nomi come Krizia,
Schubert e alle Sorelle Fontana
Un viaggio iniziato nel tempo
lontano in cui il concetto di unicità definiva la vera fisionomia
della moda. Fra i protagonisti delle pagine di quel meraviglioso
passaggio storico, vi è Maria Caruso. Nata nel 1934 a Misterbianco –
comune della provincia catanese – Maria trascorse l’infanzia
facendosi infatuare dalle materie creative che si studiavano nel
collegio che frequentava: “Ero ben predisposta soprattutto al ricamo
e al disegno. Scelsi, così, di continuare gli studi in un istituto
professionale perché la voglia di apprendere le regole del taglio
aveva preso il sopravvento. Per perfezionare la tecnica andai da
Tinuzza, una sarta amica di mia madre che mi affidò una serie di
abiti tirolesi da rifinire. Osservavo costantemente la realtà con
gli occhi attenti e curiosi. Dopo un po’, ho iniziato a lavorare
autonomamente. Affascinata dalla moda di Christian Dior, seguita
attraverso le pagine della rivista La Donna, ho realizzato i
primissimi abiti per mia sorella che, complice il suo fisico da
modella, li indossava e li promuoveva fra le amiche entusiaste e
desiderose di possederne uno. La gioia che quelle richieste mi
procuravano, mi spronava a confezionare abiti a titolo gratuito”.
La moda di Maria Caruso aveva già
infranto le rigide regole di settore: “Dopo lo studio minuzioso
delle proporzioni anatomiche, svolto per i miei esperimenti di
pittura e disegno, ho creato una linea di taglio moderno, diversa
dalle fogge e dai canoni tradizionali. Un giorno, infastidita da
quel clamore, la sarta del paese, con molti più anni di esperienza
rispetto a me, mi propose di organizzare una sfilata di
presentazione dei nostri capi. Voleva competere per annientarmi con
la sua maestria, affinché nessuno parlasse più bene di me. Così non
è stato perché quella presentazione irrobustì ulteriormente i miei
consensi. Fu un successo inaspettato, e anche la stampa del tempo
diede un consistente risalto all’evento».
Dall’incontro fra Maria Caruso e
Francesco Ferrera, nacque un consolidato sodalizio sentimentale e
professionale: ”Lo conoscevo da quando faceva il sarto a Catania.
Ci siamo sposati nel 1958 e subito dopo abbiamo aperto la sartoria
nel centro storico della città etnea. Lavoravamo tantissimo, avevamo
una fedelissima clientela, e tante sono state le soddisfazioni
professionali. Il Circolo dei maestri sarti, nel 1961, organizzò un
evento per la sperimentazione delle nuove fibre promosso dalla
Rhodiatoce. Molti sarti da uomo – marciando col paraocchi e
mostrando perplessità a riguardo – rinunciarono senza prendere in
considerazione che il mondo stava cambiando. Noi, invece, ci siamo
voluti mettere in gioco per sperimentare e toccare con mano la
contemporaneità. Quell’esperienza ci ha permesso di partecipate a Il
Giro della Moda in Italia – progettato da Mary Giacchino e Beppe
Modenese per il lancio dei tessuti acrilici e innovativi – accanto a
nomi come Krizia, Schubert e Sorelle Fontana”.
Quando le molte tendenze
iniziarono a coesistere e a moltiplicarsi, preannunciando il
fenomeno del prêt-à-porter, l’atelier Ferrera di Catania aveva già
strizzato l’occhio alle nuove esigenze di stile e di mercato: “Nei
primissimi anni degli anni Settanta abbiamo aperto una boutique a
Taormina ché era tappa per turisti del bel mondo, soprattutto nella
stagione estiva, riservando spazio al confezionato. Molti clienti,
prima di andare al Casinò o al Festival del Cinema, passavano da noi
a ricercare l’abito dall’eleganza più appropriata. Il Corso Umberto
era come una passerella. È stato un bel periodo, e si lavorava
tanto”.
Oggi, mantenendo sempre vigile
l’attenzione sulla moda che ha sempre amato, Maria guarda con occhio
un po’severo all’evoluzione del settore: “È un trionfo di brutte
copie, e mi dispiace ammetterlo. Stiamo assistendo al tracollo delle
idee, del buon gusto, e alla diffusione della massificazione
dell’omologazione. Ho sempre lavorato con spirito diverso, riuscendo
a vestire tre generazioni di donne. Anche oggi che produciamo
soltanto abiti da cerimonia o eleganti da sera, non rinunciamo
all’esclusività, al pezzo unico e ricercato, nonostante la crisi
che, mordendo anche a noi il collo, ci ha costretto a limitare il
personale. Ho sempre creduto al potere dell’artigianato, del talento
e della manodopera. Non si può essere stilisti se non si è prima
artigiani. Molti ragazzi della moda contemporanea non conoscono la
sartoria, purtroppo. Lo spirito del tempo li spinge a correre, ad
affannarsi, e a ignorare l’artigianato che è una risorsa italiana da
incentivare e promuovere per riprodurre ricchezza e bellezza.
Soltanto così il Paese tornerà a regnare sovrano nel mondo”.

|
MANDOLINI
E CHITARRE di Vittorio Fagone
Chi
conosce la Sicilia, i paesi dell'interno e della zona orientale, sa cosa
siano le
"uri 'i cauru", le ore di caldo. Le strade diventano deserte
come, e forse più, che di notte. Le donne s'affacciano un momento sugli
usci per girare la conserva di pomodoro esposta al sole nei grandi
piatti smaltati, con un grande fazzoletto in testa. Dentro le case si fa
il grande silenzio della siesta. Anche i ragazzi riposano, o perlomeno
lasciano riposare gli altri. lo ricordo quelle insonnie di ragazzo in
una stanza candida, con solo una consolle rustica di ciliegio e sopra
una lastra di marmo bianchissima, e il gioco delle ombre rovesciate nel
muro dallo spiraglio di luce sulla strada. Chiuso dentro quel silenzio
bianco, attendendo i passi capovolti delle rare ombre, mi raggiungeva
presto consolatrice la voce lieta e tenera di un mandolino. Io la
seguivo; una canzone, un motivo dietro l'altro e, se mi assopivo, al
risveglio la ritrovavo con gioia. Il barbiere catanese era forse nella
strada l'unico che non dormisse. Dentro la bottega chiusa, forse
sdraiato nella poltrona dei suoi clienti, s'esercitava col mandolino.
Spesso provava delle nuove canzoni: a certi passaggi si fermava; poi
ripeteva lentamente. Poi di nuovo suonava la canzone tutta intera, senza
esitazione. Non mi capitò mai di vederlo suonare. La voce del mandolino
usciva da uno spiraglio stretto forse più che quello da dove
penetravano le ombre. C'è un punto nel "Don Giovanni", e tra
quelli non trascurabili, in cui si sente netta e briosa la voce del
mandolino. E ce n'è un altro, se non mi sbaglio, all'altro estremo
nella storia della musica, dove è singolare l'apparizione del
mandolino: la settima sinfonia di Mahler. Tra queste due opposte pagine
ci sono le rare apparizioni "nobili" dello strumento. La vita
del mandolino è diversa. È nella musica popolare; basta poco perchè
diventi quasi un'orchestra: una sola chitarra. Una chitarra e un
mandolino fanno una serenata, una festa, un piccolo spettacolo. Per
questo sono gli emblemi di un Sud lieto e romantico. Ma chitarra e
mandolino hanno una storia gloriosa della quale conviene accennare. La
chitarra è uno strumento originale antichissimo: c'era una "cithàra"
presso gli antichi greci e romani, e una chitarra anche in Egitto; ma
erano strumenti diversi e a quattro corde. La chitarra da cui deriva la
nostra, arrivò in Sicilia con gli arabi nel secolo XIII; da qui si
diffuse in tutta l'Europa. Nel secolo XVIII le sue corde diventarono sei
e la sua evoluzione fu, così, completa.
La
fabbrica di chitarre e mandolini, la più giovane ma anche la più
attiva in Sicilia, è sulla strada tra Catania e Messina, al bivio per
Acireale. t nei giganteschi locali del vecchio mulino Samperi. Dal
grande portone di ferro si entra nella corte vastissima; non si fa
sforzo a rivederlo uno dei punti più attivi dell'industriosa Catania
del secolo scorso. I locali dove ora è sistemata la direzione erano
allora abitati, secondo la consuetudine ottocentesca dei "patrons",
dallo stesso vecchio Samperi con tutta la famiglia. Dell'orgoglioso
splendore borghese sono testimonianza gli stucchi e le pitture. Anche i
grandi saloni di lavoro sono costruiti con la stessa generosità: hanno
alte volte a crociera su robusti pilastri e in quelli al piano terreno
la luce dall'esterno vi filtra viva. Ora lì dentro lavorano insieme una
cinquantina di artigiani, eredi e continuatori dei famosi chitarrari
catanesi. A Catania infatti almeno da un secolo e mezzo si costruiscono
strumenti musicali. Gli artigiani stanno dispersi dietro grandi banconi;
lavorano in un grande silenzio con una visibile concentrazione, da soli
o al massimo in due allo stesso banco. Vicina a ogni tavola c'è una
macchina dipinta di verde chiaro, però coperta con uno spesso foglio di
cellophane. I due fratelli mi spiegano che le macchine sono pronte a
entrare in funzione e che miglioreranno la produzione. Sono troppo
gelosi, si capisce subito, della silenziosa sapienza delle loro mani,
dell'antica nobiltà di tutti quei piccoli strumenti preziosi che ognuno
tiene attaccati sul muro bianco alle spalle. Però sono lieti della
disposizione razionale del lavoro: da una parte stanno i diversi legni, da uno ben secco e
stagionato viene ricavato il manico sul quale poi verranno segnate le
note; da un altro sottile viene ricavata la cassa, quella dalla forma
caratteristica a otto coperta dalla tavola armonica, all'interno divisa
in tanti solchi per le diverse onde sonore. Ci fermiamo nella grande
sala in due punti a osservare gli artigiani più anziani e più abili.
Uno curva su un ferro cavo rovente, alimentato da un piccolo focolare, i
legni. Lo fa con piccoli colpi delle mani seguendo la tensione del
legno, abbandonandolo e riprendendolo con miracolosa sensibilità.
L'altro è il più anziano, pittoresco e bravo. Ha una faccia serena e
curiosa sempre protesa, anche mentre parla, al lavoro che va compiendo:
rifinire una cassa, legare le sin. gole parti degli strumenti e,
soprattutto, intarsiarvi un piccolo fregio. Gli strumenti catanesi sono
famosi anche per gli splendidi intarsi che portano sempre. Ogni
mandolino, ogni chitarra ha un suo contrassegno grafico, quasi un
monogramma. La tematica ornamentale è ingenua e poetica: una stella, un
triangolo, un circolo, un rombo, la corolla di un fiore, un foglie, due
fiori su uno stelo, una farfalla, una farfalla con le ali screziate,
un'ape, un'ape sopra un fiore, una cetra, un'aquila, un giglio, una
rosa, una margherita, una rondine. La rondine non sta che sulle
chitarre, a larghe ali spiegate. Una rondine vuoi dire nostalgia,
bellezza, casa: è uno dei segni patetici e antichi della tradizione
popolare italiana. Queste forme gli intarsiatori catanesi (a Catania
c'è forse il più abile fra tutti oggi in Italia, Franceschini)
hanno esposte in un largo campionario che non guardano mai; gli
artigiani le riproducono a memoria. Esse vengono riportate nello strato
più superficiale del legno, con abilità e destrezza. Gli intarsi, va
detto, un tempo erano fatti esclusivamente in madreperla; ora, per la
necessità di mantenere accessibile il costo di uno strumento così
popolare, anche. in celluloide. Però l'abilità e il gusto di chi sono
testimoni non cambia. Un colpo solo, mi dice il direttore della
fabbrica,
lavoro: da una parte stanno i diversi legni, da uno ben secco e
stagionato viene ricavato il manico sul quale poi verranno segnate le
note; da un altro sottile viene ricavata la cassa, quella dalla forma
caratteristica a otto coperta dalla tavola armonica, all'interno divisa
in tanti solchi per le diverse onde sonore. Ci fermiamo nella grande
sala in due punti a osservare gli artigiani più anziani e più abili.
Uno curva su un ferro cavo rovente, alimentato da un piccolo focolare, i
legni. Lo fa con piccoli colpi delle mani seguendo la tensione del
legno, abbandonandolo e riprendendolo con miracolosa sensibilità.
L'altro è il più anziano, pittoresco e bravo. Ha una faccia serena e
curiosa sempre protesa, anche mentre parla, al lavoro che va compiendo:
rifinire una cassa, legare le sin. gole parti degli strumenti e,
soprattutto, intarsiarvi un piccolo fregio. Gli strumenti catanesi sono
famosi anche per gli splendidi intarsi che portano sempre. Ogni
mandolino, ogni chitarra ha un suo contrassegno grafico, quasi un
monogramma. La tematica ornamentale è ingenua e poetica: una stella, un
triangolo, un circolo, un rombo, la corolla di un fiore, un foglie, due
fiori su uno stelo, una farfalla, una farfalla con le ali screziate,
un'ape, un'ape sopra un fiore, una cetra, un'aquila, un giglio, una
rosa, una margherita, una rondine. La rondine non sta che sulle
chitarre, a larghe ali spiegate. Una rondine vuoi dire nostalgia,
bellezza, casa: è uno dei segni patetici e antichi della tradizione
popolare italiana. Queste forme gli intarsiatori catanesi (a Catania
c'è forse il più abile fra tutti oggi in Italia, Franceschini)
hanno esposte in un largo campionario che non guardano mai; gli
artigiani le riproducono a memoria. Esse vengono riportate nello strato
più superficiale del legno, con abilità e destrezza. Gli intarsi, va
detto, un tempo erano fatti esclusivamente in madreperla; ora, per la
necessità di mantenere accessibile il costo di uno strumento così
popolare, anche. in celluloide. Però l'abilità e il gusto di chi sono
testimoni non cambia. Un colpo solo, mi dice il direttore della
fabbrica, osservando il vecchio artigiano al suo lavoro, un colpo
sbagliato potrebbe distruggere uno strumento. Lo dice osservandolo con
una punta di orgoglio e di preoccupazione. L'uomo anziano ride mostrando
una fila di rughe attorno agli occhi. Forse non avrà mai sbagliato quel
colpo. Nel piano più alto del mulino gli strumenti sono verniciati,
stagionati, lucidati. Alla fine controllati severamente nella loro
qualità musicale. Chi esegue il collaudo degli strumenti, chi li
"prova" non e pero un uomo anziano. t un giovane, quasi un
ragazzo, con una maglietta a righe e i capelli nerissimi. Controlla gli
strumenti a lungo, all'orecchio, uno a uno. Fa questo lavoro contento,
nelle pause si sente attorno un grande silenzio. Sembra lavorare senza
nessuno sforzo. Mentre lo osservo mi ricordo di tutte le teorie
scientifiche che andiamo ricavando dalla fine dei secolo scorso, sopra
le età dei nostri sensi. Il nostro udito incomincia a invecchiare a
venticinque, a trent'anni. Forse è vero. L'odore di vernice, il colore
caldo degli strumenti, la folla delle loro forme accatastate, e però
sempre distinte, fanno una strana composizione. Uscendo da qui questi
mandolini con quanti oggetti si combineranno, daranno valore e una forma
armoniosa, imprevedibile. Quando con i fratelli
Leone ci
ritroviamo nella stanza della direzione il balcone sul mare ha, nel
caldo pomeriggio di autunno, le imposte socchiuse. Dei due fratelli
l'abile conversatore mi dice, quasi a conclusione: "I nostri
mandolini li portiamo in giro per il mondo. Li accompagno io stesso. Le
chitarre le fanno anche i tedeschi e gli spagnoli ma i mandolini li
facciamo solo noi. Li esportiamo dovunque, forse più che in qualunque
altra parte in America ". Chi cercherà i mandolini catanesi in
America? Ne soppeso uno: è elegante ma leggero e non superbo. Penso
all'addensarsi di emozioni, di immagini, di segnali, di locuzioni, di
voci, di canzoni che uno strumento come questo può riportare. Ecco
rivedo il silenzioso barbiere con i capelli bagnati incollati in testa
aprire, alle sei, nella mattina limpida e fresca le imposte complicate
della bottega e scambiare il suo contegnoso saluto dall'altro lato della
strada. Ma non trovo più la voce di quel mandolino che mi restituisca
la tenerezza di una infanzia tutta consumata nel sole. osservando il vecchio artigiano al suo lavoro, un colpo
sbagliato potrebbe distruggere uno strumento. Lo dice osservandolo con
una punta di orgoglio e di preoccupazione. L'uomo anziano ride mostrando
una fila di rughe attorno agli occhi. Forse non avrà mai sbagliato quel
colpo. Nel piano più alto del mulino gli strumenti sono verniciati,
stagionati, lucidati. Alla fine controllati severamente nella loro
qualità musicale. Chi esegue il collaudo degli strumenti, chi li
"prova" non e pero un uomo anziano. t un giovane, quasi un
ragazzo, con una maglietta a righe e i capelli nerissimi. Controlla gli
strumenti a lungo, all'orecchio, uno a uno. Fa questo lavoro contento,
nelle pause si sente attorno un grande silenzio. Sembra lavorare senza
nessuno sforzo. Mentre lo osservo mi ricordo di tutte le teorie
scientifiche che andiamo ricavando dalla fine dei secolo scorso, sopra
le età dei nostri sensi. Il nostro udito incomincia a invecchiare a
venticinque, a trent'anni. Forse è vero. L'odore di vernice, il colore
caldo degli strumenti, la folla delle loro forme accatastate, e però
sempre distinte, fanno una strana composizione. Uscendo da qui questi
mandolini con quanti oggetti si combineranno, daranno valore e una forma
armoniosa, imprevedibile. Quando con i fratelli
Leone ci
ritroviamo nella stanza della direzione il balcone sul mare ha, nel
caldo pomeriggio di autunno, le imposte socchiuse. Dei due fratelli
l'abile conversatore mi dice, quasi a conclusione: "I nostri
mandolini li portiamo in giro per il mondo. Li accompagno io stesso. Le
chitarre le fanno anche i tedeschi e gli spagnoli ma i mandolini li
facciamo solo noi. Li esportiamo dovunque, forse più che in qualunque
altra parte in America ". Chi cercherà i mandolini catanesi in
America? Ne soppeso uno: è elegante ma leggero e non superbo. Penso
all'addensarsi di emozioni, di immagini, di segnali, di locuzioni, di
voci, di canzoni che uno strumento come questo può riportare. Ecco
rivedo il silenzioso barbiere con i capelli bagnati incollati in testa
aprire, alle sei, nella mattina limpida e fresca le imposte complicate
della bottega e scambiare il suo contegnoso saluto dall'altro lato della
strada. Ma non trovo più la voce di quel mandolino che mi restituisca
la tenerezza di una infanzia tutta consumata nel sole.
I
FRANCHESCHINI, UNA FAMIGLIA DI GRANDI INTARSIATORI CATANESI (grazie al
prof. Salvo Di Marco Franceschini)
Sono il pronipote di Antonino
Franceschini, mio bisnonno, fondatore insieme al fratello Alessandro
della rinomata frabbrica di strumenti musicali ANTONINO FRANCESCHINI
& Co., e di Michele Franceschini, fratello di mia nonna e figlio di
Antonino. Da notizie pervenutemi da parte dei miei familiari sapevo
dell’importanza di questa azienda, chiusa, forse per motivi
politici, durante il ventennio fascista.

  Fornivano
le finiture in madreperla, tra le altre attività, alle ditte
Scandalli e Soprani, i costruttori di fisarmoniche di Castelfidardo,
con i quali intercorrevano
rapporti di profonda amicizia oltre a quelli di carattere
industriale, per la loro produzione più pregiata. I Franceschini,
inoltre, erano fornitori ufficiali di Casa Savoia per quanto
riguarda portagioie, cofanetti e altro. Mia nonna Rosa mi raccontava
che Il Re Vittorio Emanuele III concesse per una lotteria di
beneficenza, negli anni '20, un servizio da toletta costruito e
decorato proprio dalla fabbrica di suo padre Antonino. Fornivano
le finiture in madreperla, tra le altre attività, alle ditte
Scandalli e Soprani, i costruttori di fisarmoniche di Castelfidardo,
con i quali intercorrevano
rapporti di profonda amicizia oltre a quelli di carattere
industriale, per la loro produzione più pregiata. I Franceschini,
inoltre, erano fornitori ufficiali di Casa Savoia per quanto
riguarda portagioie, cofanetti e altro. Mia nonna Rosa mi raccontava
che Il Re Vittorio Emanuele III concesse per una lotteria di
beneficenza, negli anni '20, un servizio da toletta costruito e
decorato proprio dalla fabbrica di suo padre Antonino.
Come Le avevo accennato in una
precedente email, mio nonno, Salvatore di Marco Mancuso, genero di
Antonino Franceschini, rinvenne nel corso della sua lunga prigionia
in India, durante la seconda guerra mondiale, una chitarra "Antonino
Franceschini e Co." della quale non trovo più la foto, purtroppo,
che mio nonno aveva fatto. So anche da fonti familiari che parte del
legname per la costruzione delle chitarre e dei mandolini proveniva
dal Brasile (me lo diceva mia nonna) e che una delle cause, oltre a
quella politica, della chiusura della fabbrica, fu proprio il regime
autarchico a cui venne sottoposta l'Italia durante il ventennio, che
impediva anche importazioni di legni pregiati. Purtroppo la
memoria storica si è esaurita non essendo più in vita i nonni e i
prozii. Ma chissà se i discendenti di altre liuterie catanesi,
qualora esistessero e fossero reperibili, potrebbero fornire altri
lumi per le importanti attività industriali, non solo artigianali,
della Catania della prima metà del sec. scorso.
L'incisore di cui parla Fagone
come "migliore incisore d'Italia" è senz'altro Michele Franceschini
di Antonino, l'unico ad avere esercitato questa professione con
grande maestria. I fabbricanti di pianoforti catanesi Strano mi
dicevano che ebbe modo di collaborare con loro, ancora per decenni,
dopo la chiusura della fabbrica. Per quanto riguarda le marche dei
pianoforti incise appunto in madreperla. Non si sposò, terzo degli
otto figli di Antonino, unico maschio della famiglia del mio
bisnonno, e non ebbe discendenti: dei figli di Antonino convolò a
nozze la sola Rosa, mia nonna, coniugata con Salvatore Di Marco
Mancuso di Palermo.
Prof. Salvo di Marco Franceschini
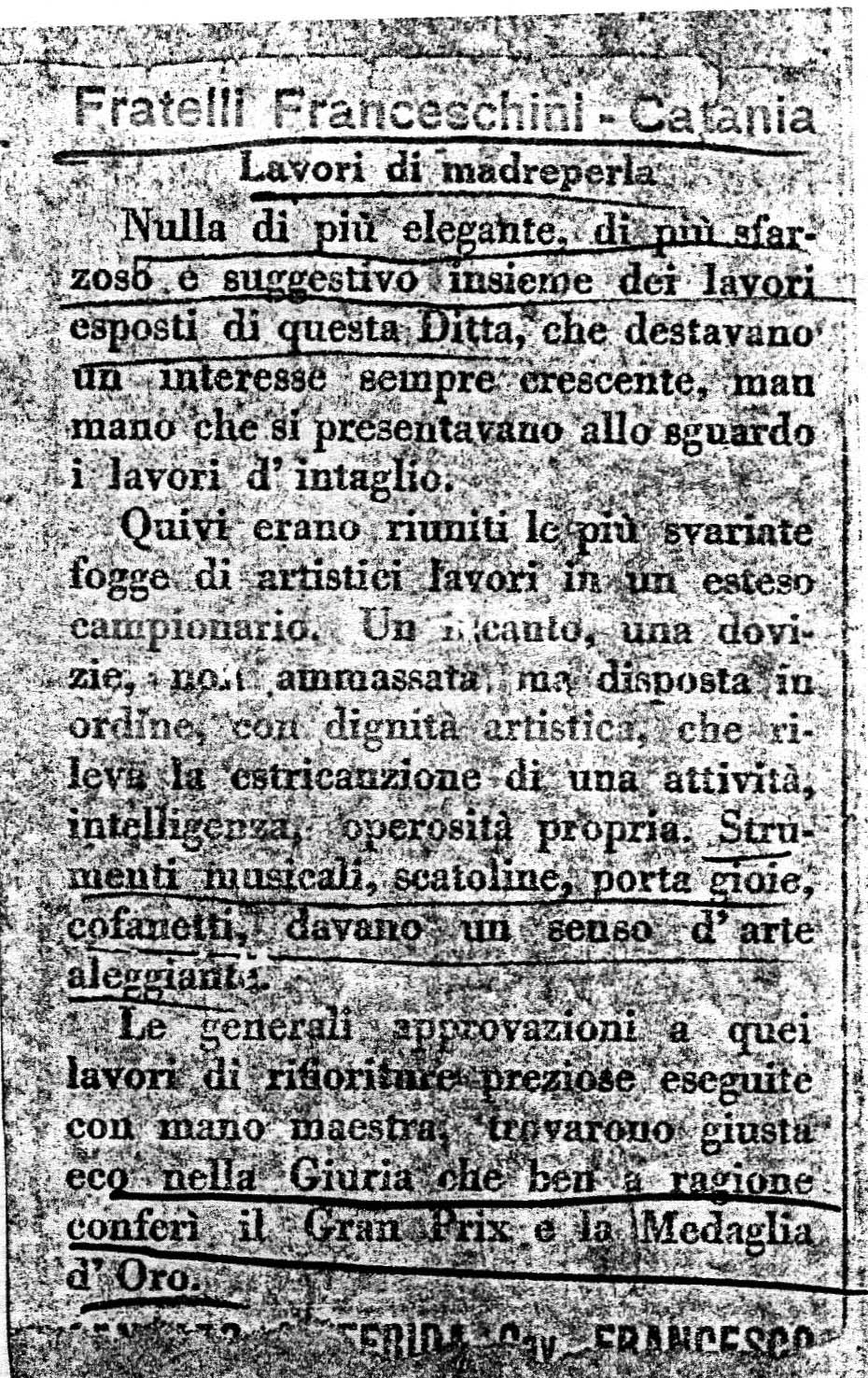

CARMELO
CATANIA
La
stella di prima grandezza dei liutai siciliani fu sicuramente Carmelo
Catania che fu l'unico, forse, a capire che la figura del liutaio doveva
fondersi a quella dell'imprenditore per sopravvivere sul mercato interno
e internazionale. Il periodo d'oro di Carmelo Catania fu quello dopo la
guerra, fino agli anni 60. Le condizioni economiche e culturali
portarono Carmelo Catania a produrre una gamma vastissima di strumenti
artigianali prodotti su scala industriale. Le poche pagine del suo
catalogo qui riprodotte testimoniano una capacità di filtrare tutte le
influenze esterne con una sensibilità tutta Siciliana. Carmelo Catania
fu forse il primo liutaio a organizzarsi industrialmente, promuoversi,
esportare chitarre, stabilire alleanze e scambi commerciali. In Sicilia
si creò un vero e proprio polo produttivo che realizzava strumenti o
parti per conto terzi, Anche le prime acustiche di Oliviero Pigini furono
costruite in sicilia e costituirono il primo catalogo Eko e GIEMMEI. Carmelo
Catania è noto
ai più per aver costruito la prima chitarra di Claudio Baglioni e
Domenico Modugno e al pari di Eko contribuì alla diffusione della
chitarra in Italia producendo modelli entry-level di acustiche per tutti
gli anni 60.
Da
Settembre 2005 Tony Braschi è diventato ufficialmente Endorser
Saldaneri, per sponsorizzare uno dei modelli delle
chitarre di alta liuteria della imponente produzione Saldaneri strumenti
musicali. SALVATORE SALDANERI è uno dei maggiori liutai italiani
di nuova generazione. Premiato nel 1998 con una borsa di mestiere dal
SADA-CASA Artigiani, ad oggi ha esposto i suoi strumenti musicali in
alcune delle maggiori Locations italiane ed
internazionali come: il parco museo Jalari a Barcellona, le fiere
internazionali di Musik Messe a Francoforte e del Mediterraneo a
Palermo, il Disma Music Show di Rimini (nel 2000 e nel 2001) ; le
iniziative "Spazio-Laboratorio" & "Antichi
mestieri" , le mostre a Messina in Piazza Duomo e l’esposizione
in occasione di "TELETHON” nel 2000. Le manifestazioni tra cui
"Le botteghe del borgo" a Taormina, ed il quinto meeting
internazionale 5Th International "Meeting Acoustic Guitar" di
Sarzana (La Spezia). Numerosi i consensi ricevuti in questi anni
correlati da importanti riconoscimenti conseguti dalla stampa disettore,
tra cui le pubblicazioni di articoli come"GUITAR CLUB" a
Maggio 2000; interviste e recensioni per riviste come Icocktails di
maggio 2003, Guitarcook.com e nel 2005 viene pubblicato un articolo sul
"Gazzettino del Tirreno". Per ulteriori informazioni visitare
il sito: http://www.saldaneriguitars.it


Mi
è arrivata questa mail:
Alla
cortese attenzione dei maestri liutai Catanesi.
Siamo
allievi della Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, e
siamo stati autorizzati a contattarvi dal
nostro Maestro, Vicepreside Giorgio Scolari. E'
in nostro possesso un violino fabbricato ad Acireale, di Alfio
Anastasi datato 1826,
e
vorremmo avere qualche informazione a riguardo di questa fabbrica e
del suddetto liutaio. Potreste
gentilmente inviarci qualche notizia? In
attesa di vostra risposta vi porgiamo cordiali saluti.
Gli
allievi Rosalba De Bonis,
Masahiro Awabayashi ,Oh Dong-Hyun
Chi
è a conoscenza di fonti relative a questo liutaio, visto che
l'interesse arriva proprio dalla città di Stradivari, è pregato di
fornirmi qualsiasi notizia in merito.
Grazie
- Mimmo Rapisarda

 |

|
La
Città di Caltagirone sorge alle sommità di un monte che separa la
piana di Gela da quella di Catania. Il territorio è ricco di siti
archeologici (S.Mauro, Montagna, S.Ippolito ecc.) che testimoniano
insediamenti fin dall' epoca preistorica. In occasione di campagne di
scavi sono stati reperiti diversi manufatti, anche in terracotta,
risalenti ad epoca preellenistica.
L'
utilizzazione dell' argilla, presente in gran quantità attorno a
Caltagirone, è occasione di sviluppo artigianale ed economico già nel
sec. VII a.C. per divenire, attorno al sec. V a.C., più raffinata e
riconoscibile. Di questa epoca è, infatti, il famoso cratere a figure
rosse che mostra un artigiano intento a modellare un vaso al tornio,
conservato nel Museo della Ceramica di Caltagirone.
Con
gli Arabi Caltagirone conosce un periodo fiorente sia in agricoltura che
in altri settori e, certamente, nella produzione di manufatti in
terracotta che divengono maiolica grazie alla tecnica dell'invetriatura
importata dai Saraceni.
La
ceramica di Caltagirone, costituita a quel tempo da manufatti di uso
giornaliero, si diffonde rapidamente in tutta la Sicilia. In seguito i
"cannatari"(fabbricatori di brocche)" , i "ciaramitari
(fabbricatori di tegole)", gli "stovigliari (fabbricatori di
stoviglie)" ebbero riconoscimento della loro valentia tanto che la
ceramica di Caltagirone poteva circolare liberamente nel Regno di
Sicilia in esenzione da tasse.
Purtroppo
il terremoto del 1693, nefasto per tutta la Sicilia orientale, oltre a
far crollare gran parte della Città, mandò in rovina quasi tutti i
manufatti antichi in ceramica che si erano conservati fino a quel
momemto. Fortunatamente, la diffusione della ceramica di Caltagirone
permette di ritrovare oggetti di epoca precedente al terremoto in
collezioni sparse nel mondo.
La
ricostruzione impegnò grandemente gli amministratori della Città, i
Senatori, che diedero commissione alle migliori maestranze. Furono
aperte nuove strade a valle del nucleo originario e la città assunse l’aspetto
barocco che ancor oggi possiamo ammirare.
Ai
primi dell’800 inizia la fiorente attività dei figurinai che
inizialmente produssero esclusivamente pastori da presepe. Nel 1848 il
figurinaio Giacomo Bongiovanni si impegnò a fornire al Comune di
Caltagirone annualmente quattro gruppi di figurine per il corrispettivo
di settentadue ducati annui.
Il
Bongiovanni ebbe il merito di vestire le sue figurine di argilla. Prima
di lui, soltanto le teste , le mani ed i piedi erano di argilla ed il
resto del corpo era costituito da stoffa o carta pesta alla maniera dei
pupi napoletani. Figurinai che si distinsero nel tempo sono da ricordare
i Morretta, i Bonanno, i Bongiovanni Vaccaro, per giungere ai nostri
tempi con gli Scuto, i
Branciforti, i Romano, i Patrì, i Raimondo, i Biondo
ecc.
Nell’800
la ceramica trova diffusa utilizzazione in architettura tanto che si
costruiscono capolavori quali la Villa Carolina, poi Vittorio Emanuele,
con arredi del Basile realizzati dalla fabbrica Vella di Caltagirone, o
il Cimitero nel quale il Progettista Nicastro volle tutti i particolari
architettonici in terracotta sicchè costituisce un esempio unico nel
suo genere.
L’ultimo
grande lavoro pubblico che ha visto impiagata la ceramica è il
rivestimento dei frontali dei gradini della famosa scala di Maria SS.
del Monte realizzato negli anni ’50 dalla Scuola d’Arte di
Caltagirone diretta dal Prof. Antonino Ragona al quale si deve anche l’istituzione
del Museo della Ceramica.
Questa
scala , in occasione dei festeggiamenti di luglio in onore del Patrono
S.Giacomo, viene illuminata da migliaia di lucerne ad olio che disegnano
splendidi arazzi. Questa antica tradizione è stata codificata a metà
dell’800 dal francescano Padre Benedetto Papale.
 Oggi
Caltagirone offre ai visitatori un centro storico nel quale convivono
edifici medioevali, barocchi, liberty che ha il cuore nella vecchia
piazza della Loggia (Municipio) delimitata dal maestoso Palazzo dell’Aquila,
dalla Corte Capitaniale, dal Palazzo Gravina con il lungo balcone
gaginesco e dalla Galleria Luigi Sturzo nel cui interno è il più
grande pannello di ceramica mai realizzato nel quale il Maestro Pino
Romano ha rappresentato la
battaglia di Judica che vide vincitori i Calatini sui Saraceni. Tale
evento diede inizio alla potenza di Caltagirone che fu infeudata della
Baronia di Camopietro. Oggi
Caltagirone offre ai visitatori un centro storico nel quale convivono
edifici medioevali, barocchi, liberty che ha il cuore nella vecchia
piazza della Loggia (Municipio) delimitata dal maestoso Palazzo dell’Aquila,
dalla Corte Capitaniale, dal Palazzo Gravina con il lungo balcone
gaginesco e dalla Galleria Luigi Sturzo nel cui interno è il più
grande pannello di ceramica mai realizzato nel quale il Maestro Pino
Romano ha rappresentato la
battaglia di Judica che vide vincitori i Calatini sui Saraceni. Tale
evento diede inizio alla potenza di Caltagirone che fu infeudata della
Baronia di Camopietro.
A
pochi metri dalla Piazza del Municipio, sul Corso Vittorio Emanuele, è
la Mostra Mercato Permanente della Ceramica di Caltagirone che espone
ceramiche prodotte da oltre sessanta botteghe della Città su una
superficie di circa ottocento metri quadrati. Nello stesso edificio
della Mostra si può ammirare il grande presepe animato nel quale i
personaggi si muovono all’interno di una Caltagirone in miniatura.
Sembra
superfluo consigliare per chi viaggia da queste parti l'acquisto di un
bell'oggetto di ceramica.
Ve
ne sono di tutti i tipi, per tutti i gusti, per tutte le tasche. La
qualità è in genere buona, anche se all'incremento di questi anni dei
turisti in visita a Caltagirone si è accompagnata l'apertura di negozi
che vendono paccottiglia scadente.
Molto
interessanti le ceramiche di Giacomo
Alessi, un
negozio ai piedi della scalinata, il cui laboratorio conduce una seria
attività di studio e di ricerca sulle maioliche antiche, riproponendo
con attenzione filologica i colori caldi ed i disegni tradizionali delle
ceramiche rinascimentali e barocche del territorio calatino.
Belli
da acquistare e facili da trovare dappertutto sono gli stampi per la
mostarda: semplici formine in ceramica, decorate con motivi
tridimensionali di piante ed animali, che una volta venivano utilizzate
per informare questo dolce tipico della tradizione siciliana, a base di
mosto di vino cotto e aromatizzato.
Caltagirone
è al centro di un territorio agricolo ricco e vario e nei negozietti
del centro storico potrete trovare perciò un'ottima varietà di
prodotti agricoli, formaggi e altre prelibatezze confezionate
artigianalmente: vi consigliamo per esempio di acquistare un vasetto di
miele biologico, di eucalipto, di timo, di rosmarino, d'arancio, o di
millefiori, raccolto nella campagna di San Pietro e confezionato
artigianalmente da Gaetano Cannizzaro e dalla moglie Silvana nel loro
laboratorio in centro: una vera esperienza del gusto.
(www.guidasicilia.it)

|

|
Le
officine ceramiche a Catania
tra la fine dell'Ottocento e il primo
Trentennio del Novecento
 L'arte
della ceramica era molto conosciuta e diffusa nella città di Catania
al tempi del Principe di Biscari (metà del XVIII), che la L'arte
della ceramica era molto conosciuta e diffusa nella città di Catania
al tempi del Principe di Biscari (metà del XVIII), che la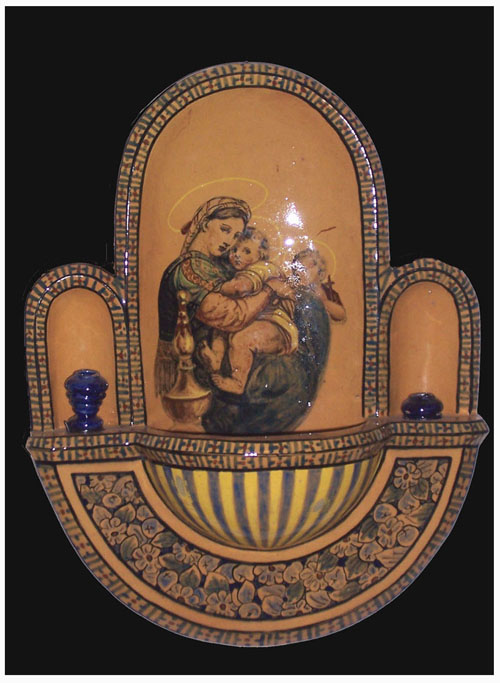 promosse e
incoraggiò insieme alla cultura della canna da zucchero. promosse e
incoraggiò insieme alla cultura della canna da zucchero.
Alla
fine dell'Ottocento appare piuttosto trascurata ad eccezione dei
bellissimi costumi
siciliani in terracotta. Si può documentare nel 1883 l'esistenza di
una Società industriale di cristalli e porcellane operante a Catania
in via Lincoln 146 e 148.
Inoltre
in tale periodo erano numerose sia a Catania che in provincia molte
fabbriche di lavori in argilla.
L'argilla
era mista a gesso e calce e veniva utilizzata per la realizzazione di
tegole, mattoni,
quadrelli e vasi per usi domestici.
Lo
stabilimento sotto la ditta R. Ravesi & C. si distingueva in
Sicilia per lavori in quadrelli di cemento idraulico, belli per
eleganza e per la varietà del disegno, igienici perché non subivano
le variazioni atmosferiche e resistenti, dal momento che si
consolidavano come marmo.
Nel
1899 circolavano a Catania le pillole vegetali Ravesi
"espulsivi" dei calcoli e della renella; erano preparate dal
farmacista-chimico Cav. R. G. Ravesi Cesare, che ebbe diversi premi in
varie esposizioni. Il laboratorio farmaceutico era sito in via
Garibaldi 3 (ciascun scatolo veniva venduto L. 2,50).
Alla
luce di tale testimomanza si spiega a Catania la circolazione di
contenitori in ceramica collocabili nel primo ventennio del Novecento
(come dai seguenti esemplari della collezione privata Mario Russo) che
recavano la seguente dicitura dipinta: "Cachets Ravesi, efficace
rimedio per espellere renella e calcoli"; sul fondo la sigla del
vasaio "C. Limo aurum, Catania".
Un
altro stabilimento ceramico, sito in via Lincoln 77, si firmava con la
sigla "Scalia e Coniglione". Tra i committenti che si
fornivano presso tale officina ricordiamo il Bar Brasile gestito da A.
Imbrosciano.
 |
per
una migliore visione salvare le immagini col tasto destro del mouse

|
La
pietra lavica
La
lavorazione della pietra lavica, derivante dall’industria estrattiva
delle vicine cave, per scopi ornamentali o per materiali da costruzione
diede da vivere a molte famiglie. Ancora oggi é praticata da bravi
artigiani locali. Molti mestieri erano legati all'estrazione ed alla
lavorazione della pietra lavica.
Anticamente
i"pirriaturi", estraevano lungo i costoni della montagna, solo
strati superficiali di lava perché più porosi e più facilmente
lavorabili con arnesi quali la subbia, lo scalpello, la mazzola e
martello. Sul materiale estratto interveniva lo spaccapietre che
ricavava lastre di pietra, infine lo scalpellino rifiniva il materiale.
Uno degli usi prevalenti cui era destinata la pietra lavica era la
pavimentazione delle strade urbane e rurali. Un tipo particolare di
pietra, la "pietra pomice", leggerissima, veniva adoperata per
la copertura a cupola delle chiese. Due cave famose furono u fussuni e
la Perriera, quest'ultima forniva pietra pomice.
 Oggi
l'estrazione avviene con l'ausilio di moderne macchine quali la pala
meccanica e le ruspe che permettono di raggiungere strati profondi dove
la lava è più compatta, più dura e di colore più chiaro. Anche la
lavorazione è facilitata dall'uso di altri strumenti e macchine:
trapano, flex, fresa e levigatrice. Oggi
l'estrazione avviene con l'ausilio di moderne macchine quali la pala
meccanica e le ruspe che permettono di raggiungere strati profondi dove
la lava è più compatta, più dura e di colore più chiaro. Anche la
lavorazione è facilitata dall'uso di altri strumenti e macchine:
trapano, flex, fresa e levigatrice.
Col
passare del tempo l’antico mestiere dello scalpellino ha subito un
forte declino, lasciando vuoti incolmabili. D’altro canto anche l’edilizia,
nei nostri centri si è snaturata, perdendo la connotazione col
territorio, in nome o con l’alibi dello "sviluppo
turistico". Tuttavia, in quest’ultimo periodo sembra però sia in
atto un’inversione di tendenza. Soprattutto nel centro storico si
punta alla ristrutturazione nel rispetto dei vincoli imposti da Comune e
Sovrintendenza e, complessivamente, si assiste ad una ripresa nell’uso
della pietra lavica.
Il
basalto è un materiale resistente, espressivo e decorativo, quindi si
presta alla lavorazione per la realizzazione di oggetti per arredamento
e per pezzi di arredo urbano.
Con
la pietra lavica si possono realizzare oggetti ornamentali e sculture ed
in campo artistico si è notato un positivo incremento nel suo utilizzo
per usi abitativi interni. Sempre più numerose sono le abitazioni nel
cui interno le alzate dei gradini, i tavoli o le basi dei camini sono
realizzati in questo modo.
L'anima
della pietra lavica
di
Maurizio Merlini

Cultura
e scultura si compenetrano in un rapporto osmotico dalle mirabili
suggestioni.
Nelle
sorprendenti creazioni di Nino
Valenziano Santangelo
la generica peculiarità, tutta etnea, della lavorazione basaltica
diviene singolare interpretazione di un artista ispirato, capace di
apporre il sigillo d’autore a pietre laviche in apparenza amorfe e
prive di personalità particolare.
Da
vent’anni l’autodidatta maestro, avvocato nella società civile, si
sbizzarrisce nell’intuizione figurativa dei blocchi lanciati dal
vulcano, limitandosi ad assecondare sembianze già insite nelle rocce e
che ai nostri sguardi, profani e distratti, appaiono dotate di
configurazioni astratte, anonime e bislacche; dunque, il geniale artista
innamorato dell’Etna non è un demiurgo, non plasma con capriccio
inventivo la materia informe.
"Le
pietre laviche - afferma compiaciuto Nino Santangelo - presentano
aspetti pressocchè definiti, come le nuvole, basta solo leggere con
attenzione".
Così
questo scultore anomalo e originale riconosce nei massi lanciati dalla
grande Montagna soggetti statuari già ben delineati da perfezionare,
spesso con appena un paio di leggere incisioni di scalpello con cui dà
corpo ai molteplici stimoli ondeggianti nel suo vasto retroterra
culturale.
Le
sale espositive del piccolo museo d’ineguagliabile valore, trascurato
dalle autorità catanesi impegnate nella promozione turistica, sono
gremite di statue, (alcune addirittura double face) raffiguranti volti
celebri attinti da mitologia, religione, tradizioni popolari, storia,
fauna, paesaggistica e architettura locale, stati d’animo: in rapida
successione coinvolgente è possibile ammirare Gesù, Giufà, Socrate,
Ciranò de Bergerac, il cavallo di Troia, Don Chisciotte, Angelo Musco,
la vispa Teresa, Omero, Pirandello, il guerriero Vichingo, cani di tutte
le razze, buonumore e malumore, Giove, Polifemo e una serio di "u
liotru", elefante con obelisco emblema del capoluogo etneo . Tutti
i pezzi della vasta collezione sono custoditi a Catania in via
Santangelo Fulci 55/a, dove i visitatori sono accolti previa telefonata
allo 095 7221642.
Da
sottolineare la netta contrarietà dell’eccentrico Santangelo alla
mercificazione dell’arte: le sue opere infatti non sono in vendita; l’autore
si è voluto privare solamente di una statua bifronte, carica di
significati esistenziali, donata a Papa Giovanni Paolo II e conservata
nella biblioteca dei Musei Vaticani.
Il
Museo di sculture in pietra lavica "Valenziano Santangelo" è
stato realizzato ed allestito dallo scultore autodidatta avvocato Nino
Valenziano Santangelo , che dal 1978 crea con la pietra lavica opere
uniche. Le sculture costituiscono una mostra permanente, che contiene
circa 230 capolavori, ricavati da leggeri ed intuitivi interventi su
massi lavici.
Dall'intuizione
tipica dell'artista, suggerita dalla forma primitiva della pietra,
insieme alla creatività, prendono forma le sculture- meraviglia, che
fanno rivivere storie, personaggi, miti del mondo greco-romano,
cinematografico, letterario ed anche della tradizione siciliana.
Colpiscono tra tutte la "maschera teatrale greca", dove volumi
traforati in movimento richiamano le quinte nelle scene, e la
"Maternità", in cui la pietra lavica si addolcisce nelle
curve, dando l'idea della protezione materna. Interessanti sono poi le
sculture -sorpresa, realizzate in modo che, attraverso una semplice
rotazione orizzontale o verticale, la stessa opera assuma un aspetto
profondamente diverso. Tutte le sculture hanno la caratteristica di
essere quasi incolumi da interventi, poiché, come dice l'artista:
"la stessa pietra fornisce i tratti particolari dell'opera
finale". Simbolo di questa tecnica è la testa color ruggine del
dio Vulcano, in cui sono stati scolpiti solo tre punti, gli occhi e il
naso.
Oltre
alle sculture il museo ospita anche una serie di reperti che mettono in
risalto il carattere poliedrico della pietra lavica: bombe vulcaniche,
cenere vulcanica, lava a corde, lava a lastroni, lapilli, conci
antropomorfi dell'eruzione del 2001, basole, uno scampolo di muro a
secco fatto di pezzi di sciara, come quelli delle tipiche 'casudde' , i
muri di confine ed altri.
All'interno
della galleria sono esposte delle foto che ritraggono alcune sculture
naturali, trovate dall'avvocato Santangelo a San Giovanni Li Cuti,
Acitrezza, e Pozzillo oltre che tra le sciare dell'Etna.
Il
museo si trova in Via A. Santangelo Fulci, 55/A-B-C - telefonare per
prenotare una visita: Tel 095 7221642


 Michele
Bertino è nato a
Paternò il 10-06-1934. Maestro artigiano nella lavorazione della pietra
lavica e dei marmi con laboratorio in Via Pò a Paternò. Ha iniziato
l'attività ad 11 anni seguendo la scuola del Maestro Barbaro Costa di
Paternò e da allora ha sempre svolto l'attività di lavorazione della
pietra lavica con particolare attenzione alla creazione di oggetti e
manufatti con pregiati intarsi realizzati rigorosamente a mano. Michele
Bertino è nato a
Paternò il 10-06-1934. Maestro artigiano nella lavorazione della pietra
lavica e dei marmi con laboratorio in Via Pò a Paternò. Ha iniziato
l'attività ad 11 anni seguendo la scuola del Maestro Barbaro Costa di
Paternò e da allora ha sempre svolto l'attività di lavorazione della
pietra lavica con particolare attenzione alla creazione di oggetti e
manufatti con pregiati intarsi realizzati rigorosamente a mano.
Negli
anni compresi tra il 1950 e il 1954 ha seguito corsi di disegno
prospettico con il Prof. Salvatore Palumbo di Paternò per avere una
maggiore competenza tecnica nella realizzazione dei disegni nelle opere
in pietra che già da anni eseguiva. Ha realizzato centinaia di sculture
in pietra lavica e marmi ed alcuni di essi sono posti in aree pubbliche
quali le due fontane a zampillo in pietra lavica poste all'ingresso del
Giardino Moncada di Paternò ed una fontana posta in via C. Renna in
Paternò oltre ad innumerevoli sculture cimiteriali.
http://www.paternesi.com/Michele%20Bertino.htm

I
COLTELLI DI SAN FRATELLO (da
www.coltelliversaci.com)
Io
e il coltello "Sanfratellano"
Mi
chiamo Antonino Versaci, ho 20 anni e sono di San Fratello, un paesino
in provincia di Messina. La mia storia ha inizio quando da piccolissimo,
nell'officina di mio padre (fabbro), curiosando tra i vari cassetti,
trovai un coltello "Sanfratellano" in fase di realizzazione e
da quel giorno il mio unico desiderio fu quello di impossessarmene per
ultimarlo da me. Ho ancora davanti agli occhi quel bambino accanto al
nonno (anch'egli fabbro, ma in pensione), tutto eccitato dal fatto di
finire il coltello, anche se non aveva la più pallida idea di come fare
e ricordo ancora, come fosse oggi, mio nonno che con tantissima pazienza
seguiva e correggeva i disastri del suo nipotino, tutto sporco, ma
felicissimo di imparare.
A 17 anni, finalmente, grazie all'aiuto di mio padre, che si sacrifica
in qualsiasi momento pur di rendermi felice, ho potuto realizzare il mio
sogno imparando in un batter d'occhio a forgiare da me ed a costruire
interamente un coltello secondo l'antica tradizione del mio paese…e
quindi il coltello "Sanfratellano".
Quello "Sanfratellano" era il coltello posseduto dalla quasi
totalità della popolazione dello stesso paese ed utilizzato per
qualsiasi tipo di uso, ma per lo più era il coltello adoperato dai
pastori, non solo del paese stesso ma un po' di tutta la zona, che a
volte erano disposti a percorrere anche moltissimi chilometri pur di
avere in tasca uno di questi rinomati coltelli, infatti, con esso il
pastore poteva macellare le sue bestie, curarle, nutrirsi, difendersi,
offendere e nelle lunghe giornate di solitudine con il proprio gregge,
si prestava a strumento per intarsiare dei pezzi di legno che nelle mani
abili del pastore assumevano la forma di vere e proprie opere d'arte…
Questo coltello, forgiato e creato dalle mani forti ed esperte di fabbri
artisti, ha una forma abbastanza semplice con la lama a "foglia di
ulivo" e in alcuni casi, a richiesta per lo più dei pastori, molto
più fine e appuntita, proprio per facilitare ancor di più la
macellazione degli animali; il manico in genere in corno bovino o in
altri metalli come il rame e in qualche caso, in alluminio…
 Tutte
le parti metalliche che compongono il coltello vengono forgiate a mano
dall'artigiano ed in particolare la lama e la molla per lo più con
acciai al carbonio, le parti metalliche del manico sono invece forgiate
in ferro (caratteristica principale è che le due parti del manico
vengono forgiate in un singolo pezzo, una parte verrà lucidata mentre
nell'altra sarà montato il corno). Tutte
le parti metalliche che compongono il coltello vengono forgiate a mano
dall'artigiano ed in particolare la lama e la molla per lo più con
acciai al carbonio, le parti metalliche del manico sono invece forgiate
in ferro (caratteristica principale è che le due parti del manico
vengono forgiate in un singolo pezzo, una parte verrà lucidata mentre
nell'altra sarà montato il corno).
Caratteristica fondamentale del coltello "Sanfratellano", se
eseguito secondo l'antica tradizione, è che la sua forma non può esser
riprodotta fedelmente neanche dallo stesso artigiano, poiché lo stesso
lavora non facendo riferimento ad un disegno ben preciso su carta su cui
sagomare le parti del coltello…ma sagoma con esperienza la forma del
coltello direttamente sullo stesso una volta assemblate le varie parti
forgiate…dando spesso anche qualche tocco personale al coltello…
Purtroppo, nonostante il coltello "Sanfratellano", come già
detto, sia stato, e lo è ancora oggi, molto conosciuto e apprezzato,
non solo all'interno del paese stesso, questa tradizione è andata un
po' perdendosi poiché nessuno è stato capace di portare avanti con
passione questa antica tradizione e quindi cercare di pubblicizzarlo per
poterne trarre un più ampio apprezzamento dello stesso e di riflesso un
maggiore sviluppo economico…al giorno d'oggi infatti, all'interno del
paese stesso, sono pochissimi coloro capaci ancora di realizzarlo, ma
ancor peggiore è il fatto che non c'è più nessun giovane che intende
avvicinarsi a questa antica tradizione con la voglia di imparare…
diciamo
pure che io sono l'eccezione che conferma la regola, infatti, anche se
per me non è un lavoro (studio Giurisprudenza) cerco sempre di
adoperarmi, nelle mie possibilità, per portare avanti il nome e la fama
del coltello "Sanfratellano", cercando di rispecchiare e
rispettare il più possibile l'antica tradizione tramandata dai fabbri
del mio paese…
Unico
mio dispiacere è quello di non poter più avere mio nonno al mio
fianco, ma ogni qual volta ho tra le mani un coltello, lo sento
vicinissimo nel mio cuore, che mi guarda e che mi guida proprio come la
prima volta da bambino e nel mio cuore ritorno ad essere il nipotino,
tutto sporco, ma felicissimo e voglioso di imparare…e sicuramente è
proprio in questo che va ricercata la ragione della mia grandissima
passione per i coltelli…
GLI
ALTRI MESTIERI
PERDUTI (da
www.lentinionline.it)
Sono
ormai figure rare quella del maniscalco ("u firraru"), del
sellaio ("u baddunaru"), così detto perchè costruiva una
specie di sella, "u badduni", dalla quale pensolavano due
capienti sacche, dell'artigiano ("u quarararu") che costruiva
od aggiustava grossi panciuti pentoloni in rame ("i quarari")
da porre direttamente sul fuoco.
Resiste
ancora qualche tradizionale attività artigianale come quella del
calzolaio ("u scarparu") o del sarto ("u custureri"),
pochi ma valenti, dedicati prevalentemente alle riparazioni.
ANTICHI
MESTIERI LEGATI all’estrazione della pietra lavica e alla sua
lavorazione.
PIRRIATURI
Il
mestiere del pirriaturi prende il nome dalle cave di pietra (pirrere)
presenti nel territorio di Nicolosi, dove si trovano i più grossi e
compatti blocchi di basalto. Si trattava di un lavoro molto faticoso che
consisteva nella vera e propria estrazione della pietra e in una sua
prima lavorazione per l’ottenimento di blocchi anche di grandi
dimensioni che venivano utilizzati soprattutto per la costruzione di
abitazioni, delle strade e dei muretti. Il lavoratore si serviva di
attrezzi piuttosto rudimentali quali la mazza (un grosso martello), u
lagnettu (attrezzo affilato con il quale si intaccava la pietra per
indebolirla), u cugnu e u cugnittu (cunei che si introducevano nelle
spaccature della pietra e che servivano ad allargare la fenditura per
arrivare alla vera e propria rottura del blocco compatto). Anche se
attualmente la fatica degli uomini impiegati nell’estrazione dei massi
rimane, importante è l’impiego di macchinari più moderni.
GHIAROTU
Gli
intonaci delle abitazioni di Nicolosi, come si può vedere ancora nelle
vecchie costruzioni, erano tutti della stessa tonalità di colore: terra
bruciata digradante al rosa intenso. Questo perché veniva usata allo
scopo "a ghiara", che altro non è che finissima lava, simile
nella consistenza alla farina o alla sabbia che si trova nelle viscere
della terra sotto le colate.
Per
estrarre questa "sabbia" i ghiaroti scavavano dei cunicoli di
grandezza tale da permettere l’accesso all’uomo, ma anche ad una
particolare specie di muli di piccola statura, i quali venivano abituati
a percorrere soltanto lo stretto cunicolo. Essi riportavano in
superficie sacchi o bisacce contenenti la "polvere colorata"
che, mischiata a calce e a pietrisco lavico, proteggeva le facciate
delle abitazioni.
Oggi
questa attività estrattiva è stata completamente abbandonata,
soppiantata dai moderni prodotti che, pur cercando di
"imitare" il colore della tradizione, non vi riescono né per
la durata né per la consistenza.
SCAPPIDDINU
Lavorava
nella cava di pietra utilizzando lo scalpello, quindi i manufatti da lui
realizzati erano più raffinati e precisi di quelli del pirriaturi che
si limitava a sgrossare i blocchi.
L’opera
degli scalpellini era vistosamente presente nelle abitazioni, tutte
anticamente fornite di un "porticato", con l’arco in pietra
lavica, che si differenziava per la chiave di volta e per le lavorazioni
laterali. Le parti che costituiscono questi archi non sono tra loro
cementate e tutto l’insieme si regge avendo come perno la chiave di
volta.
Grande
maestria dunque degli scalpellini che, oltre ad abbellire con fiori,
rami o lettere la struttura, dovevano essere in grado di determinare la
precisa allocazione e grandezza della chiave in relazione all’altezza
dell’arco.
PRICCIALARU
Operaio
che con una grande mazza spaccava le pietre che servivano da base per le
strade. U pricciali si divideva in due categorie: "rossu"(grosso)
e "nicu"(piccolo).
GHIACATARU
Operaio
specializzato per la costruzione della ghiacata cioè la massicciata
delle strade, cortili, piazze.
BOTTAIO
Il
bottaio "u vuttaru ", era uno di quei mestieri che venivano
considerati privilegiati e di difficile esecuzione. Il procedimento di
lavorazione era fatto necessariamente a mano e consisteva nel sistemare
delle listelle di legno, di preferenza castagno, o rovere (per le botti
che dovevano contenere vini o liquori pregiati ). Queste listelle di
legno, doghe, potevano avere dimensione diversa in funzione delle
dimensioni della botte che si doveva costruire, il lavoro cominciava col
sistemare ogni doga, perfettamente piallata, in una forma circolare al
cui interno c'era un fornello per alimentare una fiamma, la doga era
normalmente più larga nella parte centrale e più stretta alle
estremità, il numero delle doghe variava in funzione della capienza
della costruenda botte, il fornello centrale serviva per fare quel
vapore necessario a rendere il legno più duttile ed elastico alla
lavorazione e facilitare la necessaria curvatura delle doghe, inoltre
era essenziale per liberare il tannino dal legno, sostanza che passa
facilmente nel vino e lo rende tossico. Per completare il lavoro
occorrevano inoltre sei cerchi di ferro di diversa dimensione e due
coperchi "timpagni ", che avevano il diametro della dimensione
del foro finale della botte. L'arte magica del bottaio era ed è, per
quei pochi artigiani rimasti; quella di far aderire le doghe l'una
all'altra, tenerle con i cerchi metallici che venivano poste
naturalmente all'esterno aiutandosi con uno speciale attrezzo a forma di
scalpello smussato con un lungo manico che si colpiva con un martello e
tutto questo veniva fatto senza l'uso di collanti, ottenendo dei
contenitori che non facevano perdere il liquido contenuto. Purtroppo la
moderna tecnologia ed il ricorso massiccio a contenitori di acciaio e di
vetroresina stanno facendo scomparire la magia di un mestiere
affascinante. circolare al
cui interno c'era un fornello per alimentare una fiamma, la doga era
normalmente più larga nella parte centrale e più stretta alle
estremità, il numero delle doghe variava in funzione della capienza
della costruenda botte, il fornello centrale serviva per fare quel
vapore necessario a rendere il legno più duttile ed elastico alla
lavorazione e facilitare la necessaria curvatura delle doghe, inoltre
era essenziale per liberare il tannino dal legno, sostanza che passa
facilmente nel vino e lo rende tossico. Per completare il lavoro
occorrevano inoltre sei cerchi di ferro di diversa dimensione e due
coperchi "timpagni ", che avevano il diametro della dimensione
del foro finale della botte. L'arte magica del bottaio era ed è, per
quei pochi artigiani rimasti; quella di far aderire le doghe l'una
all'altra, tenerle con i cerchi metallici che venivano poste
naturalmente all'esterno aiutandosi con uno speciale attrezzo a forma di
scalpello smussato con un lungo manico che si colpiva con un martello e
tutto questo veniva fatto senza l'uso di collanti, ottenendo dei
contenitori che non facevano perdere il liquido contenuto. Purtroppo la
moderna tecnologia ed il ricorso massiccio a contenitori di acciaio e di
vetroresina stanno facendo scomparire la magia di un mestiere
affascinante.
CALZOLAIO
Il
mestiere del calzolaio "scarparu" nel catanese o "solacchianeddu"
nel palermitano, è un mestiere antico e per molti versi in antitesi con
i dettami della vita moderna, infatti esso consisteva e consiste per chi
lo esercita, nel costruire scarpe su misura (che si rivelano
"indistruttibili"), ma in ciò che egli si dimostrava prezioso
per le esigue finanze delle famiglie contadine era nal lavoro di
aggiustare le scarpe, risuolatura, mettere i sopratacchi e ricucire le
parti che via via andavano sdrucendo. La materia prima utilizzata dal
ciabattino e in relazione al tipo di lavoro e all'uso che si farà delle
scarpe. Se deve fare delle scarpe che serviranno per una occasione, la
pelle sarà delle più pregiate e le rifiniture molto più curate, le
scarpe da lavoro saranno costruite con un principio che si ispira alla
robustezza ed alla solidità. Infine se deve fare un lavoro di
trattamento della scarpa (risuolatura ecc...) il materiale che una volta
si usava era il cuoio duro, mentre oggi si è più portati ad  usare
materiale di gomma. Gli attrezzi, che sono gli strumenti indispensabili
al suo lavoro, che in parte non si sono modificati sono, delle forme in
ferro di varia dimensione che servono per inserirci le scarpe un
caratteristico ed affilatissimo coltello "u trincetu", il
martello anch'esso dalla forma caratteristica, tenaglia, lesina, spago,
aghi, cera, pece, vetro per levigare le suole, e tutta una serie di
piccoli chiodi "a siminziedda" , il tutto sparso su un basso
tavolo da lavoro "u bancareddu". A completare un lavoro
artigianale ben fatto; la solerzia, la pazienza e la passione
dell'artigiano. usare
materiale di gomma. Gli attrezzi, che sono gli strumenti indispensabili
al suo lavoro, che in parte non si sono modificati sono, delle forme in
ferro di varia dimensione che servono per inserirci le scarpe un
caratteristico ed affilatissimo coltello "u trincetu", il
martello anch'esso dalla forma caratteristica, tenaglia, lesina, spago,
aghi, cera, pece, vetro per levigare le suole, e tutta una serie di
piccoli chiodi "a siminziedda" , il tutto sparso su un basso
tavolo da lavoro "u bancareddu". A completare un lavoro
artigianale ben fatto; la solerzia, la pazienza e la passione
dell'artigiano.
CANNIZZARU
La
canna comune(Arundo donax), che cresce spontaneamente lungo i corsi
d'acqua e in genere in terreni sabbiosi e paludosi, era molto usata
nell'ambiente contadino per la sua molteplicità di usi. Serviva per
costruire ripari, fungeva da palo di sostegno delle viti degli alberelli
ancora deboli, la si usava per delimitare i confini di una proprietà, e
per costruire silos contenitori di frumento. Il Cannizzaru era la figura
addetta alla costruzione dei silos per i cereali. Cominciava il suo
lavoro già nei mesi di Gennaio e Febbraio, quando raccoglieva ed
avvolgeva in fasci canne grosse e lunghe dai quattro ai cinque metri. Le
lasciava essiccare al sole ed al vento fino al mese di Giugno e solo
allora passava alla costruzione dei silos. Il Cannizzaru disponeva le
canne spaccate su un piano perfettamente livellato e procedeva ad una
vera e propria tessitura. Nella fase di definizione, quando la
superficie tessuta veniva avvolta a cilindro e sollevata verticalmente,
l'artigiano ricorreva alla collaborazione di un volontario che, dentro
il silos, recuperava e gli restituiva ogni volta il grosso ago col quale
si procedeva a cucire il complesso.
CARDATORI,
FILATORI, TINTORI E TESSITORI
Nella
zona della ricerca il paese che produceva fibbre tessili era Carini,
infatti in questo paese si produceva molto lino (Linum usitatissimum),
agave (Agave sisalana), ampelodesmo "'ddisa" (Stipa
tenacissima), cotone (Gossypium hirsutum), canapa (Cannabis sativa) e
molta lana (prodotta anche in altri paesi della ricerca), da ciò lo
sviluppo di una discreta attività artigianale inerente alla
trasformazione delle fibre. Così per esempio, giunto il lino a
maturazione, si falciava e si si consegnava ai marinai, i quali lo
seppellivano a mare per un certo periodo, giunto a maturazione, si
procedeva alla cardatura che consisteva nel battere il lino fino a
renderlo filamentoso; dopo di che si consegnava ai filatori, che lo
rendevano appunto in fili e si consegnava ai tintori. Cotone, agave,
lana, ampelodesmo, subivano lo stesso procedimento, tranne che per il
bagno in acqua di mare. Purtroppo questi mestieri sono scomparsi nella
zona. L'ultima fase della artigianale era rappresentata dalla tessitura
delle fibre, che si svolgeva in appositi telai. I prodotti più fini di
questo processo, cotone e lino, erano riservati per la dote delle
signorine delle famiglie più facoltose.
CARRETTIERE
Il
carrettiere era un trasportatore di merci varie, che andavano dai
prodotti stagionali della campagna al materiale da costruzione, al
carbone, al concime. Generalmente lavorava per conto terzi, proprietari
terrieri, commercianti e costruttori; raramente lavorava in proprio e
cioè comprando e rivendendo egli stesso la merce. I rapporti tra
produttori, acquirenti, carrettieri erano spesso curati da un sensale. I
carrettieri in linea di massima godevano di un mezzo di loro proprietà:
un carretto e un cavallo. La forma di pagamento era quella a viaggio, la
retribuzione era pattuita in base al percorso da compiere e al tipo di
trasporto; chi lavorava per conto terzi poteva essere retribuito anche
"a terzo", cioè percepiva un terzo del guadagno derivante dal
servizio di trasporto. La vita dei carrettieri era " 'nca si
caminava stratuna stratuna "( che si era sempre in giro per le
strade), lungo i percorsi si fermavano " nno funnacu "
fondaco, luogo di sosta dove i carrettieri albergavano assieme agli
animali e per mangiare" un piattu ri pasta agghiu e ogghiu "
(pasta con aglio ed olio) chiamata a tutt'oggi alla carrettiera, o
" all'asciuttu, pani cu cumpanaggiu " (pane con formaggio e
olive). Nei fondaci i carrettieri si scambiavano le loro esperienze di
vita, si informavano sui prezzi correnti nei vari paesi, ma soprattutto
cantavano a gara , sfidandosi a chi sapesse il canto più bello. Ragione
di incontro erano poi le fiere di bestiame e le feste religiose dove
essi convenivano insieme alle famiglie con cavallo e carretto riccamente
bardati. " Cacciari a misteri " , cioè guidare il cavallo a
regola d'arte è ciò che distingue un carrettiere vero da chi "
caccia a fumirari ", come un portatore di letame. L'appartenenza
alla loro categoria era avvertita con orgoglio; essi, con il fatto che
andavano in giro per la Sicilia, conoscevano molte persone, insomma si
consideravano profondi conoscitori della vita. Del mondo così
riccamente articolato dei carrettieri, che cosa è rimasto? Purtroppo
questo passato si presenta in maniera frammentaria nella memoria di
qualche anziano, un passato, però, cui si è rimasti affettivamente
legati, che non viene cancellato dalla propria storia. I carrettieri
hanno sostituito il mezzo di trasporto, divenendo per la maggior parte
camionisti o venditori ambulanti, chi tra essi ha conservato il
carretto, assegna a questo antico mezzo di trasporto un valore immenso,
come se si trattasse di un gioiello di famiglia. Il carretto oggi ha un
valore essenzialmente affettivo, esso è simbolo della vita del
carrettiere, una vita che ha profonde radici nella storia delle
generazioni, una storia sempre presente e viva nella memoria. I canti
dei carrettieri vivono ancora oggi numerosi e rappresentano una delle
espressioni più importanti della nostra musica etnica. In sostanza quei
canti, le specifiche  modalità della loro fruizione all'interno
dell'ambito sociale in cui sono vissuti confermano un concetto d'arte,
di arte popolare, come tecnica, come qualità privilegiata. modalità della loro fruizione all'interno
dell'ambito sociale in cui sono vissuti confermano un concetto d'arte,
di arte popolare, come tecnica, come qualità privilegiata.
CUFINARU
E FASCIDDARU
La
materia prima utilizzata da questa figura professionale era il giunco,
variamente intrecciato e lavorato in relazione anche al genere di pianta
utilizzata. Si trattava di attività periodica che assorbiva pochi mesi
dell'anno. I tipi di giunco cui si faceva solitamente ricorso erano due:
il primo (detto iunco munti),esile e lungo, era invece utilizzato nella
fabbricazione di fiscelle per formaggi e ricotta. Le tecniche di
lavorazione erano naturalmente diverse e richiedevano differenti
competenze ed abilità. Nel primo caso, in particolare, il giunco veniva
"cardato", schiacciato cioè per essere successivamente
sottoponibile alla torsione secondo un procedimento assimibile a quello
adottato nella tessitura della prima nana.
CURDARU
Il
luogo di lavoro del curdaru era la strada. Per questo speciale artigiano
qualsiasi spazio andava infatti bene, purchè abbastanza esteso da
consentire la stesura dei filati: le lunghe vie strette ed ombrose, le
piazzole retrostanti le chiese purchè poco frequentate. Nel condurre le
operazioni di filatura il curdaru metteva in mostra la sua maestria,
frutto di anni di apprendistato, ed una speciale abilità nel coordinare
i movimenti delle mani e dei piedi. L'attività nel suo complesso
richiedeva però la collaborazione esperta e fattiva, di più persone
ognuna delle quali impegnata in fasi che, più che succedersi, si
accavallavano. Il lavoro alla ruota manovrata a mano per imprimere
movimento alle pulegge, il bagno in vasche di pietra in cui venivano
immerse le matasse delle filacce, la lavorazione e la torsura delle
corde stese ad una certa altezza da terra, il successivo stenderle per
asciugarle: erano tutte operazioni regolate e successive che potevano
essere portate a termine con la fattiva collaborazione del gruppo di
lavoro.
MIETITORI
E SPIGOLATORI
Le
due attività, di mietitura e spigolatura, erano due lavori stagionali
concatenati, legati alla coltivazione del grano. La zona di riferimento
della ricerca non era e non è una zona cerealicola, quando a fine
giugno si cominciava a mietere il grano, dove questo era più coltivato
, era frequente assistere alla migrazione di numerosi contadini "viddana"
verso le zone cerealicole, attirati da un congruo guadagno, che faceva
dimenticare l'immane fatica del lavoro e la lontananza, anche se
temporanea, dai propri affetti più cari, al lavoro della mietitura
seguiva il lavoro più umile, ma non meno faticoso della spigolatura,
che consisteva nella raccolta delle spighe che rimanevano sul terreno
fuori dai covoni di grano, a queste due fasi seguiva la trebbiatura
delle spighe per dividere la granella dalla paglia (spagliari). Nella
zona di riferimento della ricerca la mietitura era riservata soprattutto
a quelle essenze foraggiere che costituivano il rifornimento essenziale
per i prosperosi allevamenti della zona.
PESCATORI
Reti,
nasse, molta audacia e conoscenza delle abitudini dei pesci erano e sono
gli arnesi dei pescatori della zona. Le reti e le nasse più che opere
di artigiani specifici erano il frutto del sacrificio del pescatore o
dei membri della sua famiglia, anche se l'intreccio delle nasse o la
tessitura delle reti richiede una particolare maestria, che potrebbe far
pensare a degli artigiani specifici. Per le reti un tempo si usava la
canapa o il cotone, questo tipo di materiale aveva bisogno di molta
manutenzione , infatti succedeva che qualche pesce restava tra le maglie
della rete ed imputridendo determinava la lacerazione della stessa ed il
pescatore era costretto a rammendare utilizzando uno speciale ago "vugghiola
" nella quale era avvolto il filo di cotone o di canapa, ora invece
si utilizza filo di nylon, che è molto più resistente e meno
attaccabile delle fibre naturali. Esistono diversi tipi di reti, che
assumono diversa denominazione in funzione del tipo di pesca svolta:
reti di posta con deriva (alalungara); reti di circuizione ("u
cianciolu "),che un tempo aveva la lunghezza di 250 m ed adesso se
ne tessono di 1000 m ; reti di posta senza deriva tremaglie o "
rrizzuolu "; reti da traino " a stràscinu " come la
paranza. Per la costruzione delle nasse la materia prima è costituita
dal giunco (detto iuncu munti), importato solitamente dalla provincia di
Catania. E' necessario tenerlo in acqua per 24 ore prima di cominciare
ad intrecciarlo in modo da formare le piccole maglie romboidali tipiche
delle nasse, che verranno utilizzate nella così detta pesca minore.
Nella fabbricazione delle nasse il pescatore comincia l'intreccio della
campana esterna, il cui anello terminale è costituito da una verga di
oleastro,si procede quindi alla tessitura della parte interna, a forma
di imbuto: i fili terminali di questa parte costituiranno la maglia a
trappola che impedisce ai pesci di uscire, una volta penetrati
all'interno della nassa. Fatti combaciare perfettamente la campana e
l'imbuto, il nassaru procede alla tessitura finale del coperchio. Le
nasse nella zona erano utilizzate soprattutto per la pesca degli "asineddi
", tipo di maenide (maena smaris). Per pescare questa specie
bisognava conoscere il ciclo della specie , infatti il periodo più
propizio era fra marzo e giugno, periodo in cui essa è nella stagione
dell'amore " u varu ", l'abilità del pescatore consisteva
nell'individuare il branco fra i fondali di "rinazzuolu ", che
è formato più da terriccio che da sabbia.
RICAMATRICI
Accanto
al mestiere della sarta, era praticata anche l'arte del ricamo. Spesso
esso era eseguito per l'allestimento della dote delle ragazze della
famiglia, ma non era raro trovare chi ricamava per le ricche signore del
paese e del vicino capoluogo, contribuendo così alle scarse finanze
familiari. Il lavoro del ricamo si svolgeva, a secondo della estensione
del capo da ricamare, o in un lungo telaio "tilaru ", in cui
si lavorava a quattro mani, o in un maneggevole telaio formato da due
cerchi concentrici, di diametro di 30 cm circa, in cui si incastra il
tessuto da spessore variabile ma mai più . I punti che maggiormente si
eseguivano nella zona erano:(i così detti punti sfilati) il 400, il 500
il 700 ; il punto ad intaglio ; il punto rodi ; il punto croce ; il
pittoresco ; il punto norvegese. Da menzionare assieme a questi punti
impegnativi ci sono pure ; il lavoro ai ferri, con i quali si facevano
calze e maglioni per tutta la famiglia, ed il lavoro ad uncinetto, che
è un piccolo ferro della lunghezza di 25 cm circa e di spessore
variabile ma mai più spesso di 3 mm, con il quale si riusciva a fare
anche delle bellissime copriletto matrimoniali.
 SAPONARO SAPONARO
Intorno
al 1900 uno dei mestieri tipici di Capaci era quello del saponaro. Il
sistema di fabbricare il sapone consisteva nell'utilizzare la morchia
"muria" (residuo dell'olio d'oliva), che il saponaro comprava
al frantoio locale o in quelli dei paesi limitrofi, oppure la reperiva
da persone che la compravano a loro volta in giro per i paesi "i
murialori ". La Muria veniva raccolta e conservata negli otri
" utra " (recipiente di pelle di capra) e poi lavorata con l'
aggiunta di cenere (ottima quella di scorza di mandorle verdi ), che
contiene potassio, questo ultimo serviva per fare avvenire l'idrolisi
alcalina degli acidi grassi . Il tutto poi veniva versato in un tipico
recipiente "quarara " dalla capienza variabile, ma mai
inferiore a 500 l, e fatto bollire nell'apposita " Fornacella"
col buco nel centro. Questo recipiente era collegato con dei tubi a
delle vasche. Dopo cinque ore di cottura, il sapone, che via via si
formava finiva nelle vasche di raffreddamento dove veniva rimosso spesso
con l'aiuto di una cazzuola da muratori, quindi veniva conservato in
delle latte o barili e pronto per la vendita. Quando il sapone riusciva
troppo molle veniva chiamato "trema-trema". Se si voleva che
il sapone assumesse una colorazione verde, nella prima fase di cottura
si aggiungevano dei rami di fico d'india "pale ". Il sapone
che si otteneva nella zona, appunto per l'utilizzo del potassio e non
del sodio, era quello molle, che si usava per lavare la biancheria.
SIGGIARU
Quella
del siggiaru era un'attività lavorativa semiprofessionale, in quanto
integrata periodicamente con attività consimili.Oltre che costruttore
di sedie, quest'ultimo, svolto per le strade dei paesi e dei quartieri
urbani. Il lavoro di costruzione di una sedia era costituito da due fasi
distinte. La prima consisteva nella sacomatura, nell'intaglio e
nell'incollaggio delle aste di legno lavorate variamente (ncavigghiari i
seggi era il modo di intendere complessivamente questo complesso di
operazioni). La seconda fase, spesso riservata alla collaborazione dei
membri della famiglia, moglie e figlie in primo luogo, consisteva invece
nell'intreccio e nella definizione del fondo della sedia (ntranari i
seggi era l'espressione usata per indicare questo secondo complesso di
operazione). L'abilità dell'artigiano si manifestava nella sicurezza
con cui incideva e rifiniva i singoli elementi, al fine di poterli
successivamente assemblare senza alcuni intervento correttivo. Nella
tessitura del fondo della sedia si manifestava invece, accanto
all'abilità, il gusto delle decorazioni e delle varianti ad un modello
sostanzialmente unitario.
STAGNINO
Un
altro dei mestieri che resiste ma che un tempo era molto praticato è
quello dello stagnino "stagnaru". L'artigiano aveva due luoghi
di esecuzione della sua professione; nel laboratorio e nelle strade. Il
lavoro consisteva nel fare le saldature a stagno per
"aggiustare" vari tipi di recipienti metallici; pentole,
pentoloni "quarare, contenitori di lamiera per l'acqua da usare
nelle abitazioni "quartare, ma soprattutto nel passare o ripassare
uno strato di zinco all'interno delle pentole di rame. Quest'ultima
operazione era necessaria per poter utilizzare le suppellettili di rame,
perchè esso rilascia una sostanza tossica a contatto con gli alimenti,
lo strato di zinco creava un sicuro isolante. Gli arnesi che erano usati
dallo stagnino erano: delle grosse forbici per tagliare le lamiere da
utilizzare per rattoppare, un ferro per fondere lo stagno ed applicarlo
nei posti dove era necessario, la forma di questo arnese era più o meno
quella di un martello di ferro con la parte finale del manico composta
di materiale termoisolante in considerazione del fatto che la parte
metallica veniva immersa nella brace incandescente, delle barrette; di
una lega di stagno e piombo (per le saldature dolci) di una lega di
zinco rame e piombo (per le saldature forti), dei martelli di varia
dimensione per sagomare i rattoppi di lamiera. Il metodo di saldatura
sfruttava la diversa fusione dei metalli, il ferro aveva la stessa
funzione dei moderni saldatori per i circuiti elettrici, ma a differenza
di questo era riscaldato col fuoco quindi strumento indispensabile per
gli stagnini era un fornello per il fuoco, che spesso era una normale
latta di quelle usate per le riserve alimentari, la latta era riempita
di carbone, al quale si dava fuoco fino a ridurlo in brace.
ZIMMILARU
La
materia prima impiegata in questa attività era costituita dalla palma
nana (Chamaerops humilis) "giummara" di cui venivano
utilizzate sia le foglie lanciformi che la parte centrale, tenera e
filamentosa (curina). La pianta veniva divelta nel periodo primaverile e
lasciata ad essiccare al sole, per poi lavorarne le foglie nel periodo
estivo. Si fabbricavano scope e scopini di vario tipo e destinati ad usi
diversi. Dalla parte centrale della pianta si ricavavano invece
cordicelle ed intrecci vari utilizzati successivamente nella tessitura
di contenitori. Lo zimmini (da cui la denominazione dell'operatore)
costituiva il contenitore di derrate agricole cui si faceva più
ricorso. Lo zimmilaru svolgeva la treccia ripiegandola ogni volta verso
il basso, in modo che le punte delle lacinie laterali si accavallassero
su quelle interne, alternativamente, assumendo la conformazione di una
spina di pesce.
|
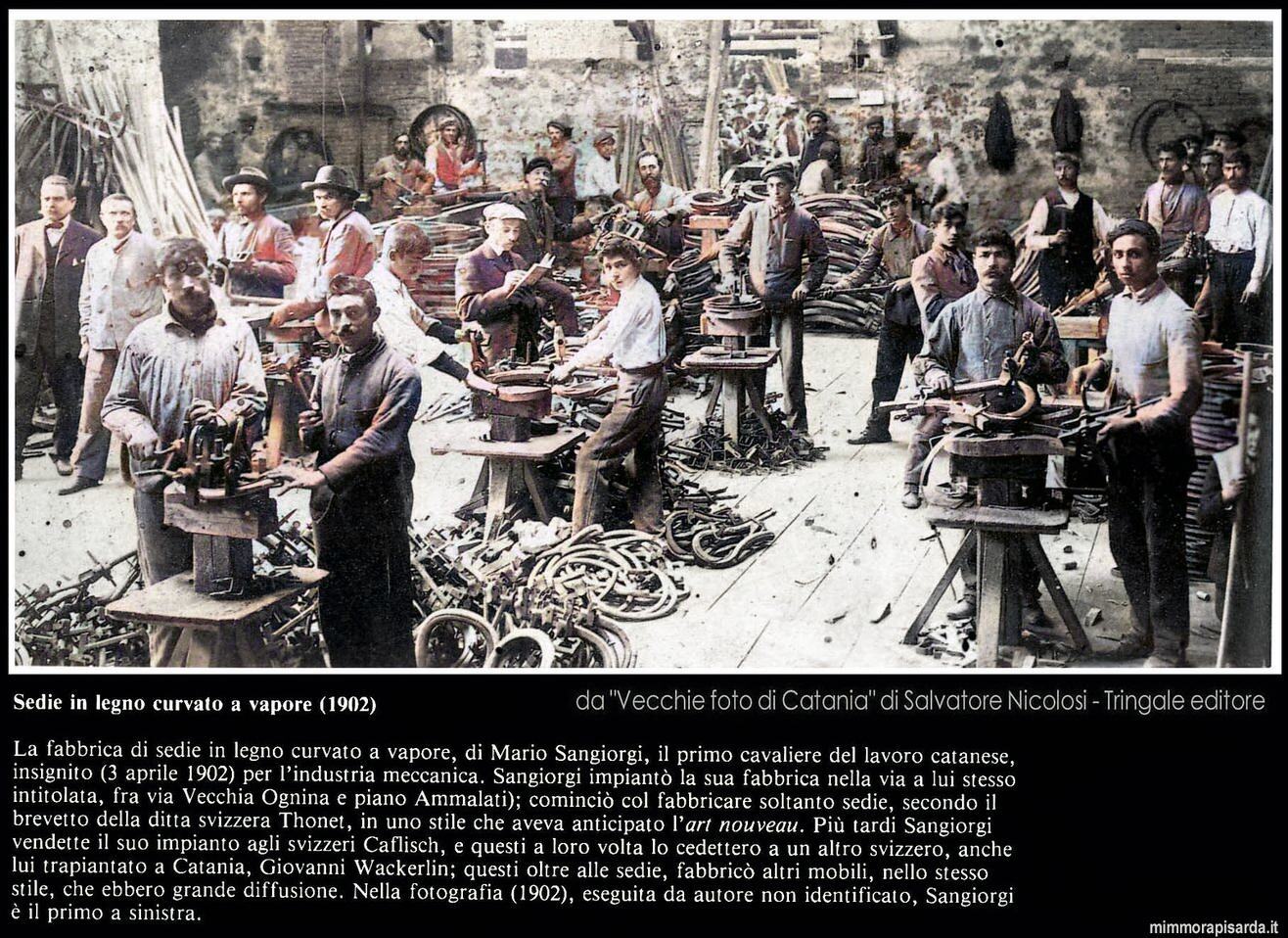

Da «uòrrica/morti» a «pisciaru» - i soprannomi in mestieri e lavori
In un saggio curato da Giovanni
Ruffino una Sicilia che non c'è più e un ricco vocabolario per
conoscere meglio il nostro dialetto
Sabato 10 Luglio 2010
Cultura&SocietàCT, pagina 25 e-mail print Salvatore Claudio Sgroi
«Mestieri e lavoro nei soprannomi
siciliani» di Giovanni Ruffino, sottotitolo «Un saggio di
geoantroponomastica», con la collaborazione di E. D'Avenia, A. Di
Giovanni e G. Rizzo, e con un dvd su «zzimmilaru/cuffaru» (chi fa
bisacce e ceste) di G. Rizzo, pp. 388 (in quarto, carta patinata),
edito dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani di
Palermo, è un grande libro che contiene più libri. E quindi un libro
complesso di non comune ricchezza, e anche di notevole visibilità
iconico-figurativa.
E' un libro con più oggetti di
analisi: nomi comuni di persona indicanti mestiere e soprannomi
siciliani (in primo piano nel titolo), spesso scomparsi. Messi a
fuoco da più punti di vista. Un libro che ricostruisce un'immagine
della Sicilia che non c'è più, o votata al passato. Un libro sì
di/per specialisti ma pienamente godibile anche per gli appassionati
del dialetto siciliano e dei dialetti italiani. Un testo da studiare
a fondo per la conoscenza della realtà dialettale italiana, ma anche
disponibile per la puntuale consultazione di questo o quel
soprannome/nome di mestiere. Ordinati in un vocabolario di circa 300
parole nella sezione centrale del testo (oltre 100 pp.), fittissime
di dati geo e socio-linguistici, iconografici, antroponomastici,
storico-etimologici, puntualmente documentati con una bibliografia
di oltre 250 titoli. Il rilevamento dei nomi comuni di persona
indicanti mestieri, spesso presenti ne "i ngiurii" (a Catania "i
pèccura") muove sia da tale bibliografia sia da inchieste sul campo
in circa 200 località delle nove provincie siciliane (con la
collaborazione anche di bravissimi laureandi in dialettologia).
La funzione principale del
soprannome è la "identificazione" referenziale di un individuo
all'interno di una comunità essenzialmente rurale, e si affianca
come apposizione a quella ufficiale del nome e del cognome, quando
non lo sostituisce. La "motivazione" del soprannome, per essere
correttamente colta, se non ignota agli stessi protagonisti (come
per es. «varbariscaru» e «calamiddaru» «cardatore»), richiede
l'indagine nell'ambiente sociale in cui la voce è vitale, come in
particolare ha ben sottolineato a suo tempo A. Marrale (1990). Ed è
qui testimioniata dai frammenti di interviste-etnotesti, spesso
presenti nei 300 soprannomi. Un es., straordinario, è «Tènziu»: il
banditore che «ogni ccantunera iva vanniannu "tenziò", ca vuol diri
"attenzioni"». E «a fforti di diri "tenziù!" ogni ccosa ca si
pirdìa, dici, 'va nni "Tenziù", e cci scieru "Tènziu"».
Ai fini della motivazione del
soprannome, l'etnotesto è ben più attendibile del significato
puramente linguistico-lessicografico. Così "lann/aru" è sì «stagnaio
ambulante» e «venditore di stoffe e di biancheria ricamata», ma
etnograficamente del tutto "impertinenti", in quanto a Mazzarino «cci
dicìvanu "Lannara" pròpriu picchì tutti li lanni vicchi li iva
rricampannu idda». O è essenziale la duplice motivazione di "siggi/ara"
fornita dai protagonisti. A Bagheria: «A zza Vicenza a Siggiara»
perché riscuoteva i soldi per le sedie in chiesa. Invece a Ravanusa:
«Vanniava: 'cu è ca av'âggiustari seggi?'… e cci rristà "Siggiara"».
O ancora a Mazzarino «piscam/aru» «pirchì vinnia a piscami»,
trasferito anche al fratello (non pescivendolo) e a tutta la
famiglia. E a Campofranco: «Pisci/aru» perché andava «âccattari
pisci, sempri pisci, pisci, pisci, pisci e rristà Totò Pisciaru».
Diversamente, al dialettologo rimane solo la definizione puramente
lessicale, così «ammola/cutedda» "arrotino". Ovvero lo scavo
linguistico-etimologico del termine, decontestualizzato e spesso
glottologicamente oscuro.
I circa 300 nomi, corredati con
oltre 100 foto e disegni della cultura materiale, sono in prevalenza
suffissati per es. "cuff/aru", "varv/eri", "gginis/anu", "pirria/turi",
"bazzari/otu", ecc., ma pure composti("piatte/llemmi", "uòrrica/morti",
e proprio di Licata "du sali" «venditore del sale»), o prestiti: "criata",
l'angloamericanismo "scimeccu" «calzolaio», ecc. I 300 nomi sono
quindi proiettati in 12 preziose inedite cartine geografiche della
Sicilia, sì da visualizzare la loro distribuzione geografica nei
circa 200 punti di inchiesta. I dati dialettali siciliani sono
inoltre messi a confronto con i dati di 34 cartine dei dialetti
italiani dell'Ais, Atlante dialettale italiano e svizzero di
Jaberg-Jud (1928-40), rimesse qui a disposizione per comodità del
lettore.
Il lessico dei nomi comuni di
persona indicanti mestieri, secondo la migliore tradizione
dialettologica di "Parole e cose", ha infine un triplice prezioso, e
per lo più inedito, corredo iconico di studiosi illustri
(sommessamente indicato come "Appendici"): 64 fotografie di G.
Rohlfs (1922-28), 16 di P. Scheuermeier, e 64 disegni di P. Boesch
(1930), che anche editorialmente impreziosiscono non poco il volume.
E sorvoliamo sugli Indici di parole, antroponimi e nomi propri,
essenziali per una puntuale consultazione. Al lettore, avido, che
non si accontentasse di questo volume, preannunciamo la
pubblicazione, da parte dello stesso presidente del Centro
palermitano, di un ulteriore volume sui nomi di persona indicanti
mestieri della Sicilia, al di là del loro legame con i soprannomi.
10/07/2010
GRANDI DINASTIE IMPRENDITORIALI CATANESI
I PORTO (Liutai)
Rosario Porto,Catanese,fondò nel 1860 l'omonima
casa per la produzione di strumenti musicali e di pizzico che,sotto
l'impulso dei figli,estese anche a quella di pianoforti,organi e
organetti a mantice e strumenti di ottone usando il marchio "Excelsior".
Porto realizzò una delle fabbriche di strumenti
musicali piu' importanti in Italia localizzata,inizialmente,in via
Maddem 141 e a partire dal 1903 in via Porto 2.
Per comprendere le dimensioni della loro attività
imprenditoriale,ecco uno stralcio di articolo dell'epoca:"La più
grande ed importante fra le fabbriche catanesi di istrumenti
musicali è quella della ditta Rosario Porto e Figli, che per il suo
vasto impianto, la bontà universalmente riconosciuta della immensa
varietà di strumenti che sorgono dalle sue officine, eccelle non
solo sulle sue consorelle siciliane, ma eziandio su tutte le altre
case consimili italiane. Fu fondata nel 1860, e quasi mezzo secolo
di attività utilmente utilmente spesa ha progressivamente allargato
la cerchia dei suoi affari sì da permetterle di potère soddisfare
qualunque richiesta le venga fatta tanto da dilettanti che da
professori di musica. Il suo grande catalogo illustrato, che
gratuitamente viene spedito a chiunque ne faccia richiesta [...]
enumera tutte le specialità che essa fabbrica, e fra le principali
di queste troviamo,oltre ad un grande assortimento di strumenti a
corda, quali mandolini, chitarre, violini, viole,violoncelli,
contrabbassi, di ogni qualità e prezzo, dal tipo più corrente da
poco prezzo, a quello di lusso, fabbricato con eccezionale
ricchezza, un lungo elenco di altri. Pianoforti,
harmonium,pianoforti a manubrio e piani melodici, piani concerto e
organetti a mantice, organi da chiesa,a flauti, trombe e ottoni di
qualunque tipo, tutto insomma quello che può prodursi in fatto di
musica qui viene fabbricato.
Lo stabilimento occupò sino a 350 operai (1907).
Franz Cannizzo
LE GRANDI DINASTIE IMPRENDITORIALI CATANESI : I
FICHERA (liquirizia)
Quello postato è un documento
fotografico,dell'Archivio di Stato Italiano,datato 1894,che fu
presentato in Prefettura,a Catania, dall'imprenditore Bernardo
Fichera per la registrazione del marchio Sanagola.
Bernardo Fichera fondò a Catania l'omonima
fabbrica di liquirizia nel 1840.I figli Antonio,Concetto,che divenne
Presidente della Camera di Commercio di Catania dal 1910 al 1919 e
Giovanni Battista, aggiunsero alla ditta la produzione di conserve
alimentari.
Specialità della casa fu la Sanagola.
Sotto forma cooperativa istituirono una mutua
interna per l'assistenza sanitaria,ed elargirono,nei primi anni del
Novecento,legati nuziali di 100 e 200 lire alle operaie che andavano
a nozze.
Dal punto di vista storico,tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, l’industria italiana della
liquirizia aveva i suoi stabilimenti nell’Italia
meridionale.Iniziata alla fine del Seicento con le prime produzioni
calabresi che da Livorno raggiungevano i principali mercati
dell’Europa, la cultura industriale dell’estrazione si diffuse
all’inizio del Settecento in altre aree della penisola come la
Sicilia, minacciando la supremazia qualitativa e quantitativa dei
produttori spagnoli.
Nella seconda metà dell’Ottocento la liquirizia,
molto richiesta per le sue proprietà coloranti e medicinali,
occupava un posto di rilievo tra i prodotti agricoli oggetto di
coltivazione, lavorazione e commercio nel territorio etneo. I
processi produttivi erano di tipo artigianale: dalle radici della
liquirizia, infuse in acqua calda fino ad addensarsi, si otteneva
l’estratto da confezionare in bastoncini, pastiglie o sciroppi.
Nell’ultimo decennio del'Ottocento Catania era
tra le massime produttrici della liquirizia, esportataverso le città
italiane ed europee e, persino, in Giappone e in Australia.
I maggior stabilimenti per la lavorazione delle
radici e del succo di liquirizia, sorgevano nell’area, compresa tra
i quartieri San Cristoforo e Fortino (lo stabilimento di Fichera,chiuso
a metà degli anni '70 del secolo passato e si trova in via Mulini a
Vento). Spiccavano tra gli imprenditori,gli stranieri Adamo
Kaemmerer, Ottone Geleng, Jacques Ritter, i fratelli Bartolomeo e
Cristiano Caflish.
Adamo Kaemmerer che possedeva una fabbrica anche
a Taranto con il marchio “Guisberti”, per le biglie di liquirizia
prodotte a Catania scelse un marchio con l’immagine di una corona
reale e la parola “Regina”.
Il marchio utilizzato dalla ditta Bernardo
Fichera, sin dalla fondazione, dava risalto alle proprietà
medicinali del prodotto: la parola in corsivo “Sanagola”, sotto la
quale era disposta la scritta a caratteri maiuscoli
PASTIGLIE-LIQUIRIZIA FICHERA, era ospitata in cima a una conchiglia,
posta ad ornamento di un busto femminile con abito scollato, braccia
nude e capo coperto da un velo spagnoleggiante; ai lati della figura
femminile si disponevano due scritte a caratteri maiuscoli, l’una
"CONTRO L’INFLUENZA E LA RAUCEDINE" a destra e a sinistra l’altra
"LA TOSSE FACILITA L’ESPETTORAZIONE".
Il mercato della liquirizia crollò dopo la Prima
Guerra Mondiale.
Cannizzo
I GALATOLA (tipografia)
La fotografia di oggi riprese,agli inizi del
Novecento,parte dei macchiari dell'Officina Tipografica Galàtola,in
via Crociferi,nel Collegio dei Gesuiti.
Crescenzio Galàtola e i Suoi discendenti
condussero a Catania dalla metà del diciannovesimo secolo fino al
1929 la loro importante attività imprenditoriale,che operò nella
stampa e nell'editoria.
Il capostipite,Crescenzio Galàtola, (Napoli,1813
- Catania,1866), giunse a Catania da Napoli nel 1843 e costitui',
quasi dal nulla, la scuola tipografica del Reale Ospizio di
beneficenza,i cui lavoranti popolarono le tipografie della città.
Il mondo della scienza, rappresentato
dall'Accademia Gioenia e l'Università, la Pubblica Amministrazione,
la Diocesi e i più significativi personaggi della cultura del tempo,
a partire da Capuana, Verga, Rapisardi, fino a De Roberto,che della
famiglia fu particolarmente intimo, si rivolsero ai Galàtola per la
stampa delle loro pubblicazioni. Tra le edizioni Galàtola, anche
importanti dizionari dialettali e la raccolta dei Canti popolari di
Lionardo Vigo, a testimonianza di un'attenzione anche per la cultura
popolare siciliana.
In particolare,dal 1840,su iniziativa del
fondatore Crescenzio,lo Stabilimento Galàtola si insediò con una
scuola professionale tipografica, in via dei Crociferi nei locali
del Reale Ospizio di Beneficenza,già Collegio dei Gesuiti.
Nella seconda metà dell’Ottocento, il settore
poligrafico-editoriale contava in Sicilia poco più di duecento
imprese, talora ad esclusiva conduzione del proprietario, poiché
spesso il reddito di lavoro non riusciva a coprire l’intero arco
dell’anno. Erano piccoli esercizi a struttura artigianale, che
impiegavano pochi lavoratori; in luogo dei moderni macchinari,
disponevano di qualche torchio ed erano costretti a importare ogni
cosa, compresi i caratteri tipografici, gli inchiostri e, persino,
la carta, a causa dello scarso numero di cartiere isolane.Catania
nel 1871 possedeva 10 librerie e 12 tipografie con 4 torchi a
macchina e 39 a mano; i lavoratori impiegati erano poco meno di un
centinaio.
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento, in Sicilia si registrò una crescita del settore
poligrafico-editoriale. A Catania le tipografie erano 13 nel 1884,
17 nel 1894, 21 nel 1902. Per la modernità dei macchinari, prodotti
dalle migliori marche straniere e per la qualità dei caratteri,
primeggiavano quattro ditte: la Giacomo Pastore, che era la più
antica fondata nel 1779, la Nicolò Giannotta, la Fenice di Giuseppe
Musumeci e la Crescenzio Galàtola.
Cannizzo
GLI SCANNAPIECO (legnami)
Vincenzo Scannapieco (Cava dei
Tirreni,Salerno,1849 - Catania,1930) si trasferi' a Catania nel 1876
dove,dieci anni dopo,fondò un'azienda per l'industria e il commercio
dei legnami, arricchendola,nei primi dello scorso secolo,di una
segheria a vapore che dava lavoro a ben 150 operai.Un'attività mai
esistita fino ad allora.
Vi era anche un reparto per la fabbricazione di
cassette per gli agrumi che impiegava altri 50 operai.Per questi
meriti fu nominato cavaliere del lavoro.Catania ha dedicato una via
al Suo nome.
Quella in fotografia era la Sua residenza
abituale,un vero e proprio piccolo castello,costruito nel 1907 in
via Duca degli Abruzzi ai numeri 65 - 69,in un linguaggio eclettico
(Eclettismo-liberty catanese) in stile classico-barocco
dall'architetto Francesco Fichera.
Qui al primo piano,organizzò il ricevimento
nuziale della figlia,a cui parteciparono centinaia e centinaia di
invitati.
Cannizzo
|
 |
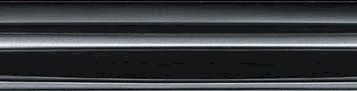
|
 |
|
|
|
|

|
|
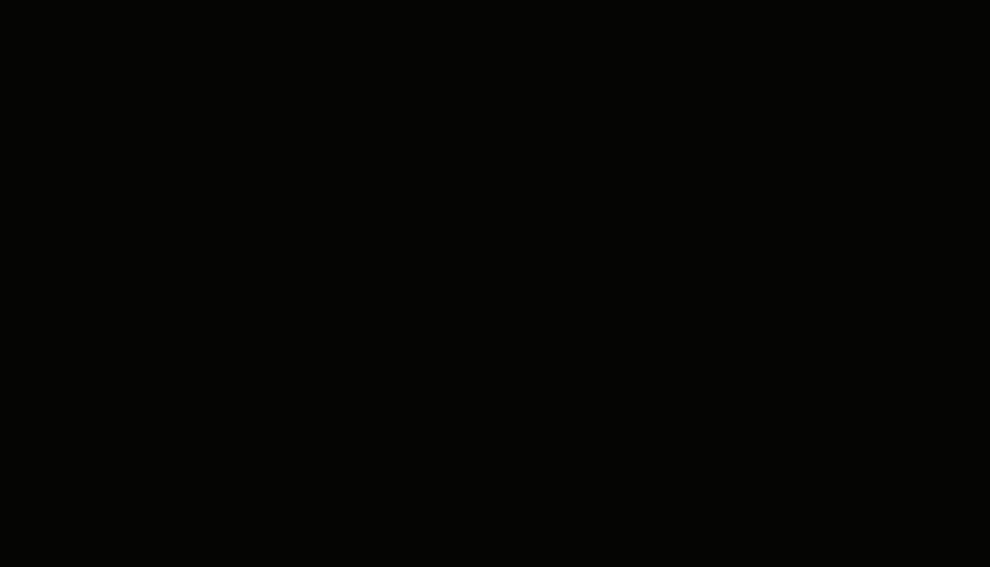

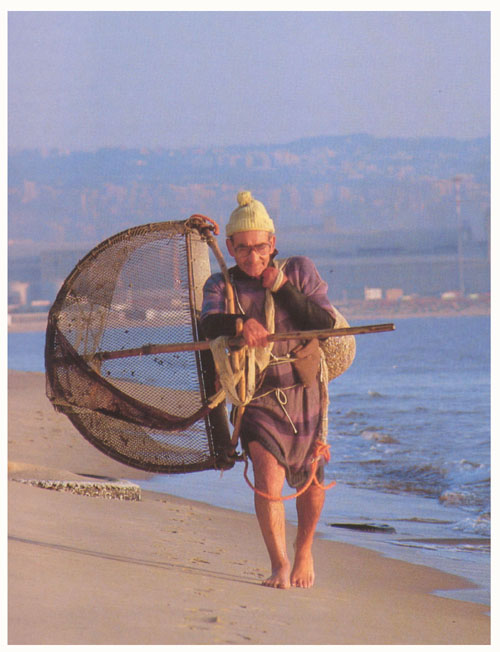

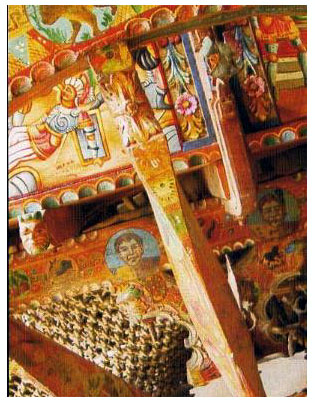 Fra
l'ottocento e la prima metà del novecento, si sviluppò nella vivace
Catania e nell'area etnea una fiorente attività artigianale: quella
dell'allestimento e della decorazione artistica del carretto.
Fra
l'ottocento e la prima metà del novecento, si sviluppò nella vivace
Catania e nell'area etnea una fiorente attività artigianale: quella
dell'allestimento e della decorazione artistica del carretto.
 Testimone
ne è il suo "Museo del Carretto Siciliano" a Bronte, che
racconta in fondo anche la storia della sua famiglia. Il padre, don
Affiu Gullotti, era infatti "Carrettiere di linea", un odierno
autotrasportatore, che all'epoca portava vino, frumento, frutta e
carbone, dalle campagne ai centri abitati e così in tutta l'Isola.
"Il mio primo viaggio da solo - racconta don Cammelu -, lo ricordo
come fosse ieri, lo feci ad otto anni andando col carretto a Pedara per
trasportare vino. Per caricare non c'erano problemi poich‚ vi erano
gli appositi carricaturi i carrettu". E poi in viaggio, con il lume
del carrettiere e il paracqua appesi fra le due ruote alla preziosa
"cascia i fusu" (copri asse ricco di piccole sculture in ferro
battuto decorato).
Testimone
ne è il suo "Museo del Carretto Siciliano" a Bronte, che
racconta in fondo anche la storia della sua famiglia. Il padre, don
Affiu Gullotti, era infatti "Carrettiere di linea", un odierno
autotrasportatore, che all'epoca portava vino, frumento, frutta e
carbone, dalle campagne ai centri abitati e così in tutta l'Isola.
"Il mio primo viaggio da solo - racconta don Cammelu -, lo ricordo
come fosse ieri, lo feci ad otto anni andando col carretto a Pedara per
trasportare vino. Per caricare non c'erano problemi poich‚ vi erano
gli appositi carricaturi i carrettu". E poi in viaggio, con il lume
del carrettiere e il paracqua appesi fra le due ruote alla preziosa
"cascia i fusu" (copri asse ricco di piccole sculture in ferro
battuto decorato).
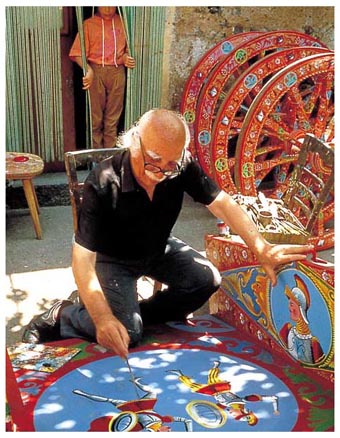




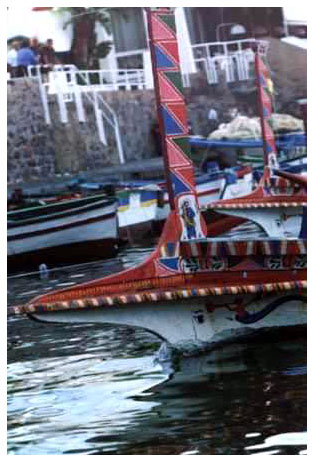 d’a ‘ncannata, ‘i ciumi, varchi… e si potrebbe
continuare ancora nell’elenco in quanto era abitudine del siciliano
nominare il tipo di barca non in base alle sue caratteristiche
costruttive, ma all’uso che se ne faceva.
d’a ‘ncannata, ‘i ciumi, varchi… e si potrebbe
continuare ancora nell’elenco in quanto era abitudine del siciliano
nominare il tipo di barca non in base alle sue caratteristiche
costruttive, ma all’uso che se ne faceva.  n
questo contesto, come già accennato, lo sviluppo della piccola
cantieristica tradizionale fu notevole ed i tipi di imbarcazioni
innumerevoli. Classificare questo vasto patrimonio culturale è compito
arduo soprattuto per la mancanza di documentazioni storiche dal momento
che l’arte costruttiva si tramandava di generazione in generazione in
modo esclusivamente artigianale.
n
questo contesto, come già accennato, lo sviluppo della piccola
cantieristica tradizionale fu notevole ed i tipi di imbarcazioni
innumerevoli. Classificare questo vasto patrimonio culturale è compito
arduo soprattuto per la mancanza di documentazioni storiche dal momento
che l’arte costruttiva si tramandava di generazione in generazione in
modo esclusivamente artigianale.
 etro. Erano riccamente decorate in modo similare ai carretti
siciliani e rappresentavano le barche sicuramente più prestigiose. Molto
slanciate, simili ad un pesce spada, armate di vela latina o "vela al
carro" con l’aggiunta del fiocco e di un piccolo albero di
bompresso, poppa e prora ampiamente pontate, venivano chiamate anche
"varchi cù speruni".
etro. Erano riccamente decorate in modo similare ai carretti
siciliani e rappresentavano le barche sicuramente più prestigiose. Molto
slanciate, simili ad un pesce spada, armate di vela latina o "vela al
carro" con l’aggiunta del fiocco e di un piccolo albero di
bompresso, poppa e prora ampiamente pontate, venivano chiamate anche
"varchi cù speruni". Le
"varche ‘i conzu" o "varche cù speruni e palummedda"
di Santa Maria della Scala e di Ognina, sicuramente le più complete
e fedeli in quanto costruite dal maestro maestro d’ascia detentore
dell’antica arte Ignazio Garozzo presso il cantiere navale situato in
Piazza Mancini Battaglia CT nell’anno 1982. Riportati agli antichi
splendori nello stesso cantiere nell’anno 2009 dallo stesso Mastro d’ascia
e decorati dal prof. Salvatore Finocchiaro, decoratore di Aci Trezza.
Le
"varche ‘i conzu" o "varche cù speruni e palummedda"
di Santa Maria della Scala e di Ognina, sicuramente le più complete
e fedeli in quanto costruite dal maestro maestro d’ascia detentore
dell’antica arte Ignazio Garozzo presso il cantiere navale situato in
Piazza Mancini Battaglia CT nell’anno 1982. Riportati agli antichi
splendori nello stesso cantiere nell’anno 2009 dallo stesso Mastro d’ascia
e decorati dal prof. Salvatore Finocchiaro, decoratore di Aci Trezza.
 di: "Via Rodolico". Gli strumenti utilizzati al tempo, per dar
vita alle barche di legno, erano l'ascia, la sega a mano, il chianozzo
(pialla a mano), il chiano (pialla lunga) e i virrina (i trapani a mano).
Gli anni '60 segnano l'inizio di una stagione florida per il cantiere che,
passato nelle mani di Salvatore Rodolico (figlio di Sebastiano), comincia
a costruire imponenti pescherecci di legno. Le commesse erano tantissime:
arrivavano dalla Toscana, dalle isole Eolie e dall'isola D'Elba. Intanto
il cantiere si era stanziato all'interno del porto di Acitrezza,
di: "Via Rodolico". Gli strumenti utilizzati al tempo, per dar
vita alle barche di legno, erano l'ascia, la sega a mano, il chianozzo
(pialla a mano), il chiano (pialla lunga) e i virrina (i trapani a mano).
Gli anni '60 segnano l'inizio di una stagione florida per il cantiere che,
passato nelle mani di Salvatore Rodolico (figlio di Sebastiano), comincia
a costruire imponenti pescherecci di legno. Le commesse erano tantissime:
arrivavano dalla Toscana, dalle isole Eolie e dall'isola D'Elba. Intanto
il cantiere si era stanziato all'interno del porto di Acitrezza, 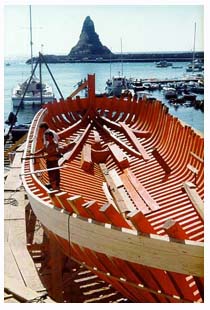 proprio
dirimpetto all'isola Lachea, mentre andava sviluppandosi la pesca con i
pescherecci anche a Trezza. Grazie alla gran quantità di commesse, anche
da Acitrezza, il cantiere diede in quegli anni lavoro a più di 20
persone. Oggi non costruisce più imponenti pescherecci, l'ultimo risale
al 1989, ma continua ad esistere grazie ai lavori di manutenzione e
costruzione di piccole barche di legno. Passato in mano al giovane
Sebastiano Rodolico
(figlio di Salvatore) continua nella sua secolare arte
di dar vita alle barche a legno. La tecnica, seppur con qualche variante
dovuta alla nuova tecnologia, è sempre la stessa: "il fasciame di
legno viene attaccato con la chiodatura zincata, poi il comento (le
fessure tra un legno e l'altro) vengono chiuse con la stoppa catramata e
quindi con la lanata (un pennellone) si passa, sul fasciame esterno, la
pece per proteggere lo scafo (oggi sostituita con stucchi e
pittura)". Le barche che solcano il mare di Trezza sono resistenti
come una volta e l'arte dei maestri d'ascia attira, oggi anche, tantissimi
turisti che percorrendo il Lungomare dei Ciclopi rimangono estasiati nel
vedere quegli artigiani al lavoro.
proprio
dirimpetto all'isola Lachea, mentre andava sviluppandosi la pesca con i
pescherecci anche a Trezza. Grazie alla gran quantità di commesse, anche
da Acitrezza, il cantiere diede in quegli anni lavoro a più di 20
persone. Oggi non costruisce più imponenti pescherecci, l'ultimo risale
al 1989, ma continua ad esistere grazie ai lavori di manutenzione e
costruzione di piccole barche di legno. Passato in mano al giovane
Sebastiano Rodolico
(figlio di Salvatore) continua nella sua secolare arte
di dar vita alle barche a legno. La tecnica, seppur con qualche variante
dovuta alla nuova tecnologia, è sempre la stessa: "il fasciame di
legno viene attaccato con la chiodatura zincata, poi il comento (le
fessure tra un legno e l'altro) vengono chiuse con la stoppa catramata e
quindi con la lanata (un pennellone) si passa, sul fasciame esterno, la
pece per proteggere lo scafo (oggi sostituita con stucchi e
pittura)". Le barche che solcano il mare di Trezza sono resistenti
come una volta e l'arte dei maestri d'ascia attira, oggi anche, tantissimi
turisti che percorrendo il Lungomare dei Ciclopi rimangono estasiati nel
vedere quegli artigiani al lavoro.





 "L'oro
dei Napoli". Su testi di Salvatore Zinna, la storia di questa
straordinaria famiglia, nota in tutto il mondo, applaudita in ogni parte
ma, spesso ed ancora oggi, dimenticata proprio a Catania
"L'oro
dei Napoli". Su testi di Salvatore Zinna, la storia di questa
straordinaria famiglia, nota in tutto il mondo, applaudita in ogni parte
ma, spesso ed ancora oggi, dimenticata proprio a Catania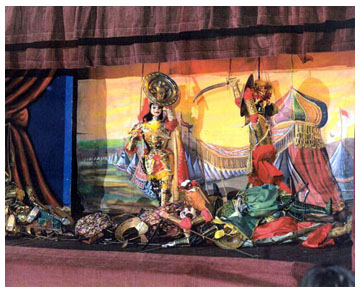 uello che narra la storia,
che rappresenta e che muove le fila di questa famiglia e che, durante lo
spettacolo, apre lo scrigno dei ricordi e da vita ad una pièce che
emoziona, che interessa grandi e piccini.
uello che narra la storia,
che rappresenta e che muove le fila di questa famiglia e che, durante lo
spettacolo, apre lo scrigno dei ricordi e da vita ad una pièce che
emoziona, che interessa grandi e piccini. pettacoli senza cuore, solo commerciali
e poi la mancanza di una sede istituzionale per una famiglia che ha già
conquistato un posto tra i miti. Lo spettacolo, prodotto da Arcana, si
avvale delle musiche di Third Earl Band, Gonzales, Comelade, Salvi,
Mahler, Jarret, Martens, Verdi e Bregovic. Uno spettacolo da vedere, un
viaggio nella nostra storia, nei nostri ricordi, grazie ad una
straordinaria famiglia da proteggere gelosamente e che custodisce il
segreto delle tradizioni e di un mestiere eterno, quello dei miti.
"Il nostro è un lavoro corale - spiega Fiorenzo Napoli - e questa
tradizione vive in quanto è supportata dal lavoro di tutti. Il presente
sono io, i miei fratelli, Salvatore e Giuseppe, mia moglie Agnese, mio
cugino Alessandro. Il futuro è rappresentato dai miei figli, Davide,
Dario e Marco".
pettacoli senza cuore, solo commerciali
e poi la mancanza di una sede istituzionale per una famiglia che ha già
conquistato un posto tra i miti. Lo spettacolo, prodotto da Arcana, si
avvale delle musiche di Third Earl Band, Gonzales, Comelade, Salvi,
Mahler, Jarret, Martens, Verdi e Bregovic. Uno spettacolo da vedere, un
viaggio nella nostra storia, nei nostri ricordi, grazie ad una
straordinaria famiglia da proteggere gelosamente e che custodisce il
segreto delle tradizioni e di un mestiere eterno, quello dei miti.
"Il nostro è un lavoro corale - spiega Fiorenzo Napoli - e questa
tradizione vive in quanto è supportata dal lavoro di tutti. Il presente
sono io, i miei fratelli, Salvatore e Giuseppe, mia moglie Agnese, mio
cugino Alessandro. Il futuro è rappresentato dai miei figli, Davide,
Dario e Marco".








 Sotto
le sue mani abilissime, lo stanzone che accoglieva ogni sera centinaia
di spettatori urlanti, divenne un teatro vero e proprio, ed il numero
dei pupi passò dalla trentina al centinaio. Ma Pennisi, oltre al teatro
ed ai Pupi, ha regalato al folklore siciliano anche il suo successore,
Emanuele Macrì. Nel 1908, infatti, non appena seppe del disastro di
Messina, partì con una squadra di operai che l´aiutarono per due
giorni e per due notti sotto una pioggia battente, a disseppellire la
sua famiglia del suo vecchio amico Macrì.
Sotto
le sue mani abilissime, lo stanzone che accoglieva ogni sera centinaia
di spettatori urlanti, divenne un teatro vero e proprio, ed il numero
dei pupi passò dalla trentina al centinaio. Ma Pennisi, oltre al teatro
ed ai Pupi, ha regalato al folklore siciliano anche il suo successore,
Emanuele Macrì. Nel 1908, infatti, non appena seppe del disastro di
Messina, partì con una squadra di operai che l´aiutarono per due
giorni e per due notti sotto una pioggia battente, a disseppellire la
sua famiglia del suo vecchio amico Macrì.
 I
Pupi Siciliani sono patrimonio dell'umanita'. L'Unesco ha ricosciuto il
valore di questa forma d'arte di cultura popolare e nella primavera
dello scorso anno il teatro dei pupi siciliani e' stato dichiarato
"Capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanita'"
dall'Unesco, insieme ad altre 18 espressioni culturali popolari di tutto
il mondo.
I
Pupi Siciliani sono patrimonio dell'umanita'. L'Unesco ha ricosciuto il
valore di questa forma d'arte di cultura popolare e nella primavera
dello scorso anno il teatro dei pupi siciliani e' stato dichiarato
"Capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanita'"
dall'Unesco, insieme ad altre 18 espressioni culturali popolari di tutto
il mondo.





 Com'è
consuetudine cittadina, da ormai un secolo, dal caffè all'aperitivo,
dall'arancina al pasticcino, a seconda dell'ora e degli impegni, Savia
è la meta preferita da giovani e da eleganti signore, ragazzine e
nonni, commendatori azzimati, impiegati e commesse frettolose nel
break lavorativo di mezzogiorno.
Com'è
consuetudine cittadina, da ormai un secolo, dal caffè all'aperitivo,
dall'arancina al pasticcino, a seconda dell'ora e degli impegni, Savia
è la meta preferita da giovani e da eleganti signore, ragazzine e
nonni, commendatori azzimati, impiegati e commesse frettolose nel
break lavorativo di mezzogiorno.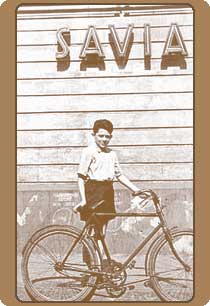
 sua
esperienza, maturò il suo mestiere grazie all'intuito e alla sagacia
di Alfio e Carmelina Savia, trovò degna sistemazione nel cuore della
città, proprio in quella via Etnea che Federico De Roberto aveva
battezzato col nome prestigioso di "Salotto di Catania".
sua
esperienza, maturò il suo mestiere grazie all'intuito e alla sagacia
di Alfio e Carmelina Savia, trovò degna sistemazione nel cuore della
città, proprio in quella via Etnea che Federico De Roberto aveva
battezzato col nome prestigioso di "Salotto di Catania".


 "La mia
vita", pubblicato recentemente da Maimone. Nelle pagine autobiografiche,
con la memoria prodigiosa che lo contraddistingueva, il cavaliere ci permette di
entrare nel suo mondo più intime, in quello dei suoi affetti, ma anche nella
vita sociale ed economica della provincia etnea. Significativi, per i dettagli e
gli spunti di riflessione, le pagine che egli dedica agli anni del boom
economico, quando la vita della zona etnea, pur tra gli alti e bassi dovuti alle
difficoltà del la ripesa post bellica, fece di Catania la Milano del Sud.
"La mia
vita", pubblicato recentemente da Maimone. Nelle pagine autobiografiche,
con la memoria prodigiosa che lo contraddistingueva, il cavaliere ci permette di
entrare nel suo mondo più intime, in quello dei suoi affetti, ma anche nella
vita sociale ed economica della provincia etnea. Significativi, per i dettagli e
gli spunti di riflessione, le pagine che egli dedica agli anni del boom
economico, quando la vita della zona etnea, pur tra gli alti e bassi dovuti alle
difficoltà del la ripesa post bellica, fece di Catania la Milano del Sud. negli anni Settanta,
quando inventò un prodotto - il torrone morbido monodose con glassa - che ha
conquistato il mercato mondiale per la stia bontà e per merito di una abile
campagna pubblicitaria, affidata a personaggi siciliani che hanno avuto successo
nel mondo dello spettacolo. 1 messaggi promozionali e innovativi - celebre gli
spot con i Re Magi - identificano immediatamente ed efficacemente i "Torroncini
CondorelIi". Ma forse non tutti sanno che l'ìdea del morbido monodose
maturò in seguito ad una cena in casa di una vedova a Venaria Reale in
provincia di Torino. Quella sera il dolce era proprio una stecca di torrone che
venne rotto con un grosso coltello in parti disegnali. A Condorelli, che era
l'ospite, fu dato il pezzo più grosso e questo non gli sembrò giusto, per non
parlare dei problemi di masticazione che, a causa della durezza, creava
soprattutto alle persone anziane Gli balenò l'idea di un torrone morbido, dal
gusto delicato, incartato in porzioni singole. E da qui anche il salto di
qualità perché il marchio Condorelli divenne presto sinonimo di torroncino.
Oggi nell'industria dolciaria Condorelli si trasformano ogni giorno settemila
chili di mandorle per confezionare 15 mila chili di torrone morbido ricoperto in
sette glasse diverse, L'industria dà lavoro a 54 dipendenti fissi, a 66
stagionali e a 96 agenti, che coprono tutto il territorio nazionale. Sono cifre
imponenti e - siamo certi - destinate ad accrescersi con la istituzione della
Fondazione, nata per ricordare uno dei più importanti imprenditori siciliani
nel settore dolciario.
negli anni Settanta,
quando inventò un prodotto - il torrone morbido monodose con glassa - che ha
conquistato il mercato mondiale per la stia bontà e per merito di una abile
campagna pubblicitaria, affidata a personaggi siciliani che hanno avuto successo
nel mondo dello spettacolo. 1 messaggi promozionali e innovativi - celebre gli
spot con i Re Magi - identificano immediatamente ed efficacemente i "Torroncini
CondorelIi". Ma forse non tutti sanno che l'ìdea del morbido monodose
maturò in seguito ad una cena in casa di una vedova a Venaria Reale in
provincia di Torino. Quella sera il dolce era proprio una stecca di torrone che
venne rotto con un grosso coltello in parti disegnali. A Condorelli, che era
l'ospite, fu dato il pezzo più grosso e questo non gli sembrò giusto, per non
parlare dei problemi di masticazione che, a causa della durezza, creava
soprattutto alle persone anziane Gli balenò l'idea di un torrone morbido, dal
gusto delicato, incartato in porzioni singole. E da qui anche il salto di
qualità perché il marchio Condorelli divenne presto sinonimo di torroncino.
Oggi nell'industria dolciaria Condorelli si trasformano ogni giorno settemila
chili di mandorle per confezionare 15 mila chili di torrone morbido ricoperto in
sette glasse diverse, L'industria dà lavoro a 54 dipendenti fissi, a 66
stagionali e a 96 agenti, che coprono tutto il territorio nazionale. Sono cifre
imponenti e - siamo certi - destinate ad accrescersi con la istituzione della
Fondazione, nata per ricordare uno dei più importanti imprenditori siciliani
nel settore dolciario.

 lavoro: da una parte stanno i diversi legni, da uno ben secco e
stagionato viene ricavato il manico sul quale poi verranno segnate le
note; da un altro sottile viene ricavata la cassa, quella dalla forma
caratteristica a otto coperta dalla tavola armonica, all'interno divisa
in tanti solchi per le diverse onde sonore. Ci fermiamo nella grande
sala in due punti a osservare gli artigiani più anziani e più abili.
Uno curva su un ferro cavo rovente, alimentato da un piccolo focolare, i
legni. Lo fa con piccoli colpi delle mani seguendo la tensione del
legno, abbandonandolo e riprendendolo con miracolosa sensibilità.
L'altro è il più anziano, pittoresco e bravo. Ha una faccia serena e
curiosa sempre protesa, anche mentre parla, al lavoro che va compiendo:
rifinire una cassa, legare le sin. gole parti degli strumenti e,
soprattutto, intarsiarvi un piccolo fregio. Gli strumenti catanesi sono
famosi anche per gli splendidi intarsi che portano sempre. Ogni
mandolino, ogni chitarra ha un suo contrassegno grafico, quasi un
monogramma. La tematica ornamentale è ingenua e poetica: una stella, un
triangolo, un circolo, un rombo, la corolla di un fiore, un foglie, due
fiori su uno stelo, una farfalla, una farfalla con le ali screziate,
un'ape, un'ape sopra un fiore, una cetra, un'aquila, un giglio, una
rosa, una margherita, una rondine. La rondine non sta che sulle
chitarre, a larghe ali spiegate. Una rondine vuoi dire nostalgia,
bellezza, casa: è uno dei segni patetici e antichi della tradizione
popolare italiana. Queste forme gli intarsiatori catanesi (a Catania
c'è forse il più abile fra tutti oggi in Italia, Franceschini)
hanno esposte in un largo campionario che non guardano mai; gli
artigiani le riproducono a memoria. Esse vengono riportate nello strato
più superficiale del legno, con abilità e destrezza. Gli intarsi, va
detto, un tempo erano fatti esclusivamente in madreperla; ora, per la
necessità di mantenere accessibile il costo di uno strumento così
popolare, anche. in celluloide. Però l'abilità e il gusto di chi sono
testimoni non cambia. Un colpo solo, mi dice il direttore della
fabbrica,
lavoro: da una parte stanno i diversi legni, da uno ben secco e
stagionato viene ricavato il manico sul quale poi verranno segnate le
note; da un altro sottile viene ricavata la cassa, quella dalla forma
caratteristica a otto coperta dalla tavola armonica, all'interno divisa
in tanti solchi per le diverse onde sonore. Ci fermiamo nella grande
sala in due punti a osservare gli artigiani più anziani e più abili.
Uno curva su un ferro cavo rovente, alimentato da un piccolo focolare, i
legni. Lo fa con piccoli colpi delle mani seguendo la tensione del
legno, abbandonandolo e riprendendolo con miracolosa sensibilità.
L'altro è il più anziano, pittoresco e bravo. Ha una faccia serena e
curiosa sempre protesa, anche mentre parla, al lavoro che va compiendo:
rifinire una cassa, legare le sin. gole parti degli strumenti e,
soprattutto, intarsiarvi un piccolo fregio. Gli strumenti catanesi sono
famosi anche per gli splendidi intarsi che portano sempre. Ogni
mandolino, ogni chitarra ha un suo contrassegno grafico, quasi un
monogramma. La tematica ornamentale è ingenua e poetica: una stella, un
triangolo, un circolo, un rombo, la corolla di un fiore, un foglie, due
fiori su uno stelo, una farfalla, una farfalla con le ali screziate,
un'ape, un'ape sopra un fiore, una cetra, un'aquila, un giglio, una
rosa, una margherita, una rondine. La rondine non sta che sulle
chitarre, a larghe ali spiegate. Una rondine vuoi dire nostalgia,
bellezza, casa: è uno dei segni patetici e antichi della tradizione
popolare italiana. Queste forme gli intarsiatori catanesi (a Catania
c'è forse il più abile fra tutti oggi in Italia, Franceschini)
hanno esposte in un largo campionario che non guardano mai; gli
artigiani le riproducono a memoria. Esse vengono riportate nello strato
più superficiale del legno, con abilità e destrezza. Gli intarsi, va
detto, un tempo erano fatti esclusivamente in madreperla; ora, per la
necessità di mantenere accessibile il costo di uno strumento così
popolare, anche. in celluloide. Però l'abilità e il gusto di chi sono
testimoni non cambia. Un colpo solo, mi dice il direttore della
fabbrica, osservando il vecchio artigiano al suo lavoro, un colpo
sbagliato potrebbe distruggere uno strumento. Lo dice osservandolo con
una punta di orgoglio e di preoccupazione. L'uomo anziano ride mostrando
una fila di rughe attorno agli occhi. Forse non avrà mai sbagliato quel
colpo. Nel piano più alto del mulino gli strumenti sono verniciati,
stagionati, lucidati. Alla fine controllati severamente nella loro
qualità musicale. Chi esegue il collaudo degli strumenti, chi li
"prova" non e pero un uomo anziano. t un giovane, quasi un
ragazzo, con una maglietta a righe e i capelli nerissimi. Controlla gli
strumenti a lungo, all'orecchio, uno a uno. Fa questo lavoro contento,
nelle pause si sente attorno un grande silenzio. Sembra lavorare senza
nessuno sforzo. Mentre lo osservo mi ricordo di tutte le teorie
scientifiche che andiamo ricavando dalla fine dei secolo scorso, sopra
le età dei nostri sensi. Il nostro udito incomincia a invecchiare a
venticinque, a trent'anni. Forse è vero. L'odore di vernice, il colore
caldo degli strumenti, la folla delle loro forme accatastate, e però
sempre distinte, fanno una strana composizione. Uscendo da qui questi
mandolini con quanti oggetti si combineranno, daranno valore e una forma
armoniosa, imprevedibile. Quando con i fratelli
Leone ci
ritroviamo nella stanza della direzione il balcone sul mare ha, nel
caldo pomeriggio di autunno, le imposte socchiuse. Dei due fratelli
l'abile conversatore mi dice, quasi a conclusione: "I nostri
mandolini li portiamo in giro per il mondo. Li accompagno io stesso. Le
chitarre le fanno anche i tedeschi e gli spagnoli ma i mandolini li
facciamo solo noi. Li esportiamo dovunque, forse più che in qualunque
altra parte in America ". Chi cercherà i mandolini catanesi in
America? Ne soppeso uno: è elegante ma leggero e non superbo. Penso
all'addensarsi di emozioni, di immagini, di segnali, di locuzioni, di
voci, di canzoni che uno strumento come questo può riportare. Ecco
rivedo il silenzioso barbiere con i capelli bagnati incollati in testa
aprire, alle sei, nella mattina limpida e fresca le imposte complicate
della bottega e scambiare il suo contegnoso saluto dall'altro lato della
strada. Ma non trovo più la voce di quel mandolino che mi restituisca
la tenerezza di una infanzia tutta consumata nel sole.
osservando il vecchio artigiano al suo lavoro, un colpo
sbagliato potrebbe distruggere uno strumento. Lo dice osservandolo con
una punta di orgoglio e di preoccupazione. L'uomo anziano ride mostrando
una fila di rughe attorno agli occhi. Forse non avrà mai sbagliato quel
colpo. Nel piano più alto del mulino gli strumenti sono verniciati,
stagionati, lucidati. Alla fine controllati severamente nella loro
qualità musicale. Chi esegue il collaudo degli strumenti, chi li
"prova" non e pero un uomo anziano. t un giovane, quasi un
ragazzo, con una maglietta a righe e i capelli nerissimi. Controlla gli
strumenti a lungo, all'orecchio, uno a uno. Fa questo lavoro contento,
nelle pause si sente attorno un grande silenzio. Sembra lavorare senza
nessuno sforzo. Mentre lo osservo mi ricordo di tutte le teorie
scientifiche che andiamo ricavando dalla fine dei secolo scorso, sopra
le età dei nostri sensi. Il nostro udito incomincia a invecchiare a
venticinque, a trent'anni. Forse è vero. L'odore di vernice, il colore
caldo degli strumenti, la folla delle loro forme accatastate, e però
sempre distinte, fanno una strana composizione. Uscendo da qui questi
mandolini con quanti oggetti si combineranno, daranno valore e una forma
armoniosa, imprevedibile. Quando con i fratelli
Leone ci
ritroviamo nella stanza della direzione il balcone sul mare ha, nel
caldo pomeriggio di autunno, le imposte socchiuse. Dei due fratelli
l'abile conversatore mi dice, quasi a conclusione: "I nostri
mandolini li portiamo in giro per il mondo. Li accompagno io stesso. Le
chitarre le fanno anche i tedeschi e gli spagnoli ma i mandolini li
facciamo solo noi. Li esportiamo dovunque, forse più che in qualunque
altra parte in America ". Chi cercherà i mandolini catanesi in
America? Ne soppeso uno: è elegante ma leggero e non superbo. Penso
all'addensarsi di emozioni, di immagini, di segnali, di locuzioni, di
voci, di canzoni che uno strumento come questo può riportare. Ecco
rivedo il silenzioso barbiere con i capelli bagnati incollati in testa
aprire, alle sei, nella mattina limpida e fresca le imposte complicate
della bottega e scambiare il suo contegnoso saluto dall'altro lato della
strada. Ma non trovo più la voce di quel mandolino che mi restituisca
la tenerezza di una infanzia tutta consumata nel sole.

 Fornivano
le finiture in madreperla, tra le altre attività, alle ditte
Scandalli e Soprani, i costruttori di fisarmoniche di Castelfidardo,
con i quali intercorrevano
rapporti di profonda amicizia oltre a quelli di carattere
industriale, per la loro produzione più pregiata. I Franceschini,
inoltre, erano fornitori ufficiali di Casa Savoia per quanto
riguarda portagioie, cofanetti e altro. Mia nonna Rosa mi raccontava
che Il Re Vittorio Emanuele III concesse per una lotteria di
beneficenza, negli anni '20, un servizio da toletta costruito e
decorato proprio dalla fabbrica di suo padre Antonino.
Fornivano
le finiture in madreperla, tra le altre attività, alle ditte
Scandalli e Soprani, i costruttori di fisarmoniche di Castelfidardo,
con i quali intercorrevano
rapporti di profonda amicizia oltre a quelli di carattere
industriale, per la loro produzione più pregiata. I Franceschini,
inoltre, erano fornitori ufficiali di Casa Savoia per quanto
riguarda portagioie, cofanetti e altro. Mia nonna Rosa mi raccontava
che Il Re Vittorio Emanuele III concesse per una lotteria di
beneficenza, negli anni '20, un servizio da toletta costruito e
decorato proprio dalla fabbrica di suo padre Antonino.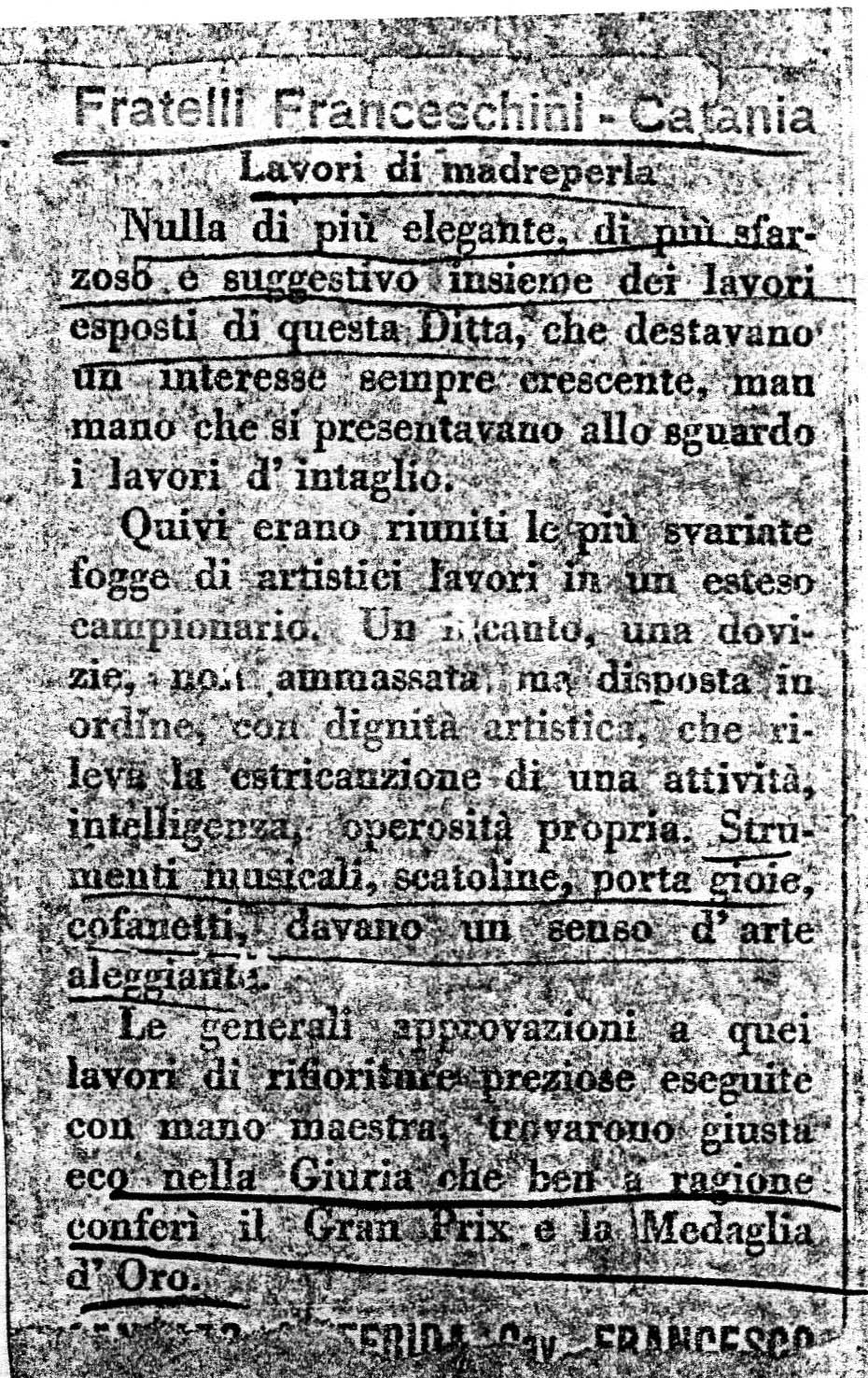



 Oggi
Caltagirone offre ai visitatori un centro storico nel quale convivono
edifici medioevali, barocchi, liberty che ha il cuore nella vecchia
piazza della Loggia (Municipio) delimitata dal maestoso Palazzo dell’Aquila,
dalla Corte Capitaniale, dal Palazzo Gravina con il lungo balcone
gaginesco e dalla Galleria Luigi Sturzo nel cui interno è il più
grande pannello di ceramica mai realizzato nel quale il Maestro Pino
Romano ha rappresentato la
battaglia di Judica che vide vincitori i Calatini sui Saraceni. Tale
evento diede inizio alla potenza di Caltagirone che fu infeudata della
Baronia di Camopietro.
Oggi
Caltagirone offre ai visitatori un centro storico nel quale convivono
edifici medioevali, barocchi, liberty che ha il cuore nella vecchia
piazza della Loggia (Municipio) delimitata dal maestoso Palazzo dell’Aquila,
dalla Corte Capitaniale, dal Palazzo Gravina con il lungo balcone
gaginesco e dalla Galleria Luigi Sturzo nel cui interno è il più
grande pannello di ceramica mai realizzato nel quale il Maestro Pino
Romano ha rappresentato la
battaglia di Judica che vide vincitori i Calatini sui Saraceni. Tale
evento diede inizio alla potenza di Caltagirone che fu infeudata della
Baronia di Camopietro.
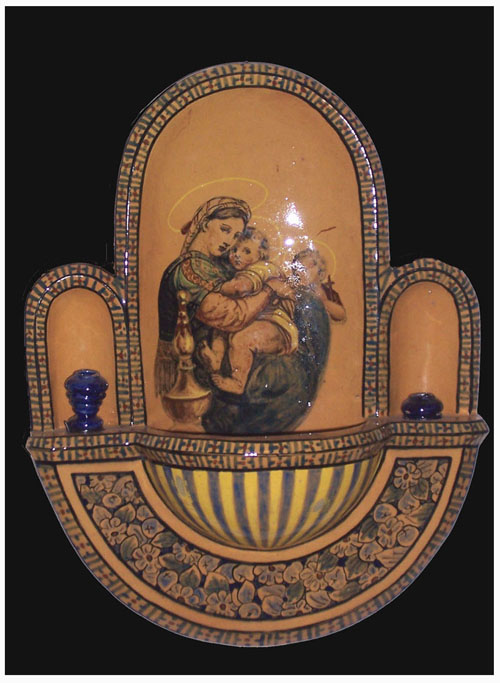 promosse e
incoraggiò insieme alla cultura della canna da zucchero.
promosse e
incoraggiò insieme alla cultura della canna da zucchero.





 Oggi
l'estrazione avviene con l'ausilio di moderne macchine quali la pala
meccanica e le ruspe che permettono di raggiungere strati profondi dove
la lava è più compatta, più dura e di colore più chiaro. Anche la
lavorazione è facilitata dall'uso di altri strumenti e macchine:
trapano, flex, fresa e levigatrice.
Oggi
l'estrazione avviene con l'ausilio di moderne macchine quali la pala
meccanica e le ruspe che permettono di raggiungere strati profondi dove
la lava è più compatta, più dura e di colore più chiaro. Anche la
lavorazione è facilitata dall'uso di altri strumenti e macchine:
trapano, flex, fresa e levigatrice.
 Michele
Bertino è nato a
Paternò il 10-06-1934. Maestro artigiano nella lavorazione della pietra
lavica e dei marmi con laboratorio in Via Pò a Paternò. Ha iniziato
l'attività ad 11 anni seguendo la scuola del Maestro Barbaro Costa di
Paternò e da allora ha sempre svolto l'attività di lavorazione della
pietra lavica con particolare attenzione alla creazione di oggetti e
manufatti con pregiati intarsi realizzati rigorosamente a mano.
Michele
Bertino è nato a
Paternò il 10-06-1934. Maestro artigiano nella lavorazione della pietra
lavica e dei marmi con laboratorio in Via Pò a Paternò. Ha iniziato
l'attività ad 11 anni seguendo la scuola del Maestro Barbaro Costa di
Paternò e da allora ha sempre svolto l'attività di lavorazione della
pietra lavica con particolare attenzione alla creazione di oggetti e
manufatti con pregiati intarsi realizzati rigorosamente a mano. circolare al
cui interno c'era un fornello per alimentare una fiamma, la doga era
normalmente più larga nella parte centrale e più stretta alle
estremità, il numero delle doghe variava in funzione della capienza
della costruenda botte, il fornello centrale serviva per fare quel
vapore necessario a rendere il legno più duttile ed elastico alla
lavorazione e facilitare la necessaria curvatura delle doghe, inoltre
era essenziale per liberare il tannino dal legno, sostanza che passa
facilmente nel vino e lo rende tossico. Per completare il lavoro
occorrevano inoltre sei cerchi di ferro di diversa dimensione e due
coperchi "timpagni ", che avevano il diametro della dimensione
del foro finale della botte. L'arte magica del bottaio era ed è, per
quei pochi artigiani rimasti; quella di far aderire le doghe l'una
all'altra, tenerle con i cerchi metallici che venivano poste
naturalmente all'esterno aiutandosi con uno speciale attrezzo a forma di
scalpello smussato con un lungo manico che si colpiva con un martello e
tutto questo veniva fatto senza l'uso di collanti, ottenendo dei
contenitori che non facevano perdere il liquido contenuto. Purtroppo la
moderna tecnologia ed il ricorso massiccio a contenitori di acciaio e di
vetroresina stanno facendo scomparire la magia di un mestiere
affascinante.
circolare al
cui interno c'era un fornello per alimentare una fiamma, la doga era
normalmente più larga nella parte centrale e più stretta alle
estremità, il numero delle doghe variava in funzione della capienza
della costruenda botte, il fornello centrale serviva per fare quel
vapore necessario a rendere il legno più duttile ed elastico alla
lavorazione e facilitare la necessaria curvatura delle doghe, inoltre
era essenziale per liberare il tannino dal legno, sostanza che passa
facilmente nel vino e lo rende tossico. Per completare il lavoro
occorrevano inoltre sei cerchi di ferro di diversa dimensione e due
coperchi "timpagni ", che avevano il diametro della dimensione
del foro finale della botte. L'arte magica del bottaio era ed è, per
quei pochi artigiani rimasti; quella di far aderire le doghe l'una
all'altra, tenerle con i cerchi metallici che venivano poste
naturalmente all'esterno aiutandosi con uno speciale attrezzo a forma di
scalpello smussato con un lungo manico che si colpiva con un martello e
tutto questo veniva fatto senza l'uso di collanti, ottenendo dei
contenitori che non facevano perdere il liquido contenuto. Purtroppo la
moderna tecnologia ed il ricorso massiccio a contenitori di acciaio e di
vetroresina stanno facendo scomparire la magia di un mestiere
affascinante. usare
materiale di gomma. Gli attrezzi, che sono gli strumenti indispensabili
al suo lavoro, che in parte non si sono modificati sono, delle forme in
ferro di varia dimensione che servono per inserirci le scarpe un
caratteristico ed affilatissimo coltello "u trincetu", il
martello anch'esso dalla forma caratteristica, tenaglia, lesina, spago,
aghi, cera, pece, vetro per levigare le suole, e tutta una serie di
piccoli chiodi "a siminziedda" , il tutto sparso su un basso
tavolo da lavoro "u bancareddu". A completare un lavoro
artigianale ben fatto; la solerzia, la pazienza e la passione
dell'artigiano.
usare
materiale di gomma. Gli attrezzi, che sono gli strumenti indispensabili
al suo lavoro, che in parte non si sono modificati sono, delle forme in
ferro di varia dimensione che servono per inserirci le scarpe un
caratteristico ed affilatissimo coltello "u trincetu", il
martello anch'esso dalla forma caratteristica, tenaglia, lesina, spago,
aghi, cera, pece, vetro per levigare le suole, e tutta una serie di
piccoli chiodi "a siminziedda" , il tutto sparso su un basso
tavolo da lavoro "u bancareddu". A completare un lavoro
artigianale ben fatto; la solerzia, la pazienza e la passione
dell'artigiano.
 modalità della loro fruizione all'interno
dell'ambito sociale in cui sono vissuti confermano un concetto d'arte,
di arte popolare, come tecnica, come qualità privilegiata.
modalità della loro fruizione all'interno
dell'ambito sociale in cui sono vissuti confermano un concetto d'arte,
di arte popolare, come tecnica, come qualità privilegiata.
 SAPONARO
SAPONARO