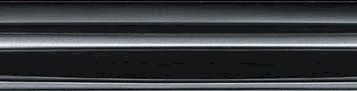|
“Manciasti?”
A noi siciliani piace
mangiare. Ma non è solo fame: è identità, è appartenenza.
Mangiare, per noi, è un’arte
antica, un gesto d’amore tramandato come una ricetta segreta.
Ogni giorno è una festa,
ogni piatto un racconto: arancine, panelle, sfincione, caponata, pasta alla
Norma, con le sarde, anelletti al forno, involtini di pesce spada, parmigiana,
cannoli, cassata, granite con la brioche col tuppo, couscous trapanese, focacce
ragusane… lo stomaco applaude solo a pensarci.
Ecco perché, per noi
siciliani, mettersi a dieta è quasi un trauma.
Quasi, ho detto. Perché poi
– incredibile ma vero – ci riusciamo.
Ma, come tutto in Sicilia,
anche la dieta ha le sue regole… personalizzate.
Quando il medico ci dice:
“Devi fare la dieta”, noi non pensiamo a cosa dobbiamo eliminare, ma a cosa
possiamo ancora mangiare.
Occhio, perché la differenza
è sostanziale: non è rinuncia, è strategia.
Noi restiamo innamorati del
cibo. Cambia il menù ma la domanda rimane sempre uguale "

“Chi manciu oggi ? "
Perché mangiare, per noi, è
un atto d’amore.
Ce lo insegnano da piccoli:
le nonne, le mamme, le zie.
Quando ci vedono, la prima
domanda non è “Come stai?”, ma:
“Manciasti?”
È la versione siciliana del
“Ti voglio bene”.
Io stessa, quando chiamo mia
figlia che vive lontano, la prima cosa che le chiedo è:
“Manciasti?”
Lo chiedo dopo se ha
dormito, lavorato, perso il treno, trovato l’amore o litigato col mondo.
Mi interessa subito sapere
se ha mangiato. Perché per noi, se hai mangiato, allora stai bene. Il resto si
aggiusta.
Mio padre, già di prima
mattina, aveva pronto il menù della giornata.
Era una promessa sacra allo
stomaco: colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena… e sempre qualcosa prima di
dormire, un pezzu di cioccolato, fondente però, sinnò fa mali .
Poi arriva la dieta. Con la
sua aria minacciosa, la lista dei “no” e la bilancia in agguato.
Ma noi siciliani abbiamo un
talento raro: dopo 24 ore ci sentiamo già magri.
Ci guardiamo allo specchio
con aria soddisfatta:
“Mi pare che la pancia sia
già più piatta, no?”
E nella suggestione ci
stiamo bene.
Comincia così una nuova
fase: si va al mercato e si scopre l’esistenza di verdure che prima erano solo
“contorno per fare scena”.
Eh sì, perché per noi la
verdura è uno sgrasce' – ci serve a pulire lo stomaco da tutto quello che
abbiamo mangiato – mentre la frutta ci serve per “passarini a vucca”.
E al primo appuntamento col
dietologo, parte la vera domanda di cuore:
“Dottore… ma 60 grammi di
pasta cu i sardi, i finucchieddi e l’astrattu squagghiatu, ma pozzu manciari?
Perché, mi scusi… i sardi du
pisci, l’estratto è pomodoro, i finucchieddi su virdura, giusto?”
E lì il dottore capisce con
chi ha a che fare.
E sa che sarà una lunga
battaglia… ma con gusto.
E se proprio non riusciamo a
dimagrire e la salute non ci fa guerra, allora sì: ci vuole il nero.
Il nero sfina!
E se neanche il nero ci
aiuta, allora parte la nostra filosofia per eccellenza:
Mancia e futtitinni! Chi ci
n' è di sta vita ?!
(Rosanna Badalamenti)

Dove si narra dell’arrivo dei popoli del nord e delle sarde a
beccafico, della pasta secca e dei mulini di Al Tarbiah, dello stocco e del
baccalà, delle aringhe e della caccia reale, dei Vespri e della cucina alla
sanfasò, dell’aggrassato e del polpo alla greca; l'era deii Monsù.
Difficile trovare una netta linea di demarcazione tra
l’influenza Arabo-berbera, quella Normanna e quella Sveva.
Ruggero II il Normanno, alla guida delle esigue truppe di
Roberto il Guiscardo, qualche centinaio di cavalieri ed un seguito di varie
tribù franco-galliche, dopo le prime scaramucce iniziali conquistò facilmente la
nostra Isola: vuoi per la debolezza delle tre amministrazioni
siculo-arabo-berbere che avrebbero dovuto governare la Sicilia, sempre impegnate
a lottare fra di loro, vuoi per il carattere dei siciliani sempre o quasi ben
disposti ad assimilare le culture straniere, ci mettemmo pochissimo a diventare
normanni.
Con l’arrivo degli uomini del Nord, sembra cambiare poco
nella vita dei siciliani: qualche chiesa in più e qualche moschea in meno. Non
più di tanto, se i cattolicissimi uomini del nord continuano ad utilizzare
scrivani arabi, artisti greci, e così via. Ancora una volta vinsero i profumi di
questa terra, la dolcezza del clima e delle sue donne, l’abbandonarsi al piacere
della pace da alcuni definita mollezza. Inutile e ripetitivo raccontare i fasti
della corte palermitana dei grandi Re siciliani, casomai varrebbe evidenziare
gli aspetti negativi, come ad esempio, l’inasprimento delle tassazioni.
Sicuramente in Sicilia, a Trabbia, nascono i maccheroni,
dall’arabo “Mu-karana-tun e/o Makruna, mettere in file o mettere in parallelo.
Lo racconta il geografo Al-Idrisi al servizio di Ruggero II,
che narra di Al Tarbiah, un agglomerato di mulini a pochi chilometri da Aziz,
Palermo la splendente, dove certi pastai arabo-normanni-siciliani producevano
una pasta secca chiamata itrija, strisce di sfoglia esportati in
tutto il Mediterraneo. Ne è conferma la Pasta e tria pugliese, una minestra di
ceci e tagliatelle di grano duro ancora di uso comune. La pasta lunga, sia
fresca che secca, si diffuse molto rapidamente in tutto il meridione d’Italia ed
in Liguria, cioè nelle regioni dove le condizioni climatiche ne consentivano
l’essiccazione naturale, ma soltanto fra gli strati più popolari, perché non
essendo ancora state inventate le forchette… mangiarla con le mani era
decisamente poco elegante!

Uno dei formati di pasta più antichi sono gli Strozzapreti,
ne troviamo traccia nei ricettari scritti fra la fine Medioevo e l’inizio del
Rinascimento col nome di strangulapriévete, descritti come una specie di gnocchi
di farina e crosta di pane, ma già nel 1524 il cuoco Antonino Camuria, al
servizio della nobile famiglia lucana dei Carafa, li descrive come degli gnocchi
di ricotta, uova, caciocavallo e mandorle, cotti in brodo di cappone e poi
cosparsi ancora di caciocavallo, mozzarella, zucchero e cannella. Degli gnocchi
quindi, quasi dei ravioli nudi eredi del raviolo senza spoglia dello Scappi, che
pestava provola fresca o tuma nel mortaio e l’impastava
 con formaggio
grattugiato e uova. Con questo impasto lo Scappi faceva delle polpette ovali
grandi quanto una noce, che cuoceva in brodo di pollo e condiva con altro
formaggio grattugiato, zucchero e cannella. Questo tipo di raviolo nudo
chiamato, strangulapriévete, pare fosse diffuso nel meridione d’Italia, con vari
impasti anche a base di carne, come racconta un Anonimo del ‘300 cuoco alla
corte angioina: “un impasto di carne o interiora di maiale o capretto, erbe
odorose, spezie pestate e uovo, con le quali si formano polpette della grandezza
di un uovo che si avvolgono con frammenti della pellicina che ricopre i visceri” con formaggio
grattugiato e uova. Con questo impasto lo Scappi faceva delle polpette ovali
grandi quanto una noce, che cuoceva in brodo di pollo e condiva con altro
formaggio grattugiato, zucchero e cannella. Questo tipo di raviolo nudo
chiamato, strangulapriévete, pare fosse diffuso nel meridione d’Italia, con vari
impasti anche a base di carne, come racconta un Anonimo del ‘300 cuoco alla
corte angioina: “un impasto di carne o interiora di maiale o capretto, erbe
odorose, spezie pestate e uovo, con le quali si formano polpette della grandezza
di un uovo che si avvolgono con frammenti della pellicina che ricopre i visceri”
Ma cosa c’entrano i preti e perché si strozzerebbero?
Nulla di nulla, tranne che la sagacia popolare ha costruito
attorno a questo nome, strangulapriévete, decine e decine di leggende e
racconti, tutte con interpreti pretacchioni grassocci e golosi, che si
strozzerebbero ingozzandosi di gnocchi che gli vanno per traverso. Tranne che in
Toscana, dove da mangiapreti come sono, i cantastorie associano il nome della
pasta al laccio con cui gli anarchici giuravano di strangolare ogni prete.
Strangulapriévete, altro non è invece che l’italianizzazione medievale di una
parola greca frutto dell’unione di due verbi: straggalào, arrotolare e prepto,
incavare. Ed infatti si ricavano da un cordoncino di pasta che si incava, quasi
come i cavati, e poi si arrotola su se stesso.
Poi, intorno al 1700, Gennaro Spadaccini, ciambellano di Re
Ferdinando II, ebbe la geniale idea di inserire altre due punte al forchettone
che usualmente veniva all’epoca usato a tavola assieme a coltello e cucchiaio,
inventando di fatto la forchetta a quattro rebbi, grazie a cui la pasta lunga fu
servita anche nei pranzi delle corti di tutt’Italia introducendola al Mondo.
Quella pasta lunga era già fatta a macchina, al torchio, quello splendido
attrezzo che in Sicilia chiamiamo arbitrio, diffusosi tra il XVI e il XVII
secolo, la macchina che favorì la diffusione della pasta ma anche dei pastai che
cominciarono ad unirsi in corporazioni. All’interno delle Corporazioni dei
pastai si distinguevano due sottocategorie, come attesta lo Statuto delle
Corporazioni di Roma che risale alla fine del ‘500, quelle col torchio e quelle
senza. In ogni caso, quando la pasta era soltanto un cibo popolare, praticamente
non esistevano condimenti: la pasta era mangiata sempre per strada, tirata fuori
dai pentoloni posti davanti le taverne e versata in grandi ciotole spesso
comuni, dove si attingeva con le mani. Al massimo ci si metteva sopra un filo di
strutto fuso o formaggio grattugiato.

E la pasta col pomodoro?
La prima notizia di una pasta col pomodoro, importato dal
Perù nella seconda metà del ‘500 come pianta ornamentale ma considerato per
molto tempo velenoso, è del 1779 e la troviamo nel Cuoco Maceratese di Antonio
Nebbia, anche se una salsa di pomodoro speziata di cannella e chiodi di
garofano, consigliata per accompagnare sia carni che pesci, la racconta, nel
Cuoco Galante, Vincenzo Corrado.
La gastronomia siciliana come al solito si arricchisce
dell’arrivo dei popoli del Nord, ma non dimentica il passato: le fave rimangono,
come del resto in tutta l’Europa che si affaccia sul Mediterraneo, alla base,
insieme ai cereali, dell’alimentazione popolare e contadina. Anche se la carne
ed il pesce sono pure presenti nelle diete popolari. Possiamo dire che nel medio
evo siciliano non ci sono alimenti nettamente preclusi, casomai si differenziano
la periodicità e le quantità di carni che il popolo poteva permettersi. Con i
popoli del nord arrivano due nuovi pesci, o per meglio dire arriva un uso nuovo
di questi pesci, lo stoccafisso e l’aringa. Lo Stocfisc-piscistoccu-baccalaru è
il felice connubio tra due culture: loro, gli uomini del Nord, ci misero i
grossi merluzzi, noi ci mettemmo il sale. Un connubio tra profondo Sud e
profondo Nord d’Europa che, senza grandi differenze, continuò fino a pochi
decenni fa.

Piscistoccu e baccalaru
sono o dovrebbero essere in realtà
due cose diverse: u piscistoccu è il merluzzo secco, u baccalaru è il merluzzo
sotto sale.
A me piace dare un’altra chiave di lettura, più fantasiosa,
dell’arrivo in Sicilia di queste due prelibate materie prime. Secondo me, alla
partenza si trattava dello stesso prodotto, merluzzo essiccato sulle rive dei
mari del Nord, poi stivato a strati nelle stive delle navi a vela latina che
dopo un lunghissimo viaggio lo portavano in Sicilia: non era pesce sotto sale,
era solo essiccato sulla riva del mare, ma volete che durante l’essiccatura non
venisse spruzzato d’acqua di mare?
Ancora oggi su molte isole Norvegesi si possono vedere, sul
finire dell’estate, grandi tralicci su cui sono appeso i merluzzi in
essiccazione; vi dovesse capitare di assaggiarne la superficie vi accorgereste
che è leggermente salata. Durante la navigazione, col peso stesso del pesce
coperto soltanto da teli cerati e col calore mediterraneo, il sale sarebbe sceso
verso il fondo dello stivato, creando, negli strati più profondi u baccalaru.
Q uesta mia personalissima teoria avrebbe anche conferma nella maggior diffusione
dello stoccafisso nei porti del nord Italia, rispetto alla diffusione del
baccalà al sud. Infatti i primi pesci ad essere sbarcati erano ovviamente quelli
della parte superiore del carico, mentre gli strati più profondi, quelli più
salati, il baccalà insomma era quello che arrivava in Sicilia. Questo
spiegherebbe anche l’uso esclusivo per la Sicilia dello stoccafisso a Messina,
non dimentichiamo infatti che mille anni fa nel Mediterraneo si navigava quasi
esclusivamente sottocosta, quindi Messina era il primo porto Siciliano per le
navi che arrivavano dal Nord. Che la sposiate o no questa fantasiosa teoria non
è del tutto mia, mi fu esposta da un vecchio capitano trapanese che negli anni
’20 del secolo scorso comandava, appena diciannovenne, uno schifazzo una barca
da carico di 18 metri senza coperta, che da Trapani portava sale in Norvegia e
tornava carico di stoccafisso. Navigavano con vela latina, quindi solo con venti
di poppa, o con i venti di terra, la famosa “termica”, quindi navigavano
sottocosta. Fu lui a farmi notare che il fondo della stiva, quello che di solito
portava a casa, era praticamente baccalà, praticamente uguale al baccalà che
vendevano tutti i pizzicagnoli trapanesi. uesta mia personalissima teoria avrebbe anche conferma nella maggior diffusione
dello stoccafisso nei porti del nord Italia, rispetto alla diffusione del
baccalà al sud. Infatti i primi pesci ad essere sbarcati erano ovviamente quelli
della parte superiore del carico, mentre gli strati più profondi, quelli più
salati, il baccalà insomma era quello che arrivava in Sicilia. Questo
spiegherebbe anche l’uso esclusivo per la Sicilia dello stoccafisso a Messina,
non dimentichiamo infatti che mille anni fa nel Mediterraneo si navigava quasi
esclusivamente sottocosta, quindi Messina era il primo porto Siciliano per le
navi che arrivavano dal Nord. Che la sposiate o no questa fantasiosa teoria non
è del tutto mia, mi fu esposta da un vecchio capitano trapanese che negli anni
’20 del secolo scorso comandava, appena diciannovenne, uno schifazzo una barca
da carico di 18 metri senza coperta, che da Trapani portava sale in Norvegia e
tornava carico di stoccafisso. Navigavano con vela latina, quindi solo con venti
di poppa, o con i venti di terra, la famosa “termica”, quindi navigavano
sottocosta. Fu lui a farmi notare che il fondo della stiva, quello che di solito
portava a casa, era praticamente baccalà, praticamente uguale al baccalà che
vendevano tutti i pizzicagnoli trapanesi.
Nel medio-evo i siciliani conoscevano poco
le aringhe
(aregni),
ma certamente non ne conoscevano la conservazione per affumicatura che appresero
dai pescatori-guerrieri del Nord, e coniugarono, come loro solito, questo nuovo
elemento con l’esistente, inventando la ‘Nzalata d’aranci, splendido connubio
tra arance, aringhe affumicate, olio, e pane.
Non so bene come venissero consumate l’aregni in Scandinavia,
ma a Trapani era in uso un sistema quasi poetico. Premesso che per consumare le
aringhe affumicate è necessario spellarle, e per facilitare questa operazione
bisogna scaldarle, i trapanesi usavano a questa bisogna una candela: la fiamma
dolce evitava la bruciatura e l’alterazione del sapore del pesce. C’è anche un
ricordo venatorio nel consumo dell’aregni a Trapani.
La caccia alle anatre,
chiamata a Trapani Caccia reale, si praticava d’inverno, tra dicembre e gennaio,
al freddo, in solitudine e quando ancora era consentito praticarla nelle saline
tra Trapani e Nubia, l’aregna era la colazione preferita di quei cacciatori.
Per praticare quel tipo di caccia, si arrivava alle saline
verso le due di notte, per aver il tempo di preparare i richiami e attendere
l’arrivo delle anatre. I cacciatori prendevano posizione nelle poste, esili
ripari di tufo e cannicciole chiusi su tre lati e senza
 tetto, e attendevano al
gelo delle prime luci dell’alba folaghe e coddrivirdi: niente fuochi, niente
riscaldamento, unico conforto una candela per impedire l’intorpidimento delle
mani al momento di sparare. Quale migliore uso all’ora della candela per
scaldare un’aregna? tetto, e attendevano al
gelo delle prime luci dell’alba folaghe e coddrivirdi: niente fuochi, niente
riscaldamento, unico conforto una candela per impedire l’intorpidimento delle
mani al momento di sparare. Quale migliore uso all’ora della candela per
scaldare un’aregna?
Al seguito degli uomini del nord arrivarono gli scalchi, i
tagliatori di carne. Questi maestri, che quando arrivavano alla perfezione
diventavano siniscalchi, ci insegnarono l’uso dello spiedo e noi inventammo la
rosticceria. Non già quella che conosciamo adesso, vera arte, ma rosticceria nel
senso di arte dell’arrostire. Ed assieme ebbero origine gli allardiati, pesci,
ma soprattutto carni cucinate allo spiedo su cui si versava costantemente i
succhi colati nella lardaiola, un vassoio posto sotto le carni in cottura. Ai
succhi della carne erano uniti spezie ed aromi, così da profumare gli arrosti.
Ma torniamo al pesce ed ad un altro piatto “simbolo” della
gastronomia siciliana: le sarde a beccafico.
I beccafico sono degli uccelletti
lacustri dal becco molto lungo, che come tanti altri piccoli uccelli erano
ampiamente cacciati e cucinati allo spiedo. La somiglianza fra uno spiedino di
uccelletti e le sarde a beccafico palermitane è molto evidente, quindi è stato
facile ipotizzare che le sarde a beccafico palermitane siano nate dal popolo
imitando gli spiedini di uccelletti dei nobili. Ipotesi credibile che però non
spiega le sarde a beccafico della Sicilia orientale, due sarde aperte a libro,
farcite di pangrattato, pecorino grattugiato, una passa e pinoli, infarinate e
fritte.
E se invece la parola beccafico fosse una contrazione di
bread and fish, o brot und fisch o ancora brød og fisk, pane e pesce in una
qualunque lingua del Nord Europa, e le sarde a beccafico catanesi fossero quelle
originali importate dai popoli del Nord, che poi secoli dopo I Monsù palermitani
elaborarono mascherandole da uccelletti allo spedo.
Niente è eterno, neanche il regno di Federico II che muore
nel 1250, o la casa Sveva, che alla deposizione dell’ultimo re di Sicilia,
Corradino, nel 1258, si dissolse come neve al sole scatenando la lotta senza
quartiere fra le famiglie siciliane per il potere. Fino al 1270, anno in cui
s’insediò sul trono siciliano Carlo D’Angiò, in Sicilia regnarono lutti e
orrori, ma non è che nei dodici anni successivi di colonizzazione angioina, le
cose andarono meglio per il popolo siciliano. Ovviamente, per i nobili le cose
andavano sempre allo stesso modo: feste, lussi, e sprechi. Se tanto ci da tanto,
il breve periodo di colonizzazione francese, deve essere stato ben duro se, il
30 marzo del 1282, i siciliani si sollevarono in massa e con tale ferocia da
paragonare la lotta di liberazione ad una mattanza: ‘Nt’a un’ura fu distrutta
dra simensa, fu pi tunnina salata la Franza!
E fu il Vespro.
In pochi giorni i francesi presenti in Sicilia o furono
passati per le armi, a migliaia, o scapparono o si rifugiarono a Sperlinga,
ultima roccaforte degli Angioini. Ogni traccia del passaggio dei francesi fu
cancellata col sangue, ma non fu cancellata la memoria della loro gastronomia
già portata in Sicilia da clan francofoni al seguito dei Normanni. Forse da
questo dovremmo imparare una lezione: tanti affari di Stato sarebbero meglio
risolti a tavola.
Dai Vespri, paradossalmente, l’influenza francese iniziata un
paio di secoli prima, in un modo o in un altro, non ha mai abbandonato la
gastronomia siciliana, rimanendo radicata per cinque secoli, come ad aspettare
il ritorno dei Monsù. In un modo o in un altro perché, mentre le cucine nobili
acquisiscono la nascente raffinatezza francese, la cucina povera, irride
l’occupatore inventando la cucina alla sanfasò o alla ‘nfrinzè, intendendo
ridicolizzare chi, volendo imitare i cuochi francesi, mischia gli ingredienti
senza nessuna logica. All’influenza francese dobbiamo gli arrotolati di carne
cucinati al forno, i Rollè, che poi daranno origine all’ottocentesco Farsumagru
— da magro-farcito e non da falso-magro — più volgarmente conosciuto come u
Braciolone, entrambi cucinati al ragù. Ovviamente il popolo rivisitò anche
questa ricetta inventando un arrotolato di budella di agnello farcito di
interiora. Una specie di stigghiolone.
Non essendoci ancora il pomodoro, e fino a quando il pomodoro
non dilagò in Sicilia eleggendo il raù di carni a Re della gastronomia isolana,
questi arrotolati erano cucinati al forno con l’aggiunta di cipolle ed altre
verdure come piselli, carciofi, patate ed irrorati di vino. A questo tipo di
cottura poi si aggiunse quella al tegame, mantenendo inalterati gli ingredienti.
Una rilettura dell’aggrassato.
Aggrassato,
non agglassato,
perché in questo piatto una vera glassatura non c’è. Qualunque glassa, sia dolce
che salata, è frutto di una emulsione di grassi, vino o acqua, con l’aggiunta di
addensanti ma anche no, di aromi o succhi di frutta o versure, ecc… ed esistono
una miriade di ricette di arrosti di carne glassati. In un arrotolato agglassato
si impregna la carne nella glassa preparata e lo si manda al forno in teglia per
un paio d’ore, poi si spennella con la grassa e si continua fino a cottura
perfetta sempre spennellandolo di tanto in tanto. Alla fine si raccolgono i
fondi di cottura, si filtrano, si versano sull’arrosto affettato che si serve
con la rimanente grassa da aggiungere. L’aggrassato non è questo.
Proviamo ad ipotizzare una origine molto più antica di questo
piatto, una origine radicatasi indissolubilmente con la cucina siciliana ed
arrivato a noi dopo millenni. Un piatto così radicato nella nostra cultura
gastronomica che con nome di “carne e patate” e mille varianti, è cucinato in
tutte le famiglie siciliane. Il termine aggrassato potrebbe derivare dal
vocabolo greco κρατήρ, che indicava il grande vaso dove si mescolava il vino
all’acqua per servirlo ai banchetti e da στο κρασί, cioè cucinato nel vino. Come
il polpo affogato che un giorno mangiai in una taverna nel Peloponneso, chtapódi
sto krasí (χταπόδι στο κρασί), cucinato con cipolle, vino e pomodoro.
Neanche l’aggrassato si salva dal destino di una doppia
versione, quella popolare e quella nobile.
Nella cucina nobile le carni usate erano quelle dell’agnello
e del vitello, i tagli quelli più teneri, lacerto e noce, nella cucina povera
entravano in gioco il pollo, le interiora, soprattutto la trippa, e il manzo, ma
a parte la differenza di carni e di tagli, la ricetta rimaneva e rimane però la
stessa. La carne rosolava lentissimamente, con tante cipolle cremate in bianco,
magari novelle, piccole piccole, cuocendo nei propri umori e nei profumi delle
spezie, per ore. Qua ndo poi le carni cominciavano a colorire, giù una arrusciata
di vino vecchio, l’antenato del Marsala, fino alla completa cottura. Aumentando
di molto la quantità di cipolle e fermandoci a questo punto avremmo cucinato la
napoletana Genovese, ma quello che distingue questo splendido piatto partenopeo
dal nostro aggrassato non è soltanto la quantità di cipolle, ma l’aggiunta di
verdure, come patate o piselli, fave, asparagi selvatici, carciofi da stufare
assieme alla carne giunta quasi a cottura.
Come per molti piatti della cucina
classica siciliana, dell’aggrassato arriva al popolo soprattutto il sistema di
cottura, e quello che rimaneva nel tegame dopo avere tolto la carne, magari
attraverso gli sguatteri che avevano diritto agli avanzi, cioè l’untino e le
verdure che ad un certo punto diventarono soprattutto patate. Con queste verdure
e l’unto rimasto, quello che oggi chiamiamo il “fondo di cottura”, gli sguatteri
condivano la pasta inventando “la grassa” una delle ricette più diffuse a
Palermo. ndo poi le carni cominciavano a colorire, giù una arrusciata
di vino vecchio, l’antenato del Marsala, fino alla completa cottura. Aumentando
di molto la quantità di cipolle e fermandoci a questo punto avremmo cucinato la
napoletana Genovese, ma quello che distingue questo splendido piatto partenopeo
dal nostro aggrassato non è soltanto la quantità di cipolle, ma l’aggiunta di
verdure, come patate o piselli, fave, asparagi selvatici, carciofi da stufare
assieme alla carne giunta quasi a cottura.
Come per molti piatti della cucina
classica siciliana, dell’aggrassato arriva al popolo soprattutto il sistema di
cottura, e quello che rimaneva nel tegame dopo avere tolto la carne, magari
attraverso gli sguatteri che avevano diritto agli avanzi, cioè l’untino e le
verdure che ad un certo punto diventarono soprattutto patate. Con queste verdure
e l’unto rimasto, quello che oggi chiamiamo il “fondo di cottura”, gli sguatteri
condivano la pasta inventando “la grassa” una delle ricette più diffuse a
Palermo.
La glassa invece la troviamo, e quindi ci suggerisce
l’attribuzione all’influenza francese, in un piatto in uso a Castellammare del
Golfo, l’Agneddru cu riquagghiu, una preparazione di agnello aggrassato e poi
passato al forno con una glassa di uovo e formaggio.
Altro retaggio francese sono il Gattò, torte di riso prima e
poi di patate, la Matalotta, una zuppa di pesce profumata di cannella, alloro,
mandorle e scorza di limone, il Ratafià un rosolio di frutta, la Fricassè una
preparazione di carne o più raramente di pesce con aggiunta di uovo e succo di
limone, i Ramacchè, bignè salati di pasta choux farciti di salame e
caciocavallo, fritti e non cucinati al forno, le Briosce. Dopo il Vespro
l’indipendenza siciliana durò solo cinque mesi, e le famiglie siciliane, prima
di dilaniarsi in una nuova guerra civile, preferirono chiamare Pietro III
d’Aragona, che da tempo aspirava a dominare la nostra Isola.
Il 30 agosto 1282 gli spagnoli sbarcano in Sicilia, a
Trapani, e in un modo o in un altro vi rimasero fino all’inizio del ‘700.
Angelo Bentivegna
https://medium.com/@angelobenivegna/il-raconto-del-cibo-siciliano-e-non-solo-d029b5e59471

|
"Sulla Via Etnea sono due le botteghe rivali così come rivali sono
pescatori e macellai per il menù"
È il phoen a sollevare la tunica nera coi bordi rossi
che ondeggia come un derviscio sui marciapiedi neri di pietra lavica. Il
monsignore si tiene stretto il capello. Questo vento caldo che giunge da
oltre il mare, dall'Africa, spazza via le malinconie dell’inverno, ma
non toglie la voglia di buccellati, il dolce natalizio tipico di
Catania. Il prelato, però, è indeciso. Glielo si legge in faccia: «Entro
al 300 o al 302?». È la stessa domanda che si fanno le madri mentre
trascinano via dal giardino di Villa Bellini i bimbi esausti dei giochi
coi nuovi balocchi comprati a' Fera o Luni, e le comari ancora
maliziosamente velate dirette alla Cattedrale di Sant'Agata all'ora dei
vespri. Savia o Spinella?
Sì, perché solo a Catania, dove la pasticceria è
un’arte in mostra sul palcoscenico barocco di Via Etnea, gli Champs
Elysées della Sicilia, le «dolcerie» più famose e nemiche stanno l’una
accanto all’altra. Oggi sembra avere la meglio la più giovane, Spinella.
Il monsignore, infatti, alla fine si dirige deciso verso il vassoio dei
buccellati. E deve avere una buona mascella a giudicare da come
sgranocchia queste «coroncine» di pasta frolla di cui il signor Alfio,
il mastro pasticcere più «anziano» nemmeno sotto tortura rivelerebbe gli
ingredienti segreti mescolati ai fichi secchi, ai pinoli e alle
nocciole.
Eppure è un omertà dolciaria a cui si brinda
volentieri col marsala, come ai datteri resi più peccaminosi dalla
gianduia. Più penitenti, ma solo un poco sono invece le olivette, altro
dolce tipico della città etnea. Queste pepite di vaniglia e zucchero
glassato «tinte» di verde, prelibate anche da Nonna Vincenza in piazza
San Placido, sono un omaggio a S. Agata: in fuga dal proconsole
Quinziano la vergine patrona trovò riparo, secondo la leggenda, proprio
accanto a un olivo selvatico.

Eppure la rivincita non tarda. Perché il catanese è
un cittadino fedele, soprattutto alle tradizioni. Ed ecco che, appena
Alfio si gira e scompare nel laboratorio, i golosi lasciano Spinella
alla chetichella e fanno il loro ingresso nel Salotto di Catania per
antonomasia, la Pasticceria Savia, aperta nel 1897: le cassate, sublimi
ricotte zuccherate di pasta reale orlata da frutta candida, sono
decorate da canditi che specialmente a Natale sono così colorate da
luccicare come le luminarie di Via Etnea riflesse nella vetrina, mentre
la frutta martorana pare uno dei cesti pinti dal Caravaggio.
E anche la torta Savoia al cioccolato per le feste si
ingioiella con una parure di fiori d'albume. E come dimenticare i
cuddureddi, anelli di farina ripieni d'impasto di vino cotto, mandorle,
fichi, cannella e arance candite orginiari della cittadina di
Grammichele, che le massaie sono solite preparare in casa?
 Uno scrigno di tesori zuccherati e paste ripieni che
i pronipoti di Angelo Savia hanno pensato bene di proporre anche in un
cestello di legno decorato affinché i catanesi se lo portino pure a
passeggio. E' indubbio, infatti, che si debba camminare a lungo per
smaltire i dolci. Almeno sino alla Piscaria, sotto gli archi della
Marina, un suq a due passi dall'elegante Palazzo Chierici, che sarebbe
tanto piaciuto a Corto Maltese per quelle facce da marinai che hanno i
venditori dai soprannomi impronunciabili per chi viene dal continente. Uno scrigno di tesori zuccherati e paste ripieni che
i pronipoti di Angelo Savia hanno pensato bene di proporre anche in un
cestello di legno decorato affinché i catanesi se lo portino pure a
passeggio. E' indubbio, infatti, che si debba camminare a lungo per
smaltire i dolci. Almeno sino alla Piscaria, sotto gli archi della
Marina, un suq a due passi dall'elegante Palazzo Chierici, che sarebbe
tanto piaciuto a Corto Maltese per quelle facce da marinai che hanno i
venditori dai soprannomi impronunciabili per chi viene dal continente.
Sino a mattina inoltrata gridano i complimenti alle
curve morbide delle signore. La «vuciata» di Ninuzzo si traduce così:
«Compri il pesce spada, le spigole e le triglie, e poi potrà mangiare
tutti i dolci che vuole, non stia ad ascoltare Achille». Anche a Natale,
infatti, va in scena l'altra gastronomica tenzone: a una manciata di
vicoli di distanza da U Liotru, la fontana dell' elefante, il macellaio
Achille nella sua storica bottega di Via Plebiscito, pure quando è buio
e i «nemici» pescatori sono fuori con le barche, arrostisce sulle
griglie in strada le bistecche di cavallo. «Un uomo vero a Catania
mangia filetti, non masculini fritti». Traduzione dalla immancabile
vuciata.... di rimando di padron Achille.

E infatti, quanti Bell’Antoni coi baffi tengono al
braccio le signore col visone, che accaldate stanno in fila per un
ruspante panino di cavallo. Sarà così anche domani, dopo il Concerto di
Natale quando le note dell’Ave Verum Corpus K. 618 di Mozart,
inframmezzate dai versi di Quasimodo riscalderanno quella bomboniera del
Teatro Massimo Bellini, coi suoi palchi alcova. Perché Catania è città
ghiotta non solo di dolci ma anche di passioni furtive, consumate
insieme ai cannoli ripieni all'ombra dello Castello Ursino. E
sull'infinito tulle sabbioso della Playa, la lunga spiaggia, dove le
donne, le uniche, le normanne di Sicilia, erigono presepi di sabbia. Più
effimeri di quello settecentesco e vernice colorata del Barone
Scammacca, ma pur sempre doni che prima o poi le onde scarteranno, anche
se è lento e dolce il natale catanese.
http://viaggi.lastampa.it/articolo/catania-non-e-natale-senza-i-buccellati

I sapori del vulcano Catania in festa con i dolci della Santa
CATANIA
- Cuoco raffinato e cerimoniere impeccabile, l' ex sindaco Enzo Bianco
amava partire proprio da lì per incantare gli ospiti. E quando fu il
turno dell' allora presidente del Consiglio Romano Prodi la pescheria
offrì il meglio di sé. Tra novellame, triglie, cozze e ricci di mare
l' ex premier fu iniziato ai piaceri del gambero della nassa, resistette
all' ardua prova del sangeli (il sanguinaccio), riuscì a sillabare solo
un flebile «mi arrendo» nella gioielleria di frutta secca di via
Gisira.
A Catania la pescheria è un impasto di sapori, odori e colori.
E' il posto da cui partire per capire la città. Seguendo la stella
polare del vulcano, lungo quella strada che non poteva che chiamarsi via
Etnea, la nera pietra lavica si intreccia con il bianco delle facciate
barocche.
Sa di sciara anche il torrone che si vende nelle bancarelle in
questi giorni della festa di Sant' Agata (che si concluderà il 5
febbraio con il solenne pontificale nella cattedrale), la patrona per
cui i catanesi nutrono un amore talvolta pagano, sino a mangiarne i
segni del martirio, i minnuzzi di Sant' Aita: cassatelle di ricotta
ricoperte di glassa e sormontante da una ciliegia rossa. Anche le
olivette (paste di mandorle colorate di verde) sono un segno della via
crucis della «santuzza»: mentre la giovane Agata veniva condotta al
processo si chinò per allacciarsi un calzare. In quel luogo sbocciò un
olivo i cui frutti furono conservati come reliquie e dati agli ammalati
come farmaco miracoloso.
Ma la città pratica anche altri culti
culinari, come quello degli arancini. Se il commissario Montalbano li ha
resi famosi, Savia ne ha fatto un' opera d' arte. «Non c' è dubbio -
sentenzia Pino Correnti, presidente onorario dei cuochi siciliani -: gli
arancini di Savia sono i migliori al mondo». Il segreto? «Innanzitutto
il riso amalgamato con caciocavallo ragusano: l' impasto deve riposare
una notte. Il ragù deve essere secondo la ricetta siciliana con l'
aggiunta di pezzetti di formaggio primosale. Per carità, niente
mozzarella: contiene troppa acqua». Dall' arancino ai sughi con la
cotenna e la salsiccia di maiale il passo è breve: qui il segreto «è
nell' astrattu, il concentrato di pomodoro asciugato al sole»
raccontato anche da Tornatore in «Nuovo cinema Paradiso».
Lungo
la direttrice dell' Etna sono tanti i tributi al vulcano, come nella
pasta col nero di seppie. C' è chi ne ha partorito anche la versione
invernale (' u ripiddu nivicatu) facendo cadere su una montagna di riso
al nero una valanga di ricotta con in cima un rivolo di sugo. Ma sono
stati riscoperti anche sapori antichi come il maccu (il passato) di fave
fresche usato come addensante al posto della panna da cucina o la
poverissima insalata di arance con cipollina tenera che non manca mai
nei buffet più raffinati. Il tutto esaltato da vini che debbono il loro
carattere a quella terra vulcanica che spesso rende la città
invivibile. «I suoi sali minerali - spiega Camillo Privitera, presidente
regionale dell' associazione sommelier - conferiscono sapidità al vino».


La
Sicilia dove la natura è generosa - qui fioriscono gli agrumi, i
mandorli, i fichi d'India, qui gli ortaggi, i cereali e tutti i frutti
sono di
qualità eccezionale - offre un repertorio di cibi e di prodotti
caratteristici così ricco di fantasia e di fasto da non essere
paragonabile a quello di nessun'altra regione. Basta entrare in una
pasticceria di Catania o di Palermo. I luoghi della gastronomia sono
ribalte sontuose. Ne sono un esempio la ricchezza cromatica e la
complessità strutturale della cassata, cibo di tanta seduzione da
indurre nei secoli andati certe suore a trascurare le pratiche pie per
dedicarsi alla ricotta e ai canditi. di prodotti
caratteristici così ricco di fantasia e di fasto da non essere
paragonabile a quello di nessun'altra regione. Basta entrare in una
pasticceria di Catania o di Palermo. I luoghi della gastronomia sono
ribalte sontuose. Ne sono un esempio la ricchezza cromatica e la
complessità strutturale della cassata, cibo di tanta seduzione da
indurre nei secoli andati certe suore a trascurare le pratiche pie per
dedicarsi alla ricotta e ai canditi.
Si pensi anche alla quantità di
ingredienti della ricetta del "fassumauru", o falsomagro, quel
rotolone ripieno di uova sode, formaggio, lardo, salsiccia, prosciutto;
o alla "caponatina", che all'originaria congiunzione di
polipetti, sedano e melanzane in salsa di pomodoro pretende l'aggiunta
di bottarga, capperi, pesce spada in scaloppine, coda di aragosta,
girelli di carciofi, punta di asparagi e, per una versione ancora più
opulenta, la salsa di san Bernardo con cioccolata amara, mandorle
tostate, aceto e zucchero e decorazione di uova sode a fettine, code di
gamberi e olive farcite. Sarà a questo punto chiaro perché la cucina
siciliana parve a Alphonse Daudet (1840-1897) "un'esaltazione del
barocchismo cucinario spagnolo".
La Sicilia ha esaltato i
contributi degli arabi, gli apporti degli spagnoli, perfino le
attitudini delle religiose.Riconoscere
oggi le origini, ricostruire gli itinerari più lontani, non è sempre
facile. Sappiamo che gli agrumi, lo zucchero e il riso furono portati
dagli arabi, ma nessuno di questi doni sarebbe bastato a dar reputazione
alla Sicilia se i cuochi e i pasticcieri locali non avessero
trasfigurato i materiali di cucina. Ogni cultura ha lasciato in Sicilia
qualche eredità di sapori: se la ricotta salata, il miele e le olive
conciate risalgono alla Magna Grecia, il macco, la farinata di fave e il
modo di cucinare le seppie sono contemporanei di Roma antica. Il
"cuscus" fu portato dagli arabi, il "fassumauru" fu
scoperto al tempo degli Angioini, il largo ricorso alla melanzana
coincise con il dominio spagnolo.


|
|
Sapori vari, dovizie, trionfi in cui le varie influenze si mescolano fin dai
tempi più antichi se ricette siciliane sono già presenti nel Libro de arte
coquinaria di Maestro Martino che visse e operò a Roma intorno alla metà del
XV secolo.
Basti ricordare i "Maccaroni siciliani", di cui ci fornisce una
puntuale ricetta: "Piglia de la farina bellissima, et inpastala con biancho
d'ovo et con acqua rosa, ovvero con acqua communa. Et volendone fare doi
piattelli non gli porre più che uno o doi bianchi d'ova, et fa' questa pasta
ben dura; dappoi fanne pastoncelli longhi un palmo et sottili quanto una
pagliuca (= pagliuzza). Et togli un filo di ferro
longo un palmo, o più, et sottile quanto uno spagho, et ponilo sopra 'l ditto
pastoncello, et dagli una volta con tutte doi le mani sopra una tavola; dapoi
caccia fore il ferro, et ristira (=ritrai) il maccherone pertusato (= bucato) in
mezo. Et questi maccharoni se deveno seccare al sole, et dureranno doi o tre
anni, specialmente facendoli de la luna de agusto; et cocili in acqua o in brodo
di carne; et mettegli in piattelli con caso grattugiato in bona quantità,
butiro frescho et spetie dolci. Et questi tali maccharoni vogliono bollire per
spatio de doi hore".

Anche Cristoforo Messisbugo (originario delle Fiandre e attivo in qualità di
scalco - una sorta di maggiordomo con responsabilità anche della cucina - nei
primi decenni del XVI secolo, presso la corte degli Estensi) nella sua opera Banchetti,
composizioni di vivande fornisce una ricetta che - con le dovute
modificazioni - è ancora presente nella cucina siciliana; si tratta
della preparazione "A fare dieci piatti di riso o farro alla
siciliana". "Servirai l'ordine di quelli dei tortelli d'uova
del sopradetto, fino a che serà imbandito nei piattelli; poi gli
farai quattro o cinque poste per piattelli di sopravia (= sopra),
della grandezza d'un uovo, e gli metterai uno uovo per buco col chiaro
e torlo. Poi gli darai il zuccaro e cannella di sopravia, nella
medesima quantità che si è data nell'altra. Poi gli darai una calda
col testo e li manderai in tavola; e invece delle uova, gli potrai
mettere i torli d'uova duri di sopravia, e farà quel medesimo
effetto".
Anche il vino prodotto in
Sicilia ha avuto apprezzamenti fino da epoche antiche se si pensa che
ad esso riserva Sante Lancerio, vissuto nel secolo XVI, una lettera,
che indirizzò al cardinale Guido Ascanio Sforza, sulla natura e
qualità dei vini, lettera che può essere considerata il testo-base
della letteratura enologica italiana.


Così egli scrive del vino siciliano: "Viene dall'isola così
nominata. Ne vengono di più sorti e da più luoghi di detta isola,
bianchi e rossi, ma generalmente più bianchi che rossi. Li bianchi
hanno un colore bellissimo et odore grandissimo, ma come se li mostra
l'acqua subito perde il suo profumo et odore, et ogni poca l'acqua
ammazza. È buono bere il rosso nell'autunno, et il bianco alli caldi
grandissimi. Ma hanno un difetto, che alli caldi sobbollono, et alli
freddi imbalordiscono (= si viziano) e mutano di colore; ma non già
che si facciano forti, ché alli tempi freschi ritornano nel loro
pristino stato. Di tale vino S. S. non bevevo che già non fosse stato
del rosso scarico di colore, ancorché nel suo Pontificato pochini
venivano alla Ripa. Molto meglio sono quelli di Palermo che di altri
luoghi di quest'isola, sicché sono vini da famiglia".



|
|
Basterà
considerare la ricetta dei "Pollastri alla siciliana" in cui
la ricchezza degli ingredienti è pari alla cura della preparazione:
"Fiambate (= dal francese flamber : scottare, esporre alla fiamma),
spiluccate e sventrate due o tre belli pollastri, levategli l'osso del
petto, riempiteli con ragù crudo d'animelle; cuciteli, trussateli (=
incosciateli, dal francese trousser) colle zampe dentro il corpo
infilate sotto le cosce, metteteli in una cazzarola con una fetta di
limone senza scorza sopra il petto, fette di lardo sotto e sopra, una
fetta di prosciutto, un mazzetto d'erbe diverse, due scalogne, poco
sale, pepe sano, poco brodo, mezzo bicchiere di vino di Sciampagna o
altro vino bianco consumato per metà; coprite con un foglio di carta,
fate cuocere con fuoco sotto e sopra. Quando saranno cotti, scaldateli,
scuciteli, poneteli sul piatto, guarniteli di pomidoro di Sicilia
ripieni e serviteli con sopra una salsa al culì di pomidoro".

Ma
Leonardi ci parla anche di frisole di Maiorca, una sorta di fagioli
pregiati, nella ricetta, certamente retaggio del dominio spagnolo,
"Cappone di galera (= vivanda così denominata perché
originariamente confezionata a bordo delle galee) alla siciliana".
"Intingete un poco nove preselle maiorchine (= frisole di Maiorca
fresche) nel vino di Malaga, indi aggiustatele sopra il piatto che
dovete servire, fateci sopra una bella decorazione con filetti di alici
e di tarantello (= sorta di salame fatto con la pancia del tonno) ben
dissalato, capperi, cedrioletti, olive disossate, gamberelli e
calamaretti fritti, ostriche imbianchite nella loro acqua e qualche
filetto di linguattola fritta, che il piatto sia ben guarnito e pieno.
Nel momento di servire versateci sopra una salsa come segue: pestate
assai fini due once di pistacchi ben verdi e pelati, stemperateli poscia
con olio fino, aceto di dragoncello o altro aceto, sale, pepe
schiacciato, e passate al setaccio".
La
cucina siciliana può vantare, dunque, parecchi primati. È
probabilmente la più antica d'Italia, è forse la più ricca di
specialità, certo è la più scenografica. Persino il piatto più
italiano che ci sia, la beneamata pastasciutta, ebbe nell'isola del sole
la sua culla, al tempo della dominazione araba. Il nome più antico era
"maccarunne", da "maccare", cioè schiacciare (il
grano, evidentemente) per impastare.
Indipendentemente
dall'influsso che su questa cucina ebbero le usanze delle varie corti
europee, essa presenta una rilevanza che risale ai tempi più antichi, e
precisamente ai tempi della raffinatissima civiltà della Magna Grecia,
fiorita in Sicilia all'incirca quattro secoli prima di Cristo; già
allora la cucina era tenuta in gran conto: il cuoco Trimalcione, nativo
di Siracusa o di Gela, divenne così famoso per la sua abilità e la sua
inventiva, da essere conteso in tutto il mondo greco. Un certo Miteco di
Siracusa scrisse un trattato, "Il cuoco siciliano", che
anticipa di ben duemila anni l'attuale esplosione dei libri di cucina e
ci fu persino un tale Laoduco, siciliano anch'egli, che aprì una scuola
alberghiera a pagamento. La cucina nasce dunque in Sicilia come una vera
e propria arte e tale resta per tutta la lunghissima e tormentata storia
dell'isola.
I
dolci siciliani sono i più coloriti e sostanziosi del mondo. Il
ricchissimo repertorio dolciario dell'isola è fonte di scoperte e di
meraviglia: esperienza consigliabile da fare in un viaggio in Sicilia è
quella di "andar per dolci" nei conventi. Questi antichi
istituti religiosi sono da secoli luoghi di preghiera ma anche di
delizie per il palato: seguendo ricette più o meno segrete, le suore
fabbricano ancora squisitezze a base di marzapane, pistacchi, miele,
mandorle, cedro e ricotta. Sono "mostaccioli",
"cannoli", "conchiglie" e maliziose "minni
(cioè seni) di vergini" che si acquistano attraverso la grata
prendendoli sulla "ruota" senza vedere in faccia la religiosa
che li porge al compratore.
 E
poiché siamo in vena di scoperte, una visita al mercato di Palermo, la
famosa "Vucciria", potrà avvicinarci nel modo più diretto
allo spirito della cucina siciliana e al carattere della Sicilia stessa.
Tutto è esposto con eccezionale senso del colore e uno strabiliante
gusto scenografico. Sul banco dell'ortolano trofei di carnosi peperoni
gialli, rossi, verdi si alternano a cascate di melanzane che variano dal
viola più quaresimale al bianco appena azzurrato. Incredibili varietà
di broccoli, zucchine, carciofi, insalate formano composizioni
trionfali. E
poiché siamo in vena di scoperte, una visita al mercato di Palermo, la
famosa "Vucciria", potrà avvicinarci nel modo più diretto
allo spirito della cucina siciliana e al carattere della Sicilia stessa.
Tutto è esposto con eccezionale senso del colore e uno strabiliante
gusto scenografico. Sul banco dell'ortolano trofei di carnosi peperoni
gialli, rossi, verdi si alternano a cascate di melanzane che variano dal
viola più quaresimale al bianco appena azzurrato. Incredibili varietà
di broccoli, zucchine, carciofi, insalate formano composizioni
trionfali.
Così l'esposizione della frutta, fresca e secca, lascia
senza fiato per
ricchezza e varietà, mentre il pescivendolo chiama ad
ammirare la sua mercanzia odorosa e stillante: i grandi tranci di pesce
spada e di tonno dalle carni rosate contrastano con l'azzurro argenteo
delle sarde e col bianco acquoso dei neonati di sardine e di acciughe.
Con
queste magnifiche materie prime si cucinano piatti altrettanto
spettacolari, in cui profumi, colori, rilievi, luci sono elementi
essenziali, l'esuberanza e l'abbondanza necessità istintive, il gusto
della decorazione fortissimo.
Anche
la più semplice delle pastasciutte diventa così qualcosa di speciale:
la "pasta con le sarde" per esempio, che è forse il più
famoso piatto siciliano, in cui grossi maccheroni vengono conditi con un
ragù di sarde arditamente accostate a finocchio selvatico, uva passa,
pinoli e zafferano. Straordinario incontro di sapori e di aromi, si
serve coperto di sarde intere. Ancor più colorita è la pasta condita
con sugo di pomodoro e basilico sulla quale vengono posate grandi
melanzane fritte a stella, che sembrano uccelli dalle ali spiegate (e
infatti a Palermo le chiamano "quaglie") pronte a spiccare il
volo.
Condita
nei modi più svariati, la pastasciutta è d'obbligo, mezzogiorno e
sera, sulle tavole dell'isola. Il riso compare soltanto in un'altra
scenografica preparazione, gli arancini, che si ispirano agli agrumi
nell'aspetto e nel nome, e che sono una felicissima sintesi di varie
influenze: quella araba per il riso e lo zafferano, quella francese per
il ragù, quella spagnola per il pomodoro e quella greca per il
formaggio "canestrato fresco" che costituisce la parte più
interna dell'arancino dorato e fritto. Questo prodotto della ricchissima
rosticceria isolana si trova quasi ovunque e non è troppo difficile da
riprodurre, anche se richiede parecchio tempo in cucina.
Nell'infinita
serie di altre specialità, emergono quelle a base di pesce, superbe
soprattutto per la qualità del pescato proveniente dai tre mari che
bagnano l'isola. Tra le ricette esclusive eccellono le "sarde a
beccafico" preparate in tre versioni diverse a Palermo. Catania e
Messina, e che sono il trionfo dell'agrodolce. I messinesi sono maestri
nel cucinare il pescespada, i trapanesi il tonno, che viene conservato
sott'olio e anche sotto sale e allora si chiama "bottarga". I
piatti di carne sono quasi sempre a base di carne tritata; la poca
disponibilità di carne bovina e la qualità non eccelsa consigliava
preparazioni ingegnose come polpette o marinate. Ottima invece la carne
di maiale, con salsicce di ogni tipo. Ma l'apice della tavola sono le
già ricordate verdure, sempre prelibate, siano esse domestiche oppure
selvatiche. Una assoluta particolarità sono i carciofini selvatici che
si mangiano di solito bolliti; si trovano allo stato spontaneo soltanto
in Sicilia e sono eccezionali anche nel sapore.
Per
finire, una notazione: caratteristica della cucina siciliana è il fatto
che uno stesso piatto può essere preparato in una versione più ricca e
una più modesta. Si parte cioè da una base semplice, che poi - a
seconda delle disponibilità - viene arricchita di ingredienti e sapori
complementari. Tipico esempio è la già citata "caponata",
che presenta tre differenti stadi di preparazione. All'origine è
un'insalata di polipetti, sedano, melanzane, sugo di pomodoro in
agrodolce. Ma si possono aggiungere capperi, olive, bottarga, pesce
spada, aragosta, carciofi, punte di asparagi. E se la si vuole ancora
più opulenta, si copre il tutto con la salsa di San Bernardo (così
detta dal convento di Catania dove i monaci si abbandonarono a piaceri e
stravizi inusitati per troppa ricchezza e golosità) a base di
cioccolata amara, mandorle tostate, zucchero: per finire, una
decorazione di uova sode, code di gamberi, olive farcite. Piatto
barocco, denso di sovrapposti sapori, tipico di una cucina esuberante,
decisamente inadatta a qualunque tipo di dieta, ma trionfo dei
buongustai e di chi giustamente sostiene che a tavola l'occhio vuole la
sua parte: qui l'occhio, prima ancora del palato, ha di che esaltarsi.

|
|

Il
turismo eno-gastronomico va sempre più di moda: si cercano il gusto, il
particolare e, allo stesso tempo, la ricetta sana e nutriente; sono sempre più
richiesti poi gli itinerari del gusto, dove insieme si fondono gastronomia, arte
e storia. Andiamo allora alla scoperta di uno di questi itinerari, a Catania e
provincia.
 Catania è una città dalle mille risorse naturali, paesaggistiche e
monumentali, ed allo stesso tempo offre una lunga tradizione gastronomica,
influenzata anche dalle diverse dominazioni subite nei secoli. Catania è una città dalle mille risorse naturali, paesaggistiche e
monumentali, ed allo stesso tempo offre una lunga tradizione gastronomica,
influenzata anche dalle diverse dominazioni subite nei secoli.
Proviamo adesso a trascorrere insieme una giornata in città, camminando tra le
attrattive monumentali e concedendoci dei gustosi spuntini!!!
Il nostro clima è spesso tiepido: quasi tutto l'anno abbiamo delle belle
giornate di sole. Perché, allora, dal centro della città, da piazza Duomo, non
cominciamo la nostra passeggiata assaporando una bella granita fresca, così da
avere un dolce risveglio?
La granita è una produzione del tutto siciliana; sull'Etna, infatti, nelle “neviere”,
delle fosse che venivano create nel terreno, durante l'inverno si conservava la
neve in modo tale da poterla poi utilizzare durante l'estate per rinfrescare le
calde giornate. Una volta portata in città, la neve mescolata con il succo di
limone o con altri aromi diveniva granita. Adesso è facilmente reperibile tutto
l'anno nei diversi e più svariati gusti, limone, gelsi, fragola, cioccolata,
mandorla e caffè...
Per il pranzo di certo non può mancare un menù a base di pesce, un piatto di
spaghetti al nero di seppie, una pepata di cozze, pasta con le sarde... con, a
seguire, un secondo di pesce fritto e un misto di frutti di mare, magari
insaporito e colorito da agrumi, cannella o zafferano, ma tutto rigorosamente
accompagnato dal vino locale dell'Etna, ovviamente D.O.C.
Dicono in giro che la cucina siciliana sia la più ricca e completa: l'unica che
si uniforma alle influenze greche, arabe, spagnole e borboniche. La verità è
che si utilizzano e coniano insieme prodotti naturali e semplicità!!!
Tra una passeggiata ed una sosta, è piacevole sorseggiare una bevanda nei
‘chioschi di acquaioli o acquafrescai’, che servono seltz e bibite fresche
con sciroppi miscelati in quantità nascoste. A Catania, tutti i chioschi hanno
una lunga storia; particolari quelli in piazza Vittorio Emanuele, realizzati in
stile liberty.
Di certo poi, durante la giornata, non possono mancare alcune specialità
pasticcere, come cannoli, cassate, paste di mandorla, frutta di pasta reale con
chiare riproduzioni artistiche. I profumi sono nell'aria e camminando è facile
lasciarsi guidare dagli odori aromatici sempre più forti...
Alla mente vanno ricordi di altri tempi, di lavorazioni artigianali… ed è
bello pensare che proprio con queste specialità noi andiamo lontano, partiamo
insieme al turista che c'è venuto a trovare, e lo accompagniamo insieme ai
ricordi durante il viaggio di ritorno!!!
(Anna
Milazzo)

La "Dolce Sicilia" di Martorana
I dolci dei morti e quelli pasquali, le minnuzze di Sant'Agata e i capolavori di
mandorla creati dalle monache, i dolci bianchi e intarsiati come ventagli di
pizzo e i cestini di frutta "fioriti" di fragole: è un viaggio golosissimo
quello che il fotografo palermitano Giò Martorana compie nel suo volume "Dolce
Sicilia" (Electa, 85 euro) - che non a caso ha in copertina una meraviglia di
pasta reale - con i testi di Marco Ghiotto e la presentazione del regista
Giuseppe Tornatore. Un viaggio godurioso in cui i più famosi pasticceri
dell'Isola convivono con feste e tradizioni immancabilmente legate a un dolce e
quindi a chiese, processioni, ville, in un intreccio d'arte culinaria e cultura
che coinvolge anche altri ambiti: i dolci alla mandorla sono fotografati con
barocchi orecchini di corallo; i colori della cassata ricordano le ceramiche di
Caltagirone, i pesci di frutta martorana si accostano a spiagge e faraglioni, i
ghirigori di glassa a colonne barocche. Martorana, nato a Palermo nel ‘60, ha
pubblicato libri fotografici, firmato numerose campagne pubblicitarie (negli
ultimi anni spesso legate al vino) è autore di bellissimi ritratti e le sue foto
sono state ospitate da note riviste italiane e straniere. Nel volume - una vera
gioia per gli occhi, foto a colori e in bianco e nero, scorci di Sicilia di
bellezza assoluta, storie di alta pasticceria che esalta le proprie radici - c'è
spazio pure per una dolce Sicilia al cinema e in letteratura, dai trionfi del
"Gattopardo" alle golosità del commissario Montalbano.

|
Parla
Gian Luigi Beccaria, professore di Storia della lingua italiana e membro
dell'Accademia della Crusca, autore di un saggio sul rapporto tra
scrittori e gastronomia
La Sicilia, Mercoledì 24 Marzo 2010
Cibo e scrittura, così come cibo e pittura, vanno a braccetto. Non solo
trionfi di frutti, carni e pesci sulle tele dei più grandi artisti dal
Rinascimento in poi; ma anche stravaganti impalcature cibarie nella cena
del "parvenu" Trimalcione, apoteosi di dolci nel pranzo di
nozze della provinciale Madame Bovary, filosofici gaudi promessi dalle
"spigole immerse nelle soffici salse" al ballo del
"Gattopardo", o "il 'pudding', il prosciutto, e l'oca
grassa dorata" di Joyce nel racconto "I morti"…
"Nelle pagine degli scrittori - nota Gian Luigi Beccaria in "Misticanze.
Parole del gusto, linguaggi del cibo" (Garzanti, 233 pagine, 15 €)
- la gola passa attraverso l'occhio, e attraverso la parola, scorre
lungo la qualità fonica del nome. Come se un nome lo si potesse
assaporare, masticare o bere." Un saggio che ci guida attraverso
letteratura e cibo e naturalmente lingua, visto che a condurci è un
professore di Storia della lingua italiana all'Università di Torino e
membro dell'Accademia della Crusca.
Il cibo è fantasia creatrice di termini, specialmente in questa Italia
che non ne vuol sapere di un idioma gastronomico nazionale; per cui non
c'è ancora accordo tra Nord e Sud per "cornetti" e
"fagiolini", branzino e spigola, anguria e cocomero; e se a
Brescia e Bergamo si mangiano i "casonséi", ecco a Mantova i
"tortei", a Ferrara i "caplázz" e a Parma gli
"anolén"; e se in Sicilia la fantasia mette in tavola gli
"uccelli scappati" che non sono affatto uccelli, in Lombardia
con ritagli di salumi imbandisce "a repüblica"; abbondano poi
i nomi di cibi usati per indicare difetti, per cui in Sicilia un
citrullo è un "cucciddatu" e in Lombardia un uomo goffo è un
"gnoch" o un "lasagnón".
- Professor Beccarla, il cibo, oltre che un "lusso di colore",
è anche un "lusso di parola"?
"Certamente, con la scrittura si sentono a parole nuovi sapori, le
parole fanno rigustare il cibo. Basti la lettura della famosa pagina di
Gadda sulla preparazione del risotto alla milanese o di quella in cui
Tomasi di Lampedusa descrive il 'torreggiante timballo di maccheroni'.
Il cibo è nomenclatura, 'ghiottoneria' mentale ed estetica, così come
lo è stato per tanti pittori, dalla 'Canestra di frutta' di Caravaggio
alle mele e pere di Cézanne, alle nature morte specie barocche."
- Per gli scrittori, insomma, il cibo è fonte d'ispirazione come lo è
per i pittori?
"Lo scrittore trova nella descrizione di un cibo un esercizio di
scrittura singolare, quasi che a parole si possano sentire nuovi sapori,
profumi, colori, e le parole ricucinassero il tutto."
- Perché il cibo ha una tale capacità di concentrare in sé tanti
significati filosofici e simbolici ?
"Il cibo è identità culturale, anche religiosa - nel libro ho
dedicato alcune pagine ai cibi ebraici, - è rito, è status symbol.
L'atteggiamento di fronte al cibo cambia da cultura a cultura; tutta la
storia dell'umanità civilizzata è ad esempio segnata dall'opposizione
sobrietà-eccesso, genuinità-corruzione. Un alone di sacralità ha
sempre circondato la mensa e la stessa preparazione del cibo, in
particolare del pane. Pane e convito sono diventati simboli di
fratellanza e dialogo. Nell'antica Grecia il convito era il luogo eletto
della conversazione, del canto. Grande poema conviviale è
l''Odissea'."
- Anche la fame ha avuto i suoi fasti letterari?
"La fame, che percorre la storia dell'umanità ha scatenato gli
eccessi della festa popolare, del carnevale, e coltivato l'illusione del
paese del Bengodi, o di Cuccagna, dove chi non lavora mangia, le
montagne sono di burro, gli alberi portano come frutti capponi già
cotti. E penso poi a pagine del Folengo, al 'Morgante' del Pulci, a
certi sonetti del Belli. Il sogno gastronomico di sontuosissimi
banchetti è stato ampiamente sviluppato da Cervantes, nelle fiabe con
le loro grandi tavole imbandite, la casina di cioccolato zucchero e
marzapane che compare nel bosco. La fame è sullo sfondo di molte pagine
dei 'Promessi sposi': la polenta di grano saraceno, l'assalto ai forni…"
- Sono molte le espressioni idiomatiche passate dalla cucina alla lingua
italiana ?
"Moltissime. A cominciare dal pane, che si è radicato largamente
nella lingua corrente, producendo una lunga serie di locuzioni del tutto
comuni: andare via come il pane, trovare pane per i propri denti, dire
pane al pane e vino al vino, se non è zuppa è pan bagnato, rendere
pane per focaccia. Pensiamo poi a espressioni e metafore come avere le
mani in pasta, spartirsi la torta, passare la patata bollente, né carne
né pesce, finire a tarallucci e vino, la ciliegina sulla torta, trovare
la pappa fatta…"
- I nomi di pietanze, pani, frutti eccetera cambiano da regione a
regione. Dunque in questo campo l'unità d'Italia non è compiuta?
"Rispetto al tempo in cui, nel 1891, l'Artusi scrisse il suo
fortunato volume 'La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene', la
lingua della cucina si è andata normalizzando. L'Artusi riuscì a
operare una certa unificazione: prima di allora era stato un ibrido
frasario di nomi regionali o stranieri, francesi in particolare. Ma
ancora oggi non abbiamo per certi cibi, pani, dolci eccetera un nome
nazionale. Nulla di male. Contribuiscono a comporre quel 'mosaico' di
varietà e colori che contrassegna la nostra storia e la nostra
identità."
CHEF DELLA SICILIA ORIENTALE
Da Ciccio Sultano a Pino Cuttaia, passa dalla cucina
il nuovo Rinascimento siciliano
Grandi chef, materie prime uniche, pasticcerie e
cantine d’eccellenza. Mai come oggi l’Isola ruggisce. Con un obiettivo: ridare
al Sud la terza stella Michelin.
di
LICIA GRANELLO
"Tante Sicilie, perché? Perché la Sicilia ha avuto la
sorte di ritrovarsi a far da cerniera nei secoli tra la grande cultura
occidentale e le tentazioni del deserto e del sole, tra la ragione e la
magia, le temperie del sentimento e le canicole della passione. Soffre, la
Sicilia, di un eccesso d’identità, né so se sia un bene o sia un male".
Deve essere stato ispirato da Gesualdo Bufalino il ragusano
Ciccio Sultano quando lo scorso inverno ha deciso di insufflare nuova energia
nella cucina del Duomo con il menù “Dominazioni”, dedicato all’evoluzione
storico- gastronomica dell’isola, impronta delle invasioni che si sono succedute
e degli ingredienti diventati parte integrante della cultura culinaria
siciliana. Un progetto così tosto, imponente, fortissimamente voluto, da far
tremare le vene dei polsi ai cultori del pessimismo isolano. "Si può fare!":
l’esclamazione-culto di Frankestein Junior vale molto più del semplice, pio,
desiderio di agguantare la terza stella Michelin, avendo consolidato negli anni
le prime due. Riguarda un modo diverso di pensare il futuro di sé e del proprio
“continente”, non più regno delle occasioni sprecate, ma nuovo paradiso
enogastronomico riconosciuto da una parte all’altra del mondo.
 |
 |
 |
 |
 |
|
Carmelo Chiaramonte
|
Ciccio Sultano |
Pino Cuttaia |
Alfio Visalli
|
Corrado Assenza |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Antonio Colombo |
Corrado Parisi
|
Philip Guardione
|
Peppe Aloisi
|
Giuseppe Catanese |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Gianluca Mignemi
|
Giuseppe Causarano |
Bianca Celano |
Seby Sorbello |
Domenico Privitera |
| |
 |
 |
 |
|
| |
Angelo Giuliano |
Carlo Sichel |
Alessandro Ingiulla |
|

Sultano non è certo un uomo solo al comando, se è vero che
altri tre cuochi bravissimi condividono lo status di bistellati. E tra loro,
Pino Cuttaia sta lanciando un progetto sulla pesca sostenibile nell’alta
ristorazione, che vedrà la luce a settembre. Ma il progetto di Ciccio Sultano è
pensato a trecentosessanta gradi, dai nuovi concetti culinari agli standard di
servizio, fino all’accoglienza in due strutture ricettive in fieri a Ragusa e a
Noto, oltre alla costituzione di una rete con alcuni tra i migliori artigiani di
Sicilia. Insieme appassionatamente il maestro di bottarga Alfio Visalli, che ad
Acireale lavora i migliori tonni delle Eolie, e le settecento galline dell’Aia
Gaia, felicemente razzolanti in un giardino aromatico sotto il borgo-presepe di
Ibla, i pescherecci della famiglia Testa e le farine di Tuminìa per il forno de
I Banchi, l’emporio- bistrot del Duomo.
ndo un momento di salute precaria dentro la famiglia Iaccarino determinò
la perdita della terza stella del Don Alfonso, a Sant’Agata sui Due Golfi, in
costiera sorrentina. Dal 2002, il margine più meridionale del gotha gastronomico
non è più sceso oltre l’Abruzzo (traguardo conquistato cinque anni fa da Niko
Romito). Il rinascimento siciliano non passa certo solo dalle valutazioni
gastronomiche francesi. La viticoltura è addirittura splendente. La visione
luminosa di un pugno di imprenditori locali — su tutti, Diego Planeta, Lucio
Tasca d’Almerita, Gabriella e Giacomo Rallo — ha determinato la fine del tempo
dei vini da taglio e delle uve vendute/acquistate a prezzi infimi, inaugurando
l’era della California d’Italia (con vini mediamente molto migliori). In scia a
Mille E Una Notte, Rosso del Conte e Santa Cecilia, è nato un intero firmamento
di piccole produzioni virtuosissime, esteso da Pantelleria all’Etna, nuovo
Eldorado enologico dove tutti i migliori (da Gaja in poi) cercano di
accaparrarsi qualche ettaro di vigna.
L’altra stella polare si chiama Caffè Sicilia, a una manciata
di passi dalla cattedrale di Noto: il suo patron Corrado Assenza, oggi
affiancato dal figlio Francesco, è il pasticciere che ha cambiato per sempre la
storia dell’arte bianca siciliana, determinando la differenza irrimediabile tra
zucchero e dolcezza, abbattendo il muro che divide il sapore dolce dal salato,
aggiungendo ai dessert freschezza e amaritudine, gusti proibiti della
pasticceria tradizionale, e assumendo come parametro senza ritorno quello della
qualità assoluta delle materie prime. Corrado Assenza è stato il primo a
raccontare, urbi et orbi, che arrampicato di fianco alla chiesa-madre di Ibla
c’era il ristorantino di un cuoco formidabile, capace di mettere insieme
ricciola e succo di carota, trasformandole in un boccone da far fare le capriole
al palato.
Sono passati diciotto anni e il rapporto tra Assenza e
Sultano è rimasto quello di allora: stima enorme e frequentazioni col
contagocce, com’è abitudine nella Sicilia ruvida dei primi della classe.
La nuova generazione è quella della fratellanza possibile:
diffusione delle pratiche biologiche, cura della terra e dell’acqua, attenzione
agli animali stanno supportando la promozione di materie prime e produzioni
strepitose. La storia della bottarga di tonno è emblematica. Visalli, che oltre
a fare delle magnifiche bottarghe è cuoco professionista, racconta come rispetto
dell’ecosistema e tecnologia si siano perfettamente integrate con la sapienza
secolare degli uomini di mare: "Agiamo di conserva con le associazioni di pesca
sostenibile, utilizziamo solo pesci di taglia adeguata. Una volta estratta la
sacca ovarica, abbattiamo, manteniamo sotto vuoto, lavoriamo solo quando ci
serve il prodotto perché non perda la fragranza". Sultano precisa che in questo
modo si ottiene l’obbiettivo di realizzare una semiconserva che ha una carica
batterica bassissima. "Nelle industrie mettono il colorante. Noi invece usiamo
solo tonno rosso, dissanguiamo la vena con la spatola per cancellare l’amarume,
lo massaggiamo dentro la salamoia. Poi mettiamo la sacca ovarica sotto pietra
per farla fermentare, per un tempo che oscilla a seconda del peso e del momento
in cui è stato pescato il pesce. Dopo il terzo cambio di sale, si aggiungono
zucchero Moscovado, rosa canina e fiori di sambuco, secondo il metodo arabo-
angioino".
La materia prima diventa una gemma preziosa, da appoggiare
sulla composizione di zucca infornata, alice marinata, arancia e gelatina di
bergamotto. La Sicilia in un boccone. Rinascimentale, of course. Tristellato,
chissà.
http://www.repubblica.it/sapori/rfood/2018/06/20/news/gastronomia_rinastimento_siciliano-198981802/?ref=search




|
|
 |
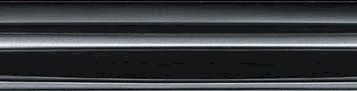
|
 |
|
|
|
|

|
|






 con formaggio
grattugiato e uova. Con questo impasto lo Scappi faceva delle polpette ovali
grandi quanto una noce, che cuoceva in brodo di pollo e condiva con altro
formaggio grattugiato, zucchero e cannella. Questo tipo di raviolo nudo
chiamato, strangulapriévete, pare fosse diffuso nel meridione d’Italia, con vari
impasti anche a base di carne, come racconta un Anonimo del ‘300 cuoco alla
corte angioina: “un impasto di carne o interiora di maiale o capretto, erbe
odorose, spezie pestate e uovo, con le quali si formano polpette della grandezza
di un uovo che si avvolgono con frammenti della pellicina che ricopre i visceri”
con formaggio
grattugiato e uova. Con questo impasto lo Scappi faceva delle polpette ovali
grandi quanto una noce, che cuoceva in brodo di pollo e condiva con altro
formaggio grattugiato, zucchero e cannella. Questo tipo di raviolo nudo
chiamato, strangulapriévete, pare fosse diffuso nel meridione d’Italia, con vari
impasti anche a base di carne, come racconta un Anonimo del ‘300 cuoco alla
corte angioina: “un impasto di carne o interiora di maiale o capretto, erbe
odorose, spezie pestate e uovo, con le quali si formano polpette della grandezza
di un uovo che si avvolgono con frammenti della pellicina che ricopre i visceri”

 uesta mia personalissima teoria avrebbe anche conferma nella maggior diffusione
dello stoccafisso nei porti del nord Italia, rispetto alla diffusione del
baccalà al sud. Infatti i primi pesci ad essere sbarcati erano ovviamente quelli
della parte superiore del carico, mentre gli strati più profondi, quelli più
salati, il baccalà insomma era quello che arrivava in Sicilia. Questo
spiegherebbe anche l’uso esclusivo per la Sicilia dello stoccafisso a Messina,
non dimentichiamo infatti che mille anni fa nel Mediterraneo si navigava quasi
esclusivamente sottocosta, quindi Messina era il primo porto Siciliano per le
navi che arrivavano dal Nord. Che la sposiate o no questa fantasiosa teoria non
è del tutto mia, mi fu esposta da un vecchio capitano trapanese che negli anni
’20 del secolo scorso comandava, appena diciannovenne, uno schifazzo una barca
da carico di 18 metri senza coperta, che da Trapani portava sale in Norvegia e
tornava carico di stoccafisso. Navigavano con vela latina, quindi solo con venti
di poppa, o con i venti di terra, la famosa “termica”, quindi navigavano
sottocosta. Fu lui a farmi notare che il fondo della stiva, quello che di solito
portava a casa, era praticamente baccalà, praticamente uguale al baccalà che
vendevano tutti i pizzicagnoli trapanesi.
uesta mia personalissima teoria avrebbe anche conferma nella maggior diffusione
dello stoccafisso nei porti del nord Italia, rispetto alla diffusione del
baccalà al sud. Infatti i primi pesci ad essere sbarcati erano ovviamente quelli
della parte superiore del carico, mentre gli strati più profondi, quelli più
salati, il baccalà insomma era quello che arrivava in Sicilia. Questo
spiegherebbe anche l’uso esclusivo per la Sicilia dello stoccafisso a Messina,
non dimentichiamo infatti che mille anni fa nel Mediterraneo si navigava quasi
esclusivamente sottocosta, quindi Messina era il primo porto Siciliano per le
navi che arrivavano dal Nord. Che la sposiate o no questa fantasiosa teoria non
è del tutto mia, mi fu esposta da un vecchio capitano trapanese che negli anni
’20 del secolo scorso comandava, appena diciannovenne, uno schifazzo una barca
da carico di 18 metri senza coperta, che da Trapani portava sale in Norvegia e
tornava carico di stoccafisso. Navigavano con vela latina, quindi solo con venti
di poppa, o con i venti di terra, la famosa “termica”, quindi navigavano
sottocosta. Fu lui a farmi notare che il fondo della stiva, quello che di solito
portava a casa, era praticamente baccalà, praticamente uguale al baccalà che
vendevano tutti i pizzicagnoli trapanesi. tetto, e attendevano al
gelo delle prime luci dell’alba folaghe e coddrivirdi: niente fuochi, niente
riscaldamento, unico conforto una candela per impedire l’intorpidimento delle
mani al momento di sparare. Quale migliore uso all’ora della candela per
scaldare un’aregna?
tetto, e attendevano al
gelo delle prime luci dell’alba folaghe e coddrivirdi: niente fuochi, niente
riscaldamento, unico conforto una candela per impedire l’intorpidimento delle
mani al momento di sparare. Quale migliore uso all’ora della candela per
scaldare un’aregna? ndo poi le carni cominciavano a colorire, giù una arrusciata
di vino vecchio, l’antenato del Marsala, fino alla completa cottura. Aumentando
di molto la quantità di cipolle e fermandoci a questo punto avremmo cucinato la
napoletana Genovese, ma quello che distingue questo splendido piatto partenopeo
dal nostro aggrassato non è soltanto la quantità di cipolle, ma l’aggiunta di
verdure, come patate o piselli, fave, asparagi selvatici, carciofi da stufare
assieme alla carne giunta quasi a cottura.
Come per molti piatti della cucina
classica siciliana, dell’aggrassato arriva al popolo soprattutto il sistema di
cottura, e quello che rimaneva nel tegame dopo avere tolto la carne, magari
attraverso gli sguatteri che avevano diritto agli avanzi, cioè l’untino e le
verdure che ad un certo punto diventarono soprattutto patate. Con queste verdure
e l’unto rimasto, quello che oggi chiamiamo il “fondo di cottura”, gli sguatteri
condivano la pasta inventando “la grassa” una delle ricette più diffuse a
Palermo.
ndo poi le carni cominciavano a colorire, giù una arrusciata
di vino vecchio, l’antenato del Marsala, fino alla completa cottura. Aumentando
di molto la quantità di cipolle e fermandoci a questo punto avremmo cucinato la
napoletana Genovese, ma quello che distingue questo splendido piatto partenopeo
dal nostro aggrassato non è soltanto la quantità di cipolle, ma l’aggiunta di
verdure, come patate o piselli, fave, asparagi selvatici, carciofi da stufare
assieme alla carne giunta quasi a cottura.
Come per molti piatti della cucina
classica siciliana, dell’aggrassato arriva al popolo soprattutto il sistema di
cottura, e quello che rimaneva nel tegame dopo avere tolto la carne, magari
attraverso gli sguatteri che avevano diritto agli avanzi, cioè l’untino e le
verdure che ad un certo punto diventarono soprattutto patate. Con queste verdure
e l’unto rimasto, quello che oggi chiamiamo il “fondo di cottura”, gli sguatteri
condivano la pasta inventando “la grassa” una delle ricette più diffuse a
Palermo.

 Uno scrigno di tesori zuccherati e paste ripieni che
i pronipoti di Angelo Savia hanno pensato bene di proporre anche in un
cestello di legno decorato affinché i catanesi se lo portino pure a
passeggio. E' indubbio, infatti, che si debba camminare a lungo per
smaltire i dolci. Almeno sino alla Piscaria, sotto gli archi della
Marina, un suq a due passi dall'elegante Palazzo Chierici, che sarebbe
tanto piaciuto a Corto Maltese per quelle facce da marinai che hanno i
venditori dai soprannomi impronunciabili per chi viene dal continente.
Uno scrigno di tesori zuccherati e paste ripieni che
i pronipoti di Angelo Savia hanno pensato bene di proporre anche in un
cestello di legno decorato affinché i catanesi se lo portino pure a
passeggio. E' indubbio, infatti, che si debba camminare a lungo per
smaltire i dolci. Almeno sino alla Piscaria, sotto gli archi della
Marina, un suq a due passi dall'elegante Palazzo Chierici, che sarebbe
tanto piaciuto a Corto Maltese per quelle facce da marinai che hanno i
venditori dai soprannomi impronunciabili per chi viene dal continente. 

 di prodotti
caratteristici così ricco di fantasia e di fasto da non essere
paragonabile a quello di nessun'altra regione. Basta entrare in una
pasticceria di Catania o di Palermo. I luoghi della gastronomia sono
ribalte sontuose. Ne sono un esempio la ricchezza cromatica e la
complessità strutturale della cassata, cibo di tanta seduzione da
indurre nei secoli andati certe suore a trascurare le pratiche pie per
dedicarsi alla ricotta e ai canditi.
di prodotti
caratteristici così ricco di fantasia e di fasto da non essere
paragonabile a quello di nessun'altra regione. Basta entrare in una
pasticceria di Catania o di Palermo. I luoghi della gastronomia sono
ribalte sontuose. Ne sono un esempio la ricchezza cromatica e la
complessità strutturale della cassata, cibo di tanta seduzione da
indurre nei secoli andati certe suore a trascurare le pratiche pie per
dedicarsi alla ricotta e ai canditi. 




 E
poiché siamo in vena di scoperte, una visita al mercato di Palermo, la
famosa "Vucciria", potrà avvicinarci nel modo più diretto
allo spirito della cucina siciliana e al carattere della Sicilia stessa.
Tutto è esposto con eccezionale senso del colore e uno strabiliante
gusto scenografico. Sul banco dell'ortolano trofei di carnosi peperoni
gialli, rossi, verdi si alternano a cascate di melanzane che variano dal
viola più quaresimale al bianco appena azzurrato. Incredibili varietà
di broccoli, zucchine, carciofi, insalate formano composizioni
trionfali.
E
poiché siamo in vena di scoperte, una visita al mercato di Palermo, la
famosa "Vucciria", potrà avvicinarci nel modo più diretto
allo spirito della cucina siciliana e al carattere della Sicilia stessa.
Tutto è esposto con eccezionale senso del colore e uno strabiliante
gusto scenografico. Sul banco dell'ortolano trofei di carnosi peperoni
gialli, rossi, verdi si alternano a cascate di melanzane che variano dal
viola più quaresimale al bianco appena azzurrato. Incredibili varietà
di broccoli, zucchine, carciofi, insalate formano composizioni
trionfali.