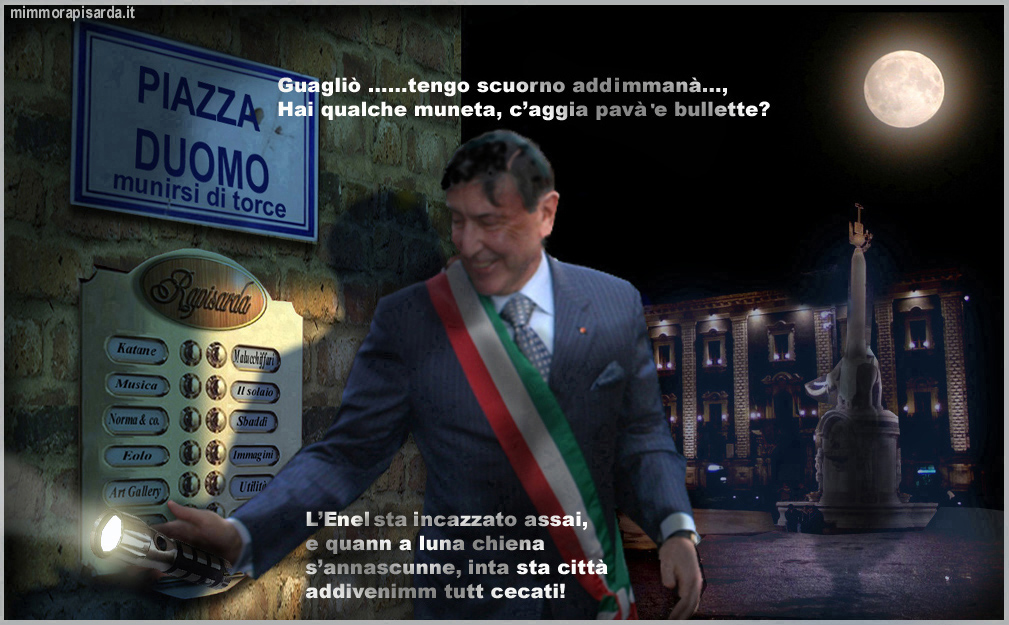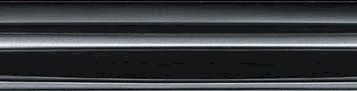|
Il nome. L'origine del toponimo è oscura. Secondo lo storico greco Plutarco, il nome deriverebbe dal greco "KATANE" ("grattugia"), in riferimento alle asperità del territorio lavico su cui sorge. Oppure dal protolatino "katina" (catino, bacinella), per la conformazione a conca delle colline intorno alla città. Secondo altre interpretazioni il nome deriverebbe dall'apposizione del prefisso greco "katà-" ("presso") ad "Aitnè", il nome greco dell'Etna (quindi "nei pressi di" o "appoggiata" all'Etna). Catania, prima di essere chiamata così definitivamente, ebbe comunque altri nomi: ETNA CATÀNA (o CÀTINA); BALAD-EL-FIL o MEDINA-EL-FIL (dall’arabo: Città dell’elefante). Altre supposizioni: KATNA (minuta, piccola); KATINON (recipiente, bacino); KATA-ANA (sconvolgimento causato da terremoti); KATÀ-AITNEN (in fondo, in basso, dell’Etna), o dalla voce araba QATANIYAH che si riferisce ad un prodotto agricolo cui era ricca la zona della Plaja. Teorie rispettabili ma la verità, probabilmente, non si saprà mai.
In termini geografici, la Sicilia aveva un aspetto molto diverso da oggi. L’abbassamento del livello del mare l’aveva collegata naturalmente alla penisola italiana, rendendo possibile il libero passaggio delle faune continentali. La Sicilia era collegata anche a Malta, formando un promontorio che si estendeva verso sud. L'isola appariva molto più grande, con un’estensione totale di circa 43.100 km², ben 17.000 km² in più rispetto a oggi.
Nonostante il clima rigido, la Sicilia era comunque un luogo
vivibile. La fauna offriva una grande varietà di prede: animali di
origine africana come elefanti e zebre, e grandi erbivori come il
cervo
europeo, il Bos primigenius (un bisonte estinto) e l'Equus
hydruntinus (un cavallo selvatico estinto). Anche i predatori erano
numerosi, tra cui leoni, ghepardi africani, lupi e orsi bruni
europei. Le antiche popolazioni siciliane vivevano grazie a una dieta che comprendeva anche molte erbe commestibili, come gli antenati di cicoria e lattuga. Le donne raggiungevano un’altezza di 1,65 m e gli uomini arrivavano a 1,70 m, notevolmente alti per l’epoca. L’aspettativa di vita superava i 30 anni, che era un record di longevità. Sono stati trovati scheletri di persone che vissero fino a oltre 43 anni, veri Matusalemme per il periodo. In questi scheletri, la dentatura è spesso quasi completa, segno di una dieta variegata e di una conoscenza avanzata dell’uso del fuoco per cucinare i cibi e renderli più facili da masticare e digerire. In sintesi, anche 22.000 anni fa, la Sicilia si dimostrava una terra generosa e accogliente per i suoi abitanti. Fonti: meteoaquilano.it; AMBIENTE E CLIMA DELLA SICILIA DURANTE GLI ULTIMI 20 MILA ANNI Alessandro Incarbona e altri -università di Palermo 2010. Il periodo preistorico. La Sicilia, prima dell'arrivo della colonizzazione ellenica, fu abitata da diverse popolazioni come Sicani, Elimi e Siculi: gli Antichi popoli di Sicilia. Queste furono le popolazioni preelleniche della Sicilia che i Greci trovarono quando arrivarono sull'isola nel 756 a.C.. Controversa è invece la presenza nell'isola di una popolazione denominata Morgeti. « I Siculi passarono in Sicilia dall'Italia - dove vivevano - per evitare l'urto con gli Opici. Una tradizione verosimile dice che, aspettato il momento buono, passarono su zattere mentre il vento spirava da terra, ma questa non sarà forse stata proprio l'unica loro maniera di approdo. Esistono ancor oggi in Italia dei Siculi; anzi la regione fu così chiamata, "Italia", da Italo, uno dei Siculi che aveva questo nome. Giunti in Sicilia con numeroso esercito e vinti in battaglia i Sicani, li scacciarono verso la parte meridionale ed occidentale dell'Isola. E da essi il nome di Sicania si mutò in quello di Sicilia. Passato lo stretto, tennero e occuparono la parte migliore del paese, per circa trecento anni fino alla venuta degli Elleni in Sicilia; e ancor oggi occupano la regione centrale e settentrionale dell'isola. » (Tucidide)
La lettera A Lo stemma di Catania che sovrasta l'elefante (simbolo di saggezza) e che ha suscitato nei secoli tante polemiche discussioni deve intendersi come l'iniziale di Agatha, la santa patrona della città. Questa è l'interpretazione più autorevole, sostenuta in primo luogo, e con maggior forza di documentazione e di logica, dal prof. Matteo Gaudioso in una sua relazione presentata il 7 luglio 1927 all'amministrazione comunale e, da questa, inviata alla Consulta araldica unitamente a due relazioni della commissione per la riforma dello stemma. Altre due interpretazioni oltre a quella religiosa (Agatha) ne erano state date in precedenza: quella politica, secondo cui la A rappresenterebbe il monogramma di Aragona («la rappresentazione simbolica - scrive il Gaudioso - della Città che sì erige in difesa dei Re Aragonesi»); e quella classicheggiante, che nella A vuole il monogramma di Athena, dea della sapienza (Catania, città colta per lo Studium generale, ossia l'università, fondata nel 1334, e per il suo primato culturale nell'antíchítà classica, per cui Catania fu denominata « la sícula Atene »). Una quarta, di compromesso, tentava di conciliare due di queste tre interpretazioni: Agatha e Aragona insieme. Se ne può concludere, sempre secondo la tesi peraltro storicamente e razionalmente valida del prof. Gaudíoso, che « le tre diverse rappresentazioni dello stemma... rispondono singolarmente, e ciascuna per la propria epoca, a tre diverse correnti di pensiero: in origine S. Agata; successivamente la rappresentazione simbolica della città, cui si pervenne per una contaminazione della originaria rappresentazione presumibilmente fra il XV e il XVI secolo; e finalmente, a fine secolo XVI, Athena, per una contaminazione mentale, senza che le rappresentazioni araldiche del tempo (il simbolo della Città) potessero dar pretesto ad una interpretazione così ardita ». da “Enciclopedia di Catania” - Autori Vari - Diretta da Vittorio Consoli - Editore Tringale www.cataniaperte.com
La Sicilia dallo stato selvaggio ai primi abitatori del paleolitico superiore Alcuni storici, come Tucidide, Strabone, Teocrito, ed altri vissuti nel Cinquecento, come Tommaso Fazello, con affermazioni strabilianti che si ritennero valide sino all'inizio dell'Ottocento, avevano diffuso tra il popolo la credenza che la Sicilia fosse stata abitata, in tempi remotissimi, da uomini di proporzioni gigantesche, alti circa dieci metri. Il Fazello avvalorava la sua tesi riferendo che nel tempo ih cui visse erano stati rinvenuti in diverse grotte sparse in Sicilia denti e ossa di incredibile grandezza. Ma, agli inizi dell'Ottocento, gli studi sulla paleontologia sfatavano la leggenda dell'esistenza, in tempi antichissimi, di uomini giganti. Evidentemente l'errata convinzione, formatasi attraverso i secoli sull'esistenza di uomini giganti, aveva tratto origine dal mito omerico dei Ciclopi .
A convalidare
l'esistenza degli uomini giganti avevano contribuito gli
sporadici ritrovamenti nelle caverne oltre che di denti
e ossa fossili, anche di crani di elefanti nani, in cui
gli orifizi della cavità nasale erano stati scambiati
per l'orbita di un solo occhio in mezzo alla fronte. L'esistenza in Sicilia di un complesso faunistico di proporzioni gigantesche, come ippopotami, elefanti, leoni, iene, orsi bruni, lupi ed altri mammiferi, che non erano autoctoni o indigeni, era avvalorata dal passato geologico dell'Isola, quando questa, attraverso un istmo, era unita alla penisola italiana. Gli sconvolgimenti del mare Mediterraneo, causati da spettacolari fenomeni vulcanici ed orogenetici agli inizi del Quaternario , quando tutta l'Europa era sotto una spessa coltre di ghiaccio, consentirono il passaggio dal Nord verso il Sud dei complessi faunistici alla ricerca di un clima meno rigido e più idoneo alla loro sopravvivenza. Il complesso faunistico, che nell'Isola per evoluzione regressiva si era fatto nano, come l'elefante, e che non raggiunse mai la terra africana per mancanza di comunicazione, scompariva definitivamente durante l'ultima glaciazione, circa trentamila anni addietro. Ai resti fossili, che nel corso dei secoli erano stati scoperti in molte grotte della Sicilia, si aggiungevano quelli che nel 1970 venivano scoperti nella grotta di Spinagallo , ad opera di un gruppo di giovani archeologi. Si rinvenivano abbondanti scheletri di mammiferi sia nani che giganti. Il ritrovamento permetteva anche la costruzione di una famiglia di elefantini . Come le grotte fossero dei cimiteri dei complessi faunistici non è del tutto chiaro. Sembra che durante i rigidi inverni dell'epoca glaciale i branchi dovettero ripararsi dagli eccessi del clima nelle grotte, senza poterne uscire, per cui ne sarebbe derivata una generale moria per inedia. tratto da “Catania - Le origini di Catania - Dal Quaternario al terremoto del 1693” Giovanni Merode e Vincenzo Pavone - Edizioni Greco CT - 1993
Sicani e i Siculi: la loro provenienza Nel corso di cinque secoli, fino alla colonizzazione greca, la situazione dell'Isola si stabilizzava con i due principali gruppi etnici dei Siculi e dei Sicani, rispettivamente ad Oriente e ad Occidente dei fiumi Imera e Salso, che ne segnavano i confini. I Sicani, che sin dal 1880 a.C. occupavano la Sicilia, come ci riferiscono le notizie tramandateci da Tucidide, avrebbero costituito indubbiamente le loro sedi anche nella zona della Sicilia orientale. Però, come riferisce'lo storico Adolfo Holm , di nessun singolo punto di questa regione può dirsi che vi abitassero. Le notizie sulla loro provenienza sono alquanto incerte. Secondo gli storici Timeo e Diodoro, venivano considerati autoctoni. Per altri storici, come Filisto, Tucidide, sarebbero un popolo di pastori, di origine giordana, che, attraverso il Nord Africa, nell'anno 2.400 a.C. erano giunti in Iberia (Spagna). Dopo alcuni secoli, in cerca di nuove terre, superando i Pirenei e la costa mediterranea della Francia e dell'Italia, sarebbero giunti in Sicilia. Tale teoria sarebbe la più accettabile. Quella sull'autoctonia si potrebbe accogliere solo se si considera che la loro lunga permanenza nell'Isola, avrebbe fatto perdere ogni memoria di una loro trasmigrazione. Si impossessavano di tutta l'Isola che da loro prendeva il nome di Sicania . Il loro dominio sarebbe durato 766 anni, fino a quando, nel 1034, sarebbe giunto il popolo dei Siculi. Gli storici antichi sono concordi nel ritenere i Siculi oriundi della penisola italiana. Tucidide afferma che provenivano dal Lazio . Spinti dagli Opifici e dagli Enotri sarebbero giunti in Sicilia con numeroso esercito. Vinti in battaglia i Sicani, li avrebbero respinti verso la parte meridionale e occidentale, occupando la zona orientale trecento anni prima della colonizzazione ellenica. I Siculi avrebbero costituito nei dintorni di Catania degli insediamenti, come è stato accertato da molti archeologi che, sin dal 1700, avevano rintracciato le vestigia di abitazioni primitive in capanne circolari e in gallerie di formazione lavica. Dai ritrovamenti archeologici si intuisce chiaramente che i Siculi avevano costituito nei dintorni di Catania i loro primi insediamenti verso il 1.000 a.C. Essi, che preferivano stanziarsi su posti elevati, sui monti e sulle colline, dedicandosi alla coltura dei campi lungo il pendio , avrebbero denominato la località Katinon. Questa voce, che apparterrebbe all'antichissima lingua sicula, avrebbe il significato di "grattugia", per indicare la caratteristica della natura topografica della zona, irta i colline sciarose, a causa delle colate del Vulcano Etna . Non si esclude l'insediamento di gruppi di Fenici, probabilmente nella zona bassa, forse alla foce del fiume Amenano, sin dal secolo X a.C, che avrebbe avuto lo scopo di incrementare l'attività commerciale con i Siculi. Alla zona del loro insediamento avrebbero dato il nome di Katua, che significherebbe "piccola città". Rivolgendo uno sguardo particolare ai Siculi, attraverso le notizie tramandateci dagli storici antichi, si deduce che essi osservavano il culto dei morti. I cadaveri venivano seppelliti in grotte, non disturbati dai viventi, e ne ostruivano l'ingresso con grossi macigni, allo scopo di assicurare agli estinti l'eterno riposo. Praticavano religioni che, secondo i fenomeni naturali, venivano considerate manifestazioni di potenze sovrumane, incarnate in entità sotterranee. Il sole, la luna, erano considerati regolatori della fecondità dei campi; il fuoco, la pioggia, le fonti e gli alberi, si animavano, divenendo spiriti naturali, divinità.
tratto da “Catania - Le origini di Catania - Dal Quaternario al terremoto del 1693” Giovanni Merode e Vincenzo Pavone - Edizioni Greco CT - 1993
"Si presentavano a loro un'insenatura formata da sabbia dorata di facile approdo (La Plaja) ed una scogliera pescosa di basalto, intervallata da ciottolato (Armisi, Li Cuti, Porto Ulisse) con lo sfocio a mare di due limpidi fiumi (Lamenano ad ovest e Lognina ad est). Un clima riparato neil mesi freddi da una montagna (Etna) con fitti boschi utili per la cantieristica marinara. Ricca di vegetazione: dal pino alla betulla, alle erbe commestibili, a numerose piante da frutto."
CENNI SULLA COLONIZZAZIONE GRECA DELL'ITALIA MERIDIONALE
Dalle fonti storiografiche,
Catania fu fondata tra il
729 e il 728 a.C. da coloni greci provenienti dalla città Calcide,
nell'Eubea, guidate da Tucle e salpati da Naxos, nel quinto anno dopo la fondazione
di Siracusa. Scacciati con le armi i siculi, fondarono le città
di Lentini e Katane. I nuovi abitan
A partire dall'VIII sec. a.C. iniziò l'espansione greca verso oriente, nel Mar Nero, e verso occidente, nel Mar Mediterraneo. La colonizzazione greca nell'Italia meridionale interessò le regioni della Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. I Greci si allontanarono dalle loro città d'origine, seguendo le rotte già percorse dagli Achei e dai Cretesi e cominciarono a fondare nuove colonie, spinti non solo da motivi politici, economici, sociali e demografici, ma anche da spirito di avventura, stimolati soprattutto dai racconti omerici. Le spedizioni furono guidate da un ecista, capo dei Greci colonizzatori, il quale prima della partenza veniva mandato a interrogare l'oracolo di Delfo, per avere istruzioni su dove fondare la nuova colonia. Iniziarono gli Ioni che fondarono Reggio sulla sponda dello stretto e dall'altra parte Zancle, l'odierna Messina. Proseguirono gli Achei con la fondazione dì Sibari e Crotone, e poi i Locresi con Locri. I colonizzatori della Ionia, per agevolare gli scambi commerciali con gli Etruschi e i Campani si spostarono sul Tirreno e fondarono altre subcolonie (Poseidonia, Laos, Terina). I siti vennero fondati in vicinanza dei corsi d'acqua, in zone pianeggianti e fertili che si prestavano bene all'edificazione di porti. I coloni trovarono in Magna Grecia un clima secco e mite, simile a quelli della madrepatria, e una terra ricca di boschi e corsi d'acqua.
Una volta fondata la colonia era necessaria la
costruzione di una cinta muraria per la difesa della città dagli
attacchi nemici; seguiva l'assegnazione dei lotti di terra ai coloni - i
primi arrivati avevano la terre più fertili - ed infine l'edificazione
di grandiosi templi. L'area dell'acropoli, "la città alta" con le dimore degli dei ed i larghi spazi riservati alle cerimonie religiose e ai sacrifici, contrastava con la disposizione irregolare e caotica dei quartieri della "città bassa" che presentava: strade strette, case assiepate, e rari pozzi d'acqua. I nuovi coloni, una volta approdati con le loro navi, si trovarono di fronte al problema di dover instaurare dei rapporti con le popolazioni del posto: Ausoni, Enotri, Itali, Siculi, Coi Messapi, Iapigi, che vivevano di pastorizia e di agricoltura. Gli indigeni erano organizzati in tribù, che però non avevano niente a che vedere con la più avanzata organizzazione politica, sociale ed economica delle poleis greche. Si venne così a creare un urto violento tra gli abitanti dell'Italia meridionale ed i nuovi colonizzatori che volevano appropriarsi delle loro terre. Il termine "Magna Grecia" (definita "Megale Hellas" dal locrese Timeo nel VI sec. a.C.) fu coniato o dai Greci orientali che rimasero affascinati dalle bellezze e dalla ricchezza dei luoghi, o dagli stessi coloni (i Greci occidentali che si stabilirono nelle nuove città) che volevano in questo modo dichiarare l'indipendenza dalla madrepatria celebrando le loro terre. Le città magnogreche raggiunsero uno splendore più grande della stessa Grecia, e assunsero grande importanza per gli intellettuali elleni tra il V e il IV sec. a.C.: vi si recò in visita Platone e vi si stabilirono Pitagora, Erodoto e Senofane. Come le poleis greche godevano di una loro indipendenza e autonomia, e spesso erano in contrasto tra loro per motivi politici e di conquista, così la stessa situazione si rifletterà anche nell'organizzazione delle colonie della Magna Grecia e ciò causerà la distruzione di fiorenti città (come Sibari, Siris). Le lotte intestine e l'eterna rivalità le poleis, porteranno, infine, ad un indebolimento delle città magnogreche che diverranno facile preda dei conquistatori romani. http://www.magnagrecia.it/pagare/calabria/italiano/itinerar/storia/storia.htm
Katane L'abitato arcaico doveva occupare una collina ben difendibile, immediatamente a ovest del centro della città moderna, in coincidenza dell'antico rione Montevergine, di piazza Dante e dell'ex-convento dei Benedettini (scavi del 1978). Si sa pochissimo sul primo periodo della sua storia. Ad esempio l'origine catanese del celebre legislatore Caronda, che fu esiliato e si trasferì da Reggio. Vi avrebbero soggiornato numerosi e celebri uomini di cultura, come il filosofo Senofane da Colofone (tra i fondatori della scuola eleatica) e i poeti Ibico e Stesicoro, che vi morì (la sua tomba era indicata presso la principale porta a nord della città, che da lui prese il nome di porta Stesicorea). Anche sulla sommità della collina dell'acropoli - oggi occupata dalla piazza Dante e dal grandioso monastero benedettino di San Nicolò l'Arena - in una serie di campagne di scavo iniziatesi nel 1978, sono stati scoperti strutture e materiali greci di VII secolo, che messi in relazione con quelli di Castello Ursino, suggeriscono l'idea che l'insediamento di Catania, al pari di quello di altre colonie siciliane, avesse occupato fin dagli inizi un ampio spazio senza procedere però alla sua capillare urbanizzazione. E' da ricordare ancora che sempre nel corso delle stesse indagini sulla collina dell'acropoli sono state rinvenute significative tracce di frequentazione del sito nel periodo preistorico, relative in specie al neolitico ed all'età del rame. Per i secoli VII e VI le fonti letterarie sono avare di notizie su Katane (questo il nome della città in epoca greca): ci fanno comunque sapere che, nei decenni iniziali del VI secolo, vi fu attivo Caronda che le avrebbe dato un corpo di leggi scritte. L'indagine archeologica invece permette di seguire durante questo periodo la progressiva - e non pacifica - espansione della colonia calcidese nel suo retroterra; una stipe votiva di eccezionale interesse (rinvenuta in città nel 1959 nell'area di piazza S. Francesco, ancora inedita), attraverso i suoi materiali ceramici di VI secolo provenienti non solo dalle officine di Atene e Corinto, ma anche di Sparta, Chio e altri centri greci, lascia poi intravedere una Katane che risulta a pieno titolo inserita nel mondo ellenico.
LA SICILIA COME LA RACCONTO' AI GRECI IL GRANDE OMERO
'MBARE TUCLE (Mimmo Rapisarda)
Vi racconto la storiella di un marinaio greco. La Grecia fu la più importante civiltà della storia antica dell’uomo; già duemila anni prima di Cristo nelle sue Agorà i filosofi si chiedevano chi fossimo, se rotondo o piatto era quel mistero oltre l’orizzonte e cosa ci sarebbe stato appena defunti. Tutto ciò mentre gli antenati di Salvini saltavano di ramo in ramo, fregando le bacche agli scoiattoli per sopravvivere. Ma, seppur potente, il territorio ellenico era di natura prevalentemente montuoso, arido, e non poteva garantire ai suoi abitanti, sempre più numerosi, una produzione agricola sufficiente al fabbisogno della popolazione. Questo problema sfociò in un diffuso malcontento sociale, già ampliato fra i ceti inferiori perchè costretti a subire la prepotenza degli aristocratici e soprattutto per i contrasti fra le “poleis” greche. E siccome ogni mondo è Paese, la residenza greca fu assicurata solo ai soliti pochi eletti, costringendo la classe meno abbiente a cercare altrove migliori condizioni di vita. Fantozzi esisteva anche allora! Così, col permesso di Atene a partire con le proprie navi, carichi da spirito di avventura e stimolati da quanto appreso nelle favole omeriche, questi esuli emigrarono altrove colonizzando terre mai viste ma conservando gli usi, i costumi e la religione della Madre Patria.
Ecco chi erano. - di etnia dorica Corinzi, Megaresi, Cretesi, Rodesi, che fondarono Megara, Siracusa, Gela, Agrigento, Eraclea, Selinute; - di etnia jonica i Calcidesi della penisola Eubea e dell’Isola di Nasso che, addentrandosi fino in Campania, fondarono la prima colonia greca italiana dal nome Cuma e dopo Naxos a Taormina, Reggio, Messina, Catania, Lentini, Milazzo; - proseguirono gli Achei con Sibari, Locri, Crotone e Metaponto; - e infine i dorici greci di Sparta, che fondarono Taranto, la più importante città della cosiddetta Magna Grecia il cui territorio si estendeva fino a Paestum, tanto da far preoccupare la terra d’origine. Il capo della spedizione era generalmente un nobile mandato ad interrogare l'oracolo per avere istruzioni su dove fondare la nuova colonia. L’Ecista (fondatore) non si limitava a guidare i coloni ma provvedeva anche alla costruzione della nuova città, all’assegnazione dei lotti di terra da coltivare e alla pianificazione urbanistica della stessa colonia. Niente a che vedere con Corso Martiri della Libertà a Catania. Se sapesse!
Il viaggio nella Sicilia orientale fu guidato dall'ecista Tucle da Calcide che, appena approdato in Sicilia, dovette fare i conti con i Siculi che si opposero per difendere le loro terre. Intorno al 734 a.C. fondò Zancle (Messina) e poi Naxos, l’approdo migliore. Viste le bellezze naturali, il promontorio e l’isola Bella ancora incontaminata, quel luogo straordinario volle chiamarlo Naxos in onore a Nasso, l'isola greca calcidese dove lui nacque e dove fu organizzata la spedizione.
In memoria di quel che accadde
tanti secoli fa, nel comune siciliano è stata eretta una statua
bronzea dedicata a Nike e rivolta verso quel mare che spinse sulle
sue spiagge le navi dei coloni greci. La statua si trova a Giardini
in Via Calcide Eubea (vi ricorda qualcosa?). Una seconda copia è
situata, invece, nell’attuale Calcide (Khalkis) per ricordare la
linea virtuale che unisce le due Naxos nonché il gemellaggio tra
Giardini Naxos e Calcide Eubea, celebrato nel 1965. Così questo Tucle, un giorno d’estate salì su quella collina dove successivamente fu costruito un teatro ad opera del rivale dorico Gerone, tiranno di Siracusa, e il suo sguardo lungimirante si allungò su qualcosa di affascinante che fumava al tramonto. Era Aitna, qualcosa che in vita loro i Greci non avevano mai visto. Così, spinto dalla curiosità e dalla sete di conquista, dopo sei anni guidò una spedizione più a sud e scoprì che adagiata sul mare e ai piedi di quel monte esisteva una terra meravigliosa ricca di laghi, fiumi, foreste, spiagge e fertili terreni. Bellissima, ma come chiamarla? Visto il territorio lavico su cui sorgeva la chiamò Katane (grattugia), anche se le interpretazioni riguardo il nome sono tantissime: da "katà-Aitnè" (dal greco "presso” e “Aitna”) fino alle nomenclature degli Arabi. Nel 728 avanti Cristo fu così fondata Katane, e poi Leontini soprattutto per tenere a bada i Siracusani, ma i nuovi abitanti (irriconoscenti “sdisangati e malusangu” già dall’antichità) fecero fuori Tucle sostituendolo con Evarco. Catania cominciò così la sua storia, con tutto quel che avvenne fino ai nostri giorni. Dichiarando l'indipendenza della Magna Grecia, tutte queste colonie raggiunsero splendori più grandi della stessa Madre Patria ma le lotte interne e l'eterna rivalità fra dorici e jonici, soprattutto in Sicilia, porteranno a un indebolimento della Grecia siciliana che diverrà facile preda dell’Impero Romano nel 263 a.C. Poi arrivarono i Bizantini nel 555, gli Arabi nel 900, i Normanni nel 1071, gli Svevi nel 1194, gli Angioini nel 1266, gli Aragonesi nel 1282 e conseguentemente gli Spagnoli nel 1516, i Borboni nel 1734, i Sabaudi nel 1860 e, dal 1947, quelli che ancora scaldano le poltrone a Sala d’Ercole. Ma questa è un'altra storiella. Purtroppo, a parte il teatro greco-romano, le testimonianze della colonizzazione greca a Catania sono pochissime rispetto a quella romana visibile ancora oggi in parecchi quartieri della città. Anche Goethe, incantato da quel monte fumante visto da Taormina, racconta nel 1787: ” …….. davanti a noi l’intero, lungo massiccio montuoso dell’Etna; a sinistra la sponda del mare fino a Catania, anzi a Siracusa; e il quadro amplissimo è chiuso dal colossale vulcano fumante, che nella dolcezza del cielo appare più lontano e più mansueto, e non incute terrore”. Questa è la storia di quel marinaio ellenico, impavido quanto Ulisse re di Itaca. Ma se l’Odisseo era solo una leggenda raccontata da Omero, 'mbare Tucle è esistito davvero. Tutto ciò che ho scritto è un piccolo messaggio ai miei concittadini: quando vi trovate al lungomare di Giardini, in attesa davanti alla pizzeria o in procinto di affittare lettino ed ombrellone, anziché guardare souvenir made in China sulle bancarelle fate qualche passo più avanti fino ad arrivare in una piazzetta dove è collocata una grande scultura in bronzo simboleggiante il coraggio, la perizia e la tenacia dei naviganti e che i residenti del luogo chiamano “L’uomo e il mare”. Se guardate bene, sulla statua c’è una targa su cui è scritto “Tucle, fondatore di Naxos”, a ricordo di quel previdente condottiero che noi catanesi dobbiamo ringraziare e che per tale motivo, essendo lo scrivente di queste righe nato nella terra del "peccuru", gli viene conferito d'autorità quello di "Tucle u spettu”. Pertanto, adesso che lo sapete, quando gli passate davanti rendetegli omaggio e toglietevi il cappello, perché vi troverete di fronte a colui che fondò Catania, la nostra città.
Il sesto giorno Dio compì la sua opera. Lieto di averla creata tanto bella, prese la terra tra le mani e la baciò. Là dove pose le sue labbra… è la Sicilia. (Renzino Barbera)
Nella splendida foto di Antonio Treccarichi, https://www.facebook.com/antonino.treccarichi https://www.instagram.com/antonio_treccarichi_ph/ la baia di Naxos e, sullo sfondo, l’Etna. Ecco quel che vide Tucle.
Del periodo greco non rimangono molte tracce, a causa di vari fattori sia naturali (terremoti che hanno rovinato la città, colate laviche) che antropici, come le ricostruzioni che spesso hanno ricoperto le precedenti architetture. Inoltre, non sono mai state eseguite grandi campagne di scavi e studi archeologici se non in casi sporadici della sua storia recente. Miglior fortuna hanno avuto i monumenti di epoca romana che hanno resistito fino ad oggi testimoniando l'importanza della città in antico, inoltre numerosissimi reperti provengono dagli scavi occasionali della città (la gran parte di questi – tra cui mosaici, statue e persino il frammento di una colonna istoriata – sono esposti al Museo civico). avevano imparato a conoscere la Sicilia attraverso l'immagine mitica che ne avevano riportato i primi navigatori audaci che dalla fine dell'VIII secolo a. C. vi si erano spinti. La loro opinione, quindi, era più favolistica che reale , ma proprio per questo l'isola costituiva agli occhi di quelle popolazioni una sorta di " eden " che stimolava lo spirito ulisside loro congeniale. La venuta dei Greci in Sicilia fu la conseguenza di una crisi s creata dalla degenerazione della situazione politica, i cui motivi possono essere schematizzati in quattro fattori essenziali, alla radice dei quali sta una potente spinta migratoria che premeva dall'Asia. Il primo è un motivo di ordine economico. La Grecia è una regione prevalentemente montuosa e povera di pianure coltivabili. Era conseguente per le popolazioni che vi abitavano e che crescevano rapidamente di numero la fame di terre fertili, da cui cavare il sostentamento per vivere: un'isola splendida, dove Proserpina andava a raccogliere tra tanto grano i fiori, era una meta desiderabile.
Il secondo è un motivo di ordine politico. Le monarchie, con il facile lavoro presso le corti e a capo di aziende e di poderi regali, avevano formato uomini abituati al benessere e alla libertà. La loro caduta lasciò una fascia di gente priva di lavoro e difficilmente docile ad un ridimensionamento sociale. Tentare una vicenda espansionistica ed assumere la guida di gruppi di emigranti era congeniale a gente abituata al comando.
Il terzo è un motivo di
ordine sociale. I vari gruppi aristocratici che successero
alle monarchie cozzavano nelle inevitabili rivalità e le
fazioni perdenti avevano vita difficile nella "polis", così
cercavano nell'emigrazione la fortuna loro negata in patria
e la libertà perduta. L'ultimo motivo, infine, che è di ordine psicologico, non si deve trascurare ed era costituito dalle condizioni umilianti a cui erano costrette le popolazioni delle città minori, vittime del gioco espansionistico. La ricerca di una libertà perduta, di un mondo ove poter realizzare i sogni di autonomia e stabilire istituzioni più libere fece da elemento unificatore e legò le molte famiglie greche coinvolte nelle vicende e nelle esigenze denunziate. Bastava trovare un capo per un sufficiente nucleo di scontenti e l'avventura cominciava. Migrarono a piccoli gruppi che andavano ingrossandosi man mano che si avvicinavano alla meta: erano calcidesi, dorici, ionici, attorno ai quali si aggregavano altri gruppi minori portanti tutti i propri usi, costumi, miti, lingua, forme artistiche e letterarie. Tutto questo spiega la molteplicità delle forme sociali, artistiche ed in genere espressive delle singolecittà che possono, quindi, dirsi calcidesi, doriche o ioniche solo perché quel tale elemento vi predomina, ma non perché ne sia l'unico. Col tempo, comunque, i Greci, dopo i primi scontri e le prime occupazioni, coesistettero con gli indigeni, convivendo e collaborando pacificamente con loro, fino ad una fusione e ad una assimilazione tali da eterminare una nuova civiltà, detta siceliota, con caratteristiche sue proprie, se pur modellata sul quadro di quella greca. Se la civiltà siceliota raggiunse l'unità di cultura, non raggiunse, tuttavia, quella di popolo. da “Catania dalle origini alla dominazione normanna” - Tino Giuffrida Libreria Editrice C. Bonaccorso www.cataniaperte.com
I Fenici in Sicilia (212-241 a.C.) La dominazione fenicia in Sicilia iniziò prima dell'VIII secolo a.C., con la creazione di alcune colonie nella zona occidentale dell'isola, e finì il 241 a.C., con la vittoria dei Romani nella prima Guerra Punica. Il periodo in cui l'isola è stata governata da Cartagine è definito "punico". I Fenici erano un popolo semita, che dall'odierno Libano stabilì un gran numero di colonie in tutto il mar Mediterraneo. La loro importanza fu offuscata da una delle colonie, Cartagine, fondata nell'814 a.C. nel nord dell'odierna Tunisia. Inizialmente, gli insediamenti, che erano di tipo commerciale(empori), erano diffusi su tutta la costa, ma con l'arrivo dei Greci si dovettero ritirare nella zona occidentale, dove fondarono vere e proprie città residenziali. Nel 734 a.C. i Fenici avevano fondato Mabbonath l'odierna Palermo, già abitata dai Sicani. Dello stesso periodo è la fondazione di Mtw cioè Mozia, che si ingrandì molto ospitando i Fenici espulsi dai Greci. Kfra (Solunto) fu il terzo polo delle colonie fenice in Sicilia, fondato intorno al 700 a.C. Le tre città rivestirono un ruolo di primaria importanza nei commerci con le zone circostanti e validi porti amici per le navi degli alleati Elimi.
La dominazione romana in Sicilia iniziò il 10 marzo 241 a.C. con la vittoria di Torquato Attico e Catulo sulle truppe cartaginesi di Annone nella battaglia delle isole Egadi. Catania fu conquistata nel 263 a.C.. La dominazione romana si concluse nel 440 d.C., con la spedizione del vandalo Genserico che conquistò l'isola.
Nel 263 a.C.,
all’inizio della prima guerra punica, Catania
(lat. Catĭna o Catăna)
venne conquistata dai Romani,
sotto il comando del console Massimo Valerio Messalla. Del bottino
faceva parte un orologio solare che fu collocato nel Comitium a Roma. Da
allora la città fece parte di quelle soggette al pagamento di un'imposta
a Roma (civitas decumana)È Intorno al 135 a.C., nel corso della prima guerra servile, fu conquistata dagli schiavi ribelli. Un’altra rivolta capeggiata dal gladiatore Seleuro nel 35 a.C., fu domata probabilmente dopo la morte del condottiero. Nel 122 a.C., a seguito dell’attività vulcanica dell’Etna, fu fortemente danneggiata dalle ceneri vulcaniche stesse piovute sui tetti della città che crollarono sotto il peso. Il territorio di Catina, dopo essere stato nuovamente interessato dalle attività eruttive del 50, del 44, del 36 e infine dalla disastrosa colata lavica del 32 a.C., che rovinò campagne e città etnee, nonché dai fatti della disastrosa guerra che aveva visto la Sicilia terreno di scontro fra Ottaviano e Sesto Pompeo, si avviò sulla lunga e faticosa strada della ripresa socio-economica già in epoca augustea. Tutta la Sicilia alla fine della guerra viene descritta come gravemente danneggiata, impoverita e spopolata in diverse zone. Nel libro VI di Strabone in particolare si accenna alle rovine subite dalle città di Syrakusæ, Katane e Kentoripa. ___________ L'attività principale dell'isola, quella agricola, era parecchio dissestata; molte terre erano abbandonate, perchè mancava la manodopera. Augusto affidò una grande estensione del territorio ad Agrippa, suo valoroso generale, e tenne per sè un'altra zona non meno estesa. Una terza zona venne divisa in piccoli appezzamenti, che furono distribuiti ai veterani in congedo dell'esercito di Augusto. Quest'ultimo accorgimento era diretto a far sì che, mescolandosi inevitabilmente i veterani con la popolazione locale, nascesse il senso di coesione e quindi la fedeltà a Roma. La struttura amministrativa fu rinnovata. Esistevano tre gruppi di città: le "colonie"(Taormina, Catania, Siracusa, Tindari, Terme e Palermo), dove affluirono molti veterani romani; i "municipia", che si differenziavano dalle prime sotto il profilo onorifico, che era di minore importanza; le città assoggettate a Roma, che continuavano ad avere autonomia negli affari interni. Fu modificato il sistema tributario: alla decima, pagata in natura, fu sostituito lo "stipendium", un'imposta sulla terra pagata in denaro, probabilmente perchè il grano siciliano non era più indispensabile a Roma, che aveva nuove fonti di approvvigionamento nell'Egitto e nel Nord Africa. Sotto l'impero la Sicilia fu integrata in modo completo nella nuova organizzazione e nel 212 le fu estesa la "Constitutio Antoniana" dell'imperatore Caracalla, che concedeva la cittadinanza romana a tutti i cittadini liberi dell'impero. In Sicilia regnò la pace, se si esclude una esplosione di banditismo nel 260. La struttura economico-sociale sotto l'impero presenta interessanti caratteristiche. Nonostante in Sicilia le classi medio-alte godessero di una certa prosperità, documentata dalle opere pubbliche, non c'è traccia di siciliani che abbiano fatto carriera in politica, come avveniva, invece, in altre province romane.
L'attività alla base della ricchezza della Sicilia era l'agricoltura, che forniva i prodotti per il commercio. Gli scambi avvenivano con l'Africa, la Gallia, la Spagna. La prosperità dell'agricoltura rimase immutata nei secoli e, quando nel III sec. l'Italia attraversò una crisi di questo settore, essa non interessò certamente la Sicilia. Gli schiavi impegnati nell'agricoltura erano numerosi, ma furono sempre più spesso sostituiti dagli affittuari. Alcuni di essi, che prendevano in affitto grandi estensioni di terreno, usavano dividerle in piccoli appezzamenti e subaffittarle.
Alla notevole ricchezza di alcune
famiglie, documentata dalla villa del Casale presso Piazza Armerina,
faceva riscontro la povertà della massa, che peraltro produceva
ricchezza con il suo lavoro. Le città più importanti e popolate erano Catania, Siracusa, Messina, Agrigento. http://www.ilcasalediemma.it/sicilia-Il+periodo+imperiale-230.asp
Il Teatro Romano (del II secolo), l'Odeon (III secolo), l'Anfiteatro (II secolo), le Terme dell'Indirizzo, le Terme della Rotonda, le Terme Achilliane, varie altre strutture termali (in piazza Sant'Antonio, piazza Itria, piazza Dante dove è stata trovata la strada basolata oggi allo scoperto) i resti di un acquedotto presso via Grassi e alcuni edifici funerari, il foro sono i maggiori resti attualmente visibili della Catania romana. Molti di questi monumenti fanno parte dal 2008 del Parco archeologico greco-romano di Catania, istituito dalla Regione Siciliana e alcuni di essi come il Teatro romano, le Terme della Rotonda e altri monumenti minori sono stati restaurati e resi visitabili. Anche i resti dell'anfiteatro sono visibili dal 1907 (anno in cui sono stati riportati alla luce) dall'ingresso di piazza Stesicoro e dal cortiletto di via Anfiteatro. Probabilmente anche "'u liotru", il simbolo della città situato attualmente al centro di piazza Duomo, è stato scolpito in epoca romana se non prima. È un manufatto in pietra lavica porosa, che raffigura un elefante. Il nome deriva probabilmente dalla storpiatura del nome di Eliodoro, negromante semi-leggendario e grande avversario di Leone il Taumaturgo. L'elefante è sormontato da un obelisco egittizzante di cronologia incerta con figure probabilmente legate al culto isideo. Del periodo Tardo Antico rimangono i resti delle necropoli a nord e ad est del centro storico (tra i quali i mausolei di viale Regina Margherita e via Ipogeo), come pure numerosi frammenti, lapidi (tra cui quella di Julia Florentina esposta al Louvre), o il cippo esposto al Castello Ursino. Sono invece di epoca paleocristiana le cripte di Sant'Euplio, di Santa Maria La Grotta, della cappella nell'Ospedale Garibaldi, nonché gli ambienti del cosiddetto Sacro Carcere. A Catania esisteva anche una naumachia, poi travolta dall'eruzione del 1669, certamente alimentata dall'acquedotto. L'acquedotto era lungo 23 chilometri e dentro Catania, a partire da un sontuoso ninfeo (il cui pavimento marmoreo fa ancora bella mostra in una sala di Palazzo Biscari), si diramava in un articolato sistema di adduzione che passava sotto i lastrici stradali (un canale è ancora esistente in via Crociferi), alimentando, oltre agli edifici ricordati, anche numerose fontane. Dell'acquedotto sopravvivono numerosi tratti, sparsi fra Catania e Santa Maria di Licodia. Quella raffigurata dovrebbe essere la porzione di contrada Porrazzo nel territorio di Paternò.
La Catania Romana: Stato giuridico, Guerre civili, Cesare, Ottaviano e i due Pompei. di Davide Valenti Prima che il console Levino stabilisse il nuovo ordinamento giuridico, amministrativo e fiscale dell'Isola , si provvide a sottoporre i territori frattanto acquisiti a Roma alla “Lex hieronica" che prevedeva, fra l'altro, un sistema tributario fondato sulla riscossione delle decime agricole. Il nuovo regime aggiunse una serie di acquisti forzosi a prezzi fissati d'autorità, un dazio del cinque per cento sulle operazioni portuali (la Lex censoria portus Siciliae), ferree restrizioni alle esportazioni che non riguardavano il territorio italiano, ed alcune gabelle destinate a mantenere flotte a difesa e presidio delle città portuali. Data l'importanza di approvvigionamenti copiosi e puntuali per Roma, si può facilmente immaginare quanto dovette rivelarsi esoso il fisco per una comunità come quella catanese che godeva dell'entroterra più , fertile della Sicilia e di un porto ampio e funzionale. L'ordinamento prevedeva la ripartizione delle 68 comunità siciliane in quattro tipologie amministrative: le foederatae, le libere atque immunes, le decumane, sottoposte cioè a decima al cui novero apparteneva Catania, e quelle costituenti, come ager publicus, proprietà della città di Roma. La riscossione delle decime, a Catania come altrove, veniva data in appalto con un sistema simile a quello in vigore sotto Gerone Il, tramite un’asta tenuta localmente ogni anno. I potenziali appaltatori potevano giovarsi di una lista di soggetti tassabili composta di proprietari terrieri e di lavoratori ed usufruttuari. All'inizio si fece in modo che i maggiori "pubblicani" fossero cospicui uomini d’affari siciliani, poi gradualmente la riscossione passò alle grandi compagnie romane. La classica città decumana rifletteva in sostanza l'ordinamento vigente a Roma: Catania ebbe così un Senato, un proágoro , con funzioni di sommo magistrato, dei questori, cui spettava la riscossione delle tasse comunali, dei magistrati edilí e dei censorí incaricati di tassare la città per le necessità interne della stessa. A capo della Provincia di Sicilia stava un governatore che, per molti versi, assumeva i connotati di un plenipotenziario ed aveva di norma un mandato annuale.
La città di Catania fu eccezionalmente ricca di acque,sin dalla sua fondazione. I Romani,in aggiunta,ne misero di propria costruendo un Acquedotto che dire stupefacente è poco.
Nel I secolo dc questo Acquedotto
portava da Santa Maria di Licodia,cioè da ben 28 chilometri da
Catania,un volume d'acqua pari a 30.000 metri cubi al giorno. Senza alcuna azienda municipalizzata ! Questa bella stampa che ho postato è della fine del '700 e ritrae proprio l'Acquedotto Romano. L'acquedotto Biscari sorge ad Adrano ed è chiamato dagli adraniti "il Ponte Biscari". Costruito a circa 1 km dalle campagne del Mendolito, convoglia in un condotto chiuso le acque delle sorgenti delle "Favare", presso “Santa Domenica” e, attraverso la contrada “ della Carrubba” e di altre terre, le incanala verso il feudo di contrada “ Ragona” o “Aragona”. Notizie tratte dal “Dizionario topografico della Sicilia” (Amico, 1865), citano come la contrada Aragona era "Casale un tempo esistente nel territorio detto oggi volgarmente di Ragona, tra Centorbi ed Adernò, con una torre. Appartenevasi nel 1408 a Giovanni Eschisano, come si rileva dal censo di Re Martino; a Perollo di Modica nel 1479, che il vendette ad Artale Mincio, donde pervenne a Giovanni Paternò, ed oggi per dritto dei padri suoi ad Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari." In esso "Ci ha una sorgiva di acqua puzzolente nerastra e zolfurea." Ancora oggi sono visibili i fabbricati ed i ruderi della masseria ubicata nel mezzo della Piana d’Aragona, adiacente alla strada. L’acquedotto attraversa il fiume Simeto nel “Passo della Carruba”, in contrada “Cimino”, nel territorio tra i comuni di Adrano e Centuripe.Nella foto di repertorio i resti dell'Acquedotto Biscari.
I RUDI ROMANI SCENDONO IN SICILIA E NE FANNO IL LORO GRANAIO I Mamertini, mercenari campani, furono al servizio di Agatocle di Siracusa fino al 289 a.C. quando, alla sua morte conquistarono Messina. I Mamertini chiesero aiuto a Roma contro nel 264 a.C. Ebbe cosi inizio la prima guerra punica. La conquista romana non fu indolore: nel 261 la splendida Agrigento, dopo un sanguinoso assedio, fu espugnata ed i suoi abitanti trucidati o venduti come schiavi.
Ai veterani romani come premio
vennero assegnati vasti possedimenti, dando cosi origine a quella
piaga siciliana dei latifondi, che dovevano scomparire solo negli
anni Cinquanta del secolo scorso, sotto la pressione dei movimenti
contadini. I Romani si stabilirono in una Sicilia dalle antiche
tradizioni culinarie e in quasi otto secoli di dominazione hanno
lasciato anche qualche traccia. Roma raggiunse nel II secolo d.C. intorno a due milioni di abitanti. Una simile popolazione poneva enormi problemi per l'approvvigionamento di cibo e di acqua. Divenuta potenza globale, importava grandi quantità di derrate alimentari dalle sue province divenendo l'insaziabile "ventre del mondo". I cuochi siciliani, fra tutti Trimalchio da Siracusa, erano ricercati nella Roma imperiale. I cuochi servivano l'aristocrazia e l'alta borghesia. La plebe, quando poteva mangiava puls di farro, un fossile vivente che ha dato il nome alla farina e oggi ritornato di moda, legumi, verdure. pane nero e qualche volta carne conservata sotto sale. Il lievito, u criscenti che faceva crescere il pane lievitandolo, fino a pochi decenni fa in Sicilia veniva preparato e conservato con lo stesso procedimento che è riportato da Plinio nella “Naturalis Historia”. Sembra che la lievitazione sia opera degli Ebrei, anche se nelle festività consumavano pane azimo. Nell'Esodo (12, 39) si legge: “Essi fecero cuocere sotto forma di focacce azime la pasta che avevano portato dall'Egitto e non avevano potuto indugiare, né avevano fatto provviste. Gli Egizi producevano un pane bianco lievitato, l'hori, che veniva consumato dai nobili. Per millenni nel Mediterraneo il pane lievitato rimarrà appannaggio delle classi dominanti. Il popolo mangiava focacce azime fatte con un miscuglio di farina di grano, spelta, crusca, legumi, cereali e verdure che sono rimasti in Sicilia tra le poche possibilità alimentari fino alla prima metà del secolo scorso. I nostri sformati affondano le radici. nelle torte salate di formaggio e di verdure che una costante nei banchetti romani. La 'mpanata con tutte le sue varianti siciliane (scacciata, scaccia, fuazza, pastizzo, u pistuni missinisi, la comisana mitilugghia, il siracusano scacciuni, l'in figghiulata di Rosolini) trova le radici nella pasta di pane farcita con formaggio e cotta al forno. La farcia nella 'mpanata dipende spesso dalla disponibilità degli ingredienti e dalla fantasia della massaia. “U chinu da 'mpanata” che Pirandello usa come metafora nel Berretto a sonagli, è sempre una sorpresa. Le 'mpanate siciliane, dove i sapori e i profumi sono nascosti in una dorata crosta di pane, sprigionano tutta la loro fragranza quando si affonda il coltello. ______________________
Stralci provenienti da SPIGOLATURE STORICHE SULLA CUCINA DI SICILIA di Gino Schilirò – Aracne editrice 2019 – esclusiva concessione del Prof. Schilirò per il sito web mimmorapisarda.it - © tutti i diritti riservati
De facto poteva considerarsi inamovibile. Buona parte dei territori appartenuti a nemici dichiarati di Roma venne invece confiscata ed annessa all' ager publicus a partire dal 210 per esser poi offerta in dono a quanti si fossero segnalati, specie nell'ordine equestre, per meriti speciali. Costoro si organizzarono presto in una corporazione, il conventus, ed esercitarono di fatto un'influenza costante sui funzionari romani. Gran parte del territorio di Leontini divenne presto ager publícus , o in forma di semplice donazione o - e ciò dovette avvenire assai di frequente, tenuto conto dellafertilità della Piana - in affitto, in grossi appezzamenti, per una somma nominale stipulata. L'entroterra di Catania che veniva regolarmente sottoposto a decima dovette corrispondere a Roma ingenti forniture frumentarie, i boschi etnei continuarono ad offrire legname pregiato mentre la pesca nei ricchi fondali ionici , a quanto risulta, arricchiva di crostacei le luculliane mense romane. E se si tiene in considerazione la larghezza con cui si fece fronte all'edilizia urbana sin dalla fine del terzo secolo, che per la monumentalità delle fabbriche pareva sollevare insospettabili ambizioni, ci si farà un'idea del tenore di vita deicatanesi, che dovettero finanziare in gran parte quelle opere pubbliche. Al Teatro greco e all'Odeon (monumento coperto destinato alle rappresentazioni musicali, unico esemplare nella grecità o ccidentale) le cui vestigia furono rinvenute dai nuovi dominatori che si accinsero presto a mutarne radicalmente l’aspetto ricostruendone intere parti, vanno aggiunti il Foro, risalente all'età repubblicana e di cui restano pochi ruderi nel'odierno Corti le San Pantaleone l'Anfiteatro, il Circo Massimo e la colossale Naumachía, tutte della tarda età imperiale. Quanto all'Acquedotto e al Ginnasio possiamo datarli rispettivamente alla prima età imperiale sebbene molti lavori venissero effettuati sino al III secolo d. C. e al consolato di Marcello il quale, trovata la fabbrica di quello greco nei pressi dell'odierno Castello Ursino, la fece subito restaurare destinandola, oltre che ai consueti esercizi ginnici, all'istruzione pubblica, e ciò realizzò giovandosi del bottino di guerra rimediato a seguito della presa di Siracusa, quasi ad indennizzo della città etnea per meriti di cui la storia tace. Intanto le nuove intraprese militari che videro l'estendersi del dominio romano dall'area greca sino all'Asia minore, comportarono l'innescarsi delle consuete economie di guerra, non ultima la compravendita delle genti gettate in schiavitù, che confluirono copiosamente verso i domini pacificati dalla lex romana. La Piana di Lentini e gran parte della Sicilia centro-occidentale furono interessate da un inspessimento della popolazione servile, di norma di lingua e costumi greci, in cui non erano rari uomini di buoni natali e di spessore culturale. Quali che siano stati i moventi primi della guerra servile esplosa nel la seconda metà del II secolo ad Enna (139?) col linciaggio del possidente Damòfilo, e secondata nella regione di Akragas dalle imprese dell'ex pastore Cleone, i dintorni di Catania pare vennero risparmiati e non si segnalarono disordini di sorta. La storia si limita a riferire che i rivoltosi di Enna, fatta giustizia sommaria del detto Damòfilo e della consorte Megàllide, vollero risparmiare la di loro figlia conducendola dai parenti a Catania ove, come si evince con disinvoltura, si riteneva altamente improbabile l’incrudelirsi dell'odio di classe, malgrado anche la città etnea venisse in mano agli schiavi, come Tauromenio ed Enna, pur senza gli spargimenti di sangue che si erano segnalati altrove. Solo nel 132 il console Rupilio soffocò i tumulti facendo intervenire un esercito regolare. La seconda guerra servile (104 99 ca.), conclusasi a un dipresso col medesimo bagno di sangue della prima, non riguardò la Sicilia orientale se non per il particolare crisma religioso che i rivoltosi di Salvio vollero conferirsi: quello dei Gemelli Pàlici, protettori dei servi fuggiaschi e tutori dei giuramenti, il cui santuario sorgeva ancora, come s'è detto, presso il lago Nàftia , non lungi dall'odierna Palagonia. Fra le due guerre servili va però collocata la devastante eruzione dell'Etna (122) che infierì sul territorio catanese quanto bastasse a che si esonerasse la città dal pagamento della decima per dieci anni. E siamo così giunti ad uno degli episodi più tristemente noti ed esemplari del dominio romano in Sicilia, complice Cicerone: il triennale governatorato di Verre.
Dopo la guerra contro Sesto Pompeo, Augusto vi dedusse una colonia. Plinio il Vecchio annovera la città che i romani chiamano Catina fra quelle che Augusto dal 21 a.C. elevò al rango di colonie romane assieme a Syracusæ e Thermæ (Sciacca). Solo nelle città che avevano ricevuto il nuovo status di colonia furono insediati gruppi di veterani dell’esercito romano. La nuova situazione demografica certamente contribuì a cambiare quello che era stato, fino ad allora, lo stile di vita municipale a favore della nuova "classe media". Nonostante questi continui disastri, che costituiscono una delle costanti della sua storia, Catania conservò una notevole importanza e ricchezza nel corso della tarda repubblica e dell'impero: Cicerone la definisce «ricchissima», e tale dovette restare anche nel corso del tardo impero e nel periodo bizantino, come si deduce dalle fonti letterarie e dai numerosi monumenti contemporanei, che ne fanno un caso quasi unico in Sicilia. Le grandi città costiere come Catina, nel corso del medio-impero, estesero il loro controllo, anche a fini esattoriali dello stipendium, su un vasto territorio nell’entroterra dell’isola che si andava spopolando a causa della conduzione latifondistica della produzione agricola. Subito agli anni dell'istituzione della colonia, quand'era necessario dare un'impronta romana alla città, è da ricondurre la sistemazione dell'area forense intorno all'attuale cortile S. Pantaleone; allo stesso periodo inoltre sembra risalire una decisa azione di riordinamento del tessuto viario della città. Sulla base di recenti scavi condotti in via Crociferi e di una carta manoscritta del Cinquecento, la rete stradale della colonia risulta in qualche modo rintracciabile in quella odierna della zona che ruota intorno alla via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra la piazza Duomo e la via Plebiscito; nei secoli dell'impero comunque il tracciato augusteo fornì le direttrici per l'espansione dell'area urbana in particolare verso sud, dove verrà anche edificato il circo per le corse dei carri.
Il limite nord della città imperiale fu invece rappresentato dall'anfiteatro: costruito nel II secolo d.C. l'edificio nella sua grandiosità può ritenersi il coronamento del processo di accumulazione di ricchezze iniziatosi a Catania con l'elevazione al rango di colonia. Esso, inoltre, considerato insieme agli altri luoghi di spettacolo della città come il teatro e l'Odeon, ai numerosi complessi termali o all'efficientissimo sistema di approvvigionamento idrico, è significativo dell'alto livello della qualità della vita che dovette caratterizzare Catania durante l'età imperiale. Il Cristianesimo vi si diffuse rapidamente; tra i suoi martiri, durante le persecuzioni di Decio e di Diocleziano, primeggia Sant'Agata, patrona della città, e Sant'Euplio. La diocesi di Catania è accertata fin dal VI secolo. Non è possibile al momento definire esattamente i tempi e i modi dell'introduzione e dell'affermazione del Cristianesimo a Catania, anche se si può pensare che qui non pochi fossero i fedeli della nuova religione alla metà del III secolo d.C. quando, durante la persecuzione dell'imperatore Decio, la tradizione data il martirio di Agata, la patrona della città. Notizie più sicure sulla Catania cristiana si hanno invece a partire dal IV secolo d.C. grazie ad un consistente nucleo di iscrizioni ed agli scavi condotti in aree sacre o cemeteriali. Ai tempi dell’imperatore Decio, Catania era una città ricca e fiorente,che per di più godeva di un’ottima posizione geografica. Il suo grande porto, nel cuore del Mediterraneo, rappresentava uno dei più vivaci punti di scambio commerciale e culturale dell’epoca.
Le fonti storiche narrano che era amministrata dal proconsole Quinziano, uomo rude, prepotente e superbo. Con moglie e famiglia, una corte numerosa, le guardie imperiali e una schiera di servi, alloggiava nel ricco palazzo pretorio, un enorme complesso di edifici con annesse aule giudiziarie e carceri, in cui si svolgevano tutte le attività pubbliche della città. L'imperatore Decio
L'imperatore Decio salì
al trono di Roma nel 249. Durante il suo consolato, l'impero romano
attraversò una profonda crisi, sia a causa d'invasioni barbariche in
alcune sue province, sia per diffico Decio si adoperò, quindi, per una salda e definitiva riorganizzazione dell'impero, incominciando col rinvigorire il culto agli dèi pagani, sia nelle cerimonie ufficiali che private. Contemporaneamente, in contrasto col comportamento del suo predecessore Filippo (244-249) che manifestò verso il cristianesimo grande tolleranza e aperta simpatia, Decio all'improvviso fece scoppiare una nuova persecuzione contro i cristiani, perché capaci di sviare il popolo dal culto pagano, orientandolo verso un unico Dio, attirando così sull'impero la collera degli dèi. Egli fece perseguitare, oltre ai comuni seguaci di Cristo, anche Vescovi e Papi. Infatti mandò al martirio il vescovo di Gerusalemme e quello di Antiochia; e sempre per volere di Decio, morì martire pure papa Fabiano, fatto che procurò sollievo all'imperatore avendo egli tolto ai cristiani di Roma l'autorevole appoggio; si racconta che così abbia commentato questa morte: "Sarebbe molto meglio aver a che fare con un altro rivale al trono piuttosto che con un nuovo Vescovo di Roma". Dalla p. 155 del libro di Michael Grant, "Gli imperatori romani", si ricava quanto segue:"Sembra che i capi cristiani tendessero a distogliere i fedeli dal manifestare deferenza alla religione pagana, che era pur sempre la spina dorsale dello Stato e compartecipe del benessere nazionale. Dai cristiani non si pretendeva di rinunciare alla propria fede, ma non veniva tollerato il loro rifiuto di partecipare alle comuni pratiche rituali".
Sempre nell'obiettivo di consolidare la religione romana, Decio - Forte dell'editto emanato qualche decennio prima dall'imperatore Settimo Severo - obbligò ogni singolo cittadino delle varie province a presentarsi davanti a una commissione, accettando di sacrificare gli dèi. Coloro che si sottoponevano all'ingiunzione ricevevano un documento, detto libellum, comprovante la loro fedeltà alla religione pagana echi ne era in possesso veniva lasciato vivere e lavorare in tranquillità. Questo provvedimento spaventò molti cristiani, i quali - temendo conseguenze cruente o addirittura la morte - divennero spergiuri aderendo all'obbligo sacrificale, e furono chiamati lapsi. I moltissimi cristiani che si rifiutarono di sottostare all'ordine, vennero mandati tutti a morte. http://www.cataniatradizioni.it/s%20agata/l'imperatore%20decio.htm Tratto da “Storia di Agata, la santa di Catania” scritto da “Ruggerina Miazzon Camilleri”, edizioni Boemi, stampato dalla Tipografia Consigliane s.n.c. - Catania
LA CATANIA ROMANA _________________________
Più o meno tutti i Catanesi conoscono le
meraviglie della propria Basilica Cattedrale. In particolare nei
giorni dei festeggiamenti agatini, questo splendido esempio
dell’arte barocca si apre agli occhi di devoti e turisti diventando
così, quasi per incanto, la casa di tutta la cittadinanza. Non tutti
sanno, però, che questo imponente edificio, la cui cupola fa da
richiamo a chi viene dal mare, nasconde sotto di sé un tesoro di
inestimabile valore. Stiamo parlando delle Terme Achilliane, che,
come altre monumentali opere d’arte del capoluogo etneo, devono la
loro fruibilità ad un famoso protagonista del settecento catanese:
Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari.
CATANIA ROMANA. La Città di Catania è, al giorno d’oggi, crocevia di popoli e culture provenienti da tutte le parti del Mondo, rispettosa così della tradizione multietnica della Sicilia, la quale ricordiamo essere stata continuamente soggetta, nel corso dei secoli, a dominazioni delle più svariate civiltà del Mediterraneo, ma che allo stesso tempo è aperta alle prospettive di rinnovamento che i tempi moderni impongono. Risulterà quanto mai difficile, a tutti noi, immaginare le affollate strade del centro storico attraversate da uomini in toga o che scorrazzano in biga. Eppure, anche il capoluogo etneo beneficiò dei fasti, della gloria e dei costumi dell’Impero Romano. Prova solenne ne è l’anfiteatro che sorge a Piazza Stesicoro, che nonostante sia stato ridotto, per le più svariate vicende storiche, a mero rudere, è, e resta, uno dei più grandi che i Romani edificarono all’interno dei loro domini.
I COMPLESSI TERMALI. L’area sulla quale si
estende il capoluogo etneo, anticamente chiamato Càtina (o Càtana),
fondato da alcuni coloni greci, divenne possedimento romano nel 21
a.C.. Da quel momento la città si dotò di grandi edifici pubblici
che la trasformeranno in uno dei più ragguardevoli centri
dell'Impero e che nei secoli successivi, fino ad oggi,
condizioneranno il suo sviluppo urbano. La città antica era ricca di
acqua. Al posto della Via Etnea, scorreva un fiume, ora sotterraneo,
l’Amenano. Ciò permise la costruzione di ben tre complessi termali,
di cui il meglio conservato è quello detto della Rotonda, una sala
circolare, sormontata da una cupola, che nel corso del VI secolo, fu
trasformata in una chiesa. Sempre in una chiesa erano state
trasformate le terme dette dell'Indirizzo, (IV - V secolo d.C.) di
cui sono ancora visibili gli impianti di riscaldamento delle acque.
Il terzo complesso, meglio conosciuto come Terme Achilliane non è
stato trasformato in una chiesa, bensì ne è stata costruita una su
di esso lasciandolo in parte immutato. La chiesa sovrastante non è
altro che Basilica Cattedrale di Sant’Agata. LE TERME ACHILLIANE. Poco si conosce circa le reali dimensioni del grande complesso termale che si trova a Piazza Duomo, poiché quanto oggi è visitabile, il tutto completamente sotterraneo, è appena una piccola porzione della sua estensione. Dell'impianto originale delle Terme Achilliane si conserva una camera centrale il cui soffitto a crociere è sorretto da quattro pilastri a pianta quadrangolare. L'epoca di fondazione dell'edificio è ancora discussa, ma è probabile che fu costruito nel II sec. d.C. Nel 1088 l'area occupata dalle terme viene scelta dal vescovo Ansgerio per ricavarne la Cattedrale (completata ed inaugurata nel 1094) e il relativo monastero benedettino (in seguito sede della badia femminile di Sant'Agata), mentre nel 1508 viene completata la Loggia Senatoria che vi si addossava per la sua lunghezza. L’impianto termale, praticamente sepolto, fu scoperto nel XVI Secolo e nel 1767 fu messo in luce e studiato da Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari, che realizzò anche il primo ingresso all’edificio. Durante il secolo scorso, tuttavia, le terme attraversarono un periodo di decadenza. Nel 1974, infatti furono chiuse al pubblico perché considerate insicure. Vennero riaperte dopo un restauro nel 1997 e nuovamente richiuse per problemi di allagamento. Dopo i lavori di pavimentazione di Piazza Duomo, intervenuti tra il 2004 e il 2006, nel corso dei quali si è ritenuto di coprire l'impianto con una poderosa piastra d'acciaio per rinforzare l'impiantito della piazza stessa, l’edificio termale è stato nuovamente riaperto al pubblico e alla realizzazione di eventi. Fortunatamente, a differenza di tanti altri tesori nascosti e purtroppo non fruibili, questo splendido esempio del glorioso passato della nostra Città, ancora oggi, continua a stupire tantissimi visitatori. Una consapevolezza fa da padrona: Catania può Simone Centamore La Sicilia 19.2.2018
Dal libro "Topografia antica di Catania "dello scrittore e saggista palermitano Marcello Scurria "I ritrovamenti archeologici più antichi di Catania " Catania è una città di remota origine calcidese posta sulla costa orientale. Il dopoguerra ne ha fornito,per circostanze diverse, testimonianze molteplici e di grande interesse.Seguendo le nobili tradizioni di Guido Libertini,che allo studio della sua città aveva dedicato molta parte di se stesso, è stato Giovanni Rizza a dirigere per incarico della Soprintendenza di Siracusa, le ricerche, i fortunati recuperi dei rinvenimenti occasionali,la documentazione scientifica delle cose ritrovate. Alla città antica si sovrappone il moderno abitato. Era ovvio che,fra il vorticoso crescere della più recente edilizia, la vigile cura dell'archeologo dovesse più volte incontrarsi con i resti delle civiltà passate.Non potremmo ricordarli tutti,tanto sono stati numerosi e vari.Fra le scoperte più notevoli citiamo quello della grande area cimiteriale nella zona di via Dr Consoli,con materiali che dall'epoca ellenistica pervengono fino al VI sec d.C.Necropoli pagana,dunque, poi continuatasi,per graduale trasformazione, in cimitero cristiano. Pertinente a questo era la grande basilica che lo scavo ha messo in luce,con pavimento ricoperto da un bellissimo mosaico policromo figurato,che il Rizza ritiene dovuto a modi palestinesi e databile appunto circa la metà del VI secolo. Nella zona di Piazza Dante,in strati profondi sotto i resti di un edificio termale, sono stati rinvenuti frammenti di ceramica protocorinzia degli inizi del VII sec a.C.,risalenti cioè a pochi decenni dopo la fondazione greca della città. Scavi di una certa entità sono stati fatti nel teatro. Ma quel che supera di gran lunga ogni altra cosa è stata la scoperta, avvenuta casualmente nel 1959,di una ricchissima stipe votiva arcaica sotto il suolo della Piazza S.Francesco. I materiali rinvenuti nel piccolo spazio che è stato possibile scavarvi sono di una quantità sbalorditiva, più di 1200 cassette al momento del recupero e datano dal VII sec a.C.Comprendono ceramiche di diversissime provenienze (Atene, Corinto,Sparta,Rodi,Chio,centri orientali solo sporadicamente rappresentati in altre città dell'occidente ),e quindi di estremo interesse per lo studio dei rapporti intrattenuti da Catania arcaica con la Grecia propria (il grosso di questi materiali appartiene al VI sec),ed opere spesso bellissime della coroplastica,in parte di fabbricazione locale, variamente databile dal VI al IV .Importante notare nel corredo della stipe l'improvviso apparire a principio del V sec di materiali relativi al culto delle Divinità atonie.
Il processo
Quinziano prese atto che lusinghe,
promesse e minacce non sortivano alcun effetto su quella giovane tanto
bella quanto innamorata di Gesù. Decise allora di dare immediato avvio a
un processo, contando così di piegarla con la forza. Convocata al
palazzo pretorio, Agata entro fiera e umile. Procedeva a passi sicuri
verso il suo persecutore e, quando i suoi occhi limpidi incontrarono
quelli di Quinziano, li trovarono accesi di rabbia e di desiderio di
rivalsa. Agata non era spaventata, sapeva che Io Spirito Santo l’avrebbe
assistita e le avrebbe suggerito le parole da dire al tiranno. Ne era
certa, perché Gesù stesso lo aveva promesso ai suoi discepoli. Si
presentò al proconsole vestita come una schiava, come usavano le vergini
consacrate a Dio, e Quinziano volle giocare su questo equivoco per
provocarla. “ Non sono una schiava, ma una serva del Re del cielo ”,
chiarì subito Agata. “ Sono nata libera da una famiglia nobile, ma la
mia maggiore nobiltà deriva dall’essere ancella di Gesù Cristo ”. Le
affermazioni di Agata erano taglienti e fiere, degne della http://www.comune.catania.it/la_citt%E0/santagata/la-vita/Il_processo.aspx
Alla caduta dell’Impero Romano, Catania fu esposta alla costante minaccia dei conquistatori che giungevano sulle coste siciliane per terra e per mare. Dalle coste dell’Africa vennero a predarci i Vandali e Catania sperimentò la loro violenza piratesca. Poi seguirono gli Ostrogoti, (440 a.C. - 535 a.C.)
Particolarmente critico sembra essere stato il passaggio dei Vandali di Genserico negli anni 440 e 441 provenienti da Cartagine: causò danni talmente gravi da indurre le autorità alla remissione del pagamento dei tributi. Nel 476, Genserico cede ad Odoacre, re degli Eruli, la Sicilia in cambio di un tributo. Teodorico, divenuto re degli Ostrogoti nel 474, dopo aver sconfitto più volte Odoacre in Italia lo uccise nel 493 restando così l’incontrastato padrone d’Italia. Teodorico rispettò le consuetudini locali e stabilì buoni rapporti con i catanesi, tali da chiedere al Re il permesso di fortificare le mura devastate dalle incursioni utilizzando le pietre dell’anfiteatro Romano, che si trovava in stato di completo abbandono. Catania non subì arresti nella prosperità economica, anzi se ne avvantaggiò grazie allo spostamento verso Oriente dei traffici marittimi e con il trasferimento in città della zecca dell´impero bizantino nonchè con le pressanti richieste di derrate e di legnami da parte di Costantinopoli, per sostenere la concorrenza delle flotte musulmane nel Mediterraneo.
Il generale bizantino Belisario, inviato da Giustiniano a riconquistare l’Italia, occupò con facilità la Sicilia nel 535 sconfiggendo gli Ostrogoti. Catania divenne bizantina nel 555 a. C..
Nuovi scontri fra Belisario e gli Ostrogoti di Totila si verificano fra il 542 e il 548, anno in cui il generale bizantino venne richiamato a Costantinopoli. Catania fu di nuovo occupata da Totila nel 550, ma dopo la sconfitta degli Ostrogoti in Umbria e la morte di Totila nel 552, tutta la Sicilia tornò sotto il controllo bizantino nel 555. Fu proprio da Catania che ebbe inizio la riconquista bizantina dell'isola, e in essa ebbe sede probabilmente il governatore civile bizantino (praetor o praefectus). Rimase bizantina sino alla conquista musulmana che avvenne nel IX secolo.
Epifania Bizantina a Catania di Luigi Giuseppe Gennaro
Dopo secoli di assenza, per iniziativa d’un intraprendente sacerdote locale la liturgia cattolica bizantina è tornata a far risuonare le sue austere salmodie nella città di Catania. Nell’antichissima chiesa di San Gaetano alle Grotte il Rettore, padre Antonio Lo Curto, che da diversi anni ha felicemente reintrodotto questi antichi riti nel capoluogo etneo, ha solennemente celebrato in pompa magna la solennità dell’Epifania, coincidente in Oriente con la memoria del Battesimo di Cristo. Il sito su cui sorge la moderna chiesa, completata nel XIX secolo dopo varie vicende costruttive, ospita ancor oggi un piccolo vano scavato nella roccia che costituiva la camera mortuaria d’un antichissimo sepolcro d’età a tutt’oggi imprecisata: se gli storici locali hanno dibattuto per tutto il XVII secolo sulla paternità della struttura (qualcuno vi vide il mausoleo del famoso Stesicoro, poi maldestramente identificato in un colombario romano ancor oggi poco distante) per la fede quel luogo è sempre stato il sito della primissima deposizione di Sant’Agata, patrona cittadina morta nell’anno 251. Proprio in memoria sua e della Madonna qui sorse la prima comunità cristiana catanese e la minuscola grotta, dotata anche d’un pozzo d’acqua sorgiva per i riti battesimali, funse per secoli da chiesa, venendo officiata ininterrottamente anche durante le persecuzioni, Romane prima ed arabe poi.
È d’uopo notare come simili iniziative non debbano costituire certamente una mera curiosità per cittadini e forestieri, e nemmeno la loro utilità possa essere limitata all’appagamento spirituale dei soli fedeli: la presenza attiva di decine di immigrati slavi e provenienti dall’Est europeo, che hanno intonato nuovamente il Pater in romeno, partecipando anche con sobri canti nelle lingue nazionali, ha dimostrato l’esistenza d’un ennesimo canale dimenticato d’integrazione tra cittadini ed immigrati, nel rispetto delle reciproche tradizioni e culture. Se è vero che alcuni dei presenti hanno assistito alle due ore piene di salmodie per mero interesse storico o musicale, è altrettanto indubitabile che sarebbe criminoso tollerare, com’è stato fatto fino ad ora, che un sì grande patrimonio culturale della nostra terra vada disperso per l’insensibilità, o per la vera e propria intolleranza, di pochi facinorosi. http://www.dietrolequinteonline.it/epifania-bizantina-a-catania/ Cappella Bonajuto
Uno dei pochi edifici di rilievo
superstite dell'epoca bizantina a Catania, la cappella è collocata
all'interno del barocco palazzo Bonajuto in via Bonajuto 7, nel popolare
quartiere
La famiglia Bonajuto prese possesso della cappella a partire dal quattrocento e nel secolo successivo vi edificò la propria residenza. Sino all'insediamento dei Bonajuto la cappella era dedicata al SS.Salvatore, denominazione che mantenne probabilmente sino al XVIII secolo.[2] Nel XVIII secolo quando la cappella fu oggetto di restauri e ristrutturazione dell'ingresso, questa fu meta del viaggio del pittore francese Jean Houel. La cappella è stata restaurata da Paolo Orsi e Sebastiano Agati negli anni trenta. Oggi è visitabile e spesso affittata per fini espositivi e conferenze nonché come pub e come palcoscenico di gruppi musicali rock e di altro genere.
La cuba di Santa Domenica a Castiglione di Sicilia. Chiamata anche « 'a cubula» dai locali, la cuba di Santa Domenica è forse la più importante cuba bizantina presente in Sicilia, monumento nazionale dal 31 agosto del 1909 grazie allo studio del rudere effettuato da Sebastiano Agati.
L'edificio ha le caratteristiche
tipiche della cuba, ovvero è rigidamente geometrico e basato su forme
essenzialmente cubiche pur se allungato. Così Santa Domenica si presenta
a croce latina con pianta quadrata, cupola e tre absidi. L'abside
posteriore ha una bifora rivolta verso oriente affinché, secondo
tradizione, durante la veglia pasquale la luce della luna piena entrando
nell'edificio attraverso l'apertura desse inizio alla Pasqua. Le altre
due absidi contenevano ciascuna una piccola cappella. La cuba, costruita
con pietra, blocchi lavici, malta e materiali in cotto internamente era
ricca di affreschi di fattura bizantina, oggi perduti. La facciata è a
due ordini. Nel primo vi è l'ingresso principale che è caratterizzato da
un arco ed è di maggiori dimensioni rispetto agli altri due presenti ai
lati. Nel secondo ordine della facciata si trovano due finestre ed una
trifora di dimensioni considerevoli. Secondo alcuni accertamenti recenti
la facciata sarebbe stata preceduta da un portico o nartece per
penitenti e catecumeni, mentre il tetto e la pavimentazio
LA CUBA BIZANTINA DI CASTIGLIONE DI SICILIA E LE PERSECUZIONI ICONOCLASTICHE Testo a cura di Enzo Crimi – Divulgatore ambientale e naturalista, già Commissario Superiore del Corpo Forestale della Regione Siciliana Antichi greci, latini, bizantini, arabi, normanni, svevi e angioini, aragonesi e borboni, tutti hanno conosciuto il fiume Alcantara, la freschezza delle sue acque, la bellezza delle sue gole, la fertilità delle sue colline degradanti e ricche di vita agreste. Tutti ci hanno lasciato, quali segni della loro presenza, incontrovertibili prove di grande rilievo culturale: intere città sepolte e templi religiosi come la famosa Cuba bizantina di contrada Santa Domenica, a due passi dal fiume Alcantara in territorio di Castiglione di Sicilia, la quale per la sua importanza culturale ed ambientale, fu dichiarata monumento nazionale il 31.8.1909. La Cuba, è una chiesa bizantina costruita tra l’VIII e l’XI secolo, di grande pregio architettonico, ancora oggi, mantenuta in discrete condizioni dopo un’accurato restauro, secondo gli studiosi, rappresenta uno dei primi avamposti bizantini in Sicilia e riveste grande rilievo nel panorama archeologico-architettonico dell’area a testimonianza della raffinata cultura dell'arte bizantina, introdotta in Sicilia dai numerosi monaci bizantini. Questi, per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste nella loro terra natìa, riuscirono a raggiungere la nostra penisola e stabilitisi originariamente sulle coste salentine, in seguito si trasferirono nella nostra isola. L'iconoclastìa, ovvero, la dottrina e il comportamento persecutorio, che, tra l'8° e il 9° secolo dovettero subire i religiosi bizantini, prima ad opera dell'imperatore d'oriente Leone III° e poi del figlio Costantino V°, irriducibili nemici della venerazione religiosa e del culto delle immagini sacre. Nell’impero bizantino, l'iconoclastìa ha rappresentato un periodo storico di grande oscurantismo nella storia dell'uomo, un periodo di violenta persecuzione. Alti prelati e funzionari furono colpiti di pena capitale o esiliati, molti conventi furono o secolarizzati o trasformati in caserme, i beni dei monaci furono confiscati. Verosimilmente, per sfuggire a queste persecuzioni iconoclastiche, una comunità di monaci fu costretta a prendere la via del mare per cercare riparo in occidente. La navigazione si presentava molto lunga e rischiosa, pertanto, non potendo affrontare la grande attraversata con cibi freschi, i fuggiaschi per sopravvivere nei lunghi giorni di navigazione si cibavano di ghiande come cibo a lunga conservazione e, prima si stabilirono lungo le coste salentine in Puglia e dopo nella Sicilia orientale, dove resistono ancora numerosi reperti a testimonianza della civiltà bizantina. La valle del fiume Alcantara assorbì una gran parte di questo massiccio flusso emigratorio proveniente dalle terre di Bisanzio, che evidentemente portò in quest’area, come in altri luoghi dell’isola, i segni dell’arte cristiana, fiorita a Bisanzio verso il IV - V secolo e diffusa in tutti gli altri territori dell’impero romano sino al XV secolo, unitamente ad altre manifestazioni di arte quali la lavorazione della seta, dell’oro, del legno e della ceramica. Possediamo ampie conoscenze storiche riguardo la Cuba bizantina, la contempliamo come incantevole monumento architettonico dell’uomo del passato e ne rimaniamo ammirati per l'indiscutibile emozione, che essa elargisce ai suoi visitatori. I ruderi delle Cube in territorio di Randazzo, la Cuba di Malvagna e questa della contrada di Santa Domenica di Castiglione di Sicilia, secondo alcuni studiosi di settore, sono verosimilmente, alcune di molte altre che sorgevano in quell'epoca in queste aree e che sono scomparse senza lasciar traccia, disperse dal tempo. Ciò fa pensare alla massiccia presenza di questa civiltà bizantina lungo il fiume Alcantara. In definitiva, lasciando l’opinabile ai sognatori, nella realtà indiscutibile, nessun mistero ascetico ma solo la spiritualità che solo una suggestiva e seducente opera come la Cuba di Castiglione di Sicilia può rappresentare, nel lento ed incessante scorrere del tempo.
Quando il generale bizantino Giorgio Maniace venne in Sicilia per cercare di prenderne possesso e di cacciare da essa gli Arabi (1038), il suo progetto sortì un iniziale successo; in seguito, essendosi inimicata la corte imperiale, Maniace ricevette l’ordine di ritornare a Bisanzio (Costantinopoli). Pertanto egli, per mitigare le ire dell’imperatore, Michele Paflagonio, prima di rimpatriare fece incetta delle spoglie dei santi più venerati nell’isola: Sant’Agata, Santa Lucia, San Leone ed altri ancora. Era l’anno 1040 ed i Catanesi, radunati sulla spiaggia, assistettero disperati ed impotenti alla partenza della nave che portava via dalla propria città il corpo della Santa. Nel 1126 la Chiesa catanese era presieduta dal vescovo Maurizio. Militavano in quel tempo nell’esercito bizantino, come ufficiali di corte, il francese Gisliberto (secondo altre grafie, Gisliberto o Gilberto, probabilmente originario della Provenza, almeno a giudicare dal nome) ed il calabrese Goselmo (o Goselino; verosimilmente nella lettera di Maurizio calabrese sta per pugliese, secondo l’uso antico). Una notte Sant’Agata apparve in sogno a Gisliberto e gli comandò di andare nella chiesa dove erano custodite le sue spoglie (Santa Sofia o il Monastero della Vergine) e ricondurle a Catania. La visione si ripeté altre due volte: allora Gisliberto, che nel frattempo si era confidato con Goselmo, decise di passare all’azione con l’aiuto del compagno. La notte del 20 Maggio i due s’introdussero nel tempio in cerca del corpo di Sant’Agata: quando lo trovarono, collocarono il busto in un cofano cosparso all’interno di rose profumate, la testa tra due scodelle e gli arti in due faretre; quindi, nascosero il tutto in casa di Goselmo. Il giorno seguente la notizia si sparse per la città e l’imperatore inviò uomini armati dappertutto alla ricerca degli autori del furto, proibendo a chiunque di lasciare Bisanzio per terra o per mare senza un permesso scritto. Gisliberto e Goselmo, non appena la calma si fu ristabilita, s’imbarcarono con le sacre spoglie. La prima tappa fu Smirne, dove rimasero quattro giorni: un terremoto li sorprese, mentre sistemavano meglio il contenuto delle faretre, provocando lo sconforto di Goselmo, al quale tuttavia un pronto e saggio discorso di Gisliberto restituì la perduta fede nel successo dell’impresa.
Ripreso il viaggio, i due compagni
sbarcarono a Corinto, dove restarono a lungo, perché non
riuscivano a trovare un’imbarcazione su cui proseguire il tragitto verso
la Sicilia. Sant’Agata riapparve in sogno a Gisliberto, rimproverandolo
per il ritardo ed annunciandogli che l’indomani mattina sulla spiaggia
una nave da carico sarebbe salpata: naturalmente, Gisliberto e Goselmo
sarebbero dovuti salire a bordo. Essi obbedirono
all’invito, verificando la veridicità della visione, ed arrivarono nella
città greca di Metone. Qui, s’imbarcarono in compagnia di mercanti ed
approdarono a Taranto. I due militi giunsero finalmente a
Messina: Goselmo rimase in una chiesa a guardia delle spoglie, mentre
Gisliberto si recò al
Castello d’Aci, che allora
faceva parte dei beni della Chiesa di Catania, dove si trovava il
vescovo Maurizio.
Gisliberto gli narrò ogni cosa e chiese al presule di inviare con lui
due monaci di sua fiducia a Messina per appurare che si trattava
effettivamente del corpo di Agata e per trasportarlo senza indugio ad
Aci. Maurizio acconsentì alla sua richiesta e mandò Luca ed Oldomano,
che portarono prontamente a termine l’incarico. Il vescovo accolse con
grande giubilo i santi resti, inginocchiandosi per ringraziare Dio del
felice evento, quindi estrasse le reliquie dalle faretre, da cui promanò
un profumo di rose fresche. Maurizio, riposte diligentemente le spoglie
in una cassa più degna di tale contenuto, si precipitò a Catania, dove
chiamò a raccolta tutti i
Era il pomeriggio del 17 Agosto 1126. Ad Ognina i Catanesi riabbracciarono la loro Patrona e più volte si levò in quell’occasione il grido “Cittadini, viva Sant’Agata”, come ancora oggi è possibile udire in entrambe le feste dedicate alla Santa; solo a fatica la processione poté proseguire fino alla sua meta. Cominciarono a questo punto ad aver luogo diversi miracoli: il primo registrato ebbe per protagonisti due ragazzi, i cui ceri non si spensero per l’intero percorso, nonostante il soffiare del vento. Quando poi la Cattedrale accolse le sante spoglie, si verificarono prodigi ben più consistenti: ci furono ciechi dalla nascita che recuperarono la vista, muti che presero a parlare, paralitici che riacquistarono l’uso delle proprie gambe ed indemoniati che furono resi liberi dalla presenza maligna. Maurizio nella sua lettera non parla della sorte occorsa a Gisliberto e Goselmo, ma la tradizione vuole che siano rimasti a Catania, svolgendo l’ufficio di custodi delle reliquie nella Cattedrale, dove sono sepolti, in un punto imprecisabile della Cappella della Madonna. C’è da aggiungere che la Traslazione, ossia il passaggio da Est ad Ovest delle reliquie agatine, ha forse anche un significato simbolico, in quanto coincise con la totale emancipazione della Chiesa siciliana da quella d’Oriente, in ottemperanza alla politica normanna nell’Italia meridionale. Inoltre, il particolare dei piedi nudi e dei vestiti bianchi di Maurizio (e della folla) sembra fornire una spiegazione dell’origine degli analoghi rituali presenti nella celebrazione della festa di Sant’Agata, seppure in realtà non siano estranei influssi riconducibili ai culti isiaci del tardo paganesimo http://digilander.libero.it/PiiFratres/gislibertoegoselmo.htm
Provenivano dalla regione che gli Arabi chiamavano Ifrìqiya, corrispondente sostanzialmente alla Tunisia, parte dell'Algeria occidentale e a piccole porzioni della Cirenaica. Misero piede in Sicilia nell'827 d.C.. Conquistarono Catania poco prima del 900 d.C. , ma in città non sono rimaste tracce significative del loro passaggio.
La dominazione araba fu tuttavia benefica ai catanesi, come a tutta la Sicilia. Gli Arabi, ottimi coltivatori e abilissimi mercanti, riattivarono l’economia dell’Isola che subiva gli effetti di un lungo periodo di decadenza; diedero nuovo impulso alle colture indigene della vite e dell’ulivo e altre ne introdussero, come quella degli agrumi, che ancor oggi costituisce una delle maggiori fonti di benessere dei Catanesi. Prima c'erano state numerose incursioni, fin dal lontano 652, e reiterati tentativi di conquistare la Sicilia, tutte fallite. La spedizione definitiva venne effettuata quando il ribelle bizantino Eufemio, li chiamò in aiuto. Alla guida della spedizione c'era un giurista settantenne, Asab ibn al-Furàt. La spedizione araba lasciò il porto di Susa il 14 giugno dell'anno 827 e dopo aver effettuato una sosta nell'isola dei conigli (Lampedusa) per rifornirsi di viveri ed uomini, sbarcò a capo Granitola presso Mazara tre giorni dopo, il 17 giugno. Le truppe di Asad, per la difficoltà dei luoghi e per lo scarso nutrimento soffrirono quanto e come gli assediati.
La loro fu una conquista dura,
Palermo la ebbero nell'831, perché stremata da una pestilenza, Messina
nell'843, aiutati da truppe napoletane, Enna, da loro chiamata Kasr
Jànna (da cui Castrogiovanni) fu presa nell'859, dopo un assedio tanto
lungo che consentì agli arabi di coniar moneta. Le ultime a cedere
furono Siracusa, nell'878, Catania, nel 900, Taormina nel 902 ed infine
completarono l'occupazione con la caduta di Rometta nel Messinese.
Correva l'anno 965. In Sicilia non ci fu un regno unitario arabo ma tante piccole signorie rette da "Kadì". Il comportamento degli arabi fu improntato alla tolleranza. Non perseguitarono i cristiani ma si accontentarono di far pagare loro una tassa la "gézia" consentendo la libertà di culto. Pochi infatti furono i tentativi di ribellione e vani furono i tentativi di riconquista da parte di Bisanzio, ricordiamo solo quello di Giorgio Maniace perché fra le sue truppe militavano anche, in qualità di mercenari, i Normanni che a breve, sarebbero riusciti a scalzare i musulmani dall'isola ed ad affermarvi la loro signoria. Gli Arabi divisero l'isola in tre grandi distretti amministrativi. Dapprima la Sicilia fu sede di Emirato dipendente dalla dinastia tunisina degli Aghlabiti che la governarono con i loro emissari, poi divenne indipendente con una propria dinastia quella dei Fatimi. La popolazione era distinta in indipendente, che conservava i vecchi ordinamenti, tributaria, che pagava la gezia, vassalla o "dsimmi" che viveva soggetta ed infine i servi della gleba o "memluk". Durante i 200 anni della loro dominazione, gli Arabi portarono nell'isola la cultura, la poesia, le arti, le scienze orientali e abbellirono il loro regno con monumenti stupendi. Durante la loro permanenza gli Arabi diedero un notevolissimo apporto all'economia ed alla civiltà Siciliana: introdussero le colture del riso e degli agrumi, realizzarono opere di canalizzazione che consentirono l'uso razionale delle risorse idriche (cosa che oggi i nostri amministratori hanno "dimenticato").
Ancora oggi nella nostra lingua usiamo termini come "gebbia", la vasca di raccolta delle acque, "saja", i canali, "senia" ruota del mulino ad acqua, ecc. Furono incrementate le piantagioni di gelsi con conseguente impianto di manifatture per la seta. Svilupparono la piccola proprietà terriera, eliminando i latifondi, con opportuni provvedimenti fiscali, quale l'abolizione dell'imposta sugli animali da tiro.
Durante la dominazione araba Palermo
(Balarm in arabo) si distingueva per lusso e per ricchezza e si
presentava con tutte le caratteristiche di una città orientale. Divenne
una capitale mediterranea Si contavano più di 300 moschee (così
riferisce nel 973 Ibn Hawqal, viaggiator La Sicilia tutta era piena di industrie e di commerci, come ci rendono conto i viaggiatori Ibn Gubayr, Ben Idrisi e lo stesso Ibn Hawqal. Era il giardino del mediterraneo. In Sicilia gli arabi favorirono la nascita di una ricca cultura, sia nelle scienze che nella letteratura. Uno tra i migliori poeti arabi siciliani è Abu al-Hasan che visse in Sicilia, tra la fine dell'XI e il XII secolo. Egli cantò l'amore e la bellezza del creato come doni di Allah. Nei suoi versi si trova anche una vena di tristezza per la sorte della sua patria, la Sicilia, che stava per cadere nelle mani dei Normanni. Sarebbe bello poter leggere "La storia araba di Sicilia" di Ibn Kalta, o gli scritti di Ibn Hamdis di Noto, entrambi scrittori arabo-siculi, di cui molti testi sono andati perduti. I ricordi più importanti che testimoniano la presenza araba in Sicilia purtroppo non sono quelli né quelli letterari né quelli architettonici. Non ci rimane alcuna Moschea, perché trasformate in chiese cristiane, e lo stesso Alkazar (l'attuale Palazzo dei Normanni di Palermo), non lascia più riconoscere la parte costruita dagli Arabi, e ben poco di altri monumenti di quell'età è giunto fino a noi; ma quanto rimane - parti di una moschea incorporata nella chiesa di S. Giovanni degli Eremiti; parti di castelli incorporati, come in quello della Zisa, o della Favara, e negli ampliamenti successivi in epoca normanna o la struttura del vecchio quartiere arabo di Mazara, o le terme di Cefala Diana - è sufficiente per documentare la continuità della tradizione araba in Sicilia.
Ma quanto ci manca d'architettura è fortemente rimpiazzato nella storia linguistica della Sicilia. Numerosissimi toponimi: Caltanissetta, Caltagirone, Caltavuturo, ecc, derivano il loro nome da "Kalat", castello; Marsala, Marzameni, da "Marsha", porto; Gibellina, Gibilmanna, Gibilrossa, da "gebel", monte; Racalmuto, Regalbuto, da "rahal", casale e così via. E poi abbiamo anche termini commerciali come: funnacu (fondaco), tariffa, sensale; termini agricoli come fastuca (pistacchio), zagara (i fiori dell'arancio o del limone), zibibbu (una varietà di uva), giggiulena (sesamo); vocaboli come "calia" (ceci abbrustoliti) "giurana" (rana), "zotta" (frusta); o cognomi come Badalà o Vadalà (servo di Allah) Fragalà (gioia di Allah) ecc. Nella cucina, dal cuscus alla cassata, alle arancine. Tutta la nostra cucina ha una forte impronta araba che si riconosce nell'uso delle spezie, dello zucchero e dei profumi. Inoltre, antichi riti di magia, credenze popolari, come le "truvature"; scongiuri e pratiche di fattura che derivano direttamente dal fondo dell'anima araba della Sicilia, come giustamente annota l'etnologo Giuseppe Pitré. Per strano che possa sembrare sedici secoli di ellenismo sono stati quasi annientati dall'arabismo che in soli due secoli è riuscito a lasciare una forte impronta che né Normanni, né Svevi, né Spagnoli o Francesi e per ultimo i piemontesi sono riusciti a cancellare. Questo può significare una cosa sola: la dominazione araba non fu mero dominio ma integrazione con i popoli autoctoni e dovrebbe essere da esempio. Fara Misuraca http://www.ilportaledelsud.org/siciliaaraba.htm
Durante il secolo XI nella Sicilia musulmana si ebbe una profonda crisi politica che oppose l’imam Fatimide ai governatori Kalbiti, che alla fine furono sconfitti e allontanati.
I Kalbiti si recarono alla corte
bizantina per comunicare all'imperatore ciò che era avvenuto, sperando
di essere aiutati. Venuto a conoscenza dei disordini scoppiati in
Sicilia, il basileus bizantino Michele IV il Paflagone ritenne
conveniente preparare una campagna di conquista, riesumando i progetti
di annessione dell'Italia del grande Basilio II Bulgaroctono. Michele IV
mise al comando della spedizione bizantina il fratello Stefano il
Calafato. Zoe, moglie di Michele IV, consigliò a quest'ultimo di mettere
al comando militare
La spedizione salpò dalla Penisola balcanica all'inizio dell'estate del 1038. La missione bizantina usò come testa di ponte la base di Reggio Calabria e quindi, verso la fine dell'estate del 1038, sbarcò in Sicilia, dove vi fu subito in brevissimo tempo l'occupazione di Messina. Successivamente la spedizione si diresse verso l'antica capitale dell'isola, Siracusa, che resistette fino al 1040, prima di cadere nelle mani dei bizantini. Maniace fu l'unico condottiero che riuscì, prima dei normanni, a liberare seppur temporaneamente (sino probabilmente al 1043) la città aretusea dai musulmani. A testimonianza di quella impresa mandò le reliquie di Santa Lucia a Costantinopoli e fece costruire in città una fortilizio che ancora oggi, pur se ampliato, porta il nome di Castello Maniace. Anche il trafugamento dalle reliquie di Sant'Agata avvenuta durante l'XI secolo avvenne probabilmente per mano delle stessa spedizione. Una leggenda vuole che fosse stato lo stesso generale bizantino a trafugare le reliquie della Santa di Catania e che, una volta partito, fu costretto a ritornare a causa di una furiosa tempesta ed a custodire la salma in una casetta, in attesa che si placasse il maltempo. Nonostante le continue vittorie che stava conquistando sul campo, il morale dell'esercito era però basso a causa dei litigi fra Giorgio Maniace e Stefano il Calafato. Maniace aveva una pessima considerazione di Stefano, infatti lo definiva un "idiota". Nel 1040 tra Randazzo e Troina sconfisse le truppe musulmane di Abd Allāh. Nei pressi del luogo della battaglia, venne fondato il Monastero Santa Maria di Maniace: l'antico cenobio si trova oggi nei pressi del paese di Maniace, anch'esso battezzato così in un secondo tempo in onore del generale bizantino. Abd Allāh, pur sconfitto, riuscì a mettersi in salvo, per fortuna, o forse per un errore di strategia di Stefano, che si rifiutò d'affrontarlo. Per questo fatto Maniace si adirò nei confronti di Stefano e si scagliò con violenza contro di lui. Stefano a sua volta lo accusò di tradimento e Maniace, richiamato a Costantinopoli, fu immediatamente incarcerato. La partenza di Maniace fu un duro colpo per la spedizione bizantina, infatti in breve Arduino si ribellò, per dei contrasti riguardanti la ricompensa, e durante questa rivolta Stefano fu ucciso in battaglia. Il comando delle truppe fu preso allora dall'eunuco Basilio che non riuscì a controllare la situazione e, con la spedizione in piena crisi, si trovò costretto ad abbandonare la Sicilia. Intanto in Puglia la situazione andava rapidamente degenerando: i longobardi si erano rivoltati e la marina bizantina si era ammutinata appoggiando l'insurrezione guidata da Argiro. Con l'esercito bizantino impegnato a soffocare la rivolta, gli arabi tornarono ad impossessarsi della Sicilia, tranne di Messina. (fonte Wikipedia)
Benedetto Croce: “La Sicilia Araba è un’invenzione di Michele Amari” C’è un grande mito da sfatare. Quello della Sicilia araba. La favola tanto cara a chi non sa fare a meno del fascino dell’oriente, a chi non ama quei pochi ultimi sprazzi di spiritualità rimasti in Europa, a chi esalta un passato (ai più poco conosciuto) in nome di un meltingpot mai avvenuto, a chi snobba il millenario passato pagano e cristiano dell’isola più grande del Mediterraneo. D’altronde quella orientalista è la stessa spinta che mosse molti annoiati aristocratici europei, tra la fine del ‘700 e tutto il 1800, verso civiltà sconosciute ed usi diversi dai costumi occidentali. Interessi talvolta scaturiti anche in approfonditi studi di filologia, linguistica, antropologia, religione e filosofia orientale ma che per lo più erano conseguenza di noia e snobbismo. Oggi, salvo qualche intellettuale degno di esser chiamato tale, l’orientalismo è solo un vezzo estetico ed artistico. Nulla più. Il controverso monaco maltese Giuseppe Vella – grande falsario, prima cattedra di lingua araba all’Università di Palermo ed ispiratore di studiosi e romanzieri del calibro di Andrea Camilleri e Leonardo Sciascia – fu il primo, a metà del 1700, a creare il mito di una Sicilia islamizzata ed arabizzata. Da li tanti studiosi. Vale certamente citare lo storico palermitano Michele Amari. Certamente i dati storici sono incontrovertibili. Nell’827 d.C. gli arabi sbarcarono Mazara e per poco più di duecento anni (1091) dominarono quasi – quasi, Catania ad esempio, secondo molte fonti, non cadde mai sotto il dominio arabo – tutta l’isola imponendo tanto ma anche regalando innovazioni. E’ altrettanto certo che dopo la conquista normanna, essi furono prima rinchiusi in isolati “pogrom” – simili alle riserve indiane o ai ghetti ebraici – dell’epoca e poi cacciati, deportati o sterminati sistematicamente. Moltissimi siciliani non conoscono cosa accadde in questi due lustri ma ancora oggi sbandierano fieri le loro presunte origini arabe. Per l’abbronzatura, per un sintomatico mistero o per trovare una terza via tra l’identità italiana e l’identità meridionale borbonica. Ciò non è dato saperlo. L’oriente affascina e quindi perchè non darsi un tono? Ma è l’intensità di tale dominazione ad esser stata così enfatizzata da apparire come il più formidabile apporto culturale e genetico di cui la Sicilia abbia beneficiato. Persino come la più ovvia risposta alla domanda sulla carnagione scura di alcuni siciliani. Non è proprio così. Il contributo genetico berbero in Sicilia, secondo gli studi più filo arabi non va oltre il 4%. La carnagione scura di alcuni siciliani è legata piuttosto ad altri fattori precedenti alla dominazione araba. Lo studio degli aplogruppi lo conferma, in Sicilia è semmai presente molto più la componente greco-anatolica che quella araba. Sono certamente più presenti le componenti : Slava, Germanica (Longobardi, Goti, Franchi, Baiuvari, Slavi), Celtica, Ligure e Italica (Liguri, Galli, Venetici, Umbri, Osci, Siculi, Romani). La conquista araba fu tutt’altro che semplice ed alcune cittadine non caddero mai sotto il dominio islamico. La stragrande maggioranza dei soldati arabi non volle mischiarsi alla rozza – questa era la loro considerazione dei figli della Magna Grecia – popolazione locale e ciò che rimase di quella conquista fu quasi interamente coperto da successive ripopolazioni forzate normanne, attraverso anche il trasferimento in Sicilia di molte popolazioni del nord Italia. Nel corso dell’invasione “mora”, molti siciliani preferirono morire combattendo piuttosto che sottomettersi ai “mori”. Durante la conquista di Palermo sopravvissero 3.000 abitanti su 70.000, a Siracusa i morti furono 4.000 dopo un saccheggio ininterrotto di oltre due mesi, a Selinunte nessun sopravvissuto, Taormina fu saccheggiata, i villaggi alle falde dell’Etna furono quasi tutti distrutti, Ragusa saccheggiata e rasa quasi interamente al suolo. Tante le esecuzioni di massa. D’altronde la successiva reconquista cristiano- normanna fu agevolata dalla popolazione e lo dimostra anche il fatto che ancora oggi, in memoria di quella liberazione, in numerose città siciliane si celebra la vittoria in guerra contro gl’islamici, come ad esempio la Madonna delle Milizie di Scicli e il Battimento di Aidone. Un successo scolpito nell’animo dei siciliani. Persino la celebre “ladata” nissena – lamento cantato durante la settimana santa e nato intorno al 1200 – è erroneamente accostato al canto (adhān) del muezzin. Nel 1221, Federico II – celebre per aver creato un formidabile sistema di convivenza fra più religioni – decise di sedare l’ennesima rivolta delle poche isolate comunità islamiche rimaste e tollerate nell’entroterra e si pose l’obiettivo, questa volta, di “extreminare de insula Saracenos”. Obiettivo portato a termine attraverso una vera e propria pulizia etnica. I sopravvissuti? Pochi. Quasi tutti deportati in Campania, Puglia e Calabria o scappati in Andalusia e Maghreb. Quasi nessuno riuscì a mischiarsi nella popolazione convertendosi o mimetizzandosi. Insomma fu una travagliata occupazione militare dove i soldati, salvo qualche stupro o qualche eccezione, non osarono mischiarsi alla rozza popolazione locale. Cosa che invece avvenne in Iberia. Una dominazione a senso unico, dove ai non musulmani fu vietato di erigere chiese, dove agli “infedeli” fu concesso di vivere ma con fortissime limitazioni ed in cambio di pesantissime tasse (la”Jizya”, la “dhimma “ e la “kharag” ) su patrimonio e sicurezza personale. Altra prova inconfutabile di questa strenue resistenza siciliana è la scarsa considerazione politica – nell’anno 948 la parte della Sicilia posta sotto il dominio musulmano si costituì in un Emirato formalmente vincolato ai Fatimidi ma de facto indipendente con la dinastia Kalbita di ramo sciita al potere – che gl’islamici avevano della Sicilia preferendo l’Iberia o addirittura la Francia. Certo. Notevoli furono gli apporti nell’agricoltura, qualcosa è rimasto nel dialetto, qualche intellettuale (i poeti Abū l-Ḥasan ʿAlī ibn ʿAbd al-Raḥmān e Abd al-Jabbār ibn Muhammad ibn Hamdīs, il giurista Muhammad b. ʿAlī al-Māzarī ed il filosofo Ḥuǧǧat al-Dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Abī Muḥammad b. Muḥammad b. Ẓafar al-Ṣaqal su tutti) ed anche nella cucina, i siciliani risentono di qualche influenza araba ma la dominazione non entrò mai a pieno nei cuori dei siciliani. I cognomi Badalà o Vadalà (servo di Allah) Fragalà (gioia di Allah) sono frutto di una conversione forzata, i nomi di molte città – Calatabiano, Caltabellotta, Caltanissetta, Caltagirone, Caltavuturo, ecc, derivano il loro nome da “Kalat”, castello; Marsala, Marzameni, da “Marsha”, porto; Gibellina, Gibilmanna, Gibilrossa, da “gebel”, monte; Racalmuto, Regalbuto, da “rahal”, casale e così via – furono conseguenza a saccheggi, distruzioni e rifondazioni. Moltissimi riti pagani e bizantini sopravvivono ancora oggi e non mancano proverbi e modi di dire dialettali contro “turchi” (“mamma li turchi”) , “saraceni” o “arabi”, frutto di sanguinosi scontri anche dopo la conquista normanna. Frutto di una dominazione mai veramente entrata nei cuori dei siciliani. http://www.lurlo.info/it/siciliaaraba/
Come gli Arabi hanno cambiato ed influenzato la Sicilia Se consideriamo la geografia, noteremo immediatamente coma la Sicilia sia ben più vicina alla parte Nord dell’Africa che non a Roma. Alcune delle grandi civiltà del mondo si trovavano lì; molte arrivarono in Sicilia da Oriente e ne influenzarono per sempre mentalità e cultura. Questo soprattutto perché molte di queste invasioni furono pacifiche; volte sì alla conquista del territorio, ma non con l’obiettivo di distruggerne le caratteristiche e nemmeno le usanze degli abitanti, bensì con l’obiettivo di nutrirle e di integrarle. Basti pensare ai Greci, ma anche agli Arabi e ai Bizantini, le cui influenze ancor oggi si respirano non solo nell’architettura e nella cucina, ma anche nella toponimia di diversi luoghi e strade e persino dei cognomi dei cittadini. Geologicamente, sembrerebbe infatti che la Sicilia non sia mai stata attaccata allo Stivale, ma che fosse in realtà un ‘pezzo’ di Africa, in corrispondenza del golfo libico della Sirte. Gli Arabi arrivarono in Sicilia nel IX secolo, e la loro influenza vi permase fino al 1492, l’anno fatidico in cui Ferdinando ‘Il Cattolico’, re di Spagna, decise la diaspora per chiunque non fosse di religione Cristiana, dunque Arabi ed Ebrei. Fu infatti proprio sotto il dominio dei viceré spagnoli, che l’Isola conobbe uno dei suoi periodi più tristi e poveri; attraverso il regno ‘dei Signori’ prima e con l’istituzione del Sant’Uffizio poi. Fu in questo periodo infatti che venne annullata ogni iniziativa di arricchimento culturale e impedita l’iniziativa politica. Nel Cinquecento come in epoca Romana, la Sicilia era dunque soltanto una provincia destinata ad essere spremuta dal punto di vista lavorativo (specialmente agrario e conseguentemente commerciale) e nulla più. Al contrario di quanto accadde durante il regno di Federico II o ancor prima degli Altavilla, quando Cristiani e Arabi vivevano pacificamente sotto lo stesso tetto, arricchendolo e migliorandolo. Testimonianze di quella convivenza ben riuscita si scorgono in alcuni nomi di origine araba come Alcamo, Marsala e Favara. A Catania si trova una località denominata Caito, nei pressi del lungomare; l’etimo sembrerebbe risalire alla parola ‘Kaid’ o ‘Al Kaid’, dove con tutta probabilità si trovava il palazzo amministrativo islamico. Per non parlare poi delle strutture, dei santi sepolcri ed edifici con finale a cupola, denominati ‘cuba’, o delle città e località che iniziano con il toponimo ‘- Cala’ come Caltagirone o Calatafimi. A Palermo si trova la ‘Zisa’, che come indicato dal nome stesso è un palazzo meraviglioso, maestoso; a Catania si trova un quartiere denominato ‘Zia lisa’, che si presume possa essere una storpiatura dell’omonimo termine arabo. La stessa parola ‘mafia’ sembrerebbe essere di origine orientale. Lo studioso Antonio Di Gregorio sostiene infatti che ‘Afia’ significhi forza, mentre la lettera ‘M’ in arabo non è altro che un avversativo ovvero un ‘non’. È possibile dunque che ‘mafia’ significasse inizialmente ‘non forte’, ‘non prepotente’; sono molti gli studiosi che ritengono che la mafia fosse in realtà diverse, che abbia nei secoli subìto un cambiamento, che precedentemente asservisse al bene comune, che fosse insomma nata di sostegno al popolo, contro lo strapotere dei signorotti. Ma le influenze arabe sono particolarmente evidenti nella cultura culinaria di Sicilia. Basti pensare al cous cous, usato e amato soprattutto in zona di Trapani e Marsala; e poi ancora alla cubbàita, o alla granita, che è stata proprio importata dagli Arabi. In Sicilia vi sono poi arancini e crespelle ripiene che somigliano un po’ al turco ‘falafel’; stesso discorso per pane e panelle che vengono oltretutto realizzate a base di farina di ceci, un ingrediente molto utilizzato nella gastronomia orientale. Sembra che anche i cannoli fossero di origine araba, e la cassata, che gli islamici chiamavano infatti ‘qas’a’. Simili alle cassatelle o panzerotti dolci, sono poi i katayef; ma in tutto il mondo arabo si usa anche cucinare una squisita insalata di peperoni e melanzane, simile alla caponata o alla peperonata. Per non parlare poi dell’utilizzo del sesamo, sia in ambito dolciario che in quello dei prodotti da forno in genere (ad esempio sul pane), che è anche un ingrediente tipico della cucina dell’area dei Balcani e oltre. Anche la parola siciliana ‘giuggulena’ che indica il sesamo è di origini arabe; stesso discorso per lo zafferano, sia come toponimo che come coltura. Molte sono infatti state le coltivazioni introdotte dagli Arabi in Sicilia. Come lo zucchero, le banane; e come dimenticare poi lo ‘zibibbo’? Ma la cultura araba si intreccia inestricabilmente anche alla letteratura dell’Isola, attraverso l’antico personaggio di ‘Giufà’, antesignano di Pierino. ‘Giufà’, o in arabo ‘Giuha’, è la maschera-simbolo della Sicilia. Ragazzo maldestro e un po’ pigro ma anche buffo e allegro, di lui parlano tantissime storie che accomunano il suo derivato siciliano al suo antenato arabo, e che caratterizzano molta della produzione orale tradizionale e antica dell’Isola. Alcuni pensano inoltre che la cultura araba abbia influenzato il resto d’Italia, molto più di quanto non si pensi o si sappia. Ad esempio attraverso l’introduzione nel volgare degli articoli, non presenti in latino, oppure attraverso la tipica aspirazione della ‘c’ che caratterizza, ancor oggi, il toscano, da cui la nostra lingua è nata. Dante Alighieri stesso aveva affermato di aver molto apprezzato le produzioni siciliane della scuola di Federico II, che furono di fatto il primo esempio di volgare esistente in Italia; la stessa “Epistola del perdono”, opera di uno scrittore persiano, sembra essere stata presa come spunto per la realizzazione della Divina Commedia, ma per ora non esistono ancora documentazioni a sostegno di questa tesi.
Enrica Bartalotta http://www.siciliafan.it/come-gli-arabi-hanno-cambiato-ed-influenzato-la-sicilia/
La storia della Sicilia normanna ha origine con la conquista normanna dell'Isola, iniziata nel 1061 con lo sbarco a Messina al tempo in cui essa era dominata da potentati e governatori musulmani, e conclude con la morte dell'ultima esponente della famiglia degli Altavilla di Sicilia, Costanza, nel 1198. Nel 1130 la dominazione normanna instaurerà il primo regno dell'Isola con Ruggero II.
Nel
1071, guidati dal
Gran Conte Ruggero, i Normanni occuparono Catania, non
senza patteggiare, sembra, con l'emiro di Siracusa, Ibn al-Werd. Era
l'inizio di una nuova vita. Ma, partito Ruggero, i Catanesi richiamarono
l'emiro, e i Normanni dovettero riconquistare la città nel 1081. I
nuovi signori dubitavano della fedeltà di queste popolazioni, che per lingua Si iniziò a ricostruire la Cattedrale, nello stile normanno di una Chiesa-fortezza, dotata di muraglioni possenti e di torri, vicina alla costa in modo da controllare il porto. Città feudale, Catania lo rimarrà per quasi centocinquanta anni: il tempo di sviluppare un ceto urbano - mercantile e produttivo - relativamente autonomo. Di questo processo non sappiamo molto; non dovette essere facile, anche perché la città fu distrutta dal terribile terremoto del 1169 che infuriò su gran parte della Sicilia orientale; per questa occasione si fa la cifra, esagerata, di diecimila morti, tra i quali lo stesso vescovo Giovanni Aiello, perito con gran moltitudine di persone tra le rovine della Cattedrale ove si officiava la festa della patrona. Catania doveva aver raggiunto comunque un buon grado di vitalità, perché appena trent'anni dopo il terremoto, in pieno fervore di ricostruzione, la troviamo parteggiare per gli ultimi eredi degli Altavilla e ribelle contro Enrico VI, il figlio del Barbarossa. Nato intorno al 1031, figlio di Tancredi d’Altavilla e della sua ultima moglie Frenseda, fu il primo Conte di Sicilia.
«Ruggero oltre che abile condottiero, fu infatti anche un fine diplomatico; appoggiò il papato e così riuscì a farsi nominare Gran Conte di Sicilia. Inoltre, riuscì a gettare le basi per un’organizzazione dello stato meno basata sui signori feudatari, ma su di una classe di burocrati formati da funzionari pubblici non legati all’aristocrazia e dove comunque la sua figura era quella che deteneva il potere assoluto. Come sovrano cattolico fu fondatore di una serie di splendide cattedrali e fortificazioni in Sicilia: a Troina, a Mazara del Vallo, a Paternò, a Modica… A lui inoltre si devono le fondazioni dell’abbazia della SS. Trinità di Mileto e dell’abbazia di Santa Maria V.G. e i XII Apostoli di Bagnara Calabra»
Il nome
Aci Castello deriva
dall'omonimo castello posto su un vicino colle di pietra lavica
costruito nel 1076 dai Normanni. Durante il periodo della colonizzazione
greca prima, e della dominazione romana poi, la rocca sulla quale si
erge il castello normanno fu frequentata per la sua posizione
strategica, che permetteva il controllo del mare e del passaggio delle
navi dirette verso lo stretto di Messina. Fu colonizzato da molte
popolazioni dell'epoca antica, anche dagli Arabi che segnarono un
periodo sanguinoso di guerre e distruzioni, testimoniato dagli stessi
scrittori arabi. Il castello fu in seguito concesso ai vescovi di
Catania che proprio qui, nel 1126, ricevettero le sacre reliquie di
Sant'Agata, riportate in patria dalla città di Costantinopoli. Nel 1169,
il Castello, fu distrutto da un duplice cataclisma un violento terremoto
ma anche da un'imponen Il disastroso terremoto che sconvolse la Sicilia orientale nel 1693 recò al castello ingenti danni, che furono tuttavia riparati negli anni successivi dai discendenti del Massa. Nel XIX secolo il castello entrò a far parte del Demanio Comunale, ma nel 1818 un terremoto provocò nuovamente danni così gravi che esso non poté più essere utilizzato come prigione. Carenti le notizie storiche sulla seconda metà dell'ottocento; il castello tuttavia ispirò in questo periodo a Giovanni Verga la novella "Le storie del castello di Trezza" che, tra amori, tradimenti e fantasmi, narra le affascinanti vicende di don Grazia e di donna Violante. Agli inizi del XX secolo il castello di Acicastello divenne deposito di masserizie; durante la seconda guerra mondiale una grotta della rupe venne usata come rifugio antiaereo. Poichè il castello sorge su di un promontorio di roccia lavica a picco sul mare blu cobalto è praticamente inaccessibile tranne che per l'accesso attraverso una scalinata in muratura. Il ponte levatoio in legno che oggi non esiste più, occupava parte della scalinata d'ingresso. Al centro della fortezza si trova il «donjon» la torre quadrangolare, fulcro del maniero. Rimangono poche strutture superstiti: l'accesso, che conserva i resti dell'impianto del ponte levatoio, il cortile dove si trova un piccolo orto botanico, diversi ambienti, fra cui quelli dove è accolto il museo e un cappella (secondo alcuni bizantina) ed un'ampia terrazza panoramica sul golfo antistante da dove si gode un bel panorama sui Faraglioni e sull'isola Lachea di Aci Trezza. http://www.rivieradeiciclopi.com/il-castello-di-aci
Ruggero II. Figlio di Ruggero I d'Altavilla e di Adelaide di Monferrato (la mitica Adelasia) fu conte di Sicilia (1101-1130), duca di Puglia e di Calabria (1127-1130) e primo re di Sicilia (1130-1154). Dapprima sotto la reggenza materna (fino al 1113) e poi autonomamente, avviò un'energica politica di consolidamento della contea di Sicilia e, alla morte senza eredi del cugino Guglielmo duca di Puglia (1127), diede inizio ad una campagna di espansione nel Mezzogiorno, col disegno di unificare tutti i domini normanni d'Italia. Incontrò tuttavia l'opposizione di papa Onorio II, che lo scomunicò e sostenne una forte resistenza locale, capeggiata da Roberto II di Capua e Rainolfo d'Alife; ma Ruggero ne uscì vincitore e il papa fu costretto a riconoscerlo duca di Puglia (Benevento, 1128). Conte di Sicilia e duca di Puglia, il principe normanno assumeva così la veste di signore di tutta l'Italia meridionale, anche se non tutta ancora conquistata. Tra il 1128 e il 1129, riuscì ad affermare il suo potere anche su Napoli, Bari, Capua e molte altre località, continuando l'opera di unificazione. Alla morte di Onorio II (1130), sostenne l'antipapa Anacleto II contro il papa legittimo Innocenzo II, e dal primo ebbe il titolo di re di Sicilia e degli Stati principeschi di Puglia, Calabria e Capua, e fu incoronato a Palermo, il 25 dicembre 1130. La costituzione del regno fu seguita da un decennio di guerre, nel quale Ruggero II ebbe contro di lui coalizzati il papa Innocenzo II, l'imperatore Lotario II di Supplimburgo, il basileus Giovanni II Comneno, le repubbliche marinare di Genova, Pisa, Venezia ed anche ribelli interni al regno. Ruggero II riuscì a sconfiggere tutti e, morto l'antipapa Anacleto II (1138), dopo aver inflitto un'ultima grave sconfitta a Innocenzo II (San Germano, 1139), ottenne da questo il riconoscimento del titolo regio, in qualità di vassallo. La pace col pontefice consentì al re di ristabilire la sua autorità anche all'interno e di riprendere, con la collaborazione di Giorgio d'Antiochia e di altri valorosi ammiragli, l'espansione oltre mare, dalla Sicilia alla costa tunisina e dalla Puglia alla Grecia (con un attacco alla stessa Costantinopoli nel 1149). Ruggero II fece del regno di Sicilia uno degli Stati d'Europa più potenti e meglio ordinati dandogli una base legislativa con le Assise del Regno di Sicilia, promulgate nel 1140 da Ariano Irpino. Molto tollerante per quanto riguardava le profonde differenze etniche e religiose esistenti tra i suoi sudditi, incoraggiò le attività artistiche e culturali gettando le basi per quella fioritura artistica, culturale e politica che raggiunse l'apice con Federico II. http://www.ilportaledelsud.org/ruggeroII.htm
Nell'agosto del 1129, Ruggero II partì da Salerno per ritornare in Sicilia. Ad un tratto, però, una nebbiolina iniziò a scendere dal cielo. La nebbia pian piano si fece sempre più fitta fino a quando il cielo non diventò pieno di nuvoloni e si alzò una tempesta. Il re e l'equipaggio erano terrorizzati, non avevano mai visto qualcosa di simile. L'acqua entrava da tutte le parti, l'interno della nave era quasi distrutto. Il re pregava chiedendo al Signore di salvarlo dalla burrasca. Pregò tanto. La nave, anche se la tempesta non permetteva alcun movimento, continuava ad andare avanti come se qualcuno la guidasse e la spingesse per poterla salvare. Come una scena da film, nel buio della notte apparve una luce, era il Signore che disse: "Non temere, io sarò con te". Ruggero promise al Signore che nel posto in cui sarebbero approdati avrebbe fatto sorgere un tempio alla sua gloria. A quel punto cadde in un sonno profondo. La mattina si risvegliò sentendo le urla di esultanti dell'equipaggio. La nave aveva gettato le ancore a Cefalù. L'anno successivo Ruggero fece ergere una cattedrale, come promesso al Signore (in realtà iniziarono nel 1131, due anni dopo, ma questo a noi non interessa, in quanto le leggende hanno sempre ragione). Autore: Alessandra Cancarè
LE LAVE DI OGNINA. L'eruzione del 425 a.C., dette "Lave di l'Ognina", raggiunsero la borgata e il lungomare e crearono (bonus per il fastidio) un fiordo naturale menzionato anche da Cicerone e Plinio come fantasioso approdo di Ulisse durante la sua odissea. Infatti nel quartiere di Ognina tutto parla di Ulisse: strade, ristoranti, negozi, imbarcazioni. A parte la leggenda, il vero porto Ulisse si estese fino a San Giovanni Li Cuti arrivando all'odierno quartiere Picanello - in zona via Savasta. Accoglieva fino a 300 galee e triremi greche e continuò ad essere zona portuale per secoli collegandosi alla città di Catania attraverso la Via per l'Ognina, oggi Via Vecchia Ognina. Durante la dominazione normanna di Guglielmo II, in pieno Medioevo, fu poi ricoperto da una grande eruzione detta "Lave del Rotolo" che, a seguito di un forte terremoto, eruttò nel 1160-9 (*) da Gravina in via Monti arsi, ricoprì le precedenti, completò il lungomare (vedasi video) di Catania fino al Gaito, risparmiò la spiaggetta di Piazza Mancini Battaglia, coprì il fiume Longane in località via Acque casse e arrivò ad Aci Castello collegando il maniero normanno alla terraferma. A quel tempo il quadro doveva essere apocalittico, ma Catania non era come quella odierna. La città era piccola e tutto attorno c'erano solo campagne e poca gente. Se riaccadesse oggi, sarebbe una catastrofe. __________ (*) Anche se qualcuno continua a menzionarla, quella del 1381 (detta "Lave del Crocifisso") non è più accreditata quale eruzione principale di quel disastro ma solo conclusiva di quanto sopra.
LA CITTÀ E IL SUO VESCOVO La prima particolarità della Catania normanna è l'unione fra il monastero benedettino e la chiesa cattedrale cioè di quei due grandi centri del potere ecclesiastico che, spesso, altrove erano rivali. Il fatto che Angerio, monaco bretone proveniente dal monastero di S. Eufemia in Calabria, fosse insieme il primo abate del monastero di S. Agata e il primo vescovo di Catania indica che, a causa della situazione particolare, a Catania non si era verificata, almeno in un primo momento, quella contesa fra abate e vescovo che altrove, spesso, sarà piuttosto evidente. Qui, infatti, al vescovo-conte, che nel contempo era anche abate, erano affidati poteri straordinari di giurisdizione, esazione fiscale, ordine pubblico: un controllo capillare del territorio in nome e per-cento della monarchia che stava costruendo una struttura statale, fortemente centralizzata per l'epoca. Al di là delle vicende militari rendere stabile l'occupazione di una città composita è difficile anche per la ricca stratificazione etnica, religiosa e culturale che ne faceva la ricchezza voleva dire non solo acquisirne il controllo militare ma anche penetrare il territorio da un punto di vista religioso e culturale.
Solo più
tardi Ruggero d'Altavilla, a differenz Angerio diresse la chiesa e la città di Catania fino al 1124 ma soprattutto seppe creare attorno alla chiesa un forte nucleo di amministratori, mercanti, nobili, contadini e artigiani forti della loro prosperità ma sottomessi al vescovo e alla sua attenta e pressante fiscalità. Tutti gli indizi portano a pensare che l'antica città murata, la città fortificata, di epoca normanna dovesse coincidere con quella zona della città che ancor oggi continua a chiamarsi "civita". È infatti plausibile ritenere che l'abate Angerio non avesse interesse alcuno a cingere di mura tutta la grande estensione della antica città romana in gran parte distrutta, ma solo la zona contigua alla cattedrale e comprendente appunto la chiesa, il monastero e i principali edifici compreso il porto: in questa zona doveva concentrarsi dunque la maggior parte della popolazione. Soprattutto Angerio seppe dare un volto nuovo alla città: prima la chiesa era collocata su un'altura, Angerio volle che fosse vicino al mare: le imponenti absidi che ancora oggi campeggiano minacciose all'interno del cortile dell'Arcivescovado, verso via Vittorio Emanuele, erano all'epoca prospicienti il mare, in una zona litoranea fra il vecchio porto arabo e il foro romano. L'edificio fu insomma pensato come una chiesa "munita" una chiesa-fortezza: non potrebbe esserci testimonianza più forte sia dello sforzo "culturale" fatto dalla monarchia normanna per cristianizzare la regione, sia anche della commistione profonda fra questo impegno per un verso e Fattività politico-amministrativa ma anche di difesa, puramente militare, per garantire alla collettività quella protezione dagli attacchi esterni che era una premessa essenziale per favorire quel radicamento che la Chiesa svolgeva anche sulla base di un proprio progetto egemonico. Plasticamente lo stesso edificio mostrava nel concreto tutta una politica che garantiva pace e protezione ai fedeli e minacciava i nemici. Difficile stabilire l'andamento della popolazione anche se sappiamo che nel terremoto del 1169 morirono quindicimila persone: la cifra ci può dare un'idea di massima, fermo restando che si tratta di un dato puramente indicativo e per nulla certo perché non vi sono riscontri che ci aiutino a stabilire l'esattezza della cifra.
I pochi
documenti dell'epoca (specialmente le platee del 1095 e del 1195)
relative a Catania ci parlano di 945 famiglie soggette al vescovo
tea giudei (25 famiglie), neri (23 famiglie) e musulmani
complessivamente fra 2800 e 3300 persone: le platee rivelano che i
Saraceni si trovavano in condizione di inferiorità, dato che erano
sottoposti a tributo, anche se erano liberi di professare la loro
fede poiché, come ricorda anche Al Idrisi, ciò è confermato dal
fatto che ci fossero "moschee grandi e piccole". Dal punto di vista
economico e commerciale gli interessi della popolazione musulmana
erano poi garantiti da un "cadì" ovvero un funzionario che aveva un
certo prestigio presso le autorità locali, a testimonianza
dell'importanza del suo ruolo nella collettività. Si tratta di un
magistrato che vediamo all'opera nei momenti difficili anche
all'epoca di Federico II. Il vescovo gestiva, insomma, un solidissimo potere politico, sociale ed economico che lo legittimava a fungere da mediatore fra la collettività urbana e il sovrano ma anche fra le diverse etnie che componevano la collettività non solo dentro le mura cittadine ma anche in vasti territori del contado su cui in modo sempre più forte si esercitava il ruolo egemonico del centro urbano. Qui egli agiva tramite il suo giustiziere e controllava il territorio con suoi ufficiali e i gain. In altri termini il vescovo appare come una sorta di funzionario straordinario garante delle comunità di fronte al sovrano e del sovrano rispetto al controllo del territorio, nonché una garanzia rispetto alle relazioni fra il sovrano e il Papa. Ma, progressivamente, più cresceva la prosperità economica, più chiaramente lo sviluppo generò un primo allontanamento tra la comunità cittadina e il suo vescovo. Lo testimonia molto bene un documento del 1168 con il quale il vescovo Aiello ci ha lasciato la traccia di una concessione che certo non fu indolore: il vescovo concedeva ai borghesi e ai cavalieri la possibilità di traghettare il Simeto senza pedaggio: anche se nella "narrano" il vescovo cerca di mostrare che fu lui a prendere la decisione e a fare "dono" di una concessione spontanea: viceversa lo scontro dovette essere serio e la concessione non del tutto indolore. Ma, parallelamente queste fonte testimonia la forza della relazione fra il vescovo e la comunità che continuò ad essere forte e decisiva per lo sviluppo della regione pur se non priva di contrasti. E infatti fu a un vescovo di origine catanese, Maurizio, il primo di cui abbiamo notizia, che toccò in sorte di accogliere trionfalmente il corteo che riportava in patria le reliquie della santa protettrice approdate a Messina dopo un tormentato, incerto viaggio e un lungo periodo di lontananza. Indubbiamente possedere sante reliquie era un ottima fonte di guadagni certi per abbazie e chiese e dunque questo aspetto non poteva sfuggire agli abitanti di una città la cui vocazione mercantile era ormai radicata da secoli e che prima di altti potevano intuire la ricchezza che era garantite dal divenire meta di pellegrinaggi. Naturalmente non si può neanche trascurare l'importante elemento di identificazione individuale e collettiva che ciò comportava per tutti in un'epoca di grande incertezza e confusione. Anche per questi motivi, probabilmente, quando la città subì un assalto di pirati saraceni ed esso venne vittoriosamente respinto, i cittadini attribuirono il successo alla rinnovate forza che la protezione della santa garantiva grazie alla presenza delle sue reliquie in città. Rifondata dagli stessi guerrieri che l'avevano distrutte Catania si identificava nel XII secolo con la sua santa protettrice e la sua chiesa e obbediva al suo vescovo. _____________________ tratto da "Catania medioevale" di M. Mangiameli - Bonanno Editore.
La dinastia sveva in Sicilia durò dal 1198, anno in cui fu proclamato re Federico II di Svevia e fino al al 1266 quando Manfredi di Sicilia fu sconfitto e ucciso nella battaglia di Benevento da Carlo I d'Angiò.
Gli Svevi, con la dinastia degli
Hohenstaufen, presero il potere in Sicilia grazie ad matrimonio fra
Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II d'Altavilla con Enrico VI di
Svevia, figlio di Federico Barbarossa. Morto il giovane Guglielmo III,
ultimo re del regno di Sicilia e prigioniero in Germania, Enrico VI
rivendicò l’Italia meridionale e la Sicilia. Nel
1194
e nel 1197 Catania, che aveva sostenuto Tancredi di Sicilia prima e poi
osato ribellarsi agli Svevi, fu saccheggiata dalle truppe germaniche. Alcune leggende raccontano di un rapporto poco felice con il grande Federico II e più in generale con gli Hohenstaufen. In realtà non c'è traccia di una rivolta a Catania, contro Federico II, avvenuta nel 1232. Catania,divenuta demaniale con la maggiore età di Federico, non fu più signoria del vescovo-conte ed ebbe in pratica la sede vescovile vacante fin dal 1221 (e tale rimarrà sostanzialmente fino al 1254) a causa del perenne contrasto fra l’autorità imperiale sveva e quella ecclesiastica del papato. (Cfr. Hans Niese, Il Vescovado di Catania e gli Hoenstaufen in Sicilia, ASSO XII, 1915, p. 74: “Probabilmente Federico nel 1221 oltre il dominio di Calatabiano revocò anche il terzo del dazio su Catania appartenente al vescovo e la custodia porti, fatti che si ripeterono nel 1267. Perché, lasciare la guardia del porto in mano ai feudatari, come dimostrò appunto l’esperienza, era pericoloso.”. Inoltre cfr. Kantorowicz, Federico II imperatore, Garzanti Ed., Milano 1988, p. 517 : "ancora il 10 ottobre 1239 Catania risulta tra le sedi vescovili vacanti") Federico II fu universalmente chiamato “Stupor Mundi”, nacque a Jesi da Enrico VI Hohenstaufen di Svevia e Costanza D’Altavilla. Fu incoronato re di Sicilia nel 1198, fu un sovrano illuminato, scienziato, poeta, filosofo e allo stesso tempo un principe dispotico, ovunque andasse destava stupore con il suo seguito stranamente composto d’elefanti, dromedari, linci e tantissimi altri animali esotici di cui amava circondarsi. Si spense nel 1250 e fu sepolto nella cattedrale di Palermo, nella “sua Sicilia”, per suo espresso volere. Con lui finì il sogno imperiale siciliano. Per volere di Federico II furono costruiti in tutto il suo regno una serie di castelli, particolarmente interessanti proprio per le forme prettamente geometriche volute dallo stesso regnante. In Sicilia essi costituiscono un insieme omogeneo e rappresentativo di edifici che nascono con uno scopo strategico e difensivo, specchio della società del tempo. Essi, infatti, furono destinati ad una vita militare ma anche culturale che fu ricca e feconda ai tempi di Federico. I castelli di Federico II nascono come cittadelle fortificate all’esterno e luminose al loro interno, i più celebri in Sicilia sono: i castelli di Augusta e Milazzo con torri quadrilatere ed i castelli di Catania e di Siracusa con torri circolari.
Lo storico Kantorowicz scrive (nell'opera citata in nota
p.289), che "Durante gli ultimi decenni di regno, Federico si recò una
sola volta in Sicilia, a reprimervi la rivolta di Messina (1223)". Nel
1239 Federico
dà il via anche a Catania alla costruzione di una fortezza a difesa del
porto che poi prese il nome di
Castello Ursino;
opera di fortificazione
fonte wikipedia __________ Contro le vessazioni fiscali di Riccardo di Montenegro, reggente della Sicilia per conto dello Svevo, ma soprattutto contro le nuove leggi di Federico che intendevano abolire il suo porto franco, imporre il monopolio statale della seta, e governare la città tramite suoi rappresentanti, Messina nel medesimo anno 1231 insorse. Il suo esempio venne seguito da Catania, Siracusa, Nicosia, Centuripe ed altre cittadine. Lo “stupor mundi” reagì con intelligenza e sicurezza, in maniera da prendere tempo. Finse all'inizio di essere accomodante, promise di ridurre le imposte, e giurò solennemente il perdono a tutti. Nel frattempo riorganizzava e consolidava il controllo del territorio siciliano tramite la rete dei suoi castelli disseminati nell'isola. Nell'aprile del 1232 con un forte esercito dalla Calabria sbarcò a Messina ed occupò la città. Riuniti i cittadini più rappresentativi nella Cattedrale rinnovò ancora una volta promesse di perdono e di riduzione delle tasse, ma anche questa era solo una mossa strategica. Pochi giorni dopo, infatti, rimangiandosi la sua parola catturò i capi della rivolta, Martino Malla e Matteo Belloni insieme ai loro complici, e li bruciò vivi nella pubblica piazza, come eretici: in quel momento ribellarsi all'imperatore gli sembrava un delitto equiparabile alla ribellione contro il Papa e la Chiesa. Ugualmente soffocò le rivolte delle altre città che avevano seguito l'esempio di Messina, in primo luogo Catania e Siracusa. Nella città etnea, dopo aver deciso di risparmiare abitanti ed edifici - secondo la tradizione su ammonimento della Santa Patrona S. Agata - dotò l'ingresso della Cattedrale normanna di un portale recante figure e simboli che servissero di monito alla città (attualmente nella Chiesa di S. Agata al Carcere). http://digilander.libero.it/cataniacultura/139-federico-rivolte.htm
Alla fine della dinastia degli Hohenstaufen, nel 1266 la Sicilia venne assegnata dal Papa, che considerava l'isola patrimonio della Chiesa, a Carlo I d'Angiò; il 17enne Corradino di Svevia tentò di riconquistare il regno nel 1268, ma fu sconfitto nella Battaglia di Tagliacozzo e decapitato.
In Sicilia, roccaforte
svevo-normanna, la situazione si fece ben presto particolarmente critica
per una generalizzata riduzione delle libertà dei baroni ed una
opprimente politica fiscale. Catania fu uno dei centri delle rivolte contro gli angioini: i catanesi, che avevano subito ingiustizie, sfruttamenti ed erano stati danneggiati economicamente dalla chiusura dei porti della città, contribuirono validamente al rovesciamento della "mala signoria". I più importanti nomi che animarono la rivolta a Catania furono quelli di Palmiero, abate di Palermo, Gualtiero da Caltagirone, Alaimo da Lentini e Giovanni da Procida. Quest'ultimo nel 1280, travestito da monaco, si recò dal papa Niccolò III, dall'imperatore di Bisanzio Michele Paleologo e dal re Pietro III d'Aragona, per chiedere: al papa di non appoggiare Carlo d'Angiò in caso di rivolta; all'imperatore Michele l'appoggio esterno contro il nemico comune; e al re d'Aragona di far valere il suo diritto al trono di Sicilia in quanto marito di Costanza figlia di Manfredi, l'ultimo degli Hohenstaufen. Nel frattempo i siciliani avevano offerto la corona di Sicilia a Pietro III d'Aragona, marito di Costanza, figlia del defunto Re Manfredi di Svevia, trasformando l'insurrezione in un conflitto politico fra Siciliani ed Aragonesi da un lato e gli Angioini, il Papato, il Regno di Francia e le varie fazioni guelfe dall'altra. Nell'estate del 1282 Messina fu posta sotto assedio da Carlo I d'Angiò, consapevole che non avrebbe mai potuto avanzare all'interno della Sicilia se non dopo aver espugnato la città sullo stretto. L'assedio durò fino a tutto il mese di settembre, ma la città non fu espugnata.
Guglielmo Stendardo e Corrado Capece. In lingua francese Guillaume Étendard, ammiraglio e condottiero francese naturalizzato italiano.
Di nobile famiglia francese,
originario della Provenza, di cui fu siniscalco, scese in Italia con
Carlo I d'Angiò. Da questi, in seguito alla campagna d'Italia, che lo
portò ad essere re di Sicilia nel 1265, fu nominato maresciallo di
Lombardia e di Sicilia e, nel 1267, grandammiraglio di Sicilia. Nel 1268, mentre Carlo I d'Angiò si trovava a Lucera, fu mandato in Sicilia ad arginare una rivolta della fazione guidata da Corrado Capece che parteggiava per Corradino di Svevia. Il condottiero francese ebbe la meglio, segnalandosi per le atrocità commesse, in particolare ad Augusta e a Centuripe, dove la popolazione fu massacrata. Non è un caso che, per la crudeltà mostrata in Sicilia, fu detto uomo di sangue. Nell'agosto dello stesso anno, al comando di uno dei tre squadroni angioini, partecipò alla battaglia di Tagliacozzo, che sancì la definitiva caduta degli Hohenstaufen. Dopo che nell'estate del 1269 un'altra puntata angioina su Palermo era fallita presso Castronuovo, l'iniziativa passò al nuovo vicario generale francese che era stato nominato nell'agosto, il maresciallo Guillaume l'Etendart famoso per la sua crudeltà, il quale, dopo la caduta di Lucera e di Gallipoli, poté contare anche su nuovi rinforzi. Dopo la resa di Augusta presa d'assalto, nell'agosto le strade dei due capitani ghibellini si divisero, ma non è chiaro se a questo risultato si giunse per la loro rivalità mai composta, oppure come conseguenza della strategia militare del nuovo vicario generale. Mentre Federico Lancia e Federico di Castiglia si ritiravano ad Agrigento, Corrado Capece, insieme al seguito di lombardi e siciliani che gli era rimasto, si diresse verso Centuripe, dove fu accerchiato e assediato per parecchio tempo dall'Etendart. Accortosi della presenza di traditori nelle proprie file (uno di essi fu Gualtieri Russo da Catania), che erano entrati in contatto con gli assedianti tra i quali si trovava con tutta probabilità Alaimo da Lentini allora capitano di Randazzo, il Capece pensò di prevenirli sacrificando se stesso: si consegnò al vicario generale, probabilmente nel maggio del 1270. L'Etendart lo fece immediatamente accecare e poco tempo dopo impiccare sulla spiaggia di Catania, facendogli però appendere accanto lo scudo in segno di rispetto per la dignità cavalleresca del Capece. Nell'obituario di S. Patrizia di Napoli, alla data del 21 giugno, si trova l'annotazione "Corrao, (!) Capece de Monacho" che forse si riferisce a lui.
Appena scoppiò la rivolta in Sicilia, la flotta aragonese era già a Palermo e l’occupazione della città da parte di Pietro dava così inizio alla dominazione degli Aragonesi in Sicilia (1282-1516), in quanto lo stesso Pietro era sposato con la figlia di Manfredi, Costanza che era nata proprio nella città etnea.
Catania fu la sede dell’incoronazione del re aragonese con il nome di Pietro I di Sicilia, ed acquistò una posizione di privilegio in quanto nel corso del XIV secolo venne scelta spesso come sede del parlamento e dimora della famiglia reale. Catania sarà capitale non solo del regno dell'isola ma anche di una porzione di territori del mediterraneo.
A Pietro III successe, in Aragona, il suo primogenito Alfonso III d'Aragona, e in Sicilia il suo secondogenito Giacomo, che già nel 1287 dovette respingere, con l’aiuto dell’ammiraglio Ruggero di Lauria, le rinnovate pretese degli angioini che avanzavano verso Catania da terra e dal mare. Alla morte del fratello Alfonso III, Giacomo prese il suo posto e lasciò in Sicilia suo fratello Federico come vicario. Ma la politica di riavvicinamento, di accordi e di legami matrimoniali con la casa d’Angiò, caldeggiata anche da papa Niccolò IV, non piacque ai siciliani che il 15 gennaio 1296 si riunirono in parlamento a Catania ed elessero loro re il giovane Federico III che darà il via alla nascita di un regno del tutto indipendente. Aragonesi e Angioini, alleati per l’occasione, attaccarono le difese siciliane che, anche grazie al tradimento di due catanesi, furono superate.
Federico il Semplice lasciò il regno alla figlia minorenne Maria, nata dal matrimonio con Costanza, figlia del re Pietro IV d'Aragona, affiancata da quattro vicari: Artale Alagona, Guglielmo Peralta, Francesco Ventimiglia e Manfredi Chiaramonte. Artale Alagona scelse per la giovane regina Maria la residenza del castello Ursino di Catania, progettando di darla in sposa a Galeazzo Visconti, duca di Milano. Ma la fazione capeggiata dai Ventimiglia, baroni d’origine catalana, volevano che sposasse Martino figlio del duca di Monteblanc presunto erede del trono aragonese. Il rapimento di Maria portato a termine da Gugliemo Raimondo Moncada fece fallire i progetti del Gran Giustiziere del regno e permise il matrimonio della regina con Martino di Monteblanc. Re Martino, dopo la morte di Maria avvenuta nel 1402, sposò Bianca, erede del trono di Navarra, che scelse di stabilirsi a Catania assieme alla corte. Ma Martino morì a Cagliari nel 1409 all’età di 33 anni e a lui succedette il vecchio padre Martino duca di Monteblanc, che però sarebbe morto l’anno successivo.
MEDITERRANEO CHE FECE GOLA A MOLTI Il regno di Sicilia nasce ufficialmente la notte di Natale del 1130. Un regno che sotto gli Altavilla arriverà a comprendere nella sua massima espansione, Albania, Tunisia, Malta, Cefalonia e Zante. Più tardi arriverà a perdere questi territori, ma in Italia i suoi confini rimarranno immutati per più di 700 anni. In seguito il regno cambiò di mano prima con gli Svevi del celebre Federico II e poi gli Angiò. Dopo la loro sconfitta, gli Angiò furono particolarmente vendicativi e ridussero molte delle Libertà. Applicarono una tassazione rigidissima e salata nonostante i vari tentativi di mediazione richiesti. Dai siciliani dimostrarono insensibili a qualsiasi richiesta di ammorbidimento e continuarono a spremerli come limoni, con una tassazione altissima e dandosi e soprusi e violenze Nel 1282 i siciliani ne ebbero abbastanza e a Palermo si scatenò una rivolta a lungo preparata, i cosiddetti Vespri Siciliani, grazie ai quali i siciliani riuscirono a liberarsi degli Angiò e offrirono la corona di Sicilia a Pietro, III d'Aragona che si era schierato con loro e che era molto ben visto dagli isolani perché sua moglie Costanza era una diretta discendente dei Normanni, ai quali i siciliani erano ancora molto legati. La guerra si concluse solo nel 1302 con la pace di Caltabellotta, nella quale sostanzialmente i contendenti si spartirono il bottino: agli Angiolini andava la parte continentale del regno di Sicilia e agli Aragonesi la parte insulare, ovvero la Sicilia. Di fatto con questa divisione nascevano due Regni separati, ma dato che sia gli angioini che gli aragonesi non rinunciarono mai a riunificare il vecchio regno, entrambi continuarono a chiamarsi regno di Sicilia, il che creava non poche difficoltà alla diplomazia Europea. Per evitare confusione, i due Regni vennero informalmente ribattezzati Regno di Napoli e Regno di Trinacria.
Il Parlamento siciliano, composto da feudatari, sindaci delle città, dai conti e dai baroni, era presieduto e convocato dal re. La funzione principale era la difesa dell'integrità della Sicilia, come valore massimo anche nei confronti dell'assolutismo del re, nell'interesse di tutti i siciliani. Il re, infatti, non poteva stringere accordi di qualunque natura (politica, militare o economica) né dichiarare guerre senza aver prima consultato ed ottenuto l'approvazione del Parlamento che, per costituzione, doveva essere convocato almeno una volta l'anno nel giorno di Tutti i Santi. Il Parlamento costituzionalmente aveva il compito di eleggere il re e di svolgere anche la funzione di organo garante del corretto svolgimento della giustizia ordinaria esercitata da giustizieri, giudici, notai e dagli altri ufficiali del regno.
- Si fa un gran parlare oggi di
città,e non soltanto nel campo degli studiosi e degli artisti, ma anche nel
popolo,ed è a questo che dedico le presenti annotazioni, di re e regine che da
secoli dormono il sonno eterno tra le mura del
Mario Rapisardi, allorché le ceneri di Bellini vennero traslate da Parigi in patria, dettò per l'ingresso del Duomo la sonante iscrizione che tutti ricordano:<<Questa basilica ove giacciono dimenticate le ossa di tanti re,diverrà da questo giorno famosa per la tomba di Vincenzo Bellini >>.Ma la Patria, pur inchinandosi riverente e commossa al sepolcro del divino musicista, non può ignorare quelli di coloro che delle fortunose vicende del lontano e corrusco '300 furono le più alte potestà civili;e le vie del Destino appaiono infinite se oggi,improvvisamente, i fantasmi di quelle figure storiche riaffiorano, a ricordo,se non altro, e a monito. Però si fanno grosse confusioni, pare,tra questi principi dai nomi esotici,tra date ed eventi. Di nomi,per esempio, come Federico e Costanza,il Medioevo siciliano è ricco;avviene perciò tra i meno provveduti che il numero d'ordine secondo cui, dinasticamente, un principe deve distinguersi dall'altro, genera invece confusione. Tale è il caso di Federico II di Svevia imperatore, sepolto nella cattedrale di Palermo, e di Federico II d'Aragona, re di Sicilia o,per essere più ligi alla storia, re di Trinacria, come venne proclamato dal parlamento adunato a Catania nel gennaio 1296. Eran tempi di ferro,di fuoco e di sangue, quelli che seguirono i Vespri. I Siciliani, riconoscendo di essere immaturi per governarsi da sé, offrirono la corona dell'Isola a re Pietro III d'Aragona, sposo di Costanza figlia dell'infelice Manfredi, e morto lui l'anno 1285,al primogenito Giacomo anteposero il fratello Federico, proclamandolo, come ho detto, re di Trinacria. Sono dunque di costui i resti raccolti assieme a quelli di altri cinque principi e chiusi nel sarcofago romano testè venuto alla luce. Federico II regnò dal 1296 al 1337 e fu sposo di Eleonora d'Angiò, sepolta nella chiesa di San Francesco d'Assisi. A lui succedette il figlio Pietro II, che sposò una Elisabetta di Boemia e morì il 15 agosto 1342,lasciando la corona al figlio Ludovico, lo stesso i cui resti sono racchiusi nel sarcofago suddetto.
Tempi tremendi e crudeli. La Sicilia era divisa in due campi spietatamente avversi :La fazione latina, che voleva un governo di siciliani e che contava tra i suoi adepti i Chiaramonte, i Ventimiglia, i Montaperti, i Lancia,i Rosso,i Tagliavia; la fazione catalana, che sosteneva i re aragonesi e si fregiava dei nomi degli Alagona, dei Calcerando, dei Moncada,dei Peralta, dei Valguarnera, tutte famiglie di origine spagnola. Di questa seconda fazione, Blasco Alagona prima e il figlio Artale poi,ne erano i capi;essi,data la minore età di Ludovico e,morto questo, di Federico III e della di costui figlia Maria, re per grazia di Dio,erano i veri re. I principi, dunque, sepolti nel sarcofago romano sono sei: re Federico III morto a Paternò nel giugno 1337; un suo figliolo di nome Giovanni; re Ludovico figlio di Pietro II cioè nipote di Federico ,morto nel dicembre del 1355; Maria, figlia di Federico III e di Costanza d'Aragona (La regina del sarcofago cristiano) e moglie di Martino I; quinto della serie, un Federico, nato da Martino e da Maria. I resti del 6*personaggio sono di un giovinetto storicamente non identificato. Per la storia, Pietro II venne seppellito nella cattedrale di Palermo, nello stesso avello di Federico II di Svevia (chi sa perché, poi!),e Federico III, dettò dai coevi il Semplice, a Messina, dove morì,probabilmente in quella cattedrale, l'anno 1377. L' altro sepolcro è quello di Costanza, figlia di Pietro IV re d'Aragona e moglie di Federico III il Semplice. Di questo sepolcro e di questa regina avrò occasione di riparlarne. Il sarcofago con i resti dei sei principi venne aperto il 3 ottobre 1958 . (Saverio Fiducia da "Passeggiate sentimentali ")
Dopo la mancata ratifica della Pace di Catania da parte del Parlamento siciliano il Re di Sicilia Federico IV d'Aragona si trovò in una difficile posizione perché il regno era indebolito dai continui attacchi esterni degli angioini che erano riusciti a riconquistare parte dell'isola ed all'interno dai signori feudali della Sicilia che si opponevano con veemenza. Nel 1357 il governatore di Messina, Niccolò Cesareo, in seguito a dissidi con Artale Alagona, richiese rinforzi a Ludovico d'Angiò, che inviò il maresciallo Acciaiuoli. Le truppe, assistite dal mare da ben cinque galee angioine saccheggiarono il territorio di Aci, assediando il castello. Proseguirono quindi in direzione di Catania cingendola d'assedio. Artale uscì con la flotta ed affrontò le galere angioine, affondandone due, requisendone una terza, e mettendo in fuga le truppe nemiche. La battaglia navale, che si svolse fra la borgata marinara catanese di Ognina ed il Castello di Aci, fu detta «Lo scacco di Ognina» e segnò una svolta definitiva a favore dei siciliani nella guerra del Vespro.
Nel 1442 Alfonso conquistò il Regno di Napoli assumendo il titolo di Rex Utriusque Siciliae e unificando anche formalmente i due regni. Gli ultimi due re sono gli stessi del regno d'Aragona: Giovanni I e Ferdinando II, che con le nozze con Isabella di Castiglia unifica la corona di Sicilia a quella di Spagna. È il 1516.
Il governo spagnolo
Catania fu teatro delle traversie
avute dalla regina Bianca
di Navarra a causa delle
mire per la successione al trono da parte del Gran Giustiziere Bernardo
Cabrera, conte di Modica. Con l’elezione di Ferdinando I come re di
Aragona, Valencia e Catalogna la Sicilia fu dichiarata parte del regno
aragonese. La vedova regina Bianca fu confermata “vicaria”.
La Sicilia quindi fu un Regno
facente parte della Corona d'Aragona
insieme e al pari dei territori spagnoli e poi di Napoli, e fu
governata da un viceré,
alter ego del sovrano. I catanesi si consolarono con alcuni
privilegi concessi loro dalla regina Bianca. Il successore di Ferdinando I, Alfonso il Magnanimo riunì il 25 maggio 1416, nella sala dei Parlamenti di castello Ursino, tutti i baroni e i prelati dell’Isola per il giuramento di fedeltà al Sovrano. A castello Ursino si svolsero, fino al 30 agosto, gli ultimi atti della vita politica che videro Catania come città capitale del regno. La Sicilia divenne parte dell'enorme complesso territoriale degli Asburgo di Spagna (detti "Austrias"), uno stato multinazionale, multietnico e multilinguistico su cui "non tramonta mai il sole", governata in assenza del sovrano da un viceré (l'unico sovrano Austrias che soggiornò per qualche mese nell'isola fu Carlo V nel 1535, nel suo grandioso viaggio cerimoniale seguito all'impresa di Tunisi). Catania fu favorita dai sovrani spagnoli, anche se si segnalavano di tanto in tanto rivolte dirette più contro il governo locale espresso dalla nobiltà cittadina (patriziato) e contro i rappresentanti del sovrano, più che contro la dinastia regnante. Una sorta di guerra civile interna scoppiò nella città tra varie fazioni che si contendevano il governo municipale in occasione della confusa e travagliata successione al trono di Carlo di Gand (Carlo II di Sicilia e futuro Carlo V imperatore), e una sollevazione popolare si ebbe nel periodo delle rivolte siciliane (ma anche in varie altre parti d'Europa) del 1647 - 1648, il periodo più difficile del governo spagnolo sconfitto in Europa dalla Francia e nel pieno della drammatica crisi generale europea e mediterranea.
Dopo i conflitti del 1516-17 in segno di pacificazione il
corpo dei Giurati adottò il "Cerimoniale" scritto da Alvaro Paternò
(1522) , che codificava le regole e l’ordine attraverso cui dovevano
manifestarsi le gerarchie interne dei soggetti e dei poteri urbani in
occasione delle grandi cerimonie laiche e religiose. Fu l’esito
conclusivo delle sanguinose lotte interne dei partiti e delle fazioni
(che si indirizzò sempre più verso l’esterno con l’impegno militare al
servizio della monarchia) , e l’inizio di una nuova fase della vita
amministrativa locale. Gli
anni Trenta del Cinquecento
ci mostrano una c Re Alfonso il Magnanimo permise la nascita a Catania dell'Università più antica della Sicilia o Siciliae Studium Generale (1434). Inoltre il 31 maggio 1421, invitato da Gualtiero Paternò e Andrea Castello, che erano stati presenti al parlamento che il re aveva incontrato a Messina, il sovrano venne a Catania per riconfermare ufficialmente le “libertà” e gli “statuti” della città.
Il palazzo dell'Università di Catania
situato nell’omonima piazza della città, deve il suo attuale aspetto ai
lavori di ricostruzione eseguiti a partire dal 1696, per far fronte ai
danni causati dal disastroso terremoto del 1693.
Le più importanti cariche comunali erano il Capitano di giustizia, il
Patrizio, e i sei membri del consiglio chiamati senatori. Nel 1412 i
cittadini avevano ottenuto lo scrutinio cioè il diritto di eleggere i
senatori, sia pure scegliendo entro liste molto controllate. Osteggiato,
sospeso e ripreso più volte, il sistema dello scrutinio rappresentava
tuttavia il luogo della decisione e della legittimazione collettiva del
governo municipale. Nel 1435
Alfonso il Magnanimo
concesse alle maestranze che i loro consoli potessero intervenire in
Consiglio, concessione ritirata qualche anno dopo.
Questa determinerà lo svolgimento urbano, fin oltre il terremoto del 1693. La città non poteva restare immune dal travaglio religioso del secolo. Nel 1494, come in tutto il regno di Ferdinando il Cattolico, si ebbe l'espulsione o la conversione forzata degli ebrei anche a Catania; la comunità ebraica vi era particolarmente forte e numerosa. Sono forse ebrei convertiti i portatori di opinioni luterane, non meglio definibili, come lo sfortunato Giovan Battista Rizzo, linciato dalla folla nel 1513 perché, sembra, aveva compiuto un gesto sacrilego in Cattedrale contro l'Ostia consacrata. In rapporto col mutato clima religioso, si definisce meglio il culto della patrona, Sant'Agata, con importanti conseguenze sul patrimonio artistico. Nel 1542 un grande terremoto sconvolse il Val Noto (nella stessa area dove avrebbe colpito nel 1693). A Catania una cronaca narra che “tutta la cita si commossi a grande paura et timuri, credendosi ogni uno sumergiri et cum grandi planto et pagura gridando misericordia ogni uno andava verso la gloriusa sancta Agatha. Era grandi atterruri intendiri li gridati et planto di li donni et pichulilli, et per quistu quasi la mayuri parti di la cita, homini, donni et pichulilli, cum grandi devocioni et planto si congregaro in dicta mayuri ecclesia et incontinenti fu ordinata una processioni”.
Nel
1541
il
viceré Gonzaga
venne a Catania, prese provvedimenti per lo Studio e
per il rifacimento della cinta muraria secondo i nuovi criteri
dell’ingegneria militare. All’edilizia militare si accompagnava quella
civile. Tommaso Fazello, in visita a Catania nel 1541, segnalava lavori
di sopraelevazione degli edifici e annotava che i resti del mausoleo di
Stesicoro si trovavano al di fuori della porta di Aci; cento anni dopo
il Grossi descriverà in quegli stessi luoghi l’esist
LE MURA DI CARLO V Le Mura di Carlo V, costituite da undici bastioni e diverse porte di accesso alla città, risalgono al XVI secolo, quando l’imperatore Carlo V diede l’incarico all’architetto Antonio Ferramolino. Questo fu un secolo alquanto travagliato per l’isola: si assistette non solo ad un peggioramento della situazione politica ed economica, ma anche alle continue invasioni dei turchi; Catania divenne dunque teatro di duri scontri tra cittadini e ottomani. Tutto ciò spinse l’Imperatore a prendere seri provvedimenti per difendere la città, costruendo appunto il complesso murario. Il progetto includeva la sostituzione delle, ormai vecchie, mura medievali con una nuova cinta muraria che si adeguasse alle nuove tecniche militari. Ma qualche secolo più tardi si dovette procedere con i lavori di restauro poiché le Mura subirono ingenti danni in seguito alla devastante eruzione dell’Etna del 1669 e al terremoto del 1693 che distrusse la maggior parte dei monumenti preesistenti.
I lavori di ricostruzione furono avviati con il duca di Camastra e fu con quest’ultimo che venne riaperta la porta d’accesso vicino alla Piazza Duomo: si tratta della porta intitolata al vicerè duca di Uzeda, una delle porte più scenografiche della città etnea. Ma sono le Mura alla Marina quelle che hanno subito maggiori rifacimenti. Le originarie porte di Catania sono state anch’esse in parte sommerse e rovinate dai disastrosi eventi e oggi la Porta di Carlo V è l’unica tra queste che si conserva intatta: questa è anche conosciuta con il nome di “Porta dei Canali”, in quanto era collegata a dei canali, e inoltre qui sgorgava l’Amenano, fiume in seguito interrato dal terremoto. Realizzata con blocchi lavici, la Porta include una lapide di marmo sulla quale sono incise a caratteri latini le parole dello stesso imperatore che esprime il suo desiderio di dotare la città di una nuova cinta muraria. http://turismoct.myhostingweb.com/articolo.php?idarticolo=8813
Con gli Aragonesi, nel XIII secolo, la cucina siciliana si arricchì ulteriormente: nacquero le preparazioni fritte; le monache di numerosi monasteri elaborarono, forse dietro richiesta delle famiglie nobili, le ricette, ancora oggi gelosamente custodite, di svariati dolci. Si fa risalire a quest’epoca il "farsumagru", piatto di carne lasciato dagli Angioini, opera dei cuochi provetti delle grandi famiglie nobili dell'isola. In questo stesso periodo giunsero in Sicilia, grazie ai commerci con il Medio oriente e alle immigrazioni degli Ebrei che già le conoscevano e le apprezzavano, le melanzane, originarie della Cina e dell’India. Nella gastronomia siciliana, le melanzane trovarono buona accoglienza: fritte, farcite, trasformate in caponate, cotte alla griglia, messe sott’olio, abbinate a preparazioni a base di riso e pasta, sono ancora oggi le dominatrici della cucina isolana. Gli spagnoli importarono dall’America alcuni prodotti ancora non conosciuti in Europa: pomodori, peperoni, granturco, patate, fagioli, cacao e vaniglia, solo per citare i più rappresentativi, eu iaddu d'India (il tacchino)
Lo strano gallo che arrivò con gli spagnoli.
Il tacchinio fu importato in
Europa nel XVI sec. dai conquistadores spagnoli che lo trovarono
in Messico presso gli Aztechi. Gli spagnoli lo chiamarono pavo
comun, sicuramente perché anche questo animale fa con la coda la ruota
come il pavone, ma la denominazione spagnola non ebbe molta fortuna e
ogni popolo inventò nomi diversi per designare quest’uccello, anche
perchè per India si intendeva la terra che fu scoperta e che invece
erano le Americhe, cioè il Messico. I Francesi, per es., dal latino scientifico gallina indica foggiarono il termine dinde, che troviamo attestato intorno al 1600 e che è un’abbreviazione di coq d’Inde (Rabelais). Dal francese dinde deriva a sua volta l’italiano dialettale dindo, dindio, diffuso specialmente nel Veneto e nella Romagna, e il marchigiano drindo, dìndero. Scendendo ancora lungo la penisola italiana incontriamo il napoletano gallërìnië e il tarantino jaddidìnië. Anche nei dialetti grecanici dell’Italia meridionale il concetto predominante e quello della provenienza dalle Indie (con la solita confusione tra Indie orientali e occidentali), tant’è vero che a Bova il tacchino è chiamato ndakó dal greco medievale indikós [aléktor]. In Sicilia (e nella Calabria meridionale) esiste una grande varietà di nomi per indicare il tacchino, ma tutti si possono raggruppare intorno a tre nuclei fondamentali che sono i seguenti: termini onomatopeici; gallo d’India; indiano Tra i nomi di origine onomatopeica, derivati probabilmente dal richiamo per questo uccello, citiamo papì m. e f., papìa f., papìu m., diffusi in provincia di Enna e di Caltanissetta, e pìu che si riscontra in vari centri delle province di Siracusa (Ferla, Solarino, Floridia, Pachino), di Ragusa (Comiso, Vittoria, ecc.), di Caltanissetta (Niscemi, Gela), di Agrigento (Favara, Raffadali, Siculiana, Lampedusa) e di Trapani. Il dim. piùzzu è stato raccolto dal Pitrè a Noto. Il tipo gallo d’India è diffuso a macchia di leopardo in tutta l’Isola e presenta una serie di varianti dovute alle caratteristiche fonetiche delle singole parlate locali. Troviamo infatti: addudìn(n)ia (in prov. di CT e di TP), addurìn(n)ia (in prov. di PA e TP),gaddrudìnnia (in prov. di AG), gaddudìn(n)ia (nei vocabolari siciliani di Del Bono, Traina, ecc.) gaddulìndia (in prov. di CT), gaddulìnia (nel vocabolario del Cannarella), iaddurìnnia (in prov. di CT), gaddurìnia (in prov. di PA), gaddurìnnia (in prov. di AG), iaddudìn(n)ia (in prov. di ME e CT), In alcune parlate è scomparsa la prima parte del composto per cui abbiamo ìnniu m. nel Del Bono e ìnnia f. nel Traina, nel Mangiameli e nelle province di TP, PA, AG. Un po’ più complessa è la trafila che dobbiamo seguire per spiegare i derivati da ‘indiano’. Il più diretto discendente è n(n)iànu m. e n(n)iàna f. attestati entrambi nelle parlate di Palazzolo Acreide, Avola e Noto. Da nniàna deriva per metatesi nanìa che, con le sue varianti nanìu e nanèu (Floridia), è diffuso in molti centri della provincia di Siracusa. Da nanìu con assimilazione vocalica deriva ninìu, attestato per Palazzo Adriano (PA), e da questo abbiamo nìu e nìa, diffusi soprattutto nella provincia di Messina. Notiamo in margine che anche in Calabria troviamo i termini ndiànu, niànu e nìu per indicare il tacchino. Infine i termini nuzza f. e nuzzu m. derivano certamente dal vezzeggiativo “indianuccio” e sono attestati non solo in alcuni vocabolari siciliani (Traina, Macaluso Storace, Piccitto – Tropea, ecc.), ma sono usati in numerosi comuni dell’Isola, tra i quali citiamo Mongiuffi Melia, Motta Camastra, S. Domenica Vittoria, Floresta, Catania, Francofonte, Vittoria, Cerami, Ribera, Caltabellotta, Sciacca, Alcamo, Calatafimi, Campobello di Mazzara, ecc. http://www.cstb.it/index.php?page=etimologie.php&menu=
TRA MEDIAZIONE E REPRESSIONE: L’ARISTOCRAZIA CATANESE DURANTE LA RIVOLTA DEL 1647
L'infausto XVII secolo delle catastrofi naturali e la rinascita successiva: il Barocco
Quella del 1669 è stata la più grande eruzione laterale avvenuta in epoca storica. Dalla fenditura prodottasi in quei giorni sgorgò una delle più disastrose colate laviche che la storia etnea ricordi; la colata che sconvolse il versante sud-orientale del vulcano distrusse non solo numerosi centri abitati, ma gran parte della stessa città di Catania.
Un’ enorme tragedia vissuta dalle genti dell’Etna che segnò inesorabilmente la
vita di decine di migliaia di persone e che ne causò in pochi mesi la morte di
oltre tremila per le terribili carestie derivanti dagli eventi. A partire dall’8 marzo sino alle ore 06.00 dell’11 marzo 1669 una sequenza impressionante di terremoti interessò l’area compresa tra gli abitati di Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Mascalucia e Gravina causando notevolissimi danni alle abitazioni. L'11 marzo accompagnata da sinistri rimbombi si aprì una fenditura profondissima larga circa 2 m che si estendeva da Piano San Leo ( circa 6 dall'abitato di Nicolosi ) sino alla sommità dell'Etna. Quella stessa mattina nel pianoro sottostante il Monte Nocilla ( 2 Km a Nord-Ovest di Nicolosi ) si aprì un'enorme voragine da cui proruppero globi di cenere e blocchi accompagnati da…grandi tuoni, fragori, e tremuori…durante lo stesso giorno si aprirono altre voragini allineate lungo la medesima direzione dalle quali si…cacciava con urli, e strepiti spaventosissimi un denso fumo nero… Dopo il tramonto, si aprì un'enorme voragine che nella notte...cominciò a vomitare un gran profluvio di liquidi sassi, che all'aspetto dell'aria, acquistando durezza e tero rosseggiante colore di schiumoso ferro, formavano quel vario misto che lava si appella… Le pareti interne dei condotti craterici sono prevalentemente costituite da scorie, blocchi, bombe vulcaniche, ghiaie e sabbie vulcaniche dalla colorazione rossastra. Il colore, rappresenta la risposta ai fenomeni ossidativi derivanti dai processi chimico-fisici esogeni. Da ciò discende in parte l’etimologia errata attribuita a questo cono a "otto". Nel frattempo alle bocche, l’accumulo dei brandelli lavici lanciati in aria dalle esplosioni aveva formato un monte bicorne alto 50 piedi (un cono a due cime alto più di 250 m. "I Monti Rossi". Esso rappresenta il più grande cono avventizio dell’ Etna e supera in grandezza moltissimi edifici vulcanici indipendenti di altre regioni del pianeta). Ha un perimetro pari a circa 3 Km e la base ellittica. L’attività esplosiva di questo monte fu talmente violenta che le ceneri spinte dai venti raggiunsero non solo le contrade meridionali della Sicilia ma anche molte zone della Calabria .
Giorno 25 marzo, un fortissimo terremoto distrusse parzialmente il cratere centrale che, sollevando un' altissima colonna di ceneri, crollò al suo interno. Nel frattempo le colate laviche scaturite andarono espandendosi in diverse direzioni divorando Malpasso, Mascalucia, S. Pietro Clarenza, Camporotondo, S. Giovanni Galermo e Valcorrente. Il 29 marzo del 1669 le colate circondarono Misterbianco e la seppellirono, la lava distrusse quasi tutte le abitazioni. Il giorno 1 aprile 1669 le lave si trovavano a 2 miglia ad occidente della cinta muraria di Catania, avvicinandosi, la colata investì dapprima la borgata di Cibali e dopo aver distrutto un antico acquedotto si diresse verso la zona nella quale oggi sorge la piazza S. Maria di Gesù. In questo luogo, centinaia di catanesi tentarono invano di contenere la furia devastante della colata lavica che proseguì in direzione del lago Anicito, formatosi in seguito dell’ eruzione del 496 a.C., profondo circa 15 metri con una circonferenza di 6 km.; prendeva il nome dalla nobile famiglia bizantina "Anicito", (attuale via Lago di Nicito) a cui quelle zone appartenevano. Il flusso lavico continuò il suo cammino in direzione del Bastione degli infetti, ai 36 canali del fiume Amenano e dopo aver distrutto completamente la parte sud-occidentale della città, le lave raggiunsero per la prima volta il mare alle due di notte del 23 aprile del 1669. Il suo pauroso fronte, largo oltre 2 miglia ed alto più di dodici metri, fece avanzare la costa di oltre un miglio. Il 30 aprile una digitazione della colata lavica penetro nell’ orto dei Benedettini circondando il convento dai lati nord e ovest, arrecando notevoli danni. Giorno 9 giugno 1669 dalla zona di Nesima, scaturì una copiosa corrente lavica che arrivò a circondare i fossati del castello Ursino (che allora dominava la costa ) per riversarsi poi in mare a formare una sorta di promontorio. La città abitata da decine di migliaia di persone, si spopolò quasi del tutto e conobbe tra l’altro anche il dramma delle tantissime persone senzatetto. L’eruzione cessò verso la metà di Luglio dopo che la lava, scaturita dalle bocche eruttive poste a circa 820 m. s.l.m aveva raggiunto il mare e aveva emesso quasi un miliardo di metri cubi di lava. Nell’immaginario collettivo delle popolazioni del versante meridionale dell’Etna e degli abitanti di Belpasso e Paternò, anche se per motivi diversi, è ancora presente il triste ricordo della grande eruzione iniziata l’11Marzo 1669 e conclusasi dopo 122 giorni. Un fiume di fuoco lungo 16 km rese sterile oltre 38 kmq di territorio, distrusse migliaia di costruzioni e con oltre 970 milioni di metri cubi di lave seppellì 16 centri abitati minori e parzialmente distrusse la città di Catania. Il 20 marzo 1669 come descrittoci dal Canonico Alessi ,"… L' infocato profluvio giunse a Malpasso, abitato da 8000 persone e nell'arco di 20 ore fu tutto ricolmo da quel fiume di fuoco e dagli ammassati sassi…"
Ricostruito più in basso con il nome di Fenicia Moncada venne distrutto dal terremoto del 1693. Riedificato nello stesso luogo, dal 1695 prende il nome di Belpasso. Quest’eruzione è nota anche per il primo tentativo documentato di deviazione di una colata. La lava che aveva scavalcato le mura di Catania fu infatti deviata tramite barriere di terra, sassi e macerie delle case crollate. Ma ancora più sorprendente per quel tempo, fu il tentativo effettuato da una manipola di temerari guidati dal sacerdote Don Diego Pappalardo, effettuato nei pressi di Malpasso; con incredibile audacia, tentarono infatti di praticare una breccia nell’argine della colata. Coperti con velli di bue bagnate d’acqua, attraverso delle aste di ferro, riuscirono ad arrivare al cuore del canale, tanto che il liquido fuoco si riversò lateralmente iniziando a scorrere nella campagna circostante per notabile spazio. Avrebbero potuto continuare nella loro opera se non fossero stati bloccati dagli inferociti abitanti di Paternò, preoccupati dalla possibile invasione del loro paese a causa dell’intervento operato "…Che si lasci correre il fuoco laddove la Provvidenza l’ha destinato "… I varchi precedentemente aperti, non più controllati, furono immediatamente ostruiti da nuova lava raffreddata, mentre il ramo principale della colata continuò a muoversi verso Catania, dove aprendosi dei varchi nelle mura delle città, distrusse interi quartieri (A. Rittmann, 1929). Quest’eruzione distrusse buona parte della città di Catania, furono sommerse le rovine della Naumachia, del Circo e del Ginnasio, il fossato ed i bastioni del castello Ursino, la porta dei Canali. Scrive Federico De Roberto: "…Tutta la plastica del territorio è stata più volte mutata dalle successive eruzioni . Il livello del suolo si è innalzato; il corso delle acque dell’Amenano è stato fuorviato ed interrato; le vallicelle di Nesima e di Albanelli sono state colmate; il laghetto di Nicito è scomparso; il contorno della costa si è modificato; il porto si è ristretto ed è poi sparito; nuovi promontori scabri si sono allungati sul mare eppure, sfidando la tragica potenza del vulcano e forte di un carattere audace, il popolo catanese ha ricostruito, ogni volta dalle macerie, la propria città…" L’abate Vito Maria Amico, storiografo (1677-1762), così ricorda l’evento: "…Aprissi la mattina da mezzogiorno a settembre dal piano di S. Leone a Monte Frumento verso il supremo cratere profondissima fenditura larga cinque o sei piedi su cui apparse fulgido splendore. All’ora undicesima fra tremiti aprissi voragine di fuoco sotto la Nocilla lungo la fenditura, che proruppe in ceneri e sassi tuonando…" Giuseppe Recupero (1720-1778) nella sua Storia naturale e generale dell’ Etna così descrisse l’ evento: "… Commoversi con grande violenza tutto il perimetro della montagna, saltare in aria dal cratere una prodigiosa colonna di nero fumo, e rovente materia, e profondarsi finalmente la sua cima con orridi rumoreggiamenti nel suo baratro. Cadde in primo luogo quella vetta che guardava verso Bronte, di poi l’altra rimpetto l’oriente ed ultimamente si rovesciò quella posta in faccia al mezzogiorno…". http://www.scuoladusmetnicolosi.it/scarica/montirossi/geologia/eruzionedel1669.htm
La Sicilia orientale fu distrutta da un forte terremoto: ma la causa non fu l’Etna. L’11 gennaio non è una data tanto felice da ricordare per gli abitanti della Sicilia orientale e soprattutto dei paesi etnei abituati ai frequenti scuotimenti periodici dell’Etna. “« All'unnici di Jinnaru a vintin'ura a Jaci senza sonu s'abballava cui sutta li petri e cui sutta li mura e cui a misericordia chiamava » recita un vecchio proverbio siciliano per indicare i gravi danni arrecati alle abitazioni dalla potenza del terremoto che, con una magnitudo di 7.4, costituisce ad oggi l’evento di più elevata energia della storia sismica italiana. Ancora in vecchi scritti si legge « All’unnici di Jinnaru a vintu’ura, fu pi tuttu lu munnu ‘na ruìna: piccini e ranni sutta li timpuna diciènu - Aiutu! - e nuddu ci ni rava. Si n’era pi Maria, nostra Signura, tutti forimu muorti all’ura r’ora; all’ura r’ora ciancieriemmu forti se Maria nun facìa li nuostri parti..». Il terremoto dell’11 gennaio 1693 ha avuto l’epicentro in Val di Noto e si è verificato intorno alle ore 21. Concomitante ad esso si verificò un maremoto catastrofico che ha interessato pressoché tutta la costa orientale della Sicilia fino all’arcipelago maltese. Le vittime dei terremoti del 9 e dell’11 gennaio furono circa 60.000 (fonte G. Patanè, S. La Delfa, J.C.Tanguy “L’Etna ed il Mondo dei Vulcani”). Negli archivi parrocchiali di Aci S. Antonio si evincono 133 vittime il che è una cifra enorme se si considera che a quei tempi il paese era una piccola borgata. Ma non solo l’11 gennaio del 1693 il terremoto fece sentire i suoi nefasti effetti; anche l’11 gennaio del 1848, si verificarono due forti scosse di terremoto che distrussero buona parte di Catania e Acireale. Quello dell'11 gennaio 1693 rappresenta, assieme al terremoto del 1908, che il 28 dicembre distrusse la città di Messina (magnitudo 7.2), l'evento catastrofico di maggiori dimensioni che abbia colpito il territorio italiano in tempi storici (il terremoto del 6 aprile 2009 che ha distrutto buona parte della città di L’Aquila è stato di gran lunga meno energetico con una magnitudo di “appena” 5.9 della scala Richter). Infatti nel 1693 si è avuta la distruzione totale di oltre 45 centri abitati. Il sisma ha interessato una superficie di circa 5600 Km2 e causato un numero complessivo di circa 60.000 morti.
D. O. M. / Ferma le piante, e leggi o passagiero / A. 9 di gen.° 1693 trema Catania a scosse / di fiero terremoto, e replicando all. 11 / del medemo con tutte, le sue grandezze / con 16 mila catanesi sepolta da sassi, / derelitta da vivi, derubata da ladri ri / mane. In simil fato à fuggir le mura a ri / covrarti nei campi, a custodir la / città questo marmo ti / insegni cossi viverai / an: do: 1693
Questa l’iscrizione, la sola non in latino e tra le prime delle nove cittadine che ricordano il terremoto del 1693, della lapide che, recuperata dalla demolizione dell’edificio precedente, campeggia sul prospetto del teatro Sangiorgi (1900) in via Antonino di Sangiuliano. La tragedia aveva sfiorato la città non molto tempo prima: l’eruzione dei Monti Rossi del 1669 produsse una colata di quasi un miliardo di metri cubi che raggiunse una Catania spopolata per paura; deviata dalle mura cinquecentesche sino al bastione San Giorgio, presidio sud orientale, la lava si riversò in mare, la battigia avanzò di centinaia di metri, il porto fu invaso, la costa mutò l’andamento lungo il fronte urbano, circondato da un deserto fumante terra di nessuno. Colmati i fossati, l’Ursino non fu più “castello a mare” presidio del porto come i coevi di Augusta e Siracusa. La città fu risparmiata, la popolazione vi fece ritorno e numerosi profughi vi cercarono asilo dai distrutti paesi del versante meridionale dell’Etna, le cui terre invase dai basalti non furono coltivabili per decenni. Non così nel 1693: le scosse della sera di venerdì 9 gennaio causarono una decina di morti e ingenti danni al patrimonio edilizio, procurando allarme nei cittadini ma non sufficiente, forse memori dello scampato pericolo di pochi lustri prima, per lasciare la città; con quelle del pomeriggio di domenica 11, sedicimila abitanti su diciannovemila, secondo fonti d’epoca, furono sepolti dalle macerie di Catania e dei suoi secoli di storia. Condivisero quella sorte le città del Val di Noto, interessato dal sistema di faglie ibleo maltese da cui originano i terremoti della regione, e molte del Val Demone, raggiunte dall’onda sismica, furono gravemente danneggiate. Con non pochi contrasti, governo, nobiltà e clero si impegnarono, animati dalla volontà di autorappresentazione, ma anche di protagonismo a fianco di una popolazione afflitta da lutti e distruzioni, in un imponente progetto ricostruttivo unitario, tendente a inserire la nuova Catania nei più aggiornati circuiti culturali europei, offrendole una rinnovata memoria storica e una nuova identità di carattere non più o non soltanto localistico, che trasformò la catastrofe in una grande occasione di riscatto economico e sociale delle popolazioni interessate. http://www.rotarycataniaest.it/
La
sequenza sismica relativa a questo devastante terremoto è iniziata il
giorno 9 gennaio 1693 e si è protratta per circa 2 anni nel corso dei
quali si sono avute circa 1500 repliche di minore energia molte delle
quali hanno completato l’opera demolitoria della scossa principale.
L'evento principale del XI grado della scala Mercalli (MCS) si è
verificato alle ore 9 della sera dell'11 gennaio, dopo che
alcune scosse di minore intensità di circa l’VIII grado della scala
Mercalli si erano già fatte sentire la sera del giorno 9 e la mattina
dell’11 gennaio giorno della scossa principale che avvenne alle ore
21. Il numero più elevato di vittime è stato registrato nella città
di Catania dove sono morti circa i 2/3 della popolazione. Le
caratteristiche dell'evento principale consentono di considerarlo, per
molti aspetti, simile al terremoto del 4 febbraio 1169 che anch’esso
ha distrutto i centri della Sicilia orientale e tale funesta data la
si può leggere nella lapide che sovrasta Giovanni Tringali
DURANTE LA RICOSTRUZIONE
Il grande terremoto siciliano del 1693 danneggiò gravemente cinquantaquattro città e paesi e 300 villaggi. la Sicilia era ancora ufficialmente sotto il controllo Spagnolo, ma in realtà era governata dalla sua aristocrazia autoctona. Questa era guidata dal Duca di Camastra, che gli Spagnoli avevano nominato viceré per appagare l'aristocrazia, che condivideva il proprio potere solo con la Chiesa Cattolica. Molti preti e vescovi erano a loro volta membri dell'aristocrazia, e la ricchezza della Chiesa di Sicilia era ulteriormente aumentata dalla tradizione di spingere i cadetti maschi e femmine verso i monasteri e i conventi, per preservare l'eredità della famiglia dalla sua divisione; una pesante tassa, o dote, veniva di solito pagata alla Chiesa per facilitare ciò, nella forma di proprietà, gioielli o denaro. Così la ricchezza di certi ordini religiosi crebbe fuori da ogni proporzione rispetto alla crescita economica di qualsiasi altro gruppo sociale del tempo. Questa è una delle ragioni per cui così tante chiese Barocche e monasteri, come San Martino delle Scale, furono ricostruiti dopo il 1693 con tale lusso. Una volta iniziata la ricostruzione, i poveri ricostruirono le proprie casupole nel solito modo primitivo di prima. Per contrasto, i più ricchi residenti sia secolari che spirituali vennero presi da una quasi maniacale orgia di edificazione. Furono costruite o ricostruite innumerevoli chiese e palazzi. I nobili si sentirono in dovere di dotarsi di palazzi e residenze di campagna per affermare il proprio ruolo sociale, favorendo le espressioni artistiche più opulente di decorazioni. Gli architetti spesso locali furono capaci di progettare in un modo più sofisticato di quello del tardo XVII secolo; molti erano stati educati nell'Italia continentale ad una comprensione più dettagliata dell'idioma Barocco. Il loro lavoro ispirò progettisti siciliani che avevano avuto minori occasioni. Va osservato che questi architetti furono anche assistiti da pubblicazioni di incisioni di Domenico de' Rossi, che per la prima volta fornì le precise dimensioni e misure di molti delle principali facciate Barocche e Rinascimentali di Roma. In tal modo il Rinascimento finalmente sbarcò in Sicilia diciamo così per procura. Giovanni Battista Vaccarini era il principale architetto siciliano durante questo periodo. Egli arrivò sull'isola nel 1730 portando un personale amalgama delle idee del Bernini e del Borromini, e introdusse all'architettura dell'isola un movimento unificato e un gioco di linee curve che sarebbe risultato inaccettabile nella stessa Roma.
Catania fu gravemente danneggiata e le strutture più imponenti che rimasero in piedi furono il medievale Castello Ursino e tre navate della cattedrale. Il nuovo piano prevedeva infatti strade più larghe e l'inserimento di ampie piazze che consentissero eventuali aree antisismiche. Così essa fu riprogettata e ricostruita. Il nuovo progetto separò la città in due principali quartieri, uno nobile (il cui terreno era venduto più caramente a 20 onze per tumulo) e uno popolano (a 13,10 onze per tumulo, dove si insinuò il nascente Monastero dei Benedettini), distinti dalle attuali vie Vittorio Emanuele II a sud e Santa Maddalena a est. La ricostruzione fu supervisionata dal Vescovo di Catania ed unico architetto sopravvissuto della città, Alonzo di Benedetto. Costui diresse una squadra di architetti chiamati da Messina, che presto aprirono i cantieri, concentrandosi prima su Piazza del Duomo. I tre palazzi collocati sono: il Palazzo Vescovile e il Seminario dei Chierici a sud, il Palazzo degli Elefanti a nord (che sostituisce l'antica Loggia medioevale) e ad ovest il Palazzo Pardo Sammartino.
Il potere ecclesiastico a Catania - I Benedettini. di Agata Nicosia Tra preghiere e peccati uno dei complessi monastici più grandi d’Europa.
Il
Monastero di San Nicolò L’Arena di Catania, è un luogo magico e
suggestivo. Intanto colpisce per la sua immensità, (è il secondo
complesso monastico in Europa, per grandezza dopo quello di Mafra in
Portogallo) quindi, per la sua magnificenza ed infine per la storia e i
segreti d Illustri viaggiatori del 700 restarono stupiti dai fasti del palazzo e dall’accoglienza regale loro riservata. Così scrive, ad esempio, Patrick Brydone in visita a Catania nel 1770 dopo aver visitato il monastero: “Entrato nel grande cancello la mia sorpresa si accrebbe: avevo dinanzi una facciata quasi uguale a quella di Versailles, un nobile scalone di marmo bianco e una magnifica cornice propria di una residenza regale”; i Benedettini, continua, “volevano assicurarsi a tutti i costi un paradiso almeno in questo mondo se non nell’altro”. Il palazzo, non sembrava certo un luogo di preghiera e penitenza e i monaci vivevano in uno stato di agiatezza degna delle loro famiglie di provenienza. Erano infatti, per lo più, i secondogeniti delle famiglie nobiliari catanesi. Considerato che il patrimonio familiare era indivisibile e che veniva ereditato solo dal figlio primogenito, per gli altri, la carriera ecclesiastica era la scelta più allettante perché consentiva potere e benessere senza spreco di energie. I Benedettini abitarono il monastero dal 1558 al 1866, con numerose vicissitudini, assumendo un ruolo di spicco e condizionando la vita sociale, religiosa e culturale dell’intera città e non solo. Nel 700, in particolare, il loro tenore di vita nettamente in contrasto con qualsiasi regola di obbedienza e povertà e la condotta spesso scandalosa, suscitarono risentimenti nella popolazione provata da carestie che usava addirittura, stazionare davanti al convento dopo i pranzi luculliani dei monaci per cibarsi degli avanzi.
Dal portale affacciato su Piazza
Dante, si accede ad un grande cortile esterno, ambiente di separazione
tra il mondo laico e quello religioso, e da qui, con la sua splendida
facciata barocca, il palazzo si presenta in tutta la sua magnificenza
non proprio monastica. Stalle, scuderie carretterie erano locali di
servizio utilizzati per regolari approvvigionamenti alimentari come
racconta Federico De
Roberto nel suo romanzo “I
vicerè”: “ogni giorno i cuochi ricevevano da Nicolosi quattro carichi di
carbone di quercia per tenere i fornelli sempre accesi…quattro vesciche
di strutto… e due cafisi d’olio…”.
Non è indulgente De Roberto riguardo le abitudini mangerecce e la condotta dei monaci – “I calderoni e le graticole erano tanto grandi che ci si poteva bollire tutta una coscia di vitello e arrostire un pesce spada…” “di tutta quella roba, se ne faceva poi tanta, che ne mandavano in regalo alle famiglie dei Padri e dei novizi e i camerieri, rivendendo gli avanzi, ci ripigliavano giornalmente quando 4 e quando 6 tari” “…subito dopo tavola, se ne uscivano dal convento, si sparpagliavano pel quartiere popolato di famiglie, ciascuna delle quali aveva il suo Padre protettore” e Don Blasco, Benedettino della famiglia Uzeda, “…aveva tre ganze nel quartiere di San Nicola: donna Concetta, donna Rosa e donna Lucia la sigaraia, con una mezza dozzina di figliuoli…”Il Monastero di San Nicolò L’Arena di Catania si cominciò a costruire nel 1558 nella zona detta “della Cipriana”, dove sorge attualmente, per accogliere i Monaci Benedettini che, provenienti da Nicolosi avevano deciso il trasferimento a causa del clima poco favorevole e delle incursioni da parte di briganti.
La Storia della Sicilia borbonica iniziò nel 1734, allorché Carlo di Borbone, mosse alla conquista delle Due Sicilie sottraendole alla dominazione austriaca. Tale periodo storico si concluse nel luglio 1860, quando, in seguito alla spedizione dei Mille, si ebbe il ritiro delle truppe borboniche e l'instaurazione del governo dittatoriale di Giuseppe Garibaldi, che portò alla successiva annessione dell'isola al costituendo Regno d'Italia.
Nel 1713 il trattato di Utrecht pone fine alla stagione aragonese e l'anno successivo Vittorio Amedeo II, accompagnato dalla regina Anna d'Orleans, giunge a Catania. Col trattato de l'Aja i Savoia otterranno il regno di Sardegna in cambio della Sicilia che viene assegnata a Carlo VI d'Austria. Questi regnerà fino al 1738, anno in cui il trattato di Vienna ridefinisce lo scacchiere europeo.
Nel 1734 (Re di Napoli e Sicilia dal 1734 al 1759), Carlo di Borbone, figlio di Filippo V di Spagna ed Elisabetta Farnese, conquistò le Corone di Napoli e Sicilia, restaurando a tutti gli effetti un regno unito e sovrano. Dopo due secoli di dipendenza politica, il “Reame” divenne di nuovo una nazione libera sotto la dinastia dei Borbone di Napoli e Sicilia. Successori di Carlo di Borbone furono: Ferdinando IV (1759-1825), dal 1814 Ferdinando I delle Due Sicilie; Francesco I (1825-1830), Ferdinando II (1830-1859), Francesco II, che nel 1860 perse il Regno, conquistato dal Vittorio Emanuele II di Savoia. Con tale conquista, il Regno delle Due Sicilie smette di esistere in quanto regno sovrano e indipendente. Una dominazione, quella borbonica, che durerà fino al 1848. La riforma amministrativa borbonica del 1817 istituì in Sicilia sette province sostanzialmente paritarie tra loro. La gerarchia tra le città siciliane fu ridefinita, e alterati i termini dell'antica rivalità tra Palermo e Messina. Catania si ritrovò capoluogo di un vasto territorio, sede di tribunali, dell'intendenza provinciale, di vari uffici amministrativi. La popolazione, che in quel momento era scesa a 40 mila abitanti, risalì a 52 mila nel 1834, iniziando una straordinaria galoppata secolare: 68.810 abitanti nel 1861, 90 mila nel 1880, 150 mila nel 1900, 230 mila nel 1931, fino agli attuali 363 mila. Ragione primaria di questa crescita continua, che non ha riscontri nell'Isola, è lo scambio tra la campagna (e i centri minori) e il centro urbano. Questo si pone sempre più come polo d'attrazione per i commerci, le industrie, i consumi, e infine - specialmente nel nostro secolo - per il terziario.
Nella prima metà del secolo, la principale attività industriale catanese è il settore tessile. Tessitori e artigiani - insieme ai pescatori e alla gente che vive del porto - formano il nerbo del proletariato; c'è però, accanto a questi, anche una plebe di lavoratori marginali, di diseredati, di servitori o manovali generici, caratterizzata dalla mancanza di cultura e di interessi tecnici, che si affolla nel vecchio quartiere della Civita e dell'Idria; ma meno tumultuosa e conscia della propria forza che non in città come Palermo.Sono invece gli artigiani da un lato, e dall'altro i borghesi dagli interessi prevalentemente mercantili, a dare il tono agli strati popolari. Lo si vedrà più avanti nel secolo, con la formazione delle società operaie, e poi del Fascio dei lavoratori. E' ancora l'agricoltura che forma la ricchezza di Catania, sia nel senso di famiglie provinciali agiate o nobili che si trasferiscono in città, sia per la partecipazione di cittadini ad investimenti terrieri. La città si costruisce così il ruolo di mercato, di centro di distribuzione, e di polo culturale: teatri, gabinetti di lettura, l'Università e le accademie come quella Gioenia, periodici culturali e politici, come Lo Stesicoro del 1835-36. Ma per tutto ciò essa deve ancora competere con altri centri, con Acireale in primo luogo. Prima dell'Unità, la città è pur sempre relativamente povera di alberghi, di strade lastricate, di locali pubblici.
La
significativa espansione demografica (nel 1798 essa conta già 45 mila
abitanti), la concentrazione di importanti attività economiche
soprattutto nel settore tessile (seta), e il
Dopo il 1770, tuttavia, l'attività edilizia rallenta di molto; incompiuto resta il monumentale edificio dei Benedettini. In parte ciò è dovuto al concludersi delle fabbriche intraprese; ma incidono anche la crisi agraria e le difficoltà del commercio internazionale. Il 1764 ha visto la città devastata, col resto dell'isola, da una terribile carestia. I privilegi che consentono alla nobiltà di controllare produzione ed esportazione di grano tendono a rafforzare le posizioni dell'aristocrazia, e a stabilizzare l'economia del latifondo. Questo, per Catania, significa soprattutto il maggiorato potere di chi, come i principi di Biscari, domina la Piana. Si apre, come per il resto della Sicilia, una questione feudale, che esplode per le riforme tentate sotto il viceregno di Tanucci e, dal 1781, di Caracciolo. Gli anni delle guerre napoleoniche nel Mediterraneo sono per la Sicilia gli anni della occupazione inglese e della trasformazione costituzionale con la fine giuridica del feudalesimo. La città di Catania non sembra riuscire ad agganciare la congiuntura commerciale positiva che nel suo stesso territorio permette invece all'area del vigneto, tra Mascali ed Acireale, di accumulare ingenti ricchezze trafficando i vini etnei con l'esercito britannico. Nonostante gli sforzi compiuti già da prima del terremoto non è riuscita a superare gli ostacoli tecnici per la costruzione di un porto. Nel 1798 e 1799 Catania è scossa da rivolte popolari per il pane. Si profila la crescita di uno strato popolare ribelle, anche se ciò non dà luogo ad alcun movimento rivoluzionario sul modello francese; ché anzi nel 1799, a Caltagirone, ha luogo un massacro dei giacobini, esemplare anche se di non chiara interpretazione. La cultura cittadina percepisce questo disagio e se ne fa interprete, in figure come l'irregolare poeta-filosofo Domenico Tempio o nella fitta schiera di filogiacobini cresciuti alla scuola del De Cosmi: Giovanni Nepomuceno Gambino che dovette fuggire in Svizzera dove fu vicino a Filippo Buonarroti; Francesco ed Emanuele Rossi, Vincenzo e Carlo Gagliani, Giuseppe Rizzari. Da questi gruppi escono i deputati catanesi al Parlamento siciliano, i quali, tra il 1810 e il 1815, si schierano con l'ala più radicale.
I moti del 1837 Nella prima metà dell’Ottocento, Catania fu protagonista in ciascuna delle sollevazioni contro il giovane Regno delle Due Sicilie, nato nel 1816 e sempre, forse oltre i suoi veri demeriti, inviso ai siciliani Al suo primo sovrano Ferdinando, si imputava, infatti, di aver abolito la Costituzione “inglese” del 1812 e quella spagnola del 1820. A smorzare la loro tenace animosità non valse certo l’opera del successore Ferdinando II, incoronato nel 1830 che accentrò a Napoli il governo del regno in spregio alle secolari autonomie garantite in passato all’ isola .
Per conseguenza, al giungere del colera, proveniente dal continente,
nell’estate del 1837 era radicato in ogni strato della popolazione il
convincimento che si volesse stroncare la latente ribellione della
Sicilia con una micidiale pestilenza. L’aggravarsi dell’epidemia a
Catania costrinse il 15 giugno la Giunta Sanitaria Provinciale,
convocata dall’Intendente principe Alvaro Paternò di Manganelli, a
disporre la chiusura preventiva dei pozzi di Battiati ed il Pozzo
Molino. L’ignoranza ed il pregiudizio fecero ravvisare proprio in questa
Condussero il malcontento popolare - espresso dal verso “veni lu mali veni ccu malizia Diu ppi Manu di l’omu fa giustizia” – ad esiti rivoluzionari taluni borghesi esponenti delle professioni come Salvatore Barbagallo Pittà, trentaseienne fondatore del giornale letterario “Lo Stesicoro”, Gaetano Mazzaglia, Giuseppe Caudullo Guarrera, Giacinto Gulli Pannetti, Giovanbattista Pensabene, Giuseppe Caudullo Amore, Angelo Sgroi, Sebastiano Sciuto, Al movimento aderirono alcuni rappresentanti dell’aristocrazia come l’influente marchese Antonino Paternò Castello di San Giuliano, cui venne affidata la guida della neocostituita Giunta di Pubblica Sicurezza. Il suo segretario, lo stesso Barbagallo Pittà, impose, il 29 luglio, al colonnello Santanello, comandante la guarnigione alloggiata nel Castello Ursino, di liberare i detenuti e consegnare le armi. Alle 14 ,00 del 1 agosto, il nuovo Governo Provvisorio, issando la bandiera gialla della Sicilia libera sulla Cattedrale, giurò fedeltà al grido di “Viva Sant’Agata e viva l’Indipendenza!”... L’imminente arrivo dell’alter ego Marchese Francesco Saverio Del Carretto - inviato da Ferdinando II con quattromila uomini per ristabilire l’autorità regia - pose fine a tale apparente unione d’intenti: il marchese di San Giuliano ed il principe di Reburdone volsero infatti le spalle all’esperienza rivoluzionaria facendone arrestare, la sera del 2 agosto i capi a Piazza Stesicorea. e liberando dal ‘ricovero forzato’ nella villa Carcaci, l’ Intendente , che potè accogliere Del Carretto e le sue truppe, entrate in città il 5 agosto. Grazie al tempestivo “voltafaccia” i nobili compromessi nella insurrezione, non vennero incriminati dalla Commissione Militare insediata il 20 agosto 1837. Il collegio, dopo un sommario processo svoltosi al Convitto Cutelli (ove una lapide lo rievoca), condannò alla fucilazione Salvatore Barbagallo Pittà, Gaetano Mazzaglia, Giuseppe Caudullo Guarrera, Giacinto Gulli Pennetti, Giovanbattista Pensabene, Giuseppe Caudullo Amore, Angelo Sgroi, Sebastiano Sciuto. irrogando, altresì ergastoli e pene detentive minori. Le esecuzioni avvennero tra il 9 ed il 17 settembre al Piano della Statua, poi chiamato Piazza dei Martiri. In questo luogo, centenario della rivolta, commemorato nel 1937, venne apposta una lapide per ricordarne il sacrificio. I falliti tentativi insurrezionali - facendo revocare a Ferdinando II le limitate concessioni fatte ai siciliani - ne accrescevano lo spirito di rivalsa, culminato il 12 gennaio 1848, nel moto rivoluzionario - preparato dai comitati segreti attivi a Palermo, Messina e Catania sin dall’anno precedente - che costrinse le guarnigioni e funzionari borbonici a reimbarcarsi per Napoli, riducendosi al possesso della sola cittadella di Messina.
Nel luglio del 1848, venne offerta al Duca di Genova la Corona di Sicilia, In quel grave momento politico e militare i Savoia non poterono accettarla,.lasciando i Siciliani isolati nell’affrontare il ritorno in forze dei Borboni. Il 7 settembre 1848 un corpo di spedizione, comandato del generale Antonio Filangieri, principe di Satriano ed appoggiato da una cospicua flotta, sbarcava a Messina espugnandola. Aveva così inizio la sfortunata battaglia di Sicilia che terminerà nella indomita resistenza di Catania il 6 Aprile 1849. Alcune lettere - inviate dal padre dello scrittore Giovanni Verga, fra le quali: “…Qui ieri giunse la posta di Palermo, ad un mio amico scrissero ... notizia certa, che Ferdinando ha preparato una spedizione … in quarantamila uomini, … contemporaneamente intende attaccare Palermo, a Catania, “ . La città, nei mesi successivi, fece del suo meglio per prepararsi all’inevitabile scontro, l’avventuriero polacco Mierolawski nominato Generalissimo passò in rivista alla Porta di Aci, acclamato dal popolo, le truppe del presidio. Erano, però, in tutto disponibili per la difesa 4.789 uomini con nove pezzi d’artiglieria e 150 cavalli contro 14.000 napoletani, 40 cannoni ed una squadra navale. Tale disparità fu aggravata dalle poco assennate disposizioni del Mierolawski che divise le forze. Tale linea di avvicinamento - lasciata, colpevolmente, sguarnita dal Mierolawski – permetteva ai Borbonici di impiegare, da posizione dominante, l’ottima artiglieria a loro disposizione, sorprendendo, peraltro, i difensori che si attendevano un attacco dal mare, tanti da collocare diverse batterie, poste nel forte Palermo, nel bastione di S. Agata, e nei forti di S. Salvatore, e di Messina, posti tre le scogliere dell’Armisi e le Sciare del Principe. Il 6 aprile, mentre la flotta nemica compiva un’azione diversiva dinanzi Catania, le truppe regie occupavano, dalla parte opposta, Aci S. Antonio, Mierolawski ordinò allora, alle scarse forze dislocate alla Barriera del Bosco di affrontare i napoletani. Via via i siciliani dovettero, però, retrocedere abbandonando Tremestieri, Trappeto, S. Agata Li Battiati, Barriera del Bosco. I regi giunsero, infine, alle barricate del Tondo Gioeni e le sbaragliarono. Alla loro avanzata si apriva, quindi, Via Etnea e le altre strade che – essendo larghe..dritte e tagliate ad angolo retto - mal si prestavano alla difesa, mancando opere fortificate permanenti dal lato di terra.
Dapprima, i napoletani, poco contrastati, giunsero sino alla Porta di
Aci dove incontrarono, l’imprevista ed accanita resistenza dei volontari
che, trascinati del comandante la Guardia nazionale Agatino Paternò
Castello e del Principe di Campofranco, poi caduto, li ricacciarono
oltre Piazza Borgo. Anche i battaglioni svizzeri del 3° Reggimento,
riserva impiegata dal Filangeri dovettero cedere il terreno che avevano
riconquistato ritirandosi, prima alla Porta
Alle le 6,30 dopo 9 ore di strenuo combattimento, gli insorti avrebbero potuto ottenere l’insperata vittoria con un ultimo e deciso attacco, cui i borbonici nell’oscurità, non avrebbero potuto resistere, ma il Colonnello Ascenso, forte di quattromila uomini, scorgendo gli incendi su Catania non prosegui oltre, reputando inutile farsi massacrare in una battaglia già perduta; se avesse proseguito la marcia, avrebbe incontrato un solo battaglione nemico al Tondo Gioeni, battuto il quale, avrebbe potuto sorprendere alle spalle le rimanenti truppe borboniche che avanzavano lentamente per Via Etnea, cosparsa di cadaveri e sinistramente illuminata dai roghi, bloccandole tra due fuochi. Le forze borboniche - soverchiando i siciliani ormai stremati e privi di munizioni - conquistarono l’ultima barricata dinanzi Piazza Duomo. Qui avvenne l’epilogo: un gruppetto di irriducibili - appartenenti al 5° battaglione e travestiti con uniformi borboniche - attaccò gli svizzeri all’arma bianca decimandoli prima di essere uccisi o costretti alla fuga. Ottenuta la sanguinosa vittoria, i mercenari commisero ogni eccesso: chiese e conventi furono depredati ed incendiati, stessa sorte tocco all’Archivio Notarile, al Municipio ed alla Cancelleria della Gran Corte Civile nel Palazzo Tezzano, nemmeno il Museo Biscari sfuggi al saccheggio. Lo scempio del Palazzo Universitario, in procinto anch’esso di bruciare con la sua ricchissima biblioteca, fu impedito da Andreana Sardo, nipote del Bibliotecario Generale, che, facendosi largo in mezzo alla devastazione della battaglia, implorò coraggiosamente il generale borbonico Nunziante, di risparmiare l’edificio “ornamento e splendore di Catania”, i danni recati ai volumi custoditi furono comunque ingenti giacchè i soldati borbonici se ne erano serviti per erigere barricate. Il martirio della città ebbe un riconoscimento postumo, allorchè, con Regio Decreto n° 187 del 22 maggio 1898 Re Umberto I, insigni Catania della medaglia d’oro al Valor Militare “per commemorare la azioni eroiche compiute dalla cittadinanza catanese nei gloriosi fatti del 1848”.
fu una impresa tentata da Carlo Pisacane e da un gruppo ristretto di mazziniani almeno in parte in modo autonomo dal proprio punto di riferimento. Un contributo finanziario fu offerto dal banchiere livornese Adriano Lemmi. Il piano originale, secondo il metodo insurrezionale mazziniano, prevedeva di accendere un focolaio di rivolta in Sicilia dove era molto diffuso il malcontento contro i Borbone, e da lì estenderla a tutto il Mezzogiorno d'Italia. Successivamente invece si pensò più opportuno partendo dal porto di Genova di sbarcare a Ponza per liberare alcuni prigionieri politici lì rinchiusi, per rinforzare le file della spedizione e infine dirigersi a Sapri, che posta al confine tra Campania e Basilicata, era ritenuta un punto strategico ideale per attendere dei rinforzi e marciare su Napoli. Il 4 giugno 1857 Pisacane si riunì con gli alti capi della guerriglia per stabilire tutti i particolari dell'impresa. Un primo tentativo fallito si ebbe il 6 giugno: l'avanguardia di Rosolino Pilo perse il carico di armi destinato all'impresa in una tempesta. Con l'intento di raccogliere armi e consensi Pisacane si recò a Napoli, travestito da prete. L'esito fu molto deludente ma Pisacane non si lasciò scoraggiare persistendo nei suoi intenti.
Il 25 giugno 1857 a Genova Pisacane s'imbarcò con altri ventiquattro sovversivi, tra cui Giovanni Nicotera e Giovan Battista Falcone, sul piroscafo di linea Cagliari, della Società Rubattino, diretto a Tunisi. Pilo si occupò nuovamente del trasporto delle armi, e partì il giorno dopo su alcuni pescherecci. Ma anche questa volta Pilo fallì nel compito assegnatogli e lasciò Pisacane senza le armi e i rinforzi che gli erano necessari. Pisacane continuò senza cambiare piani, impadronitosi della nave durante la notte, con la complicità dei due macchinisti inglesi, si dovette accontentare delle poche armi che erano imbarcate sul Cagliari. Il 26 giugno sbarcò a Ponza dove, sventolando il tricolore, riuscì agevolmente a liberare 323 detenuti, poche decine dei quali per reati politici per il resto delinquenti comuni, aggregandoli quasi tutti alla spedizione. Il 28, il Cagliari ripartì carico di detenuti comuni e delle armi sottratte al presidio borbonico. La sera i congiurati sbarcarono a Sapri, ma non trovarono ad attenderli quelle masse rivoltose che si attendevano. Anzi furono affrontati dalle falci dei contadini ai quali le autorità borboniche avevano per tempo annunziato lo sbarco di una banda di ergostolani evasi dall'isola di Ponza. Il 1º luglio, a Padula vennero circondati e 25 di loro furono massacrati dai contadini. Gli altri, per un totale di 150, vennero catturati e consegnati ai gendarmi. Pisacane, con Nicotera, Falcone e gli ultimi superstiti, riuscirono a fuggire a Sanza dove furono ancora aggrediti dalla popolazione. Perirono in 83. Pisacane e Falcone si suicidarono con le loro pistole, mentre quelli scampati all'ira popolare furono poi processati nel gennaio del 1858. Condannati a morte, furono graziati dal Re, che tramutò la pena in ergastolo. I due inglesi, per intervento del loro governo, furono dichiarati fuori causa per "infermità mentale". Nicotera, gravemente ferito, fu portato in catene a Salerno dove venne processato e condannato a morte. Anche per lui la pena fu tramutata in ergastolo solo per l'intervento del governo inglese che guardava con crescente preoccupazione la furia repressiva di Ferdinando II. http://it.wikipedia.org/wiki/Spedizione_di_Sapri
Nella città di Catania rifioriscono i negozi, i mercati, l'industria, il commercio locale e internazionale. Terminato il molo di Catania, adottato il gas per l'illuminazione, si discute sulla necessità di realizzare opere di grande importanza per la città come il Camposanto, la villa pubblica, la Marina, la Pescheria, le piazze di Mercato. Dal 1856 inizia un periodo molto importante per l'evoluzione della città, si sistemano le aree urbane e le strade: è completata la Passeggiata della Marina, innalzando la quota della sede viaria. Nel XIX secolo, si diffonde in tutta Europa il mercato coperto: a Catania si sente la necessità di trovare una sede chiusa alla Pescheria. Francesco Moncada Paterno Castello, nel Progetto del Patrizio di Catania per la pronta costruzione di varie opere comunali al Decurionato di essa città del 1856, manifesta la necessità di sistemare il sito della Pescheria, che si trovava in un locale contiguo al Duomo. Propone di togliere le mura (forte S. Agata) e le case di mezzo, per prolungare la strada che sbocca alla porta dei Canali - tra la casa Pardo/Alessi (via Pardo), quella di Ninfo (cortile Ninfo-via Gisira) ed Arcidiacono - sino al largo della Marina. Si poteva in questo modo mettere in comunicazione diretta la strada Ferdinandea (attuale via Giuseppe Garibaldi) con la Marina (attuale via Cardinale Dusmet). Il Progetto per la ricostruzione della strada Etnea di Catania del 15 maggio 1857, approvato il 24ottobre 1857, prevedeva la pavimentazione e la formazione dei canali di scolo della via in questione (via Etnea). Si effettua un mercato a piazza S. Filippo (attuale piazza Mazzini) e un altro ogni lunedì nella piazza Stesicorea (piazza Stesicoro). Nella seconda metà del XIX secolo, la rinascita del commercio a Catania è parallela alla necessità di avviare opere pubbliche. Nel 1856 il Consiglio Edilizio stabilisce che si realizzeranno a Catania sei mercati pubblici: Oggi Catania ti sembra d'altro aspetto, e nelle strade principali non trovi più quegli oggetti grasci esposti a vendita che ti mettono a schifo. É un passo dappiù alla civiltà. Un mercato pubblico per ognuna delle sei sezioni, in che è divisa la città, è stato stabilito, ed al cominciar dal 1856 il bel pensiero si è posto in attuazione. Intanto si mondano taluni punti magnifici dell'interno, e le pubbliche piazze appaiono nella loro nudità; e la di S. Filippo riprende quella imponenza che tanto si fece ammirare da Mr. Durand da distinguerla fra le più belle. - Giornale di Catania 1856 - Sig. Guerino Menneville
Irene Leonardi - da DOCUMENTI E IMMAGINI DELLA PESCHERIA DI CATANIA - di N.F. Neri e M.L. Giangrande Soprintendenza beni culturali e ambientali di Catania - Regione Siciliana - Assessorato Beni culturali - 2012
La rivoluzione del 1860 Nel 1859, i provvedimenti di clemenza adottati da Francesco II, ultimo Re delle Due Sicilie, per la sua incoronazione non poterono estinguere il sentimento antiborbonico nutrito della maggior parte dei catanesi, memori di quanto accaduto nel 1837 e nel 1849. Per l’occasione circolò, anzi, questa strofetta motteggiatoria:“Cicciu nasciu, so matri moriu! , Cicciu si maritau so patri cripau, Ora è Re, viriti cchi ccè” . Il prof Francesco De Felice, nei suoi ricordi autobiografici racconta: ”… la gioventù catanese, come quella delle altre città siciliane, veniva quasi dispersa, parte emigrando, parte confinata … I pochissimi rimasti in città non erano affatto sicuri …nessuna notte dormimmo sonni tranquilli, senza che un rumore qualunque dal di fuori, il passo misurato di una pattuglia non ci avesse fatto sospettare un arresto…” Il 30 marzo 1860, durante la rappresentazione dell’Ernani al teatro Comunale, piovvero in platea nastrini tricolore al grido di Viva Verdi (acronimo di Vittorio Emanuele Re D’Italia). I popolani - in fermento per i moti palermitani scoppiati il 4 Aprile e poi falliti - cantavano: “all’erta tutti ppi lu quattru aprili. Sangu ppi sangu nni l’avemu a fari! Sta setta impia l’avemu a finire La Sicilia l’avemu a libbirari”. Ormai gli avvenimenti incalzavano, il 10 Maggio i vapori Piemonte e Lombardo sbarcavano un migliaio di volontari a Marsala senza che le navi borboniche lo impedissero efficacemente, anche per la presenza delle navi inglesi Argus ed Intrepid Da Marsala, Garibaldi chiamò i Siciliani all’insurrezione con un celebre proclama: “All’armi dunque! Chi non impugna un’arma è un codardo o un traditore della patria … un’arma qualunque ci basta. ..
La Sicilia insegnerà ancora una volta come si libera un paese dagli oppressori,con la potente volontà di un popolo unito”. Il giorno dopo lo sbarco si unirono ai Mille le squadre capeggiate dai fratelli Santanna da Alcamo e quella di Monte san Giuliano, il contingente si mise in marcia, quindi alla volta di Palermo.
La notizia della vittoria garibaldina a Calatafimi, avutasi il 17
maggio, provocò tumulti a Misterbianco, Motta, Paternò, Belpasso,
Adrano, Mineo, Regalbuto, Leonforte, Agira, Gli armati, concentratisi in
Mascalucia il 24 maggio, erano comandati dal colonnello Giuseppe Poulet,
disertore dell’esercito regio e ministro della Guerra nel governo
Provvisorio
Non il coraggio difettava, infatti, agli insorti, ma le armi, ridotte a pochi fucili a pietra focaia e due cannoncini. Ai due emissari di Poulet: Antonio Caudullo e Agostino Di Stefano, Garibaldi in persona, accampato il 26 maggio sulle colline di Marineo, ordinò: ”si faccia una forte dimostrazione, anche se sia un fatto d’armi e qualunque sia l’esito prevedibile. Io marcio sopra Palermo”. La prova di forza avvenne il 31 maggio 1860, quando 500 uomini penetrarono in città sino alla porta di Aci.. Clary diede disposizione ai mortai - che erano postati sui torrioni del Castello Ursino - di bombardare la città, affiancando una nave da guerra in rada. Nonostante la enorme disparità di forze ed armamenti i patrioti impegnarono le truppe nemiche per l’intera giornata, tra le loro file c’era anche una popolana di nome Giuseppina Bolognani, nata a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1841 e passata alla storia, grazie ai suoi atti di eroismo, con l’epiteto di “Peppa a cannunera”. Dapprima, ella esplose un preciso colpo di un cannone collocato nell’atrio di palazzo Tornabene a Piazza Ogninella, contro le barricate dei borbonici che, disorientati, abbandonarono la posizione ed un pezzo d’artiglieria, prontamente catturato dall’intrepida popolana, tirandolo a se con un cappio Poco dopo - mentre trasportava il cannone conquistato per appostarlo sul terrazzo di Palazzo Biscari, e tirare contro la nave da guerra - Peppa, fu colta da una squadra di cavalleggeri che intendevano caricare gli insorti lungo la via Del Corso (oggi Vittorio.Emanuele). Costoro, vedendo la bocca da fuoco, si misero al riparo mentre la giovane, sparsa della polvere sulla volata, attese a piè fermo la carica ed incendio la polvere. I cavalieri, credendo che il colpo avesse fatto cilecca, si slanciarono al galoppo; la donna fece, questa volta, realmente fuoco falciando gli attaccanti. Tale sagacia e sprezzo del pericolo, fruttarono, in seguito, alla donna, che morirà sessantenne a Messina nel 1900, la medaglia d’argento al valor militare ed una gratifica di 261 ducati. Le sue imprese ispirarono al pittore Zafferanese Giuseppe Sciuti un celebre dipinto che, collocato tra i cimeli appartenenti al museo cittadino del Risorgimento, andò perduto nell’incendio del Municipio, avvenuto il 14 Dicembre 1944.. Grazie al valore dimostrato, la battaglia sembrava volgere in favore degli insorti ed il Poulet, avanzando al centro di piazza Duomo gridò ai Borbonici ”arrendetevi! siamo fratelli” ma da una finestra del palazzo universitario partì un colpo che lo ferì alla coscia destra segnando la rivincita delle truppe di Clary in una battaglia manifestamente impari che pur era costata loro 180 morti. Poulet diede, infatti, ordine alle sue truppe di ripiegare a Mascalucia. La memoria di questa eroica giornata è scolpita entro una lapide collocata, nel prospetto nord del palazzo degli Elefanti: L’effimera vittoria del 31 Maggio, per cui i Borbonici avevano persino coniato una medaglia commemorativa, non dette loro alcun vantaggio. Il 3 giugno, infatti, Clary dovette lasciare Catania con le sue truppe alla volta di Messina ricevendone l’ordine dalla corte di Napoli che preferiva abbandonare la Sicilia pur di impedire lo sbarco di Garibaldi nel continente.
Il 4 giugno a Catania s’inalberava il tricolore e, mentre la Guardia Nazionale ripristinava l’ordine pubblico, veniva creato un governo provvisorio che aderì alla dittatura di Garibaldi con la formula “Italia e Vittorio Emanuele”, Giorno 13, Francesco Pucci divenne il primo Patrizio nella Catania post-borbonica. Il Barone di S. Giuliano, nato a Palermo, si era distinto difendendo la città nel 1849 ed aveva segretamente incontrato Francesco Crispi, egli morì a Catania nella sua casa posta in Via Caronda il 6 maggio 1880.. I garibaldini, comandati da Nino Bixio e Menotti Garibaldi, entrarono in città il 4 agosto 1860, preceduti dall’avanguardia di Stefano Turr.. Con grande disappunto dei Catanesi, Garibaldi, in quei giorni, incalzato dagli avvenimenti. non potè visitare la città. Dal 14 Maggio. per evitare che l'isola cadesse nell' anarchia. e rassicurare i ceti dirigenti, lo stesso Garibaldi, aveva dichiarò la dittatura in nome di Vittorio Emanuele, nel famoso Decreto di Salemi, Venne creata, inoltre, una Milizia Nazionale, composta dagli abili dai 17 ai 50 anni. ed un battaglione degli adolescenti, che avrebbe raccolto i ragazzi poveri e abbandonati, per istruirli militarmente, alla direzione di Alberto Mario, un Consiglio di guerra avrebbe giudicare i reati di militari e civili, il furto, l’omicidio ed il saccheggio erano puniti con la pena di morte Ma ben presto le speranze degli umili in un radicale mutamento della loro condizione furono deluse: l’istituto della leva obbligatoria., che sottraeva braccia al lavoro dei campi, e la sostanziale disapplicazione del decreto di redistribuzione delle terre scatenarono l'agitazione popolare con tumulti in diversi centri rurali. Il più famoso tra essi resta quella di Bronte, teatro, ai primi di agosto del 1860, di una cruenta sommossa dei coltivatori contro i grandi proprietari terrieri repressa duramente dal luogotenente di Garibaldi Nino Bixio con lo stato d’assedio, dichiarato il 6 agosto “per delitto di lesa umanità” seguito da numerose fucilazioni, questi fatti ispireranno a Giovanni Verga la novella “Libertà”. Nel 1862, Garibaldi ritornò in Sicilia insieme a Nicola Fabrizi, Giuseppe Cadolini e Salvatore Calvino, che, a Regalbuto, cercarono di dissuaderlo dall'intraprendere la spedizione verso Roma. In quella occasione Garibaldi, venne a Catania riscattando i cittadini della cocente delusione patita due anni prima. La città divenne base di operazioni e l’eroe dei due mondi arringò la cittadinanza al grido di “Roma o Morte” dai balconi del Palazzo dei quattro Canti, all’incrocio tra le Vie Etnea e Di Sangiuliano, sede del Circolo degli Operai, nella notte del 18 agosto 1862. L’evento venne ricordato dalla lapide apposta sulla facciata del fabbricato nel 1883, primo anniversario della morte dell’Eroe. L’entusiastica adesione della città alla spedizione fu apprezzata inequivocabilmente, dallo stesso Garibaldi che anni dopo a Caprera scriveva: “a Catania trovammo vulcano di patriottismo, denaro , vesti e vettovaglie per la nuda mia gente” questa frase oggi si può leggere sul piedistallo del monumento a Garibaldi, inaugurato nel 1921 e posto alla confluenza tra le vie Etnea e Caronda
L'esercito meridionale. La campagna garibaldina del 1860 in Sicilia non è la spedizione dei Mille. I partecipanti alla campagna garibaldina del 1860 in Sicilia non sono solo i Mille.
Le operazioni di organizzazione,
raccolta fondi e arruolamento nell'Italia settentrionale
proseguirono dopo la partenza dei volontari da Quarto e il governo
sardo, presa di Palermo, si fece sempre meno scrupoli nel supportare
le manovre militari per rimpolpare il contingente volontario. La
dicevano lunga sul ruolo del regno sabaudo le divise turchine dei
sottoufficiali sardi che sbarcavano sull'isola, uomini congedati o
disertori, talvolta persino accompagnati dal rullo dei tamburi
reggimentali. Così Cesare Abba descrisse l'ingresso a Palermo della brigata di Giacomo Medici: «Medici è arrivato con un reggimento fatto e vestito. Entrò da Porta Nuova sotto una pioggia di fiori. Quaranta ufficiali, coll'uniforme dell'esercito piemontese, formavano la vanguardia» (clicca qui per leggere La memoria dei garibaldini). Era sbarcato in Sicilia alla guida di una spedizione di due navi, 2550 uomini, dopo che a Cagliari si era unito al gruppo di 1200 toscani, saliti a bordo a Livorno e guidati da Vincenzo Malenchini e da Tito Zucconi. Diverse imbarcazioni cariche di rinforzi si avvicendarono nei porti siciliani nell'estate 1860. Nell'entusiasmo generale erano sorti vari comitati di provvedimento per i soccorsi alla Sicilia, che avevano come coordinatore a Genova Agostino Bertani e in pochi mesi riuscirono a raccogliere 6.200.000 lire. La gestione delle risorse venne affidata all'Intendenza militare garibaldina, in particolare al colonnello Ippolito Nievo, che gestì l'incarico con tanta cura, da risultare inviso a quanti avrebbero voluto approfittare dell'eccezionalità del momento per trarre vantaggi economici personali. I Mille divennero presto 20.000. Il Generale pensava che avrebbero potuto essere molti di più, 250.000, e che presto avrebbero potuto formare un esercito meridionale per il proseguimento della spedizione nel continente, strutturato come un esercito regolare.
Ma la razionalizzazione
dell'apparato militare passò per una pedissequa riproposizione del
modello piemontese, che risultò piuttosto farraginosa. La Segreteria
di Stato della Guerra venne affiancata da uno Stato maggiore
generale dell'Esercito e da Ispezioni generali divise per arma:
artiglieria, cavalleria (sebbene di fatto inesistente nell'esercito
volontario), fanteria. Il 2 luglio, con il decreto n. 79, l'Esercito siciliano venne ordinato in divisioni, ognuna delle quali suddivisa in due o tre brigate, a loro volta frazionate in quattro o otto battaglioni. Ogni unità aveva vertici e stati maggiori e una mole consistente di ufficiali e superiori: Stefano Türr fu destinato al comando della 15ª divisione, strutturata in una 1ª brigata, condotta da Nino Bixio e in una 2ª guidata dal colonello Herbert, mentre la 16ª divisione, al cui interno confluivano la 3ª brigata di Enrico Cosenz, la 4ª del colonnello Poulet e la 5ª di Giacomo Medici, fu affidata a Giuseppe Paternò. Spesso si creavano conflitti tra i diversi livelli in cui era articolato il potere militare: gli alti ufficiali finivano con l'ignorare l'Ispezione generale e persino lo Stato maggiore dell'Esercito entrava in conflitto con il Ministero della Guerra. Il caos non aveva ricadute solo sugli ingranaggi della macchina bellica garibaldina, ma complicò la stessa amministrazione finanziaria della dittatura ed in particolare mise in seria difficoltà Ippolito Nievo, vice-intendente generale di Sicilia, che dalla gestione dei registri della spedizione ebbe solo grattacapi ed «incertezze», come scrisse nel novembre 1860 all'amata Bice Melzi, rassicurandola però con una curiosa e tragicamente cieca metafora marina: «È un buon tratto da percorrere ancora; ma non burrascoso, né perfido, soltanto noios fine del colonnello in un misterioso naufragio (ironia della sorte!) parve legata alla necessità di occultare i documenti contabili in suo possesso. Secondo il discendente, Stanislao Nievo, il nuovo Regno pur di smantellare il virtuoso esercito garibaldino, volle occultare l'impeccabile gestione finanziaria, opera dell'antenato, macchiandosi di quello che non fu un casuale affondamento, ma un vero e proprio delitto di Stato. All'opposto c'è chi pensa che, se davvero di sabotaggio si trattò, lo scopo era quello di celare le gravi malversazioni compiute dall'esercito e coperte degli stessi ministri del governo prodittatoriale, Giuseppe Paternò di Spedalotto e Nicola Fabrizi. A settembre il Commissario di Guerra Nicolò Agata denunciava infatti gli abusi commessi dai militari a partire dalla vendita degli abiti e degli oggetti forniti dalla pubblica amministrazione, eclatante fu il caso della vendita dei 60000 inutili cappotti comprati a peso d'oro, e ad ottobre una circolare dello stesso Ministero constatava «la sproporzione massima degli uffiziali alla forza dell'esercito». Non solo gli ufficiali erano più di 6000, ma si continuavano a pagare soldati assenti o morti, si acquistavano beni non necessari per favorire alcuni fornitori, si elargivano promozioni sul campo con un'estrema facilità e, come sottolineò il colonnello ungherese Kupa, si prendevano «razioni per il triplo degli uomini che avevano a mantenere, cioè 70.000 od 80.000 razioni quando tutta l'armata non ascendeva a più di 25.000». I grandiosi progetti del generale Garibaldi per l'ingrandimento dell'esercito siciliano non avevano avuto infatti alcun seguito. La cifra di 50.000 volontari al momento della smobilitazione del corpo il 6 novembre 1860 è infatti giustificabile solo se si annoverano nel conto dei militi i picciotti delle squadre irregolari. Vani erano stati gli sforzi del Generale di coinvolgere i siciliani facendo leva sul loro orgoglio con colti riferimenti alla vicenda dei Vespri: «Io e i miei compagni siamo festanti di poter combattere, accanto ai figli del Vespro, una battaglia che deve infrangere l'ultimo anello di catene con cui fu avvinta questa terra del genio e dello eroismo!». Né migliori risultati ebbe il decreto sulla leva obbligatoria col quale si sperava di porre un'alternativa oltre che un freno proprio a quelle bande di irregolari che non facevano che compromettere l'ordine pubblico isolano. In realtà l'assenza di vincoli disciplinari formali era un problema che non riguardava soltanto le squadre di campieri e picciotti. La «non organizzabilità» dell'entusiasmo dei volontari, che era stata un vanto per Nicola Fabrizi, rappresentò una trappola mortale per l'esercito meridionale. Ne era convinto l'autore sconosciuto della lettera che il modenese ricevette nel febbraio 1861: «Non siamo organizzati né organizzabili tu dicevi. E dove mai e più lucida verità di questa? Nel leggerla, Nicola carissimo, mi sentivo proprio venire meno la fede, e mi fosse davvero mancata, se subito davanti agli occhi mi si fosse parata gigante la tua infinità». Per dirla con Eva Cecchinato e Mario Isnenghi: «In ogni volontario si esprime una soggettività politica e già per questo si nasconde un potenziale obiettore». Quella che per molto tempo aveva suonato alle orecchie dei volontari come una rivendicazione di orgogliosa autonomia, di fiera autosufficienza, divenne un cappio soffocante nel confronto con le istituzioni dello Stato nascente: l'imprevedibilità dell'entusiasmo di una nazione armata. Ecco perché all'indomani del plebiscito un decreto del governo dittatoriale dell'11 novembre 1860 ne intimava lo scioglimento, nella nebulosa prospettiva di ricostituirlo su più solide basi e nominava anche i membri di una Commissione di scrutinio, che avrebbe dovuto valutare i titoli degli ufficiali garibaldini e decidere del loro futuro. Secondo lo storico militare John Gooch 5000 ufficiali circa vennero inseriti nell'esercito italiano entro il marzo 1862. https://pti.regione.sicilia.it/
I fatti di Bronte
Il Comune di Bronte ed i suoi abitanti, legati da sempre al lavoro della
terra, hanno vissuto per secoli all'ombra di una strana, fraudolenta
usurpazione del loro territorio: trasferito nel 1494, con bolla
pontificia, a favore dell'Ospedale Maggior di Palermo e nel 1799, con
spregiudicata donazione borbonica, a favore di Nelson. Un’incredibile causa legale volta a riavere il territorio, durata senza interruzione di fronte ai tribunali per oltre quattro secoli, era stata vana ed inutile: i contendenti (l’Ospedale, i Nelson ed il comune) agivano su piani diversi di possibilità di manovra e la comunità di Bronte priva di sostegni e protezioni risultava sempre perdente. In questo perenne stato di vassallaggio e di gravi crisi, era cresciuto nel corso degli anni, alimentato in tutti, di generazione in generazione un acuto desiderio di rivincita e di speranza di poter assistere tutti, prima o dopo, al rientro dei beni perduti. Il malcontento popolare, per nulla latente, ebbe le prime manifestazioni con i moti rivoluzionari del 1820 e del 1848, ma raggiunse il culmine dell'esasperazione con la rivolta del 1860 (meglio nota come "i fatti di Bronte"). La rivolta faceva seguito ai decreti emanati da Garibaldi che prometteva lo smantellamento dei latifondi e la spartizione delle terre. Anche perché qualche mese prima, subito dopo lo sbarco, lo stesso il Dittatore aveva annullato un'altra donazione borbonica restituendo agli antichi legittimi proprietari siciliani il feudo di "Bisaquino", sito nella zona di Palermo, anche questo regalato dal re di Napoli ad un suo favorito (il famigerato ministro di polizia Maniscalco).
Lamento di un popolano al Cristo crocifisso (Lionardo Vigo) Un servu, tempu fa di chista chiazza, ccussì priava a Cristu e cci dicia: "Signuri! U me patruni mi strapazza! Mi tratta commu ‘n cani ‘nta la via; tuttu si pigghia ccu la so manazza macari a vita e dici chi nun è a mia. Si ppò mi lagnu cchiù peggiu mi minazza, a bbastunati mi lliscia u pilu e m’impriggiunia. Quindi, ti pregu, chista mala razza, distruggila tu, Cristu, ppi mia! (una tantum), Risposta del Cristo: "E ttu, forsi, hai ciunchi li brazza? Oppuri l’hai ‘nchiuvati commu a mia? Cu voli a giustizzia si la fazza Né speri c’autru la faria ppi tia. Si ttu si omu e nun si na testa pazza, metti a fruttu sta sintenza mia: iu nun saria supra ‘sta cruciazza, S’avissi fattu quantu dissi a ttia".
(Leonardo Sciascia) La fame di terra, di queste sciare aride e nere che con indicibile pazienza e travaglio l'uomo sa mutare in giardini, qui ha generato sanguinose rivolte contadine: come quella che nell'agosto del 1860 ciecamente fu repressa da Nino Bixio a Biancavilla, Randazzo, Cesarò, Maletto, Bronte; e a Bronte con particolare rigore, poiché della fame dei contadini era oggetto anche il feudo che il re Borbone aveva donato nel 1799 all'ammiraglio Nelson, la famosa ducea di Bronte che solo ora è stata, come si dice con termine legale, "scorporata" dall'antica usurpazione (prima che dal re Borbone era stata usurpata nel 1491, dal Papa; e per secoli i cittadini di Bronte hanno lottato per i diritti del Comune sul feudo, giudiziariamente e con tragiche rivolte). A Bronte la parola "comunisti" suona da secoli ad indicare il partito, la fazione popolare, che invocava e perseguiva il ritorno al Comune delle terre usurpate e la divisione di esse; in contrapposizione al partito "ducale", in cui la classe degli abbienti, sostenendo la grande usurpazione, rappresentata dalla ducea, faceva schermo alle piccole usurpazioni proprie. E' una storia municipale quanto mai interessante: e per i fatti dell'agosto 1860 attinge a caso di coscienza dello Stato italiano, della nazione; dice quel che il Risorgimento non è stato, idea non realizzata; speranza dolorosamente delusa; e ancora ne portiamo pena e remora. Le sciare "scorporate" dalla ducea (restano al duro erede di Nelson ancora qualche centinaio di ettari) ora sono abbandonate come dovunque in Sicilia sono abbandonate le terre. Allo stesso contadino di Bronte che in paese torna dal nord d'Italia, dalla Germania, dal Belgio per trascorrervi le ferie, sembrerà inverosimile e assurdo che gente della sua condizione, se non addirittura del suo sangue, abbia ucciso e si sia fatta uccidere per un pezzo di sciara.
"Vogliamo le sciarelle", il grido dall'affocata rivolta, è lontano e irreale, quasi ridicolo, il feudo è come un deserto paesaggio lunare, Ma è sorprendente trovarsi d'improvviso, nel cuore di esso, di fronte al castello di Maniace circondato da alberi alti, circonfuso da un suono d'acqua. E gli alberi e l'acqua sembrano evocare nebbia: e si ha l'illusione di stare dentro un pezzo di campagna inglese. Ché dovunque l'uomo porta l'immagine della propria patria: e gli amministratori inglesi della ducea, forse anche senza averne coscienza, qui hanno ricreato gli elementi della loro terra lontana. E ad entrare nel castello, che è poi l'antica abbazia di Santa Maria di Maniace, la suggestione si fa più profonda: nel cortile è una croce di pietra lavica, ma di forma da noi inconsueta, borchiata, in memoria di Nelson; nella chiesa sono sepolti gli amministratori inglesi del feudo e i loro familiari; e chi sappia qualcosa dei fatti del 1860 è colpito dal nome Thovez, ché Guglielmo e Franco Thovez erano allora gli amministratori. E si può dire che come essi, e i loro predecessori e successori nell'amministrazione del feudo, sono riusciti a ricreare un paesaggio inglese intorno al castello, la realtà siciliana è riuscita a fare di loro dei siciliani della peggiore estrazione: gretti, furbi, tortuosi, abilissimi nel gioco delle parti. Qui, dove il greco Giorgio Maniace sconfisse nel 1040 i saraceni, nel feudo chiamato appunto della Saracina, la gloria di Orazio Nelson e di Nino Bixio scende nel sangue e nell'ingiustizia: Nelson ha accettato questa terra come compenso di un tradimento e di un massacro, Bixio si è fatto apostolo del terrore invece che della giustizia. (Tratto da Opere 1971-1983, a cura di Claude Ambrosie, Classici Bompiani)
Il Garibaldi era di corporatura bassa, alto 1,65, ed aveva le gambe arcuate. Era pieno di reumatismi e per salire a cavallo occorreva che due persone lo sollevassero. Portava i capelli lunghi perché, avendo violentato una ragazza, questa gli aveva staccato un orecchio con un morso. Era un avventuriero che nel 1835 si era rifugiato in Brasile, dove all’epoca emigravano i piemontesi che in patria non avevano di che vivere. Fra i 28 e i 40 anni visse come un corsaro assaltando navi spagnole nel mare del Rio Grande do Sul al servizio degli inglesi che miravano ad accaparrarsi il commercio in quelle aree. In Sud America non è mai stato considerato un eroe, ma un delinquente della peggior specie. Per la spedizione dei mille fu finanziato dagli Inglesi con denaro rapinato ai turchi, equivalente oggi a molti milioni di dollari. In una lettera, Vittorio Emanuele II ebbe a lamentarsi con Cavour circa le ruberie del nizzardo, proprio dopo "l’incontro di Teano": "... come avrete visto, ho liquidato rapidamente la sgradevolissima faccenda Garibaldi, sebbene - siatene certo - questo personaggio non è affatto docile né cosí onesto come lo si dipinge e come voi stesso ritenete. Il suo talento militare è molto modesto, come prova l’affare di Capua, e il male immenso che è stato commesso qui, ad esempio l’infame furto di tutto il danaro dell’erario, è da attribuirsi interamente a lui che s’è circondato di canaglie, ne ha eseguito i cattivi consigli e ha piombato questo infelice paese in una situazione spaventosa".
CALATAFIMI: contrariamente a quanto viene detto nei libri di storia, il Garibaldi fu messo in fuga il giorno 15 maggio dal maggiore Sforza, comandante dell’8° cacciatori, con sole quattro compagnie. Mentre inseguiva le orde del Garibaldi, lo Sforza ricevette dal generale Landi l’ordine incomprensibile di ritirarsi. Il comportamento del Landi risultò comprensibilissimo quando si scoprí che aveva ricevuto dagli emissari garibaldini una fede di credito di quattordicimila ducati come prezzo del suo tradimento. Landi qualche mese piú tardi morí di un colpo apoplettico quando si accorse che la fede di credito era falsa: aveva infatti un valore di soli 14 ducati.
PALERMO: il Garibaldi, il 27 maggio, si rifugiò in Palermo praticamente indisturbato dai 16.000 soldati duosiciliani che il generale Lanza aveva dato ordine di tenere chiusi nelle fortezze. Il filibustiere cosí poté saccheggiare al Banco delle Due Sicilie cinque milioni di ducati ed installarsi nel palazzo Pretorio, designandolo a suo quartier generale. In Palermo i garibaldini si abbandonarono a violenze e saccheggi di ogni genere. A tarda sera del 28 arrivarono, però, le fedeli truppe duosiciliane comandate dal generale svizzero Von Meckel. Queste truppe, che erano quelle trattenute dal generale Landi, dopo essersi organizzate, all’alba del 30 attaccarono i garibaldini, sfondando con i cannoni Porta di Termini ed eliminando via via tutte le barricate che incontravano. L’irruenza del comandante svizzero fu tale che arrivò rapidamente alla piazza della Fieravecchia. Nel mentre si accingeva ad assaltare anche il quartiere S. Anna, vicino al palazzo di Garibaldi, che praticamente non aveva piú vie di scampo, arrivarono i capitani di Stato Maggiore Michele Bellucci e Domenico Nicoletti con l’ordine del Lanza di sospendere i combattimenti perché ... era stato fatto un armistizio, che in realtà non era mai stato chiesto. L’8 giugno tutte le truppe duosiciliane, composte da oltre 24.000 uomini, lasciarono Palermo per imbarcarsi, tra lo stupore e la paura della popolazione che non riusciva a capire come un esercito cosí numeroso si fosse potuto arrendere senza quasi neanche avere combattuto. La rabbia dei soldati la interpretò un caporale dell’8° di linea che, al passaggio del Lanza a cavallo, uscí dalle file e gli gridò "Eccellé, o’ vvi quante simme. E ce n’aimma’í accussí ?". Ed il Lanza gli rispose : "Va via, ubriaco". Lanza, appena giunse a Napoli, fu confinato ad Ischia per essere processato. I garibaldini nella loro avanzata in Sicilia compirono efferati delitti. Esemplare e notissimo è quello di Bronte, dove "l’eroe" Nino Bixio fece fucilare quasi un centinaio di contadini che, proprio in nome del Garibaldi, avevano osato occupare alcune terre di proprietà inglese.
MILAZZO: Il giorno 20 luglio vi fu una cruenta battaglia a Milazzo, dove 2000 dei nostri valorosissimi soldati, condotti dal colonnello Bosco, sgominarono circa 10.000 garibaldini. Lo stesso Garibaldi accerchiato dagli ussari duosiciliani rischiò di morire. La battaglia terminò per il mancato invio dei rinforzi da parte del generale Clary e i nostri furono costretti a ritirarsi nel forte per il numero preponderante degli assalitori. Nello scontro i soldati duosiciliani, ebbero solo 120 caduti, mentre i garibaldini ne ebbero 780. Eroici, e da ricordare, furono i valorosi comportamenti del Tenente di artiglieria Gabriele, del Tenente dei cacciatori a cavallo Faraone e del Capitano Giuliano, che morí durante un assalto.
SMONTATA LA FAVOLA DEI MILLE Il tempo è un galantuomo e la Storia, alla fine, viene sempre fuori. Carlo III d'Inghilterra ha ammesso una verità incontrovertibile che veniva rigettata solo dai Risorgimentalisti italiani. Quelli che sbeffeggiano i meridionalisti accusandoli di raccontare frottole. Ebbene, Garibaldi non era solo ed i mille non erano affatto mille. Il Regno delle due Sicilie fu invaso dai Piemontesi. Ecco quanto detto dal sovrano inglese davanti al Parlamento italiano: "Due le navi inglesi che vegliavano durante lo sbarco a Marsala". Pronte, cioè, a intervenire. Ricordiamo che insieme agli inglesi c'erano anche i francesi. Entrambe le nazioni avevano interessi affinché i Borbone fossero spazzati via, principalmente per avere il predominio del Mediterraneo vista l'imminente apertura del Canale di Suez. Bisognava dunque creare uno stato vassallo e affidarlo a chi poteva essere facilmente controllato, ossia i Savoia pieni di debiti. Carlo ha continuato: "Molti degli eroi del Risorgimento, tra cui Cavour e Mazzini, trascorsero del tempo nel Regno Unito". Lì furono formati, indottrinati e incatenati al volere inglese. Infine: "Quando Garibaldi visitò Londra nel 1864 per ringraziare il popolo britannico del sostegno ricevuto scoppiò una vera e propria Garibaldimania, con mezzo milione di persone che accorsero a salutarlo fino alla creazione di un biscotto-omaggio ancora diffusissimo". Garibaldi e l'Italia, quindi, fedeli e riconoscenti a tal punto da recarsi a Londra per ringraziare l'Inghilterra. Fu così che - come ebbe a scrivere Dostoevskij - nacque "un piccolo regno di second’ordine soddisfatto della sua unità, che non significa letteralmente nulla. Un’unità meccanica e non spirituale e per di più pieno di debiti non pagati e soprattutto soddisfatto del suo essere un regno di second’ordine". Carlo III d’Inghilterra – aprile 2025
Camilleri, Pirandello e Verga e il marciume dell’Unità d’Italia Andrea Camilleri, scrittore siciliano famoso in principal modo per i romanzi aventi come protagonista il commissario Montalbano, da cui è stata prodotta una serie televisiva, pronunciò le parole sopra riportate in un’intervista concessa a Roberto Cotroneo nel 2008, che prendendo le mosse dalla situazione politica di allora, lo scontro tra l’appena nato Partito Democratico guidato da Veltroni e Silvio Berlusconi, ha toccato le corde della questione meridionale e dell’Unità d’Italia. Senza giri di parole Andrea Camilleri denunciò il fatto che il Mezzogiorno non è altro che una colonia destinata a soccombere sempre di più, poiché rende man mano di meno e non può essere utile alla gestione politica quale è dal 1860: “Io penso che nel 2008 l’operazione colonialista, iniziata subito dopo l’Unità d’Italia nei riguardi del Sud, sia arrivata al punto finale: questa colonia del Sud rendendo sempre di meno, sempre di più viene abbandonata a se stessa. E la colonia del Sud è come se non facesse parte dell’Italia, come qualche cosa di aggiunto all’Italia. Però se poi vado a vedere chi costituisce la mente direttiva delle industrie del nord, dell’informazione del nord, mi accorgo che sono dei meridionali. E allora mi sento in dovere di chiedere una quantificazione in denaro delle menti meridionali che promuovono il Nord. Voglio metterlo sul piatto della bilancia. Voglio vedere quanto può valere il cervello di un industriale meridionale che lavora e produce ricchezza al Nord”. Cervelli del Nord che producono ricchezza al Sud non esistono per Camilleri, il quale ha anche la spiegazione di tale circostanza: “La spiegazione risale al 1860. Quando una rivoluzione contadina venne chiamata brigantaggio. Per cui uccisero 17 mila briganti che non esistono da nessuna parte del mondo. Ed erano invece contadini in rivolta, o ex militari borbonici. Tutto già da allora ha preso una piega diversa. Quando fu fatta l’Unità d’Italia noi in Sicilia avevamo 8000 telai, producevamo stoffa. Nel giro di due anni non avevamo più un telaio. Funzionavano solo quelli di Biella. E noi importavamo la stoffa. E ancora oggi è così”. Andrea Camilleri, il maggiore scrittore italiano in vita, parla insomma di colonia interna, di sfruttamento sistematico del Mezzogiorno sin dal momento dell’Unità, di falso Risorgimento che in realtà è stato una guerra di conquista, di storia nascosta. Col passare del tempo il Sud non poteva che diventare inutile, sfruttato ed inquinato, e allora bisogna trasferire le menti al Nord dopo averle opportunamente programmate affinché dimenticassero le proprie radici, una situazione cui non è esente da colpe la classe dirigente locale: “Nell’Ottocento, quando cominciò a sorgere la cosiddetta questione meridionale, c’erano parecchi deputati meridionali che si battevano per la questione meridionale. Oggi si battono per altro, non per la questione meridionale”. Che il neonato Stato Italiano fosse marcio lo avevano rilevato anche altri due grandissimi scrittori siciliani, Luigi Pirandello e Giovanni Verga, i quali, inizialmente entusiasti per quella doveva essere una nuova epoca dorata per la Sicilia cui fu promessa l’autonomia, divennero critici e rinnegarono nei fatti l’Unità d’Italia. Pirandello nacque nel 1867 in una famiglia che aveva partecipato attivamente ai moti risorgimentali, lottando al fianco dei Mille per la liberazione della Sicilia, ma egli manifestò le proprie aspre critiche soprattutto nel romanzo “I vecchi e i giovani”, dove sono a confronto la vecchia generazione, quella protagonista dell’Unità, e la nuova, quella che vive sulle proprie spalle i fatti del 1860. È un’opera il cui fulcro è l’eredità lasciata ai giovani, ma non i giovani del tempo, bensì quelli che sarebbero continuati a nascere nei decenni successivi. Donna Caterina, nel romanzo, afferma: “Qua c’è la fame, caro signore, nelle campagne e nelle zolfare; i latifondi, la tirannia feudale dei cosìddetti cappelli, le tasse comunali che succhiano l’ultimo sangue a gente che non ha neanche da comperarsi il pane“. Eccoli qui, ma non solo essi, gli ottomila telai di cui parla Andrea Camilleri. È quella che Pirandello chiama “bancarotta del patriottismo”, l’inganno e il fallimento del Risorgimento, l’amara consapevolezza che dietro i Mille vi era ben altro disegno, ben altri burattinai che della Sicilia e, del resto, di tutto il Mezzogiorno, non se ne curavano se non come territorio attraverso cui accrescere la propria posizione, il proprio potere, la propria ricchezza. La critica di Giovanni Verga si dispiega invece nel cosiddetto “Ideale dell’ostrica”, secondo il quale è impossibile migliorare la condizione nella quale si è nati, una sorta di cu nasci tunnu un po muriri quatratu, nonostante tutti gli sforzi che possano essere fatti: Mastro Gesualdo non diverrà mai Don Gesualdo, al massimo Mastro Don Gesualdo, e la famiglia di Padron ‘Ntoni, appena cercherà di ampliare la propria “attività” perderà la barca – migliorare non si può, si può solo fare peggio, dunque è meglio restare, come un’ostrica, attaccati al proprio scoglio. I lavori di Verga sono tutti incentrati sulla condizione delle classi più povere e disagiate, implacabilmente sfruttate e impossibilitate a raggiungere non solo il benessere, ma neanche una condizione leggermente migliore rispetto a quella di partenza. In maniera un po’ velata, certo, ma evidente a chi vuole andare oltre il racconto e contestualizzare l’opera di uno scrittore, capire le basi sulle quali è stata scritta, sono presenti la sfiducia e la delusione verso qualcosa che sembrava oro, ma era un’illusione, un miraggio, un inganno: era l’oro dei pazzi.
La Rivolta del sette e mezzo. Appena sei anni dopo l'annessione della Sicilia da parte dell'Italia, tra il 15 e il 22 Settembre 1866, i cittadini di Palermo, ma anche di altri comuni come; Monreale, Marineo, Misilmeri, Bagheria, Lercara Friddi, Montelepre, Campofelice di Fitalia, diedero vita alla "Rivolta del Sette e Mezzo", definita così, per la breve durata dei moti di piazza, sette giorni e mezzo, appunto.
La constatazione del fallimento degli intenti dichiarati
all'indomani dell'Unità d'Italia, la percezione di essere stati
ingannati, questi gli elementi che hanno innescato la miccia degli
eventi. I contadini, prima illusi dalle dichiarazioni di Garibaldi, circa la destinazione delle terre da coltivare e dalla realtà affermatesi poi, la leva obbligatoria sconosciuta in Sicilia fino all'affermarsi del regno Sabaudo, l'abolizione delle Confraternite religiose che tanto lavoro creavano con le varie categorie di artigiani, decoratori, stuccatori, sarti, falegnami ect. In altre parole, malessere sociale e crisi economica sono stati gli ingredienti di questa insurrezione a cui aderirono anche coloro i quali in un primo momento avevano creduto, sostenuto e combattuto a fianco dei mille. I palermitani della città e i cittadini della provincia si scoprirono degni eredi dei Vespri Siciliani, per lo spirito di ribellione, che come allora, si manifestò contro ogni forma di sopraffazione e di violenza. La "Rivolta del Sette e Mezzo" fu soffocata nel sangue dal regio esercito sabaudo, forte di circa 40000 uomini sbarcati a Palermo con decine e decine di vascelli della marina militare Piemontese. La città di Palermo venne bombardata e messa a ferro e fuoco, si consumarono violenze ed esecuzioni sommarie, i morti a migliaia, furono sepolti anche in fosse comuni. Questi i fatti, resta l' eroico desiderio di libertà e il valore di quei "picciotti" che pur in inferiorità numerica e di equipaggiamenti, vollero ribellarsi alla tirannia degli invasori. Una vera pagina di eroico patriottismo, che andrebbe DIVULGATA e fatta STUDIARE a scuola, in modo da offrire alle nuove generazioni di siciliani, una più esaustiva narrazione dei fatti reali della Storia moderna della Sicilia. Enzo Castrenze Cassata
|










 ti di quest'ultima elessero come loro ecista Evarco.
ti di quest'ultima elessero come loro ecista Evarco.










 atta per
l'esercito cartaginese.
atta per
l'esercito cartaginese. nia, accolto
festosamente dalle popolazioni. Subito dopo Catania
entrava in un patto d'alleanza militare con Atene; la
città diventava sede del quartiere generale delle
operazioni.
nia, accolto
festosamente dalle popolazioni. Subito dopo Catania
entrava in un patto d'alleanza militare con Atene; la
città diventava sede del quartiere generale delle
operazioni.
 versari, divenendo capo della città e restaurandovi la
monarchia.
versari, divenendo capo della città e restaurandovi la
monarchia.
 un
capitano barbaro di nome Mamerco (345-338 a.C), forse
campano, governava la città di Catania. Nel momento in
cui Timoleonte iniziava l'attacco alle forze
cartaginesi, Mamerco si univa a questi ultimi, che
mandarono Giscone al comando di forti contingenti di
soldati.
un
capitano barbaro di nome Mamerco (345-338 a.C), forse
campano, governava la città di Catania. Nel momento in
cui Timoleonte iniziava l'attacco alle forze
cartaginesi, Mamerco si univa a questi ultimi, che
mandarono Giscone al comando di forti contingenti di
soldati. di portare la guerra in Africa
contro i Cartaginesi, al seguito dei Romani comandati da
Attilio Regolo e Publio Cornelio Scipione. Ma subì una
sconfitta e fu costretto a ritornare a Siracusa, ove
consolidò il suo dominio, mentre i Cartaginesi
occupavano la maggior parte dell'Isola.
di portare la guerra in Africa
contro i Cartaginesi, al seguito dei Romani comandati da
Attilio Regolo e Publio Cornelio Scipione. Ma subì una
sconfitta e fu costretto a ritornare a Siracusa, ove
consolidò il suo dominio, mentre i Cartaginesi
occupavano la maggior parte dell'Isola.


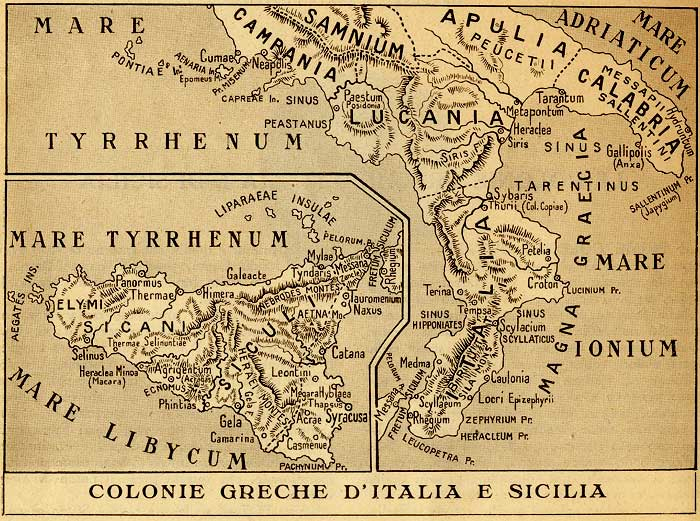


 noto che il conquistatore di Siracusa,
Marco Claudio Marcello, vi costruì un ginnasio.
noto che il conquistatore di Siracusa,
Marco Claudio Marcello, vi costruì un ginnasio.

 737
a.C. - menzionata da
Tucidide assieme ad altre eruzioni avvenute negli anni 477 e 427 a.C.;
737
a.C. - menzionata da
Tucidide assieme ad altre eruzioni avvenute negli anni 477 e 427 a.C.;






 ltà commerciali, sia perché il
paganesimo, religione ufficiale dello Stato, non sembrava più così
compatto come in passato.
ltà commerciali, sia perché il
paganesimo, religione ufficiale dello Stato, non sembrava più così
compatto come in passato.


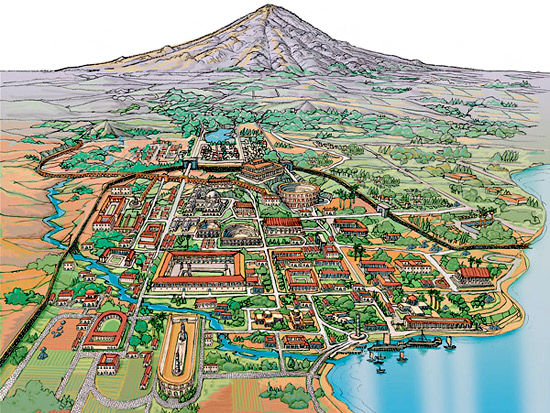



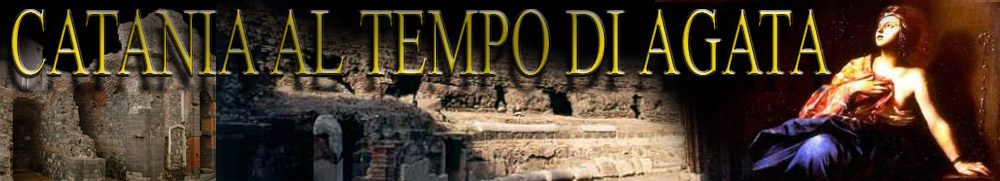
 semplicità di
una vergine e della fermezza di martire. “ Tu che ti credi nobile ”,
disse Agata a Quinziano, “ sei in realtà schiavo delle tue passioni ”.
Questa fu una grave provocazione per lui, padrone di quella terra e
garante della religione pagana in Sicilia. “ Dunque, noi che
disprezziamo il nome e la servitù di Cristo ”, domandò irritato il
proconsole, “ siamo ignobili? ”. Per Agata, che parlava con la forza
della fede e illuminata dallo Spirito Santo, era arrivato il momento di
accettare la sfida e rilanciò: “ Ignobiltà grande è la vostra: voi siete
schiavi delle voluttà, adorate pietre e legni, idoli costruiti da miseri
artigiani, strumenti del demonio ”. Quinziano a quelle parole si sentì
come un toro ferito. Era incapace di controbattere, non possedeva né le
risorse culturali di un oratore, né la saggezza e la semplicità delle
risposte ispirate dalla fede che aveva Agata. Gli unici strumenti che
conosceva bene e che sapeva usare erano la violenza e le minacce. In
questo campo era sicuro di essere il più forte e questi mezzi utilizzò:
“ O sacrifichi agli dèi o subirai il martirio ”, minacciò spazientito.
Ma, di fronte alla minaccia delle torture, Agata non si lasciò
intimorire: “ Vuoi farmi soffrire? ”, lo irrise. “ Da tempo lo aspetto,
lo bramo, è la mia più grande gioia ”. Poi, con voce sicura, aggiunse: “
Non adorerò mai le tue divinità. Come potrei adorare una Venere
impudica, un Giove adultero o un Mercurio ladro? Ma se tu credi che
queste siano vere divinità, ti auguro che tua moglie abbia gli stessi
costumi di Venere ”. Queste parole, pesanti come macigni e affilate come
lame, per Quinziano furono dure sferzate al suo orgoglio. Seppe reagire
soltanto con la violenza e ricambiò con uno schiaffo l’umiliazione
appena subita. Per niente avvilita per la percossa, Agata gli rispose: “
Ti ritieni offeso perché ti auguro di assomigliare ai tuoi dèi? Vedi
allora che nemmeno tu li stimi? Perché pretendi che siano onorati e
punisci chi non vuole adorarli? ”. Erano parole inconfutabili, ma Quinziano non volle arrendersi e ordinò che la giovane fosse rinchiusa
in carcere.
semplicità di
una vergine e della fermezza di martire. “ Tu che ti credi nobile ”,
disse Agata a Quinziano, “ sei in realtà schiavo delle tue passioni ”.
Questa fu una grave provocazione per lui, padrone di quella terra e
garante della religione pagana in Sicilia. “ Dunque, noi che
disprezziamo il nome e la servitù di Cristo ”, domandò irritato il
proconsole, “ siamo ignobili? ”. Per Agata, che parlava con la forza
della fede e illuminata dallo Spirito Santo, era arrivato il momento di
accettare la sfida e rilanciò: “ Ignobiltà grande è la vostra: voi siete
schiavi delle voluttà, adorate pietre e legni, idoli costruiti da miseri
artigiani, strumenti del demonio ”. Quinziano a quelle parole si sentì
come un toro ferito. Era incapace di controbattere, non possedeva né le
risorse culturali di un oratore, né la saggezza e la semplicità delle
risposte ispirate dalla fede che aveva Agata. Gli unici strumenti che
conosceva bene e che sapeva usare erano la violenza e le minacce. In
questo campo era sicuro di essere il più forte e questi mezzi utilizzò:
“ O sacrifichi agli dèi o subirai il martirio ”, minacciò spazientito.
Ma, di fronte alla minaccia delle torture, Agata non si lasciò
intimorire: “ Vuoi farmi soffrire? ”, lo irrise. “ Da tempo lo aspetto,
lo bramo, è la mia più grande gioia ”. Poi, con voce sicura, aggiunse: “
Non adorerò mai le tue divinità. Come potrei adorare una Venere
impudica, un Giove adultero o un Mercurio ladro? Ma se tu credi che
queste siano vere divinità, ti auguro che tua moglie abbia gli stessi
costumi di Venere ”. Queste parole, pesanti come macigni e affilate come
lame, per Quinziano furono dure sferzate al suo orgoglio. Seppe reagire
soltanto con la violenza e ricambiò con uno schiaffo l’umiliazione
appena subita. Per niente avvilita per la percossa, Agata gli rispose: “
Ti ritieni offeso perché ti auguro di assomigliare ai tuoi dèi? Vedi
allora che nemmeno tu li stimi? Perché pretendi che siano onorati e
punisci chi non vuole adorarli? ”. Erano parole inconfutabili, ma Quinziano non volle arrendersi e ordinò che la giovane fosse rinchiusa
in carcere.



 La liturgia cattolica bizantina, o
meglio costantinopolitana, è ancor oggi quella composta da San Basilio
(† 379) e, soprattutto, da San Giovanni Crisostomo († 407);
paradossalmente quindi il rito rimasto isolato in Italia da Roma in giù,
Sicilia compresa, fin dai tempi dell’Impero d’Oriente, si rivela ben più
antico rispetto a quello ancor oggi ufficiale della Chiesa Ortodossa,
che ha subito evoluzioni ben maggiori. Sebbene ad una prima impressione
esso sembri assai differente dalla Messa Tridentina o Straordinaria
propria della Chiesa Latina e diffusa dai tempi di San Gregorio Magno (†
604), quella bizantina è
a ben vedere molto simile nella struttura
bipartita (parte didattica / parte dei fedeli con il Sacrificio vero e
proprio) ed anche in certe formule che compaiono quasi del tutto
identiche, tradendo l’origine comune dei due maggiori riti in uso
nell’Impero. L’intera liturgia è stata officiata per buon 40 – 45% in
Greco bizantino, dalla nota pronunzia itacistica, mentre una schola di
fedeli d’ambo i sessi ha eseguito le tipiche cantilene che il rito vuole
ripetute con cadenza quasi ipnotica. Durante la celebrazione l’altare,
seminascosto dietro un sottile velo che sopperiva all’assenza
dell’iconostasi, è apparso come immerso in una dimensione ultraterrena,
ben prestandosi alla suggestione di fedeli ingiustamente mortificati
dalla sciatteria dei riti odierni, che sembrano aver perso il gusto per
l’imperscrutabile in favore d’una poco opportuna asetticità degli arredi
e dei paramenti. Qui al contrario il celebrante ed il diacono,
circondati dai membri in uniforme dell’Unione Cavalleria Cristiana
Internazionale, storico ente catanese, hanno sfoggiato i tipici abiti
liturgici del vicino oriente, dalle inusuali tinte turchesi, che hanno
contribuito non poco a rendere la sacralità dei gesti durante le quattro
piccole processioni caratterizzanti la festività odierna. Numerosi i
simboli, tra cui le candele intrecciate, i continui segni di croce da
parte dei fedeli, e l’immagine di Cristo posta all’ingresso per
l’adorazione personale, il tutto tra pareti tappezzate di ieratiche
icone e statue dai colori sgargianti, cui non poche persone offrivano le
tipiche candele sottili di cera naturale. Alla fine del rito, in
ossequio al calendario orientale, è stata benedetta l’acqua in memoria
del Battesimo di Cristo nel fiume Giordano, con l’arcana triplice
immersione d’una piccola croce d’argento.
La liturgia cattolica bizantina, o
meglio costantinopolitana, è ancor oggi quella composta da San Basilio
(† 379) e, soprattutto, da San Giovanni Crisostomo († 407);
paradossalmente quindi il rito rimasto isolato in Italia da Roma in giù,
Sicilia compresa, fin dai tempi dell’Impero d’Oriente, si rivela ben più
antico rispetto a quello ancor oggi ufficiale della Chiesa Ortodossa,
che ha subito evoluzioni ben maggiori. Sebbene ad una prima impressione
esso sembri assai differente dalla Messa Tridentina o Straordinaria
propria della Chiesa Latina e diffusa dai tempi di San Gregorio Magno (†
604), quella bizantina è
a ben vedere molto simile nella struttura
bipartita (parte didattica / parte dei fedeli con il Sacrificio vero e
proprio) ed anche in certe formule che compaiono quasi del tutto
identiche, tradendo l’origine comune dei due maggiori riti in uso
nell’Impero. L’intera liturgia è stata officiata per buon 40 – 45% in
Greco bizantino, dalla nota pronunzia itacistica, mentre una schola di
fedeli d’ambo i sessi ha eseguito le tipiche cantilene che il rito vuole
ripetute con cadenza quasi ipnotica. Durante la celebrazione l’altare,
seminascosto dietro un sottile velo che sopperiva all’assenza
dell’iconostasi, è apparso come immerso in una dimensione ultraterrena,
ben prestandosi alla suggestione di fedeli ingiustamente mortificati
dalla sciatteria dei riti odierni, che sembrano aver perso il gusto per
l’imperscrutabile in favore d’una poco opportuna asetticità degli arredi
e dei paramenti. Qui al contrario il celebrante ed il diacono,
circondati dai membri in uniforme dell’Unione Cavalleria Cristiana
Internazionale, storico ente catanese, hanno sfoggiato i tipici abiti
liturgici del vicino oriente, dalle inusuali tinte turchesi, che hanno
contribuito non poco a rendere la sacralità dei gesti durante le quattro
piccole processioni caratterizzanti la festività odierna. Numerosi i
simboli, tra cui le candele intrecciate, i continui segni di croce da
parte dei fedeli, e l’immagine di Cristo posta all’ingresso per
l’adorazione personale, il tutto tra pareti tappezzate di ieratiche
icone e statue dai colori sgargianti, cui non poche persone offrivano le
tipiche candele sottili di cera naturale. Alla fine del rito, in
ossequio al calendario orientale, è stata benedetta l’acqua in memoria
del Battesimo di Cristo nel fiume Giordano, con l’arcana triplice
immersione d’una piccola croce d’argento. catanese della Civita. Si presenta a croce greca con pianta
quadrata, cupola e tre absidi («cellae trichorae» o «chiesa a
trifoglio») in forma simile alla cuba bizantina presente in Sicilia.
Oggi rispetto al piano della strada si trova interrato di circa 2 metri.
L'edificio, che è inoltre arricchito di testimonianze medioevali e
quattrocentesche, è scampato ai diversi terremoti che hanno colpito la
città, fra cui quello devastante del 1693.
catanese della Civita. Si presenta a croce greca con pianta
quadrata, cupola e tre absidi («cellae trichorae» o «chiesa a
trifoglio») in forma simile alla cuba bizantina presente in Sicilia.
Oggi rispetto al piano della strada si trova interrato di circa 2 metri.
L'edificio, che è inoltre arricchito di testimonianze medioevali e
quattrocentesche, è scampato ai diversi terremoti che hanno colpito la
città, fra cui quello devastante del 1693. ne sarebbero
stati in cotto. Le finestre hanno una particolare forma a «testa di
chiodo». Nell'interno a tre navate, divise da una serie di pilastri
quadrangolari, la cupola centrale è arricchita da volte a crociera e da
minime tracce degli intonaci originali. Dopo anni di degrado la chiesa è
stata oggetto di restauro negli ultimi anni. Dopo i restauri sono stati
rinvenuti due scheletri di probabile datazione bizantina che farebbe
supporre la presenza di un attiguo cimitero basiliano.
ne sarebbero
stati in cotto. Le finestre hanno una particolare forma a «testa di
chiodo». Nell'interno a tre navate, divise da una serie di pilastri
quadrangolari, la cupola centrale è arricchita da volte a crociera e da
minime tracce degli intonaci originali. Dopo anni di degrado la chiesa è
stata oggetto di restauro negli ultimi anni. Dopo i restauri sono stati
rinvenuti due scheletri di probabile datazione bizantina che farebbe
supporre la presenza di un attiguo cimitero basiliano. I
due disertori bizantini che riportarono nella Catania normanna le spoglie di Sant'Agata da
Costantinopoli.
I
due disertori bizantini che riportarono nella Catania normanna le spoglie di Sant'Agata da
Costantinopoli.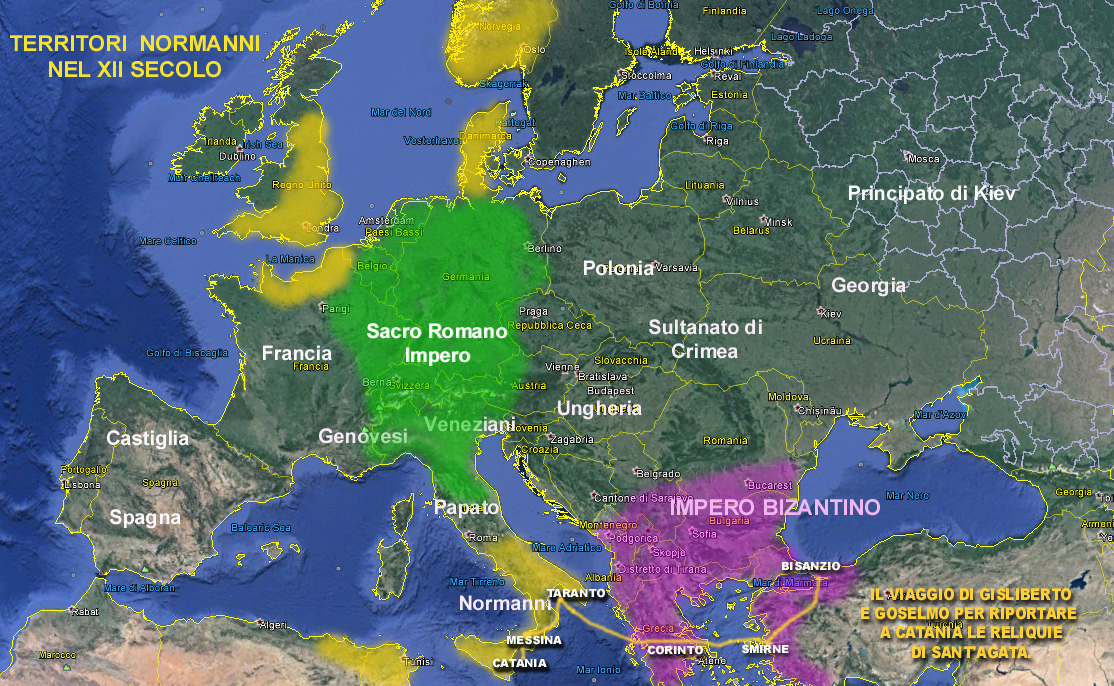
 sacerdoti della propria diocesi e li mise al
corrente di ciò che stava accadendo. Tra l’entusiasmo generale fu deciso
di riportare il santo corpo a Catania e collocarlo nella Cattedrale che
era stata edificata per volere di Ruggero I non molto dopo la
liberazione della città dagli Arabi (la prima bolla pontificia relativa
all’edificazione della nuova chiesa è datata 25 Aprile 1091). La notizia
si diffuse ben presto fra il popolo catanese che si affrettò dal suo
Pastore per avere conferma. Maurizio esortò gli astanti ad andare con
vesti bianche insieme a lui incontro al fercolo proveniente da Aci, che
frattanto si trovava già in cammino, accompagnato da una schiera di
monaci e da Gisliberto e Goselmo. Maurizio procedeva scalzo in segno
d’umiltà.
sacerdoti della propria diocesi e li mise al
corrente di ciò che stava accadendo. Tra l’entusiasmo generale fu deciso
di riportare il santo corpo a Catania e collocarlo nella Cattedrale che
era stata edificata per volere di Ruggero I non molto dopo la
liberazione della città dagli Arabi (la prima bolla pontificia relativa
all’edificazione della nuova chiesa è datata 25 Aprile 1091). La notizia
si diffuse ben presto fra il popolo catanese che si affrettò dal suo
Pastore per avere conferma. Maurizio esortò gli astanti ad andare con
vesti bianche insieme a lui incontro al fercolo proveniente da Aci, che
frattanto si trovava già in cammino, accompagnato da una schiera di
monaci e da Gisliberto e Goselmo. Maurizio procedeva scalzo in segno
d’umiltà. 



 e arabo dell'epoca normanna ) ed
una popolazione di oltre 250.000 abitanti, quando a Roma o Milano non
c'erano più di 20 o 30.000 anime.
e arabo dell'epoca normanna ) ed
una popolazione di oltre 250.000 abitanti, quando a Roma o Milano non
c'erano più di 20 o 30.000 anime. 
 La
Chiesa SS. Pietro e
Paolo è uno dei
monumenti più complessi della Sicilia.
La
Chiesa SS. Pietro e
Paolo è uno dei
monumenti più complessi della Sicilia. A
Palermo, i normanni, che succedettero gli arabi nella
dominazione della Sicilia, posero mano a tutti gli edifici
costruiti in precedenza. Ad ogni modo, l’impronta
dell’architettura araba rimane come segno indelebile di una
presenza influente anche dal punto di vista estetico. Le
moschee, i palazzi e i giardini ricchi di fontane furono
inesorabilmente riadattati al gusto normanno, arricchendo
quest’ultimo di elementi mediorientali. Gli edifici storici di
Palermo vengono, dunque, classificati stilisticamente come
architettura arabo-normanna.
A
Palermo, i normanni, che succedettero gli arabi nella
dominazione della Sicilia, posero mano a tutti gli edifici
costruiti in precedenza. Ad ogni modo, l’impronta
dell’architettura araba rimane come segno indelebile di una
presenza influente anche dal punto di vista estetico. Le
moschee, i palazzi e i giardini ricchi di fontane furono
inesorabilmente riadattati al gusto normanno, arricchendo
quest’ultimo di elementi mediorientali. Gli edifici storici di
Palermo vengono, dunque, classificati stilisticamente come
architettura arabo-normanna.

 delle
truppe il generale Giorgio
Maniace, che alla corte
bizantina era caduto in disgrazia dopo la conquista di Edessa a causa
della gelosia imperiale. Michele IV si fece convincere dalla moglie,
anche se Giorgio Maniace doveva essere sottoposto al generale Stefano.
L'esercito era composto da bizantini, in particolare dalle guardie
variaghe, da truppe guidate da Arduino, arruolate con la forza in Puglia
(i cosiddetti Konteratoi), scarsamente convinti della missione, e da una
compagnia di normanni/vichinghi comandati da Guglielmo Braccio di Ferro
e da Harald Hardrada (futuro re di Norvegia).
delle
truppe il generale Giorgio
Maniace, che alla corte
bizantina era caduto in disgrazia dopo la conquista di Edessa a causa
della gelosia imperiale. Michele IV si fece convincere dalla moglie,
anche se Giorgio Maniace doveva essere sottoposto al generale Stefano.
L'esercito era composto da bizantini, in particolare dalle guardie
variaghe, da truppe guidate da Arduino, arruolate con la forza in Puglia
(i cosiddetti Konteratoi), scarsamente convinti della missione, e da una
compagnia di normanni/vichinghi comandati da Guglielmo Braccio di Ferro
e da Harald Hardrada (futuro re di Norvegia).

 e cultura oscillavano tra la greco-bizantina e la saracena; per
non parlare della consistente comunità ebraica esistente a Catania. Né
maggiore fiducia ispirava la gerarchia della Chiesa, nella misura in cui
questa poteva essere sopravvissuta alla dominazione araba. Come per
altre parti della Sicilia, Ruggero preferì dunque creare una struttura
civile ed ecclesiastica integralmente nuova, affidando ai monaci
benedettini la direzione dell'evangelizzazione religiosa e della
riorganizzazione civile. Catania perse così la sua libertà e venne
infeudata al fidato Ansgerio, già abate di S. Eufemia. Questi venne
anche nominato abate dell'Abazia benedettina di S. Agata, e vescovo di
una diocesi molto larga (da Mascali a Enna e Piazza Armerina). Questa
configurazione del potere, con la riunione delle tre cariche - tutte
sostenute da pingui rendite - sarà a lungo un elemento determinante
nella storia della città.
e cultura oscillavano tra la greco-bizantina e la saracena; per
non parlare della consistente comunità ebraica esistente a Catania. Né
maggiore fiducia ispirava la gerarchia della Chiesa, nella misura in cui
questa poteva essere sopravvissuta alla dominazione araba. Come per
altre parti della Sicilia, Ruggero preferì dunque creare una struttura
civile ed ecclesiastica integralmente nuova, affidando ai monaci
benedettini la direzione dell'evangelizzazione religiosa e della
riorganizzazione civile. Catania perse così la sua libertà e venne
infeudata al fidato Ansgerio, già abate di S. Eufemia. Questi venne
anche nominato abate dell'Abazia benedettina di S. Agata, e vescovo di
una diocesi molto larga (da Mascali a Enna e Piazza Armerina). Questa
configurazione del potere, con la riunione delle tre cariche - tutte
sostenute da pingui rendite - sarà a lungo un elemento determinante
nella storia della città.
 Giunse in Italia
intorno al 1057 insieme al fratello Roberto il Guiscaldo con cui avvio
la sua campagna militare. Dopo la conquista della Calabria e della
Puglia, intorno al 1061 inizio per i due fratelli la stagione di
conquista della Sicilia. Approfittarono dei dissapori fra gli emiri di
Catania
e Girgenti per insinuarsi sul territorio, insediandosi in primis proprio
nel cuore dell’isola, fra Enna e Agrigento. Dopo un breve periodo di
allontanamento dalla Sicilia, il suo rientro consto nuove e
significative vittorie contro i musulmani che assediavano Nicosia. Dopo
alcuni anni di battaglie e assedi Ruggero quindi si dedicò alla
definitiva conquista dell’isola: espugnò Taormina con molti castelli di
Val Demone, Castronovo, Jato, Cinisi e Trapani. Siracusa venne
conquistata dopo la morte del fratello Roberto, insieme a Butera e Noto.
Nel 1090 torno in Puglia e sposo la contessa Adelaide di Monferrato.
Morì all’età di 76 anni a Mileto.
Giunse in Italia
intorno al 1057 insieme al fratello Roberto il Guiscaldo con cui avvio
la sua campagna militare. Dopo la conquista della Calabria e della
Puglia, intorno al 1061 inizio per i due fratelli la stagione di
conquista della Sicilia. Approfittarono dei dissapori fra gli emiri di
Catania
e Girgenti per insinuarsi sul territorio, insediandosi in primis proprio
nel cuore dell’isola, fra Enna e Agrigento. Dopo un breve periodo di
allontanamento dalla Sicilia, il suo rientro consto nuove e
significative vittorie contro i musulmani che assediavano Nicosia. Dopo
alcuni anni di battaglie e assedi Ruggero quindi si dedicò alla
definitiva conquista dell’isola: espugnò Taormina con molti castelli di
Val Demone, Castronovo, Jato, Cinisi e Trapani. Siracusa venne
conquistata dopo la morte del fratello Roberto, insieme a Butera e Noto.
Nel 1090 torno in Puglia e sposo la contessa Adelaide di Monferrato.
Morì all’età di 76 anni a Mileto.

 te eruzione lavica che, tra l'altro, avrebbe
riunito la riva all'isoletta dove sorgeva il Castello. Dalla fine del XIII secolo fino all'età dei Viceré, il castello fu testimone della
lunga lotta che contrappose gli aragonesi di Sicilia agli angioini di
Napoli. Nel seicento il castello conobbe un rinnovato splendore, dovuto
anche alla radicale opera di ristrutturazione voluta nel 1634 dal re
Filippo III, che per l'occasione fece apporre una lapide marmorea
all'ingresso con la dicitura: "PHILIPPUS III DEI GRATIS REX HISPANIARUM
ET INDIARUM ET UTRIUSQUE SICILIAE ANNO DIVI 1634".
te eruzione lavica che, tra l'altro, avrebbe
riunito la riva all'isoletta dove sorgeva il Castello. Dalla fine del XIII secolo fino all'età dei Viceré, il castello fu testimone della
lunga lotta che contrappose gli aragonesi di Sicilia agli angioini di
Napoli. Nel seicento il castello conobbe un rinnovato splendore, dovuto
anche alla radicale opera di ristrutturazione voluta nel 1634 dal re
Filippo III, che per l'occasione fece apporre una lapide marmorea
all'ingresso con la dicitura: "PHILIPPUS III DEI GRATIS REX HISPANIARUM
ET INDIARUM ET UTRIUSQUE SICILIAE ANNO DIVI 1634".


 Il
terremoto di Catania del 4 Febbraio 1169
Il
terremoto di Catania del 4 Febbraio 1169






 documentata dalle cosiddette lettere lodigiane
di Federico II, che venne realizzata sotto la direzione del praepositus
aedificiorum Riccardo da Lentini. Il castello, che fu iniziato quando
già quelli di Augusta e Siracusa erano quasi ultimati, faceva parte di
un più generale progetto di fortificazione dei punti strategici
dell'intera costa ionica (Cfr. Federico e la Sicilia, dalla terra alla
corona, a cura di Carmela Angela Di Stefano e Antonio Cadei, II Ed.
Palermo 2000, p. 465 e ss.). I noti rapporti burrascosi fra il papato e
Federico II fecero nascere diverse leggende tra le quali quella che
vuole che il castello Ursino sia stato voluto da Federico per tenere a
bada la popolazione.
documentata dalle cosiddette lettere lodigiane
di Federico II, che venne realizzata sotto la direzione del praepositus
aedificiorum Riccardo da Lentini. Il castello, che fu iniziato quando
già quelli di Augusta e Siracusa erano quasi ultimati, faceva parte di
un più generale progetto di fortificazione dei punti strategici
dell'intera costa ionica (Cfr. Federico e la Sicilia, dalla terra alla
corona, a cura di Carmela Angela Di Stefano e Antonio Cadei, II Ed.
Palermo 2000, p. 465 e ss.). I noti rapporti burrascosi fra il papato e
Federico II fecero nascere diverse leggende tra le quali quella che
vuole che il castello Ursino sia stato voluto da Federico per tenere a
bada la popolazione.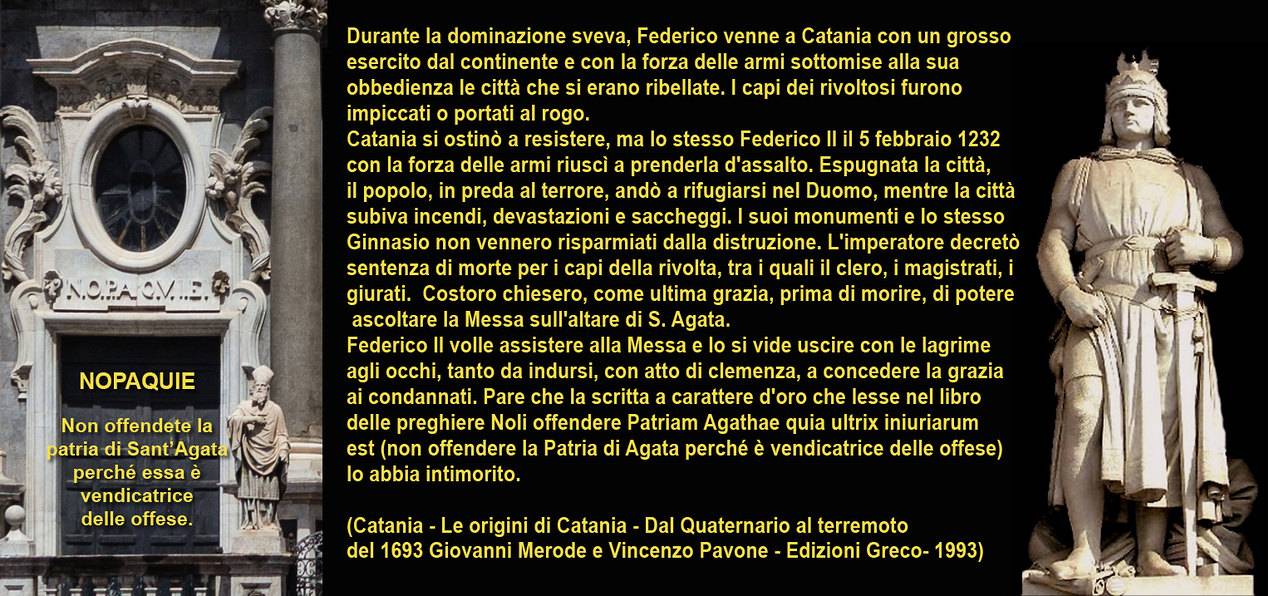
 utinarono e Catania fu tra queste. Federico II furente ne ordinò la distruzione, ma i catanesi
ottennero che, prima dell'esecuzione di quello
sterminio, in cattedrale venisse celebrata l'ultima
messa, alla quale presenziò lo stesso Federico II. Fu
durante quella funzione che il re svevo, sulle pagine
del suo breviario, lesse una frase, comparsa
miracolosamente, che gli suonò come un pericoloso
avvertimento: Noli offendere Patriam Agathae quia ultrix
iniuriarum est.
utinarono e Catania fu tra queste. Federico II furente ne ordinò la distruzione, ma i catanesi
ottennero che, prima dell'esecuzione di quello
sterminio, in cattedrale venisse celebrata l'ultima
messa, alla quale presenziò lo stesso Federico II. Fu
durante quella funzione che il re svevo, sulle pagine
del suo breviario, lesse una frase, comparsa
miracolosamente, che gli suonò come un pericoloso
avvertimento: Noli offendere Patriam Agathae quia ultrix
iniuriarum est.
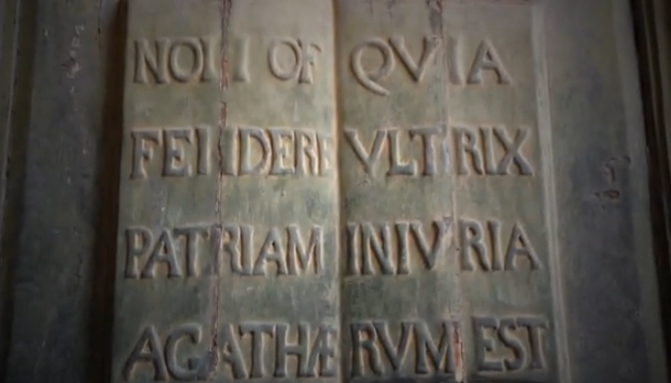

 Manfrédi
re di Sicilia.
Manfrédi
re di Sicilia. 

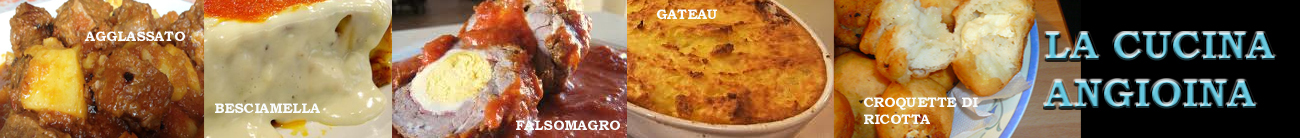


 Vespri siciliani.
Vespri siciliani.




 Il
Regno di Sicilia e la Pace di Catania
Il
Regno di Sicilia e la Pace di Catania
 vicoli della città
etnea la Pace siglata tra Angioini e Aragonesi, accordo con
il quale le due parti si impegnano a cessare le ostilità che
dal 1282, anno del Vespro Siciliano, contrappongono in una
guerra logorante e rovinosa il Popolo Siciliano e la
Dinastia Aragonese da un lato, il papato e i sovrani di casa
d’Angiò dall’altro.
vicoli della città
etnea la Pace siglata tra Angioini e Aragonesi, accordo con
il quale le due parti si impegnano a cessare le ostilità che
dal 1282, anno del Vespro Siciliano, contrappongono in una
guerra logorante e rovinosa il Popolo Siciliano e la
Dinastia Aragonese da un lato, il papato e i sovrani di casa
d’Angiò dall’altro. ia al
titolo di re di Sicilia in cambio dell'investitura a re di
Sardegna e Corsica.
ia al
titolo di re di Sicilia in cambio dell'investitura a re di
Sardegna e Corsica.


 IL REGNO DI SICILIA, LA PIU' GRANDE ISOLA DEL
IL REGNO DI SICILIA, LA PIU' GRANDE ISOLA DEL


 maggior tempio nostro;di quel re
e di quelle regine che avendo eletto Catania capitale del regno di Sicilia e
abitato il Castello Ursino quale reggia,morendo venivano sepolti nel Duomo,
vicino ai resti di quella Agata da essi invocata nel pericolo e il cui nome, in
guerra, associavano al nome della loro schiatta:<<Sant'Agata e Aragona!>>.
maggior tempio nostro;di quel re
e di quelle regine che avendo eletto Catania capitale del regno di Sicilia e
abitato il Castello Ursino quale reggia,morendo venivano sepolti nel Duomo,
vicino ai resti di quella Agata da essi invocata nel pericolo e il cui nome, in
guerra, associavano al nome della loro schiatta:<<Sant'Agata e Aragona!>>.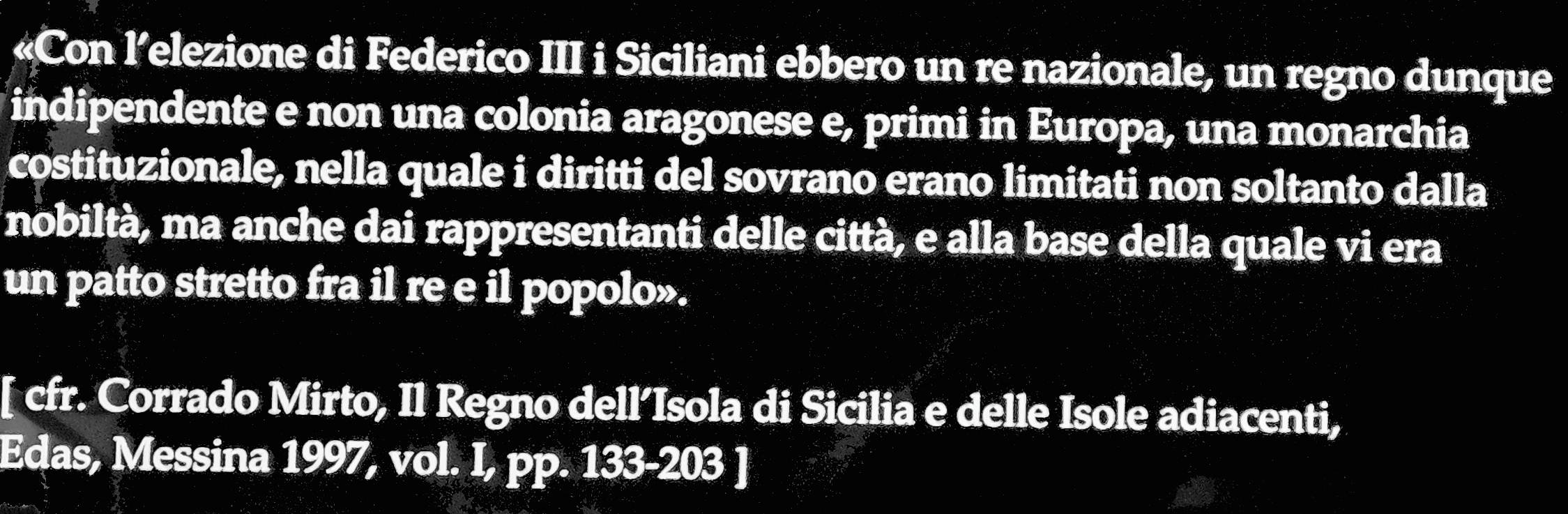

 L'ammiraglio ARTALE ALAGONA,
terrore degli Angioini.
L'ammiraglio ARTALE ALAGONA,
terrore degli Angioini.
 Lo Scacco di Ognina
fu una battaglia navale combattuta al largo del Golfo di Catania , nei
pressi di Aci Castello, nel
1356 fra angioini ed aragonesi.
Lo Scacco di Ognina
fu una battaglia navale combattuta al largo del Golfo di Catania , nei
pressi di Aci Castello, nel
1356 fra angioini ed aragonesi.
 Poi
nel 1285 riporta una notevole vittoria contro gli
angioini e i genovesi e nella notte tra il 3 e il 4
settembre 1285 sconfigge Filippo III di Francia
l'Ardito, che da due anni è in guerra contro la
Corona d'Aragona, nella battaglia navale delle
Formiche, presso Roses, in Catalogna. Vi sono
diversi resoconti sulla battaglia ma tuti
concordano sul fatto che lo scontro avvenne di
notte, il che era inconsueto per le battaglie navali
medievali, ma andava bene a Lauria, che era
specializzato nei combattimenti notturni. Egli mise
due lanterne su ogni galera per far credere
superiore il numero delle sue forze. Fuggirono da
dieci a sedici galere genovesi, sotto il comando di
John de Orrea, lasciando che quindici o venti galere
francesi circa fossero catturate, affondate o
bruciate.
Poi
nel 1285 riporta una notevole vittoria contro gli
angioini e i genovesi e nella notte tra il 3 e il 4
settembre 1285 sconfigge Filippo III di Francia
l'Ardito, che da due anni è in guerra contro la
Corona d'Aragona, nella battaglia navale delle
Formiche, presso Roses, in Catalogna. Vi sono
diversi resoconti sulla battaglia ma tuti
concordano sul fatto che lo scontro avvenne di
notte, il che era inconsueto per le battaglie navali
medievali, ma andava bene a Lauria, che era
specializzato nei combattimenti notturni. Egli mise
due lanterne su ogni galera per far credere
superiore il numero delle sue forze. Fuggirono da
dieci a sedici galere genovesi, sotto il comando di
John de Orrea, lasciando che quindici o venti galere
francesi circa fossero catturate, affondate o
bruciate.



 ittà vitale e dinamica (tendenza all’incremento
demografico ed all’espansione delle colture nell’area etnea, interventi
pubblici nell’area urbana, restaurazione delle mura, costruzione di
nuovi edifici sacri e nobiliari, diffusione della cultura del decoro),
ma una serie di catastrofi
naturali (tra
1536 e 1537
si ebbero eruzioni, scosse sismiche, esplosioni e nubi sulfuree che
scuotono l’Etna e distruggono abitati, vigne, piantagioni dell’area
collinare) ed il peggioramento della congiuntura politico-militare nel
Mediterraneo ed in Europa, determinarono un clima diffuso di paure e
ansie, aspettative escatologiche e millenaristiche.
ittà vitale e dinamica (tendenza all’incremento
demografico ed all’espansione delle colture nell’area etnea, interventi
pubblici nell’area urbana, restaurazione delle mura, costruzione di
nuovi edifici sacri e nobiliari, diffusione della cultura del decoro),
ma una serie di catastrofi
naturali (tra
1536 e 1537
si ebbero eruzioni, scosse sismiche, esplosioni e nubi sulfuree che
scuotono l’Etna e distruggono abitati, vigne, piantagioni dell’area
collinare) ed il peggioramento della congiuntura politico-militare nel
Mediterraneo ed in Europa, determinarono un clima diffuso di paure e
ansie, aspettative escatologiche e millenaristiche.

 mercato africano, e il ruolo egemonico della
Spagna (la produzione di zucchero siciliano, per esempio, viene
condannata a morte dall'impianto delle piantagioni prima nelle Canarie e
poi in America).
mercato africano, e il ruolo egemonico della
Spagna (la produzione di zucchero siciliano, per esempio, viene
condannata a morte dall'impianto delle piantagioni prima nelle Canarie e
poi in America). 


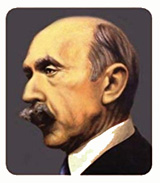



 La
grande eruzione dell'Etna
La
grande eruzione dell'Etna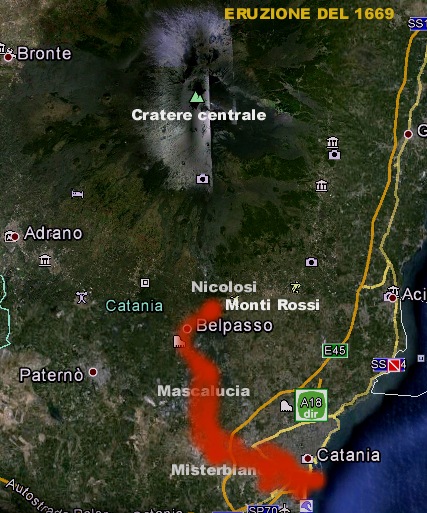

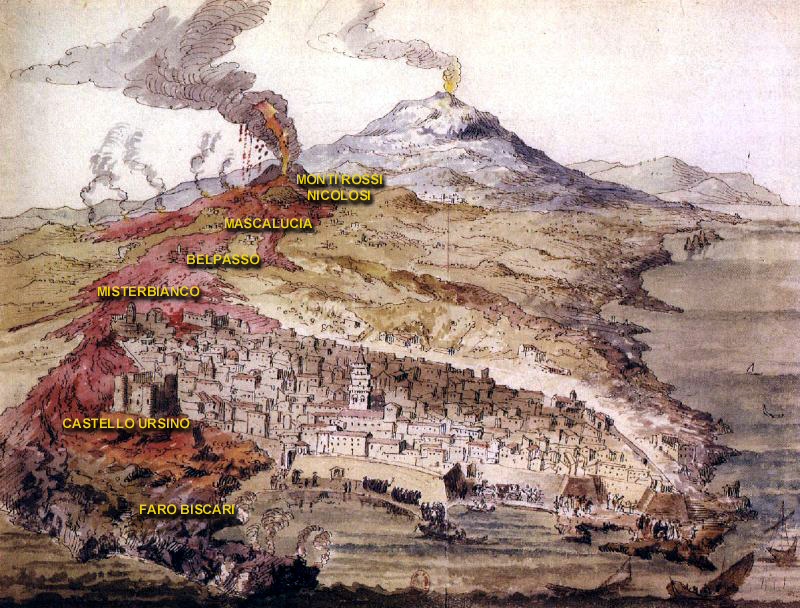

 Il
devastante terremoto della Val di Noto
Il
devastante terremoto della Val di Noto

 l’ingresso del Castello di
Acicastello. Secondo i geologi sembrerebbe che la struttura
sismogenetica sede del fuoco sismico sia posta in mare, non lontano
dalla costa tra Catania e Siracusa. Un’indiretta conferma di questa
ipotesi è fornita dal maremoto associato all'evento sismico che,
anche in questo caso come nel 1169, ha colpito la costa ionica della
Sicilia orientale. La profondità ipocentrale stimata per l'evento
principale fu di circa 20 Km quindi relativamente superficiale e
pertanto fortemente distruttivo (oltre la magnitudo occorre anche
considerare la profondità ipocentrale se lo stesso terremoto anziché
20 km fosse stato ad una profondità ipocentrale di 200 km non avrebbe
provocato alcun danno). Negli antichi scritti si legge una frase che
rende bene l’idea della grande distruzione: gli edifici furono “adeguati
al suolo”. Fonti storiche indicano che il terremoto del 1693 fu
seguito anche da un maremoto iniziato con un ritiro del mare lungo
tutta la costa della Sicilia orientale per diverse decine di metri al
quale fecero seguito altissime onde che si abbatterono prevalentemente
sul litorale di Augusta anche se disastrosi effetti si sono avuti
nel litorale catanese, mentre sembrerebbe che nel litorale siracusano
il maremoto abbia avuto un impatto meno devastante probabilmente per
la profondità dei fondali marini dovuta alla scarpata ibleo-maltese.
Infatti il run-up ossia l’altezza dell’onda di tsunami è in un
certo senso inversamente proporzionale alla profondità dei fondali.
Il terremoto dell’11 gennaio 1848, anche se di minore intensità
rispetto a quello del 1693, provocò gravi danni agli edifici di molti
centri della Sicilia orientale in particolare Catania e Acireale.
Eppure, è passato in sordina a causa dei ben noti eventi storici di
quell’epoca che, segnando importanti tappe della storia d’Italia,
ben presto lo fecero dimenticare… ubi major minor cessat. Qualcuno
parla del Big- One siciliano per analogia con un grande terremoto che
si aspetta a San Francisco. Ovviamente in una zona sismica è logico
aspettarsi un terremoto; prima o poi arriverà perché la Sicilia
orientale è una zona altamente sismica in quanto interessate da un
sistema di faglie altamente sismo genetiche che sono state generate
dalla collisione e conseguente subduzione della placca africana sotto
quella europea. L’Etna quindi non centra nulla anzi potrebbe
essere la conseguenza della tettonica regionale e certamente non la
causa. Anche nella zona dell'Aquila era atteso un forte terremoto,
visto che c'era un gap sismico che durava da 300 anni. Tutto sommato
per quello che si aspettava per la verità non è stato molto
energetico; poteva esserlo molto di più e ciò sicuramente è dovuto
alla liberazione di energia nel corso della crisi sismica che ha
preceduto la scossa più energetica… e poi come si fa a stabilire se
il terremoto accadrà tra 10, 100 o 1000 anni? Quello che si può dire
è che la scienza non ha ancora i mezzi per prevedere con certezza il
verificarsi di un evento sismico e che in Sicilia non si è fatto
nulla e si continua a far nulla per la prevenzione sismica. Per la
verità è bene dire che il radon è un buon precursore sismico e
Giampaolo Giuliani sulla base di una notevole anomalia del radon
registrata alcune decine di ore precedenti l’evento sismico aveva
previsto il terremoto di L’Aquila ma anziché un elogio si è
beccato una denuncia penale per procurato allarme… che possiamo dire…
questa è l’Italia con i suoi pregi ed i suoi difetti.
l’ingresso del Castello di
Acicastello. Secondo i geologi sembrerebbe che la struttura
sismogenetica sede del fuoco sismico sia posta in mare, non lontano
dalla costa tra Catania e Siracusa. Un’indiretta conferma di questa
ipotesi è fornita dal maremoto associato all'evento sismico che,
anche in questo caso come nel 1169, ha colpito la costa ionica della
Sicilia orientale. La profondità ipocentrale stimata per l'evento
principale fu di circa 20 Km quindi relativamente superficiale e
pertanto fortemente distruttivo (oltre la magnitudo occorre anche
considerare la profondità ipocentrale se lo stesso terremoto anziché
20 km fosse stato ad una profondità ipocentrale di 200 km non avrebbe
provocato alcun danno). Negli antichi scritti si legge una frase che
rende bene l’idea della grande distruzione: gli edifici furono “adeguati
al suolo”. Fonti storiche indicano che il terremoto del 1693 fu
seguito anche da un maremoto iniziato con un ritiro del mare lungo
tutta la costa della Sicilia orientale per diverse decine di metri al
quale fecero seguito altissime onde che si abbatterono prevalentemente
sul litorale di Augusta anche se disastrosi effetti si sono avuti
nel litorale catanese, mentre sembrerebbe che nel litorale siracusano
il maremoto abbia avuto un impatto meno devastante probabilmente per
la profondità dei fondali marini dovuta alla scarpata ibleo-maltese.
Infatti il run-up ossia l’altezza dell’onda di tsunami è in un
certo senso inversamente proporzionale alla profondità dei fondali.
Il terremoto dell’11 gennaio 1848, anche se di minore intensità
rispetto a quello del 1693, provocò gravi danni agli edifici di molti
centri della Sicilia orientale in particolare Catania e Acireale.
Eppure, è passato in sordina a causa dei ben noti eventi storici di
quell’epoca che, segnando importanti tappe della storia d’Italia,
ben presto lo fecero dimenticare… ubi major minor cessat. Qualcuno
parla del Big- One siciliano per analogia con un grande terremoto che
si aspetta a San Francisco. Ovviamente in una zona sismica è logico
aspettarsi un terremoto; prima o poi arriverà perché la Sicilia
orientale è una zona altamente sismica in quanto interessate da un
sistema di faglie altamente sismo genetiche che sono state generate
dalla collisione e conseguente subduzione della placca africana sotto
quella europea. L’Etna quindi non centra nulla anzi potrebbe
essere la conseguenza della tettonica regionale e certamente non la
causa. Anche nella zona dell'Aquila era atteso un forte terremoto,
visto che c'era un gap sismico che durava da 300 anni. Tutto sommato
per quello che si aspettava per la verità non è stato molto
energetico; poteva esserlo molto di più e ciò sicuramente è dovuto
alla liberazione di energia nel corso della crisi sismica che ha
preceduto la scossa più energetica… e poi come si fa a stabilire se
il terremoto accadrà tra 10, 100 o 1000 anni? Quello che si può dire
è che la scienza non ha ancora i mezzi per prevedere con certezza il
verificarsi di un evento sismico e che in Sicilia non si è fatto
nulla e si continua a far nulla per la prevenzione sismica. Per la
verità è bene dire che il radon è un buon precursore sismico e
Giampaolo Giuliani sulla base di una notevole anomalia del radon
registrata alcune decine di ore precedenti l’evento sismico aveva
previsto il terremoto di L’Aquila ma anziché un elogio si è
beccato una denuncia penale per procurato allarme… che possiamo dire…
questa è l’Italia con i suoi pregi ed i suoi difetti.
 L'AVVENTO
DEL BAROCCO
L'AVVENTO
DEL BAROCCO


 i coloro che per secoli lo hanno abitato: i monaci Benedettini.
i coloro che per secoli lo hanno abitato: i monaci Benedettini.







 controllo della campagna
circostante fanno del Settecento il periodo in cui Catania supera
definitivamente altri centri rilevanti del suo hinterland: Acireale,
Paternò, Lentini, Caltagirone.
controllo della campagna
circostante fanno del Settecento il periodo in cui Catania supera
definitivamente altri centri rilevanti del suo hinterland: Acireale,
Paternò, Lentini, Caltagirone.
 Si immolarono per la Patria, o, se
vogliamo, per quella voglia Autonomia alla quale i siciliani
hanno sempre aspirato. Il pensiero corre inevitabilmente
verso la storia. I fatti a cui ci riferiamo, riguardano una
delle pagine più nere, cruente e controverse ch storia
patria ricordi. L’arresto e la fucilazione degli otto
patrioti catanesi colpevoli di aver proclamato, nell’agosto
del 1837, l’indipendenza della Sicilia dai Borbone.
Si immolarono per la Patria, o, se
vogliamo, per quella voglia Autonomia alla quale i siciliani
hanno sempre aspirato. Il pensiero corre inevitabilmente
verso la storia. I fatti a cui ci riferiamo, riguardano una
delle pagine più nere, cruente e controverse ch storia
patria ricordi. L’arresto e la fucilazione degli otto
patrioti catanesi colpevoli di aver proclamato, nell’agosto
del 1837, l’indipendenza della Sicilia dai Borbone.
 diffondendo la carboneria. Nel
1812 era stato concesso ai Siciliani di godere di un proprio
Parlamento, ma fu un’esperienza di breve durata. Esponenti
della borghesia e nobili, cominciarono così a riunirsi.
diffondendo la carboneria. Nel
1812 era stato concesso ai Siciliani di godere di un proprio
Parlamento, ma fu un’esperienza di breve durata. Esponenti
della borghesia e nobili, cominciarono così a riunirsi.
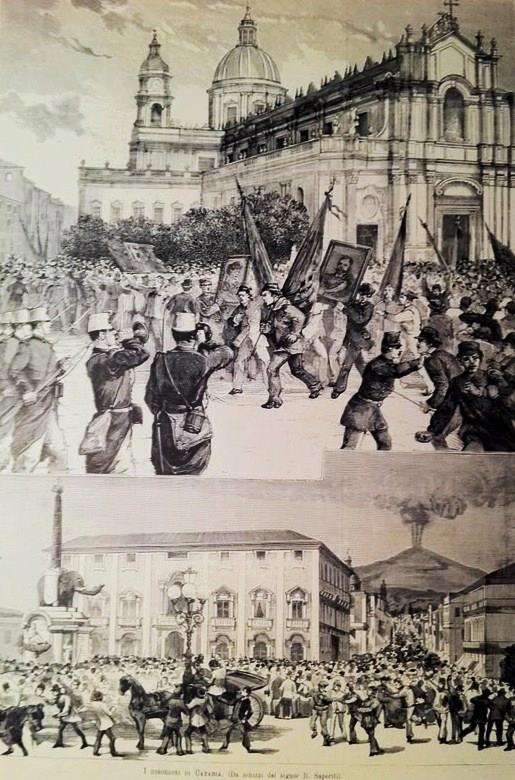

 APRILE
1849 LA BATTAGLIA DI CATANIA CONTRO IL REGGIMENTO SVIZZERO "BERNA" A
CULMINE DELLA RIVOLTA DEL 1848
APRILE
1849 LA BATTAGLIA DI CATANIA CONTRO IL REGGIMENTO SVIZZERO "BERNA" A
CULMINE DELLA RIVOLTA DEL 1848

 I
sanguinosi tentativi risorgimentali per cacciare i Borboni. La
spedizione di Sapri.
I
sanguinosi tentativi risorgimentali per cacciare i Borboni. La
spedizione di Sapri.




 gno di avventure, il giovanissimo Vanni.
gno di avventure, il giovanissimo Vanni.






 Quel
bagno di sangue per un pezzo di sciara
Quel
bagno di sangue per un pezzo di sciara
 SBARCO DI MARSALA: fu di
proposito "visto" in ritardo dalla marina duosiciliana, i cui capi
erano già passati ai piemontesi, e fu protetto dalla flotta inglese,
che con le sue evoluzioni impedí ogni eventuale offesa. Tra i famosi
"mille", che lo stesso Garibaldi il giorno 5 dicembre 1861 a Torino
li definí "Tutti generalmente di origine pessima e per lo piú ladra
; e tranne poche eccezioni con radici genealogiche nel letamaio
della violenza e del delitto", sbarcarono in Sicilia, francesi,
svizzeri, inglesi, indiani, polacchi, russi e soprattutto ungheresi,
tanto che fu costituita una legione ungherese utilizzata per le
repressioni piú feroci. Al seguito di questa vera e propria feccia
umana, sbarcarono altri 22.000 soldati piemontesi appositamente
dichiarati "congedati o disertori".
SBARCO DI MARSALA: fu di
proposito "visto" in ritardo dalla marina duosiciliana, i cui capi
erano già passati ai piemontesi, e fu protetto dalla flotta inglese,
che con le sue evoluzioni impedí ogni eventuale offesa. Tra i famosi
"mille", che lo stesso Garibaldi il giorno 5 dicembre 1861 a Torino
li definí "Tutti generalmente di origine pessima e per lo piú ladra
; e tranne poche eccezioni con radici genealogiche nel letamaio
della violenza e del delitto", sbarcarono in Sicilia, francesi,
svizzeri, inglesi, indiani, polacchi, russi e soprattutto ungheresi,
tanto che fu costituita una legione ungherese utilizzata per le
repressioni piú feroci. Al seguito di questa vera e propria feccia
umana, sbarcarono altri 22.000 soldati piemontesi appositamente
dichiarati "congedati o disertori".

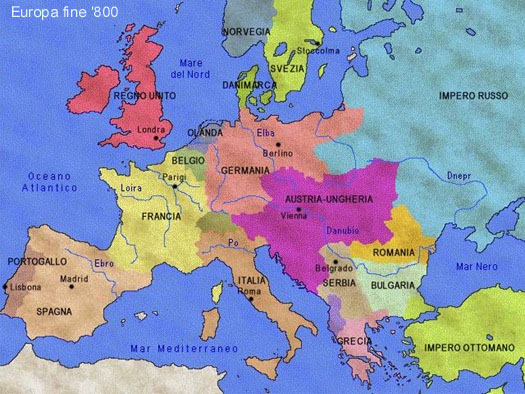







 a via Messina,
ora viale Africa, erano il segno più palese della «grande
marcia» di Catania, che dal 1885 al 1905 fu la principale
sede degli opifici per le lavorazioni dello zolfo.
a via Messina,
ora viale Africa, erano il segno più palese della «grande
marcia» di Catania, che dal 1885 al 1905 fu la principale
sede degli opifici per le lavorazioni dello zolfo.



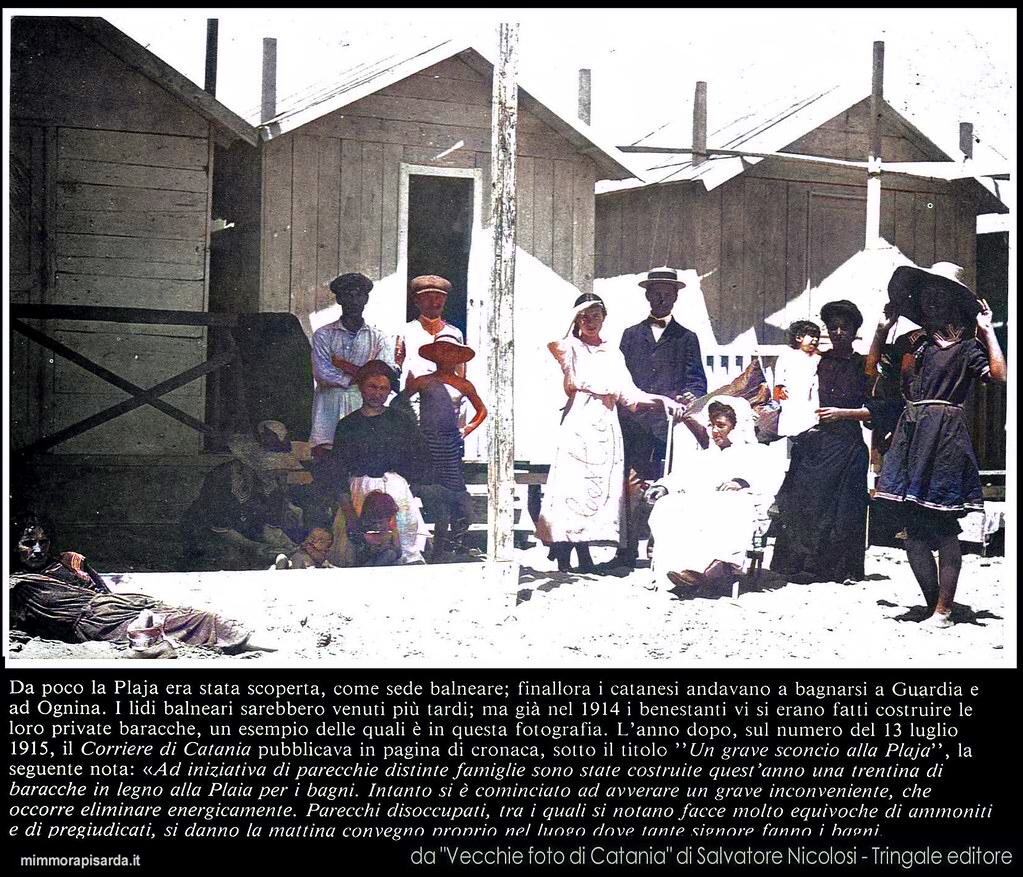











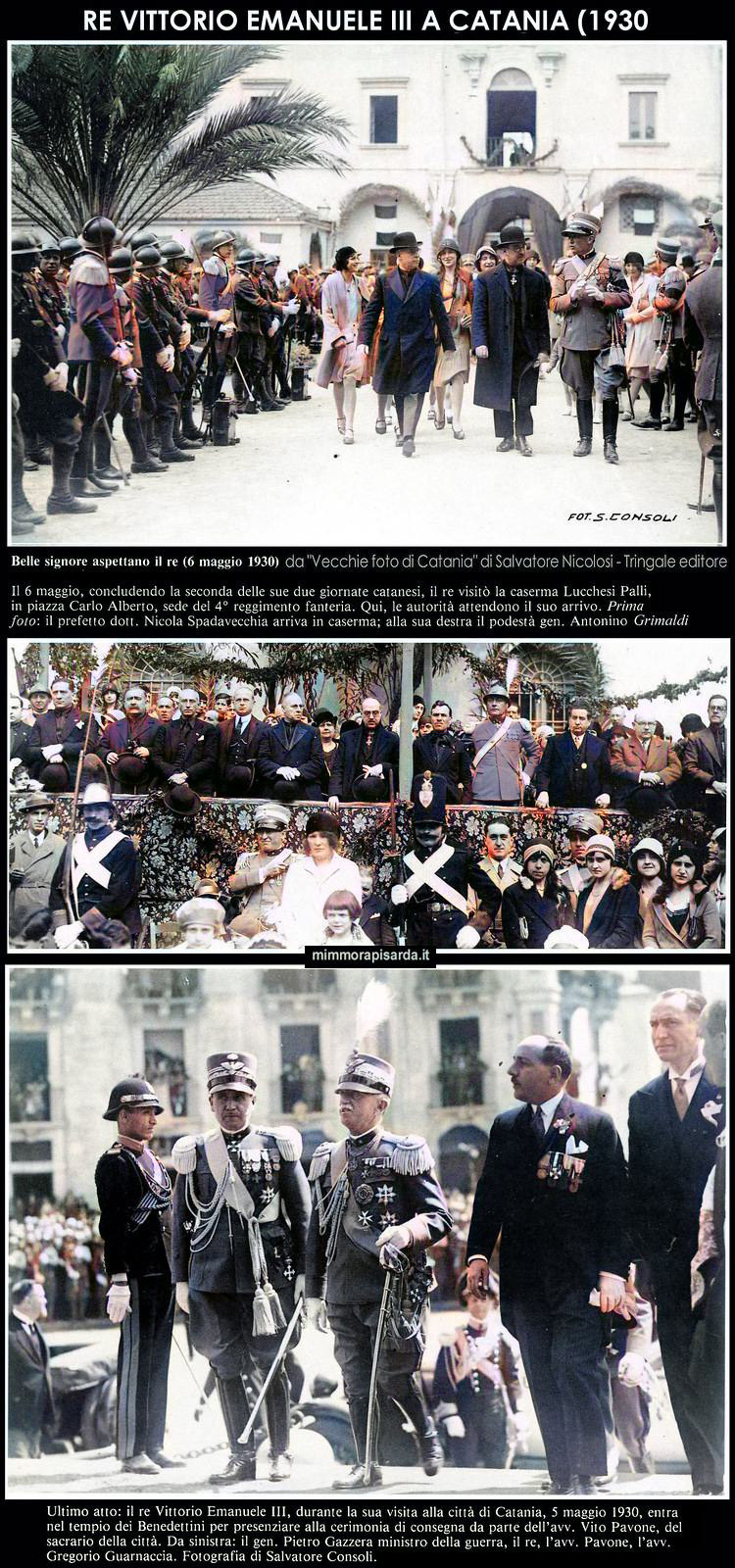

 Donato
Del "Piano; al Teatro, per l'inventiva del Sada e dello
Scimi; nella Casa natale di Bellini, per l'appassionata
raccolta delle memorie del genio; all'opera Balilla. per la
visione avveniristica dell'edificio, entro i cui «grandi
spazi sarà forgiato il carattere delle giovani leve,
speranza di un più fulgido domani della Patria immortale»,
Alla caserma Lucchesi Palli, la folla travolse i cordoni,
circondò l'automobile, gridò al Re. «col fremito vibrante di
tutta l'anima, la sua parola di devozione e di fedeltà».
Donato
Del "Piano; al Teatro, per l'inventiva del Sada e dello
Scimi; nella Casa natale di Bellini, per l'appassionata
raccolta delle memorie del genio; all'opera Balilla. per la
visione avveniristica dell'edificio, entro i cui «grandi
spazi sarà forgiato il carattere delle giovani leve,
speranza di un più fulgido domani della Patria immortale»,
Alla caserma Lucchesi Palli, la folla travolse i cordoni,
circondò l'automobile, gridò al Re. «col fremito vibrante di
tutta l'anima, la sua parola di devozione e di fedeltà».



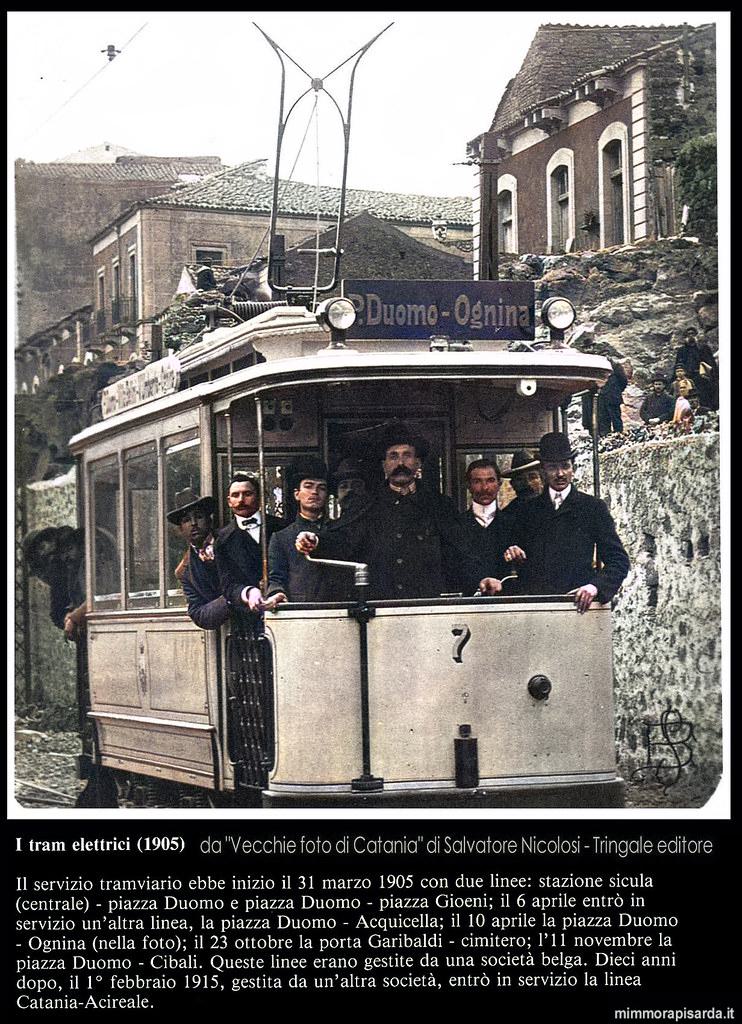






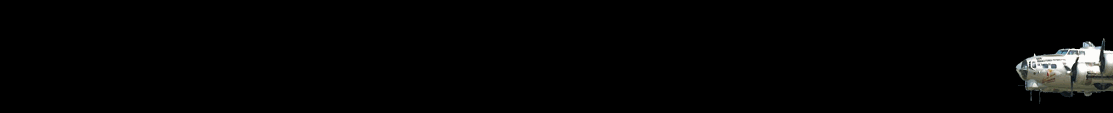



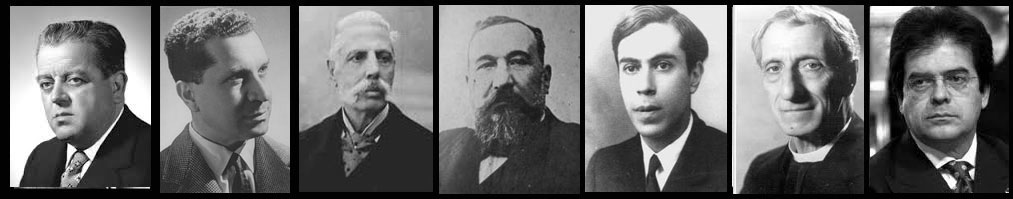



 Agli esordi della sua
carriera realizzò una serie di opere che rinnovarono
profondamente i modelli dell’architettura giapponese,
superando la fase di semplice emulazione dei modelli
occidentali per giungere ad una elaborazione estetica
originale. Riuscì in questo suo intento attraverso una
rilettura in chiave simbolica della tradizione giapponese,
sposata ad un linguaggio molto plastico cui non fu estraneo
l’influsso delle ultime opere di Le Corbusier. Ciò anche
attraverso le esperienze giovanili presso lo studio di Kunio
Mayekawa che aveva effettivamente aperto il Giappone alle
intuizioni del Movimento Moderno ed all’esperienza del
Bauhaus.
Agli esordi della sua
carriera realizzò una serie di opere che rinnovarono
profondamente i modelli dell’architettura giapponese,
superando la fase di semplice emulazione dei modelli
occidentali per giungere ad una elaborazione estetica
originale. Riuscì in questo suo intento attraverso una
rilettura in chiave simbolica della tradizione giapponese,
sposata ad un linguaggio molto plastico cui non fu estraneo
l’influsso delle ultime opere di Le Corbusier. Ciò anche
attraverso le esperienze giovanili presso lo studio di Kunio
Mayekawa che aveva effettivamente aperto il Giappone alle
intuizioni del Movimento Moderno ed all’esperienza del
Bauhaus.
.jpg) Significativo
il ruolo dei parroci di Catania che "mediano" questi
imponenti processi di immigrazione e che, per ciò stesso,
hanno parte attiva nella ridefinizione delle reti
elettorali. Dietro il "popolo", anche la borghesia delle
città dell'area arriva a Catania, città aperta, e vi
trasferisce i capitali che ritrae dalla campagna e dal
patrimonio immobiliare che aliena nel paese di provenienza:
cerca spazio anzitutto nelle professioni, ma anche
nell'accresciuto apparato amministrativo e assistenziale, e
in un mercato in crescita vertiginosa. Sulla struttura del
potere si esercitano in questo decennio due l'orti
sollecitazioni: l'offerta "dall'alto" di risorse dipendenti
dalle ipotesi di "piani industriali" e la pressione sociale
e culturale dal basso cui Catania è sottoposta per il
processo disordinato di riclassificazione sociale fra i ceti
e per l'impressionante domanda di servizi (istruzione,
assistenza, credito, consumi) da parte della Sicilia sud
orienlale e centrale.
Significativo
il ruolo dei parroci di Catania che "mediano" questi
imponenti processi di immigrazione e che, per ciò stesso,
hanno parte attiva nella ridefinizione delle reti
elettorali. Dietro il "popolo", anche la borghesia delle
città dell'area arriva a Catania, città aperta, e vi
trasferisce i capitali che ritrae dalla campagna e dal
patrimonio immobiliare che aliena nel paese di provenienza:
cerca spazio anzitutto nelle professioni, ma anche
nell'accresciuto apparato amministrativo e assistenziale, e
in un mercato in crescita vertiginosa. Sulla struttura del
potere si esercitano in questo decennio due l'orti
sollecitazioni: l'offerta "dall'alto" di risorse dipendenti
dalle ipotesi di "piani industriali" e la pressione sociale
e culturale dal basso cui Catania è sottoposta per il
processo disordinato di riclassificazione sociale fra i ceti
e per l'impressionante domanda di servizi (istruzione,
assistenza, credito, consumi) da parte della Sicilia sud
orienlale e centrale.
 pensare e scrivere il saggio
su Catania, che - vorrei notarlo - precede la mia difficile
esperienza amministrativa Ma il processo di modernizzazione,
pur confuso e squilibrato, è avvenuto qui, come in altre
grandi città del Mezzogiorno, nonostante la politica e non
certo per iniziativa di un ceto politico incerto e
frastornato e in balia ormai, qui come altrove, di affaristi
e procacciatori d'affari. Bisognerà attendere i primi anni
Novanta per riavviare, ma su differenti binari, un processo
che si era da tempo sfiancato a Catania, nel Mezzogiorno,
nel paese. Nel contempo si fa strada l'idea che solo un
ventaglio di esili - industria, commercio, servizi - può
dare a una capitale moderna un'identità che non sia
nostalgica o utopica.
pensare e scrivere il saggio
su Catania, che - vorrei notarlo - precede la mia difficile
esperienza amministrativa Ma il processo di modernizzazione,
pur confuso e squilibrato, è avvenuto qui, come in altre
grandi città del Mezzogiorno, nonostante la politica e non
certo per iniziativa di un ceto politico incerto e
frastornato e in balia ormai, qui come altrove, di affaristi
e procacciatori d'affari. Bisognerà attendere i primi anni
Novanta per riavviare, ma su differenti binari, un processo
che si era da tempo sfiancato a Catania, nel Mezzogiorno,
nel paese. Nel contempo si fa strada l'idea che solo un
ventaglio di esili - industria, commercio, servizi - può
dare a una capitale moderna un'identità che non sia
nostalgica o utopica.
.jpg)



 si
arriva al 77% contro un 22% di destinazioni finanziarie.
si
arriva al 77% contro un 22% di destinazioni finanziarie.


 IL
PAPA A CATANIA. viaggio in Sicilia. davanti a migliaia di
persone il Pontefice ha usato parole forti e invitato la
citta' " a stare in piedi e sconfiggere il male ". Il Papa:
alzatevi e vinciamo la mafia!.
IL
PAPA A CATANIA. viaggio in Sicilia. davanti a migliaia di
persone il Pontefice ha usato parole forti e invitato la
citta' " a stare in piedi e sconfiggere il male ". Il Papa:
alzatevi e vinciamo la mafia!.
 arroganti
e i prepotenti insidiano la nostra vita". E subito ha
applicato a Catania le parole che Isaia usa per Gerusalemme:
"La Chiesa sente il dovere di parlare, anzi di gridare a
quanti abitano nella citta' : Catania, alzati e rivestiti di
luce e di giustizia". Il Papa restera' in Sicilia tre
giorni: oggi pomeriggio passa da Catania a Siracusa, domani
sera rientra a Roma. Fara' sette discorsi e gia' dal primo
sappiamo che non girera' intorno ai problemi, ma li
prendera' di petto come gia' fece un anno e mezzo fa ad
Agrigento, quando grido' ai mafiosi: "Convertitevi, una
volta verra' il giudizio di Dio!". Quel grido aveva la forza
di una scomunica, segno' un punto di non ritorno nell'
impegno della Chiesa contro la mafia. Cosi' e' stato
interpretato anche fuori dalla Sicilia: il camorrista
Carmine Alfieri ha detto ai giudici che decise di
"collaborare" con la giustizia quando vide il Papa in
televisione lanciare quel monito. Pare che la stessa mafia
siciliana l' abbia preso sul serio quel grido lanciato nella
Valle dei Templi di Agrigento. Il luglio scorso il
procuratore della Repubblica di Roma Michele Coiro disse che
c' erano dei pentiti di mafia che avevano parlato di una
risposta della Cupola al Papa, che era andata dalle bombe
del luglio 1993 alle chiese di Roma all' uccisione di don
Puglisi. E' verosimile che il Papa approfitti di questa
visita per completare il messaggio di Agrigento. E ce n' e'
bisogno, dicono i sacerdoti siciliani che lottano in prima
linea contro la mafia. Ultimamente un prete palermitano e'
stato costretto ad abbandonare il campo dalle minacce
mafiose: gli avevano indicato perfino il giorno in cui l'
avrebbero ucciso. E un altro, domenica scorsa, ha visto un
gruppo di fedeli alzarsi e lasciare la chiesa appena
pronunciata la parola mafia, durante una predica in cui
invitava al riscatto, proprio come ha fatto il Papa ieri qui
a Catania. A Catania e a Siracusa il Papa doveva venire a
fine aprile: glielo impedi' la caduta in bagno che lo porto'
al "Gemelli". Sono passati sei mesi e Wojtyla ricammina
senza bastone, come gli avevano promesso i medici. Ieri per
un momento il bastone l' ha portato, ma tenendolo con la
mano sinistra (la gamba operata e' la destra) e senza
appoggiarvisi sopra. Ieri era anche l' onomastico di Karol
Wojtyla, essendo la festa di San Carlo Borromeo.
arroganti
e i prepotenti insidiano la nostra vita". E subito ha
applicato a Catania le parole che Isaia usa per Gerusalemme:
"La Chiesa sente il dovere di parlare, anzi di gridare a
quanti abitano nella citta' : Catania, alzati e rivestiti di
luce e di giustizia". Il Papa restera' in Sicilia tre
giorni: oggi pomeriggio passa da Catania a Siracusa, domani
sera rientra a Roma. Fara' sette discorsi e gia' dal primo
sappiamo che non girera' intorno ai problemi, ma li
prendera' di petto come gia' fece un anno e mezzo fa ad
Agrigento, quando grido' ai mafiosi: "Convertitevi, una
volta verra' il giudizio di Dio!". Quel grido aveva la forza
di una scomunica, segno' un punto di non ritorno nell'
impegno della Chiesa contro la mafia. Cosi' e' stato
interpretato anche fuori dalla Sicilia: il camorrista
Carmine Alfieri ha detto ai giudici che decise di
"collaborare" con la giustizia quando vide il Papa in
televisione lanciare quel monito. Pare che la stessa mafia
siciliana l' abbia preso sul serio quel grido lanciato nella
Valle dei Templi di Agrigento. Il luglio scorso il
procuratore della Repubblica di Roma Michele Coiro disse che
c' erano dei pentiti di mafia che avevano parlato di una
risposta della Cupola al Papa, che era andata dalle bombe
del luglio 1993 alle chiese di Roma all' uccisione di don
Puglisi. E' verosimile che il Papa approfitti di questa
visita per completare il messaggio di Agrigento. E ce n' e'
bisogno, dicono i sacerdoti siciliani che lottano in prima
linea contro la mafia. Ultimamente un prete palermitano e'
stato costretto ad abbandonare il campo dalle minacce
mafiose: gli avevano indicato perfino il giorno in cui l'
avrebbero ucciso. E un altro, domenica scorsa, ha visto un
gruppo di fedeli alzarsi e lasciare la chiesa appena
pronunciata la parola mafia, durante una predica in cui
invitava al riscatto, proprio come ha fatto il Papa ieri qui
a Catania. A Catania e a Siracusa il Papa doveva venire a
fine aprile: glielo impedi' la caduta in bagno che lo porto'
al "Gemelli". Sono passati sei mesi e Wojtyla ricammina
senza bastone, come gli avevano promesso i medici. Ieri per
un momento il bastone l' ha portato, ma tenendolo con la
mano sinistra (la gamba operata e' la destra) e senza
appoggiarvisi sopra. Ieri era anche l' onomastico di Karol
Wojtyla, essendo la festa di San Carlo Borromeo.

 lla, né ha mai parlato. Sulle sue condizioni è
caduto il silenzio. Si sa soltanto che è quasi
cieco a causa del forte diabete e si dice che
soffra di licantropia per cui si metterebbe a
urlare nelle notti di luna. Guarda caso, anche
l'operazione della sua cattura era stata
soprannominata «Luna piena».
lla, né ha mai parlato. Sulle sue condizioni è
caduto il silenzio. Si sa soltanto che è quasi
cieco a causa del forte diabete e si dice che
soffra di licantropia per cui si metterebbe a
urlare nelle notti di luna. Guarda caso, anche
l'operazione della sua cattura era stata
soprannominata «Luna piena».