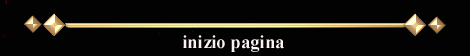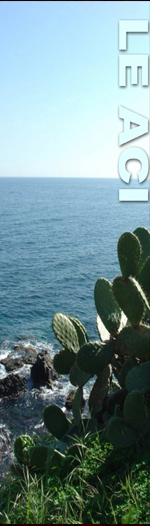Secondo
il racconto che Ulisse fa dei suoi viaggi ai Feaci (Od. IX-X), la cui
isola, Scheria, sin dall'antichità si identificò con Corcira.(Corfù)
(G. De Sanctis), quando, al ritorno da Ilio, sta per doppiare il Capo
Malea, un vento che viene da Nord lo respinge indietro lungo Citera (Cerigo):
Al 10° giorno approda al paese dei Lotofagi (IX, vv. 103-133). Gli
antichi lo collocavano sulle coste della Libia; talora invece nei pressi
di Agrigento e Camarina., come pensano anche il Columba ed il Pace. I
Greci gustano i germogli del loto offerti dagli indigeni e dimentichi di
tutto vorrebbero restare. A stento Ulisse li fa imbarcare e ripreso il
viaggio per mare. giunge nella terra dei Ciclopi , localizzata sin
dall'antichità presso l'Etna.. Vicino alla costa c'è un'isoletta
boscosa, abitata solo da capre. Attraccano nel porto ben protetto dai
venti. Durante la notte “una densa caligine stava intorno alle
navi”. Il giorno seguente scendono nell'isola e vanno a caccia di
capre.
Secondo
il racconto che Ulisse fa dei suoi viaggi ai Feaci (Od. IX-X), la cui
isola, Scheria, sin dall'antichità si identificò con Corcira.(Corfù)
(G. De Sanctis), quando, al ritorno da Ilio, sta per doppiare il Capo
Malea, un vento che viene da Nord lo respinge indietro lungo Citera (Cerigo):
Al 10° giorno approda al paese dei Lotofagi (IX, vv. 103-133). Gli
antichi lo collocavano sulle coste della Libia; talora invece nei pressi
di Agrigento e Camarina., come pensano anche il Columba ed il Pace. I
Greci gustano i germogli del loto offerti dagli indigeni e dimentichi di
tutto vorrebbero restare. A stento Ulisse li fa imbarcare e ripreso il
viaggio per mare. giunge nella terra dei Ciclopi , localizzata sin
dall'antichità presso l'Etna.. Vicino alla costa c'è un'isoletta
boscosa, abitata solo da capre. Attraccano nel porto ben protetto dai
venti. Durante la notte “una densa caligine stava intorno alle
navi”. Il giorno seguente scendono nell'isola e vanno a caccia di
capre.
L'isoletta
potrebbe essere l'Isola Lachea o di Aci, la più grande dei cosiddetti
“Scogli dei Ciclopi” di Acitrezza, e “la densa caligine” può
indicare le nere ceneri spesso vomitate dall'Etna. Il porticciolo può
ben essere l'altro “Porto di Ulisse ”, oggi Ognina. Dopo il famoso
episodio di Polifemo e la fuga per mare, l'eroe giunge all'Isola Eolia ,
identificata con Stromboli, Vulcano o Lipari, cioè una delle isole
chiamate appunto Eolie. Da questa passano nel paese dei Lestrigoni ,
antropofagi, identificato probabilmente con la piana di Catania.
Scampato ai Lestrigoni, con una sola nave Ulisse giunge all'isola Eea,
dimora di Circe, figlia del Sole e di Persa, generata da Oceano,
identificata col Promontorio Circeo (Eneide VII, 10ss.), nel Lazio,
considerato dagli antichi come un'isola. Passato un anno riparte e dopo
esser approdato nel misterioso paese dei Cimmeri, scende negli Inferi ,
nel regno di Plutone. Gli inferi sono localizzati a Cuma presso il lago
Averno, nelle cui vicine cavità sotterranee vivevano i Cimmeri.
Nell'Ade
l'indovino Tiresia lo informa dei suoi casi futuri e come evitare i
pericoli. “Tutti del mar vinti i perigli”, egli vaticina
“approderai col ben formato legno alla verde Trinacria Isola, in cui
pascon del Sol, che tutto vede ed ode, i nitidi montoni e i buoi
lucenti….”. Lo ammonisce a non toccare i sacri buoi pena gravi
sciagure. Ritornato da Circe, l'eroe riceve da costei conferma delle
predizioni e ammonimenti di Tiresia.. Dopo aver superato le insidie
delle Sirene e di Scilla e Cariddi, la maga gli predice, “Allor
incontro ti verrai le belle spiaggie della Trinacria isola, dove pasce
il gregge del Sol, pasce l'armento:….se giovenca molestate od agna,
sterminio a te predico, e al legno e a' tuoi.”. La triste predizione
purtroppo si avvera. Infatti l'eroe riparte, vince prima il pericolo
delle Sirene , la cui isola si è cercata nella penisola Sorrentina e le
loro tombe in Campania; quella della Sirena Partenope nel sito della
futura Napoli, la città Partenopea.
Altri però, meno verosimilmente,
fissano la loro sede vicino allo stretto di Messina, all'Etna, Catania,
Capo Posidonio. Ulisse oltrepassa.quindi Scilla e Cariddi , indicate
nello stretto di Messina, e subito gli appare l'Isola del Sole. Ulisse
vorrebbe evitarla, ma i suoi compagni vog liono approdare per non
incorrere, specie di notte, nelle tempeste e nei disastrosi venti. :
“Or chi fuggir potrà l'ultimo danno” dice Euriloco, “dove repente
un procelloso fiato di Mezzodì ci assalga, o di Ponente, che, de' Numi
anco ad onta il legno sperda?”.
liono approdare per non
incorrere, specie di notte, nelle tempeste e nei disastrosi venti. :
“Or chi fuggir potrà l'ultimo danno” dice Euriloco, “dove repente
un procelloso fiato di Mezzodì ci assalga, o di Ponente, che, de' Numi
anco ad onta il legno sperda?”.
Importante
questo riferimento ai venti di Mezzogiorno e di Ponente che sono proprio
quelli che dominano nel nostro versante e causano spesso violente
tempeste. Nel versante ionico invece domina il levante e lo scirocco; Le
navi dunque avevano superato il Capo Pachino e si trovavano nel nostro
litorale!
Ulisse
cede e decide di approdare.al calar del sole e “nel porto appo una
fonte e lauta cena apparecchiar sul lido”. Rientrati nelle navi,
quando erano passati i due terzi della notte, il cielo diventò
minaccioso, come spesso capita nel nostro litorale, ma non si scatenò
una tempesta. “Declinavan le stelle, quando il cinto di nembi Olimpio
Giove destò un gagliardo turbinoso vento, che la terra coverse ed il
mar di nubi, e la notte di cielo a piombo cadde. Ma, al sorgere
dell'Aurora il cielo si rasserenò, “tirammo a secco il legno ed in
cavo speco, dei seggi ornato delle Ninfe, ch'ivi i lor balli tessean,
l'introducemmo”.
Ebbene
questo porto può ben essere il nostro Porto Ulisse , come confermano il
nome e le fonti antiche! La sorgente poteva essere il fiumicello che
allora dai pantani sboccava a mare. Invero l'ampia spiaggia sabbiosa di
Porto Ulisse è adattissima per tirare a secco le leggere navi omeriche
dal basso pescaggio, mentre la vicina costa della Marza era piena di
spelonche dove potersi riparare, come scrive il Camilliani nel 1584. E
nella zona non mancavano oltre le grotte, fiumi, laghi, sorgenti,
boschi, dove avevano dimora le Ninfe della mitologia greca! I Greci si
trattengono nella nostra zona per un mese perché i venti non erano
favorevoli alla navigazione. E durante questa dimora possiamo collocare
la costruzione del tempio e del cenotafio , di cui parla Licofrone!.
“Per
un intero mese Austro [vento del Sud] giammai di spirar non restava, e
poscia fiato non sorgeva mai, che di Levante od Austro.”.
Questi
venti, specie lo Scirocco, gonfiano infatti il nostro mare e durano
parecchi giorni, impedendo l'uscita delle barche e dei pescherecci.
Durante
questa sosta forzata, i compagni di Ulisse giravano “ dispersi per
l'isola, d'augelli e pesci in traccia, con archi ed ami o di qual altra
preda lor venisse alle man…”. Viene in mente la suggestiva
descrizione del F azello “Nella città scorre una grandissima sorgente,
per cui tutta questa zona del litorale, oggi chiamata Ficallo, coi suoi
fiumi, torrenti, laghi, fonti straordinariamente irrigue, offre agli
uomini svariati piaceri, soprattutto con la pesca, l'uccellagione e la
caccia.”.
azello “Nella città scorre una grandissima sorgente,
per cui tutta questa zona del litorale, oggi chiamata Ficallo, coi suoi
fiumi, torrenti, laghi, fonti straordinariamente irrigue, offre agli
uomini svariati piaceri, soprattutto con la pesca, l'uccellagione e la
caccia.”.
Ulisse
cerca una “solitaria piaggia, gli Eterni a supplicar se alcuna via mi
si mostrasse del ritorno”. E certo l'eroe poté appartarsi in una
delle numerose piccole insenature della vicina scogliera della Marza!
I
compagni però, spinti dalla fame, rompono il giuramento fatto al loro
capo di non toccare i vitelli del Sole e di nascosto, “ del Sol
cacciate le più belle vacche di fronte larga e con le corna in alto,
che dalla nave non pascean lontane” (vv. 456-58), le arrostiscono al
fuoco e se ne cibano.
Le
vacche e gli armenti del Sole, considerate sacre come oggi per gli Indù
che non se ne cibano, potevano ben essere quelli della razza modicana,
come dice il Caruso, ma dovevano pascolare nelle vicine nostre contrade
della Marza e S. Maria, perché “dalla nave non pascean lontane”.
Una conferma possiamo trovarla nell'etimo da noi proposto del fiume
della Cava d'Ispica, Busaitone, dalle parole greche “bous = bue e
“aedòn” = canto, muggito. Ma anche la derivazione da Poseidone,
proposta da B. Pace, può mettersi in relazione col Dio del Mare, padre
di Poliremo e fiero nemico di Ulisse, che lo aveva accecato. Anche il
tempio di Apollo Libistino , di cui parla Macrobio, sito nel versante
orientale di Porto Ulisse, preesistente allo sbarco dei Libici, come già
notava il Cluverio, potè essere eretto per riparare l'offesa fatta a
Febo-Apollo, Dio del Sole, dallo stesso Ulisse o dai Greci che, dopo di
lui, vennero a colonizzare la nostra Isola. Una relazione, anche se
debole, potremmo trovarla ancora con le “ Secche di Circe ”,
distanti ca. Km.1,3 da Cirica, cosiddette non sappiamo se per voce
popolare o per indicazione di qualche studioso del sette-ottocento;
infatti. questo toponimo non si riscontra nelle carte antiche ed è
segnato solo nelle carte nautiche. Invero, se sulla base del testo
Omerico è da escludere che l'isola Eea di Circe fosse nel nostro
territorio, si può tener conto che Circe era figlia del Sole.
Malgrado
i lamenti e i rimproveri ai suoi di Ulisse, ignaro ed innocente del
misfatto, Giove vendica l'irato Sole. Infatti dopo sei giorni, cessato
“il turbinoso vento”, si misero in mare. “Di vista già della
Trinacria usciti”, dopo breve tratto, “uno stridulo ponente”,
colpisce
 la nave. Le acque si intenebrarono, un vento impetuoso
imperversò, ruppe le funi, le vele e l'albero maestro. La nave, colpita
dal fulmine di Giove si inabissa coi compagni e a stento l'eroe si salva
legandosi all'albero spezzato. Egli supera incolume ancora una volta
Scilla e Cariddi, .e dopo nove giorni in preda ai flutti, viene sbattuto
nell'isola di Ogigia , dove è accolto dalla ninfa Calipso . Questa
isola si è cercata a Gozo, nell'arcipelago maltese; ma è più
probabile l'isola Melena o Nufea nell'Illiria (Albania).
la nave. Le acque si intenebrarono, un vento impetuoso
imperversò, ruppe le funi, le vele e l'albero maestro. La nave, colpita
dal fulmine di Giove si inabissa coi compagni e a stento l'eroe si salva
legandosi all'albero spezzato. Egli supera incolume ancora una volta
Scilla e Cariddi, .e dopo nove giorni in preda ai flutti, viene sbattuto
nell'isola di Ogigia , dove è accolto dalla ninfa Calipso . Questa
isola si è cercata a Gozo, nell'arcipelago maltese; ma è più
probabile l'isola Melena o Nufea nell'Illiria (Albania).
Questa
descrizione corrisponde alle condizioni meteorologiche della nostra
zona. Il “turbinoso vento” che ostacolava l'uscita in mare, allora
come oggi, è lo scirocco; la nave non era molto distante da Porto
Ulisse e non aveva ancora girato Capo Pachino, perché viene colpita dal
vento di Ponente, dominante nel nostro litorale a sud, mentre il
versante ionico ne è riparato. E' poi evidente che l'eroe ritorna
indietro spinto dal Ponente, perché non poteva andare controvento lungo
il versante meridionale.
Un
riferimento alla leggenda dello sbarco di Ulisse nel nostro porto si può
rinvenire ancora nell'accenno di Virgilio (3° Eneide, vv. 698-670):
“Oltrepassiamo il pingue suolo dello stagnate Eloro, indi rasentiamo
gli alti scogli e le rocce prominenti di Pachino….” Enea naviga
costeggiando il litorale ionico da nord a sud e, superato il Capo
Pachino, passa oltre il Promontorio Odisseo e prosegue per Camarina,
Gela, Agrigento fino a Trapani: è in parte lo stesso itinerario fatto
all'inverso da Ulisse, come ricorda il suo compagno Achemenide che
mostra ad Enea i lidi già percorsi. E invero se riferiamo “gli alti
scogli” a Capo Pachino, cioè all'alta punta rocciosa dell'Isola di
Capo Passero, allora unita alla terraferma, possiamo ben intendere per
“le roccie che si protendeno innanzi” la nostra Punta Castellazzo,
dove già ai tempi di Virgilio c'era il castello romano dei tempi di
Verre (Cicerone, Verrine lib. V).
Prof.
Melchiorre Trigilia
https://win.lasiciliainrete.it/STORIAECULTURA/TRIGILIA/ULISSE/ulisse.htm


Efesto (Ἥφαιστος), figlio di Era, è
il Dio del fuoco e delle fucine, ma anche della scultura, della
metallurgia e dell’ingegneria. Coniuge di Afrodite e conosciuto nel
mondo romano come Vulcano (Vulcanus), Efesto è una divinità olimpica,
ossia uno dei dodici Dei dell’Olimpo.
Nell'
Iliade, Omero ci racconta di come Efesto fosse brutto e di cattivo
carattere, ma con una grande forza nei muscoli delle braccia e delle
spalle, per cui tutto ciò che faceva era di un'impareggiabile
perfezione.
Essendo
accorso in aiuto della madre Era durante un litigio con Zeus, Efesto
dovette subire le ire del padre che, infuriato, lo scaraventò giù
dall'Olimpo. Nella caduta si fratturò le gambe per cui da quel giorno
camminò zoppicando.
Efesto
aveva le sue fucine nelle viscere dell' Etna e nelle isole Eolie, a
Vulcano e Lipari . I suoi aiutanti erano i Ciclopi monocoli.

Efesto
era un fabbro, un artista eccellente,un orafo inimitabile. Tutti gli dei
e gli eroi ricorrevano a lui per avere armi invincibili e preziose. La
sua fucina però non era sull’Olimpo ma dentro i vulcani e sai
perché?….
Quando
Efesto nacque era così brutto che la bellissima mamma, Era, lanciò un
grido di orrore e non seppe resistere all’impulso di gettarlo via. Lo
buttò, dunque, giù dall’Olimpo. Il piccino cadde, continuò a
rotolare per un intero giorno ed una notte fino a quando atterrò su un’isola.
Era Lemno, l’attuale Sicilia, terra vulcanica, dove abitavano le
"ninfe". Il bimbo fu amorevolmente raccolto ed accudito da
loro. Amava giocare sull’Etna, era attratto
dall’eruzione del monte;
gli piacevano il colore delle fiamme, i lapilli che schizzavano via come
saette, la lava che, colando giù, creava delle lingue rosse in
movimento….Efesto ammirava emozionato ed entusiasta…!
Il
grande Zeus, suo padre, commosso dal fatto che era un figlio ripudiato,
lo nominò "dio del fuoco" e gli fece costruire la sua
officina nel "cratere" dell’Etna dove Efesto lavorava
allegramente in compagnia dei Ciclopi.

Il
dio del fuoco, qualche volta, quando era più triste e stanco del
solito, era tormentato dal fatto che a ridurlo così fosse stata sua
madre, quando lo aveva buttato via come un giocattolo rotto. Giorno dopo
giorno ideò la sua vendetta.
Preparò
per la madre Era un regalo che sembrava bellissimo: era un trono
elegante, luccicante, tutto d’oro, tempestato di brillanti e smeraldi
scolpito con l’abilità del migliore maestro.
In
verità, quando Era vi si sedette, quel trono regale si trasformò in
una trappola: era legata da fili invisibili, tenaci, potenti, comandati
da un meccanismo infernale che nemmeno il capo degli dei sapeva
disinnescare. Tutti gli dei, compreso Zeus, lo supplicarono di slegare
la madre. Efesto lo fece ma chiese in cambio di poter abitare anche lui
sull’Olimpo come tutti i suoi fratelli. Era sì brutto, ma pur sempre
un dio! Zeus accettò, Era fu liberata ed Efesto soddisfatto. Nell’Olimpo
però vi rimase per poco tempo perché si trovava meglio tra i suoi
Ciclopi.
Ha
ispirato scrittori e poeti come Virgilio, Dante, Esiodo.
E' di Virgilio il
terzo libro dell'Eneide,la magistrale descrizione dell'Etna,così come
la Mitologia lega miti al vulcano:Tifeo,il gigante che volle sfidare il
Dio Giove nella scalata del cielo,li venne rinchiuso il quale ancora
oggi con la sua collera erutta lapilli e lingue di fuoco.Gli
antichi guardavano il monte con paura e rispetto, poiché " li
" vi era la dimora di Vulcano, Dio del fuoco e dei Ciclopi. Gli
antichi navigatori del Mediterraneo lo conoscevano bene, perché molte
volte faceva loro da faro, ed il suo breve
nome esiste dagli albori
della civiltà.Il suo significato perciò si perde nella notte dei tempi
e degli antichi idiomi. Gli Arabi ne rimasero tanto colpiti da definirlo
"il monte dei monti"("Mongibello"), la montagna per
antonomasia. L'Etna ha circa 500.000 di anni, nata da un fenomeno legato
alla divisione dei continenti e allo scontro che avvenne tra la
piattaforma tettonica Afro-Asiatica,causò l'espulsione di magma dai
fondali marini violentemente dando vita al vulcano cosi come alla catena
delle Alpi in Europa e dell' Himalaya in Asia.
Nel corso delle ere
geologiche L'Etna ha modificato la sua "veste" con le sue notevoli eruzioni, le
conosciute sono molte , ma certamente inferiori a quelle realmente avvenute.Dalla storia, già secoli prima della nascita
di Cristo si descrive delle attività vulcaniche , negli anni 575 e 396
a.C. Una delle più grandi attività del vulcano, anticipate da
terremoti si manifestò nel 1669 dando vita a nuove bocche eruttive che
in meno di venti giorni distrusse la cittadina di Nicolosi e parte della
città di Catania.Nel 1881, devastante eruzione ebbe luogo nella valle
del Bove formando nuovi crateri.

L'officina
L’Etna e Gli Antichi Miti
Perfino i Greci raccontavano fiabe
mitologiche sul vulcano Etna e proprio dai loro scritti sono giunte fino a noi
bellissime leggende. Come quella della Fucina di Efesto. Secondo il mito, Efesto
fu cacciato violentemente dall’Olimpo dopo un litigio con Giove. Atterrò di malo
modo su una bellissima isola causando un buco in una montagna. Efesto decise
quindi di utilizzare quella stessa montagna come propria officina di fabbro … ed
ecco perché da allora l’Etna spruzza scintille di fuoco!
Un altro mito greco è legato al gigante
Tifeo. La sua punizione per aver sfidato Giove fu quella di essere legato mani e
piedi e condannato a sorreggere la Sicilia per sempre: i suoi piedi sarebbero
sul capo Lilibeo, il suo braccio destro è legato al capo Faro o Peloro e il
braccio sinistro, in basso, sul capo Passero. La sua testa giace sotto l’Etna,
per cui quando il vulcano brontola ed emana fuoco è in realtà il lamento di
protesta di Tifeo.
Tutti
conoscono la storia del pastorello Aci innamorato della ninfa marina Galatea. I
due amanti furono contrastati dal ciclope Polifemo, il quale per avere la bella
tutta per sé, uccise Aci lanciandogli contro enormi massi. Polifemo in realtà è
l’Etna, il suo unico occhio rappresenta il bagliore rosso del cratere, e ogni
tanto ancora, come allora, lancia enormi pietre pericolose in aria.
Grazia Musumeci
https://www.go-etna.it/blog/miti-e-leggende-legati-alletna/
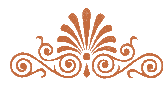


Il web è già abbastanza inflazionato di articoli inerenti alle
isole Eolie, le sette perle del Tirreno Meridionale ricche di storia,
fascino e suggestioni. Per tale ragione, vorrei soffermarmi a descrivere
soprattutto gli aspetti più misteriosi di questo meraviglioso
arcipelago siciliano, con particolare attenzione ai colori che ogni
singola isola sa esprimere, quasi a voler gareggiare, come tante
primedonne, nella vanità della quotidiana rappresentazione scenica
della natura; ma l'interesse viene catalizzato irresistibilmente anche
da tutte quelle leggende, a metà fra tradizione popolare e realtà
storica, che ancora oggi si tramandano nelle isole del fuoco e del
vento.
Tutta la Sicilia
respira di millenni di storia, spesso intrecciati col mito, ma alle
Eolie è facile confondere la leggenda con la realtà, tanto appaiono
naturalmente verosimili i racconti dei pescatori che parlano di fate,
eroi o entità divine, con gli occhi di bambini innamorati della loro
terra, mentre a volte si può restare increduli di fronte a storie vere
perse nella notte dei tempi e dalla trama sorprendentemente insolita.
Già nelle origini del
loro nome, le Eolie tradiscono la propria genesi mitica; è l'Odissea di
Omero a raccontarci che le isole sono la dimora del dio dei venti, Eolo.
Secondo una delle tante leggende, Eolo e il gemello Beoto nascono
dall'amore segreto di Melanippa per Poseidone (Nettuno); il nonno
materno, per punire la figlia, consegna Melanippa a un abitante di
Metaponto, che adotta i due bambini.
I due gemelli,
diventati adulti, prendono il potere e uccidono la moglie del padre
adottivo, per vendicarne le angherie che questa infliggeva alla madre
naturale. In seguito a tale episodio, sono costretti a fuggire, Beoto in
Tessaglia, mentre Eolo si rifugia nelle isole dove egli stesso fonda la
città di Lipara.
Eolo, narra l'Odissea,
custodiva i venti dentro alcuni otri; abitava insieme ai suoi 12 figli
(sei maschi e sei femmine, sposati fra loro) nelle isole della Sicilia
che da lui presero il nome Eolie. Dopo avere accolto Ulisse, gli fece
dono dei venti chiusi in un otre, che i suoi compagni incautamente
aprirono, pensando custodisse un tesoro, provocando in tal modo una
furiosa tempesta che fece ritornare la nave verso le Eolie: Eolo,
credendo che Ulisse fosse perseguitato dagli dei, si rifiutò di
aiutarlo e lo allontanò dalle isole.

Le Eolie rappresentano la
porta della Sicilia. Lì arrivò Ulisse con la sua flottiglia, già provata da un
lungo vagare per mari ignoti. Quando approdarono alle Isole Eolie, Ulisse e i
suoi erano appena sfuggiti ai massi del Ciclope. Lì Ulisse incontrò Eolo, il dio
dei venti, che voleva che l'eroe greco raccontasse le sue imprese e le storie
della guerra.
Per un mese intero
Ulisse si fermò da Eolo.
In realtà, le Isole
Eolie nascono in fasi successive come vulcani sottomarini quasi due
milioni di anni fa, ma vengono abitate dalla fine del V millennio A.C.
da popolazioni provenienti dalla Sicilia e stanziatesi a Lipari, Salina
e Filicudi per sfruttare la risorsa economica dell'ossidiana, eruttata
dal Monte Pelato, sulla costa Nord Orientale di Lipari. L'ossidiana, una
sorta di vetro naturale nero e brillante, per quanto possa apparire
strano, ha la stessa composizione chimica della bianca pomice, dalla
quale differisce unicamente per lo stato vetroso anziché spugnoso,
generato dalla repentina diminuzione della temperatura della colata
lavica nella fase terminale delle eruzioni.
E' incredibile come due
materiali così diversi, uno scuro e pesante, l'altro candido e leggero
(tanto da galleggiare sul mare anche a chilometri di distanza), possano
avere la medesima origine; certo è che dell'esportazione dell'ossidiana
di Lipari, il materiale più tagliente allora disponibile in natura, vi
è ampia traccia oltre che in Sicilia, in Liguria, nella Francia
meridionale e persino nella lontana Dalmazia.
Geograficamente, le
sette isole sono disposte a semicerchio, poco più a nord del 38°
parallelo (fra 38° 22' e 38° 80' di latitudine nord e 14° 22' e 15°
20' di longitudine est), per una lunghezza complessiva di oltre 70 Km
nel Tirreno Meridionale, di fronte alla costa siciliana messinese: la
forma arcuata delle Eolie ricorda i più grandi archi vulcanici del
Giappone, delle Isole della Sonda e delle Antille, che hanno un'origine
analoga: nascono infatti da profonde fratture del fondo marino, generate
dallo scontro fra la crosta di un mare e quella di un continente.
(Ermanno
Sommariva)

Si narra che Eolo, giunto alla corte di Liparo, re degli Ausoni, che,
abbandonate le coste campane, in seguito a una lite con i fratelli, vi approdò
dandole il suo nome, ebbe in sposa una sua figlia e il regno, in cambio del suo
ritorno sulle coste campane, rimastegli nel cuore, cosa che, come da promessa,
avvenne. Qui si innesta il nostro Ulisse, l’eroe più contemporaneo in quanto
portatore di armonia e caos, luce e tenebre, conosciuto e ignoto, quiete e
tempesta, che, reduce dalla guerra di Troia e privo della sua nota spavalderia,
giunto al cospetto di Eolo, conquistatolo con la sua drammatica storia,
ricevette in dono un otre di pelle, custode dei venti contrari alla navigazione
con cui ritornare nell’amata Itaca, sogno rimandato a causa della curiosità dei
suoi compagni di navigazione che aperto il contenitore, creduto depositario di
tesori di inestimabile valore, liberarono le correnti più violente, scatenando
una terribile tempesta.
____________________________________________
Viaggiando in Sicilia con Ulisse, il più arguto degli eroi -
Giusi Patti Holmes
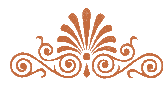
LE
ISOLE EOLIE.
L'incantevole arcipelago delle Isole Eolie si trova nel Mar Tirreno
meridionale a nord della Sicilia.
Si
compone di 10 fra isole e isolotti, ma soltanto sette sono abitate: Lipari,
Salina, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli.
La
superfice dell'arcipelago è di 115 Kmq, i centri abitati sono circa 20, i
comuni 4:
S.Marina
Salina, Malfa, Leni nell'isola di Salina e Lipari sull'omonima isola da cui,
amministrativamente dipendono tutte le altre isole.
La
popolazione è di circa 12.000 abitanti.
Le
isole fanno parte della Regione Sicilia e dipendono dalla provincia di
Messina.
Nacquero
circa 700.000 anni fa nel seguente ordine:
Panarea, Filicudi, Alicudi,
Salina, Lipari, Vulcano e per ultimo Stromboli il quale forse ha circa 40.000
anni di età. Da ricordare l'emersione di Vulcanello avvenuta nel 183 a.c.,
mentre le ultime colate di pomice ed ossidiana sul monte Pelato a Lipari, sono
avvenute circa 1500 anni fa.
Lipari
Superfice Kmq. 37,6 Abitanti 8.000
. È la più importante ed
estesa isola delle Eolie. Lipari è una isola vulcanica il cui aspetto attuale
è il risultato di innumerevoli eruzioni e lunghissimi periodi di inattività.
Lipari è la più popolosa isola dell'arcipelago ed i suoi 9.000 abitanti
vivono in diversi centri abitati: Lipari propriamente detta, Pianoconte,
Canneto, Quattropani, Acquacalda, Porticello.

Stromboli
Superfice Kmq. 12,6 Abitanti 450. Stromboli è celebre per il vulcano che la
domina, perennemente attivo, tanto attivo che l'isola può essere abitata
perchè il materiale eruttivo viene rovesciato soltanto presso la Sciara del
fuoco a nord-est dell'isola. L'unico grande cono vulcanico che forma l'isola
è alto 926 metri. I villaggi di San Vincenzo e San Bartolo nella parte
nord-est dell'isola formano il paese di Stromboli. Sulla costa meridionale
dell'isola sorge Ginostra, un villaggio praticamente isolato dal resto
dell'isola e raggiungibile soltanto via mare.
Panarea
Superfice Kmq. 3,3 Abitanti 280. Incantevole
isola, è stata abitata sin dai tempi preistorici. Alla estremità sud
dell'isola sul promontorio di Punta Milazzese è stato rinvenuto un villaggio
preistorico risalente alla età del bronzo. Anticamente l'isola era detta
Enonymos. Panarea è un pò un
arcipelago nell'arcipelago dato che è circondata da piccole isole minori:
Basiluzzo, Spinazzola, Dattilo, Bottaro, Lisca Nera, Formiche, Panarelli,
Lisca Bianca. Basiluzzo fu abitato in età romana, oggi vi si coltivano
capperi.
Vulcano
Superfice Kmq. 21 Abitanti 400. L'isola
di Vulcano è costituita da 4 edifici vulcanici il più cospicuo dei quali è
il "Gran Cratere" alto 386 metri e sul quale è presente attività
vulcanica sotto forma di fumarole. L'ultima eruzione su questo cratere risale
al 1888/90. Vulcanello all'estremità nord-est dell'isola è alto appena 120
metri e sembra sia sorto dal mare nel 183 a.C. I rilievi più alti dell'isola
sono costituiti dal Monte Aria e dal Monte Saraceno alti circa 500 metri.
Questi due crateri sono inattivi da tempi preistorici.

porto di Panarea (foto mimmorapisarda)
Alicudi
Superfice Kmq. 5,2 Abitanti 140. Dell'arcipelago
è l'isola posta più a occidente. Ha forma semisferica, è di origine
vulcanica ed il suo nome deriva dall'antico "Ericusa" per il gran
numero di eriche presenti sul suo territorio. L'ulivo e la vite sono presenti
sull'isola oltre ai capperi. Tracce di insediamenti di età romana sono stati
rinvenuti nella parte orientale dell'isola la più abitabile per la
conformazione del terreno.
Il
punto più alto dell'isola è il "Timpone della Montagnola" che
tocca i 675 mt. di altitudine.
Filicudi
Superfice Kmq. 9,5 Abitanti 450. Di
grande interesse su questa isola la presenza di numerose, bellissime, grotte
marine, la più famosa delle quali, detta del Bue Marino, si riteneva un tempo
tana di mostruose creature. Sull'isola sono presenti tre vulcani ormai spenti:
la Fossa delle Felci che con i suoi 773 metri di altitudine è il punto più
alto dell'isola, la Montagnola 333 metri e il Torrione con 280 metri di
altitudine. Caratteristica è la forma dell'isola
con un promontorio chiamato Capo Graziano, sede di importanti scavi
archeologici che hanno rilevato la presenza di un villaggio preistorico
risalente al XVI secolo a.C. Lungo la rotta per Alicudi sorge la
"Canna": un imponente faraglione alto ben 85 metri. Anticamente
Filicudi era chiamata Phoenicodes per il gran numero di felci presenti
sull'isola.

Salina
Superfice Kmq. 26,8 Abitanti 2.150
. Il suo nome deriva da uno
stagno d'acqua salata posto nella parte sud dell'isola, che un tempo veniva
utilizzato come salina. L'isola è composta essenzialmente da due ex vulcani
(Fossa delle Felci mt.962 e Monte dei Porri mt. 860). Anticamente proprio per
questa sua caratteristica era chiamata Dydime, "la doppia". L'isola
è ricca di una folta vegetazione tipicamente mediterranea.

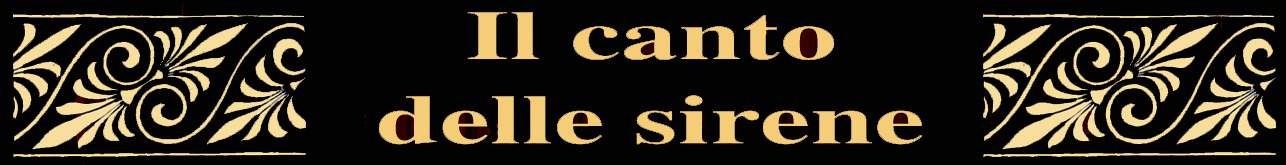
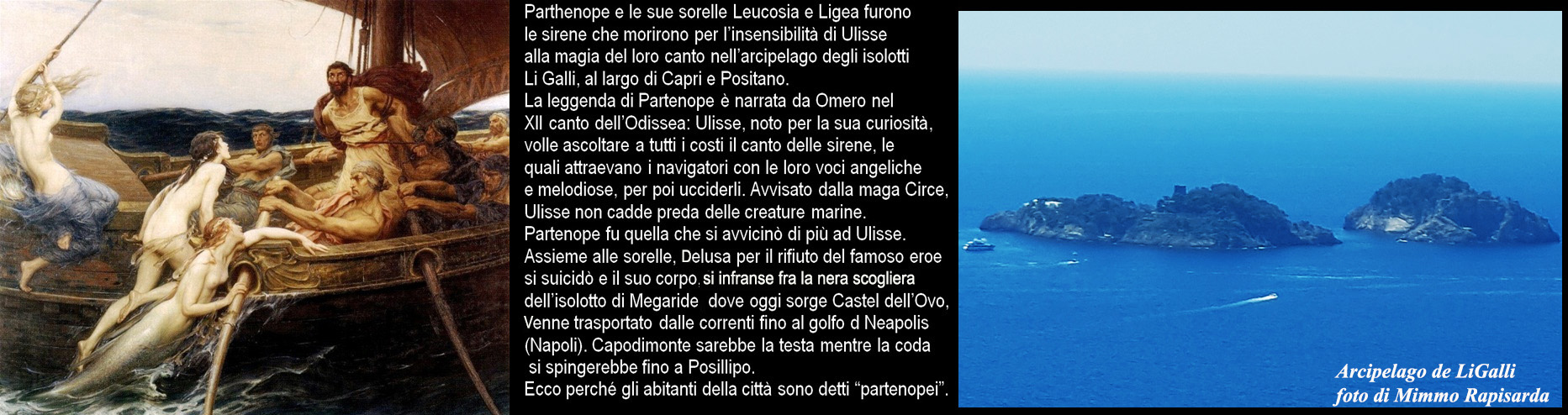
Nel
Golfo di Salerno, Odisseo e i suoi compagni incontrano le Sirene; grazie ai consigli della
maga Circe, Odisseo resiste al loro canto.La
tradizione, accolta anche da Virgilio, colloca l’isola delle Sirene
dell’episodio narrato da Omero in un gruppo di scogli a Sud della penisola di
Sorrento, al largo delle Isole Sirenuse.
Secondo altri, invece, le sirene
vivevano su un’isola tra Scilla e Cariddi, nello
Stretto di Messina.
fonte: historicaljourney.it

"Con
il fascino della loro musica attiravano i marinai che passavano nelle
vicinanze. Le navi si avvicinavano allora pericolosamente alla costa
rocciosa e si fracassavano. Le sirene divoravano allora gli
impudenti."
Due
tipi di sirene popolano il bestiario degli animali fantastici: le
sirene-uccelli e le sirene-pesci; le prime hanno preceduto le seconde.
Hanno testa e busto di donna, seni appuntiti e zampe palmate da uccello
acquatico; vivono sugli scogli delle isole disabitate. La loro arma per
"catturare" gli uomini è il canto.
La
prima storia di sirene entrata nella mitologia è quella di Orfeo che
accompagna gli Argonauti lungo il tratto presso l’isola delle Sirene.
Per distrarre i suoi uomini Orfeo suona la lira di Bitonto e va a
coprire il loro canto fatale; così perdono il loro potere. Ulisse
utilizza un altro espediente: mentre ai suoi uomini impone di turarsi le
orecchie egli, per tutelar se stesso, si fa legare all’albero della
nave. In tal modo può udire e vivere il pericolo ma uscirne vivo.
Sconfitte ancora una volta, le sirene si precipiteranno in mare. Così
narra la leggenda.
I
miti sono piuttosto contraddittori sulla loro origine. Apollonio le fa
nascere da Tersicore e da Acheloo, il dio fluviale. Altri le vedono
figlie di Melpomene. Molti affermano che fossero compagne di Persefone o
di Demetra. Fu al momento del ratto di Persefone che le sirene avrebbero
preso il volo verso la Sicilia; vennero attribuite loro ali e corpo da
uccello per volare alla ricerca della vergine rapita.
Qualcuno
avanza l’ipotesi che l’esser state trasformate in uccelli fosse una
punizione per non essersi opposte al rapimento della loro padrona.
Più
indulgenti, gli uomini, ne fecero l’immagine delle armonie celesti che
cantano per la gioia dei Beati nelle Isole Fortunate.
Nel
Medioevo, la sirena, affascinante e crudele, si confonde spesso con
l’inquietante arpia, avvoltoio del mondo sotterraneo...
Risale
forse a questa fase storica la trasformazione radicale della sirena che,
in veste di donna-pesce, si fa, via via, sempre più simbolo di
pericolosità. Le sirene hanno perso l’oscurità dei loro capelli; ora
sono bionde, hanno chiome lunghe e fluenti, ondulate come il mare.
Assieme allo specchio, simbolo che rimanda al doppio, all’ombra e
all’inganno, le sirene usano il pettine, termine che,
etimologicamente, rimanda alla sessualità. Ciò che lo specchio offre
è l’immagine di un corpo nel quale la parte animale ha pres o il
sopravvento.
o il
sopravvento.
Le
sirene moderne sono impregnate di una sessualità
che era totalmente
assente nelle sirene primitive.
Nella
mitologia greca, infatti, esse furono addirittura punite da Afrodite per
il loro tenace rifiuto a qualsiasi rapporto d’amore.
L’uomo
antico cercava nelle sirene quel dono che esse erano capaci di infondere
in un attimo di rapimento: il suono della conoscenza.
Ma
il cammino umano è lungo e faticoso; non è un caso che solo Ulisse, il
progenitore della coscienza (perchè è il primo ad usare il pronome
"io") abbia potuto reggere il peso della nuova consapevolezza
sopravvivendone.
Se
prima potevano allettare e far perire nel languore e nella malìa del
loro canto celestiale, nel medioevo il corpo diventa protagonista. Da
solari (l’oro del sole fermato nei capelli) le sirene diventano
lunari, inserite in un tempo ciclico, mutabile e misurabile. Esseri
lunari sottomessi alla temporalità e alla morte, come la luna che
nasce, cresce, decresce nel buio per poi risorgere.
Sirena
viene da sereno o da sera. Il crepuscolo evoca la pericolosità ed il
rischio di essere divorato.
Nel
Medioevo, periodo della Scolastica, dei Padri della Chiesa, delle
Crociate e di una diffusione sempre più dogmatizzata del Cristianesimo,
le sirene perdono dunque le ali; come nelle rappresentazioni alchemiche
è la caduta dell’anima.
Figure
per metà pesce e per metà donna, tra il mare, simbolo di un inconscio
ancora divorante, e la terra, luogo dell’uomo e regno assoluto
dell’Ego.
Dall’armonia
celeste - le ali da uccello dell’antichità - che si diffonde tra gli
uomini attraverso un canto che è suono, ancora troppo potente, della
conoscenza, alla "perdizione" nel profondo mare dove, per la
prima volta, le sirene iniziano a specchiare il loro corpo nudo e a
vedersi come illusione.
Il
primo autore medioevale a parlare delle sirene e del loro canto mortale
è Richard de Fournival nel "Bestiario d’amore" del 1250.
Molti viaggiatori narrarono di averne vedute e ne interpretarono i
comportamenti come segni prognostici. Anche Colombo (scopritore del
mondo "nuovo") ne vide tre che danzavano sulle onde, mute e
anche molto brutte. Due sono gli animali marini che, con le loro forme,
ben si prestano a supportare le leggende: il lamantino, un mammifero che
vive alla foce dei grandi fiumi africani e americani, e il dugon go,
cetaceo erbivoro dell’Oceano Indiano. Entrambi hanno grandi seni
rotondi privi di peli; quando allattano emergono dall’acqua con il
tronco.
go,
cetaceo erbivoro dell’Oceano Indiano. Entrambi hanno grandi seni
rotondi privi di peli; quando allattano emergono dall’acqua con il
tronco.
Nel
1614 viene descritta una storia d’amore tra un marinaio ed una sirena.
Le
storie d’amore tra l’uomo e la sirena sono meravigliose ma finiscono
sempre male: l’uomo, accompagnato nelle profondità degli abissi in
palazzi sottomarini, non può più liberarsi dal vincolo di
quell’amore.
Molto
disponibili ad aiutare i naufraghi, li nutrono e li accudiscono ma poi,
nei rapporti "traditi", non li lasciano andar via e spesso li
uccidono.
Nelle
leggende popolari sono presenti con vari nomi: in Germania è la "nixen",
sirena malvagia che spinge l’uomo al suicidio; nei Paesi Bassi le
"Merminnes", meno crudeli ma molto vendicative.
Come
simbolo, la sirena è sempre molto presente nelle rappresentazioni
iconografiche più antiche e resta vivo a lungo nelle miniature, nei
capitelli, nei blasoni e nelle incisioni.
E’
curioso che i tipografi, in passato, abbiano scelto l’insegna della
sirena a doppia coda quale simbolo della conoscenza e della cultura
umanistica.
Tra
le due branche del sapere, il due dell’opposizione e del conflitto
diremmo noi oggi, si apre il sesso affascinante, l’antro marino: è il
femminile quale ritorno al tutto, origine e fonte di ogni sapere, vera
porta dell'"altro" mondo.
E’
nel Medioevo, dunque, che la sirena diventa un mostro creato dalla
fantasia dell’uomo solo, isolato, come lo è il marinaio sempre in
viaggio, ossessionato dall’immagine della donna. E’ l’emblema del
demonio che seduce l’uomo ai piaceri della carne spingendolo alla
dannazione.
La
sirena è il fantasma della sessualità esigente e della tristezza
post-coitale: l’incanto, la fascinazione e la malìa della prima fase,
quella del desiderio erotico, si trasforma in prigionia e morte. Una
morte inutile e definitiva se l’amore è vissuto nell’immediatezza e
nell’orizzontalità. Poichè da sempre, amore e conoscenza formano un
tutt’uno inscindibile con l’uomo ed il suo stesso divenire.
Laura
Ottonello
__________________________________


Così
parlò De Crescenzo
Tra
sirene e fans deliranti, incontriamo Luciano De Crescenzo e il suo
Nessuno.
Lei
propone spesso al grande pubblico i classici, dalla filosofia alla
letteratura, a chi si rivolge in particolare?
Io
vengo definito un divulgatore, cioè uno che scrive cose complicate in
modo semplice, quindi per definizione un divulgatore si rivolge a un
pubblico di massa. Fino a poco tempo fa avevano le chiavi in mano del
paradiso letterario i critici letterari. Un autore che aveva scritto un
libro, per farsi conoscere, doveva passare sotto le forche caudine delle
terze pagine dei giornali. Oggi, grazie a Dio, e grazie ad alcuni nuovi
strumenti, ci si può far conoscere da platee vastissime.

Quali
sono questi nuovi strumenti?
Prima
di tutto, la televisione: ai fini informativi rende più un
"Maurizio Costanzo" che non un Enzo Golino, critico letterario
di Repubblica o dell'Espresso. Poi, oltre alla televisione, c'è
Internet. Quando si racconta un libro su Internet, anche con poche frasi
si fa conoscere il contenuto di questo libro a milioni di persone. Ci
sono poi anche altri fenomeni, come i "fan club". Io un
pochino mi vergogno di questa cosa. Finora c'erano i "Ramazzotti
fan club", i "Maradona fan club", si è mai visto il
"fan club" di uno scrittore? E invece sono sorti dei "fan
club" a Roma, a Napoli e anche all'estero e io, di tanto in tanto,
vado lì e incontro tutti questi ragazzi che mi vogliono bene e li
informo di quello che succede.
E
la tradizione letteraria?
Certo
è che Kafka, nel corso della sua vita, vendette solo seicento copie,
Svevo anche meno, Leopardi meno ancora, però, credetemi, Leopardi non
andò mai, nemmeno una volta, al "Maurizio Costanzo Show". A
me sarebbe piaciuto vedere Maurizio Costanzo che batteva una mano sulle
spalle (si fa per dire) del giovane Leopardi. Leopardi stava chiuso in
una stanzetta e scriveva. Lo scrittore oggi si deve dar da fare per
vendere e diffondere
il suo libro deve sopportare qualsiasi fastidio, deve sopportare la
folla, deve sopportare la sirena...
Io la
sirena la sopporto con molto piacere...
Perché
ha scelto proprio l'Odissea per questo suo ultimo lavoro?
Signori
miei, se uno si volesse oggi leggere l'Odissea, non è molto facile...
Se si prende la traduzione dell'Odissea di Ippolito Pindemonte, premesso
che Pindemonte è nato nel Settecento e ha tradotto l'Odissea in versi,
dopo tre pagine uno non ne può più, non ce la fa proprio più! Eppure
l'Odissea è un romanzo divertentissimo, pieno di colpi di scena,
accadono un sacco di cose c'è Polifemo, c'è Circe, c'è Scilla e
Cariddi, ci sono le Sirene. Così invece uno che legge l'Odissea si
diverte, però come l'ho scritta io, con un linguaggio umano, si capisce
addirittura tutto!
Quale
personaggio femminile dell'Odissea preferisce?
Tra
i quattro personaggi femminili dell'Odissea, Penelope, Circe, Calipso e
Nausicaa, io preferisco Nausicaa, se non altro per la rima... È una
battutaccia, lo so! Nausicaa si scrive con due "a"? Ma quello
è l'orgasmo finale, "Nausicaaaa..." Penelope è una signora
di mezza età, sempre triste, col velo, ma come mi può piacere? Non
dormiva, la notte sempre sveglia a fa' 'sta tela... Circe è una
tenutaria di una casa d'appuntamenti. Calipso è la peggiore di tutte:
sempre addosso con "Ti voglio bene, ti voglio bene" per sette
anni di seguito. L'unica alle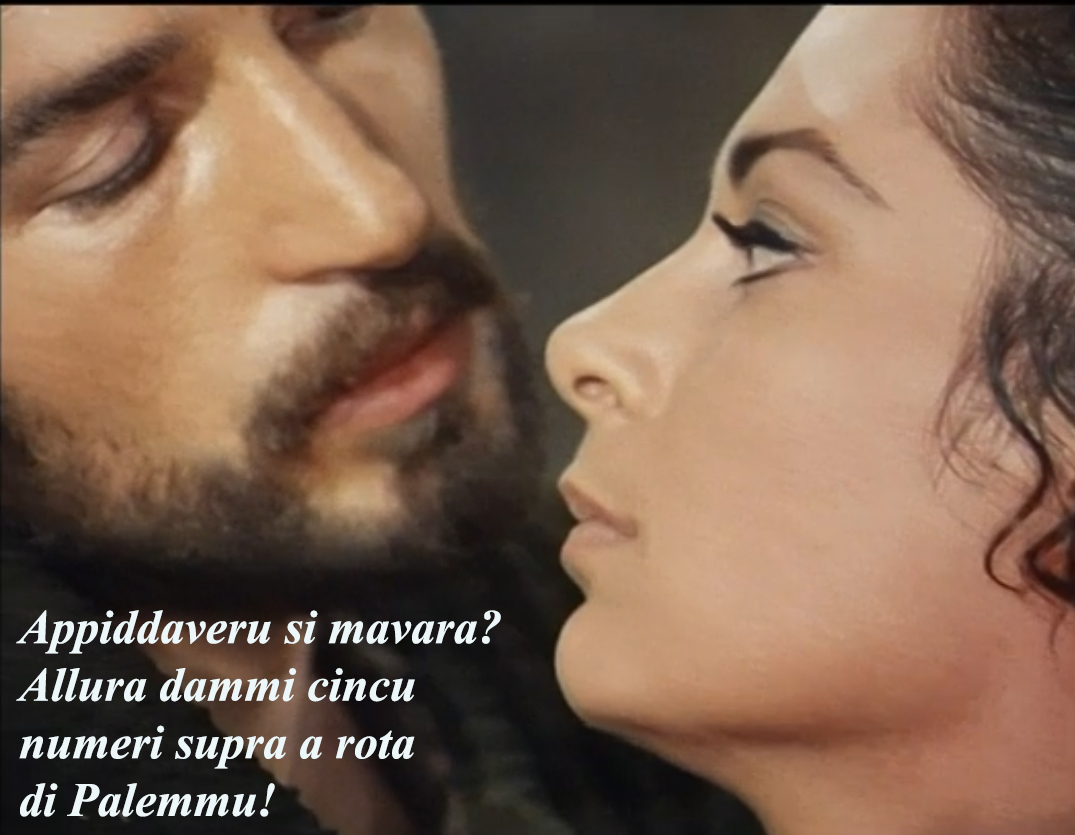 gra, giovane (stava nuda, giocava a
palla...) è Nausicaa, grazie a Dio è n'ata cosa.
gra, giovane (stava nuda, giocava a
palla...) è Nausicaa, grazie a Dio è n'ata cosa.
Quali
elementi del carattere di Ulisse le piacciono di più, il desiderio di
conoscenza o la sua debolezza per le donne?
Ulisse,
detto tra noi, delle donne non se ne fregava assolutamente niente. Perché
lui rifiuta Calipso che gli aveva promesso l'eterna giovinezza, rifiuta
Nausicaa che il padre gli voleva far sposare, insomma rifiuta tutte. Il
pregio maggiore di Ulisse era la curiosità, la voglia di sapere, la
voglia di scoprire, quindi io auguro a tutti i giovani di nascere con
dentro la voglia di sapere di Ulisse, quello è il merito del nostro
eroe.
I
suoi libri sono molto conosciuti anche all'estero, quali in particolare?
Io
all'estero vendo molto, il paese in cui vendo di più è la Germania,
poi l'Italia, poi la Spagna, il Giappone, la Corea... In Corea hanno
comprato tutti i libri miei, pure l'ultimo. Che ppò capì un coreano di
Bellavista, questo per me è un mistero! Si sono comprati pure le
videocassette, quando le vedo raccontate in coreano, è terribile, vedo
me che parlo in coreano, è proprio terribile... Bisogna sapere che il
coreano è una lingua più "corta" dell'italiano e allora si
sente parlare, poi cessa la voce e io continuo a muovere la bocca!
Nei primi anni del secolo Pascoli dedica ad Ulisse
più di un componimento: “Il ritorno”, incluso nella raccolta Odi e
Inni, il cui tema prevalente è quello della nostalgia per la patria
lontana, e “L'ultimo viaggio” che rientra nella raccolta dei Poemi
conviviali del 1904. Qui l'epopea antica è interpretata alla luce di
significati estremamente moderni.
L'astuto e inarrestabile eroe greco, una volta
tornato a casa dal celebre viaggio, trascorre la vita
invecchiando
accanto all'amata moglie. Ma in lui rimane acceso un qualcosa
difficilmente decifrabile, l'attesa di un qualcosa di indefinito,
un'inesauribile sete di conoscenza. Passati dieci anni, decide di
colmare il vuoto creatosi nella sua anima con un ultimo viaggio, una
seconda odissea verso i luoghi visitati la prima volta, da consumarsi
con i vecchi compagni superstiti. L'Odisseo pascoliano è triste e
deluso, vecchio e stanco, pieno di dubbi, dominato dall'ansia di
cogliere il vero senso delle cose. Dopo tante peregrinazioni ritorna ai
luoghi del passato, vivi ancora nella sua memoria, non per compiere
nuove audaci imprese, ma per comprendere il senso dell'esistenza. Il suo
ultimo viaggio è un vano errare, ben lontano dal coraggio e dalla
sicurezza dell'Ulisse omerico, dalla sua volontà di accettare la sorte
e di sopportare le sofferenze. La sua sete di conoscenza si è mutata
nell'impossibilità di acquisire certezze, anzi, ha sollecitato in lui
ulteriori dubbi e interrogativi.
«Son io! Son io, che torno per sapere! / Chè
molto io vidi, come voi vedete / me. Sì; ma tutto ch'io guardai nel
mondo, mi riguardò; mi domandò: Chi sono?»
Così Ulisse lancia alle due immobili Sirene la sua
domanda. Vuole capire quale sia il significato dell'esistenza, ma le
Sirene non rispondono, e lasciano schiantare la nave nera dell'eroe tra
gli scogli. Come in Dante, l'ultimo viaggio si conclude con il
naufragio: «tra i due scogli si spezzò la nave» e il corpo dell'eroe
approda all'isola di Calypso. «Giaceva in terra, fuori / del mare, al
pié della spelonca, un uomo / … Era Odisseo: lo riportava il mare /
alla sua dea: lo riportava morto».
Sarà Calypso a fornirci la tragica risposta
all'interrogativo di Ulisse: «Non esser mai! Non esser mai! Più nulla
ma meno morto, che non esser più!». Il senso delle parole della dea è
drammatico: meglio per l'uomo non nascere, dato che deve inevitabilmente
morire. Ulisse perde così le sue certezze per diventare il simbolo
della crisi di valori che caratterizza il Decadentismo.

CIRCE
Maga dell'isola di Eea. Il
suo era un amore subdolo e velenoso, dato che pur di renderlo
corrisposto, nonostante la sua rinomata bellezza,
non esitava ad utilizzare le sue insidiose magie. Significativo
fu il trattamento che riservò a Scilla, sua rivale nel corteggiamento
di Glauco: contaminò infatti la sorgente in cui la ragazza era solita
bagnarsi con una pozione magica in modo che, quando questa si immerse,
venne tramutata nel mostro da dodici zampe e sei testa che, in coppia
con Cariddi, divenne lo spauracchio di tutti i marinai che passavano per
lo stretto di Messina, compreso Odisseo. Tuttavia questo fascino
"oscuro" colpì anche l'eroe di Itaca, che dopo essere
sfuggita alla trappola della maga, passò un anno intero accanto a lei.
L’Odissea
continua con la richiesta di vendetta nei confronti di Odisseo di
Polifemo al padre Poseidone, mentre Ulisse non riesce a raggiungere
Itaca a causa della curiosità dei compagni, che mentre egli dorme
decidono di vedere il contenuto dell'otre regalato da Eolo e dal
contenitore escono tutti i venti che fanno sfumare il possibile ritorno
dell'eroe di Itaca a casa sua. Ma
subito dopo una sciagura ancora peggiore si abbatte sulla piccola flotta
di Odisseo: il popolo dei Lestrigoni, enormi uomini cannibali, che
appena si accorgono dei visitatori, li aggrediscono ferocemente
divorandone uno e affondano con dei massi tutte le navi che rimangono
eccetto quella di Odisseo che sbarca con i restanti compagni sull'isola
di Eea, dove, dopo due giorni di diffidenza passati a riposarsi, manda i
suoi compagni alla casa della maga Circe, una figura misteriosa e
conturbante su cui vale la pena soffermarsi.
«Trovarono
nelle valli il palazzo di Circe, costruito con pietre lisce, in un luogo
isolato. E intorno ad esso c'erano lupi di montagna e leoni che lei
aveva stregato, dando loro droghe maligne. E quelli non si avventarono
contro gli uomini, ma dimenando le lunghe code si rizzarono sulle zampe.
«Come
quando intorno al padrone che viene dal banchetto, scodinzolano i cani,
ché sempre porta
ghiottonerie: così intorno a loro agitavano la coda i lupi di forte
unghia e i leoni. Ed essi ebbero paura al vedere i bestioni terribili.
«Si
fermarono nell'atrio della dea dalle belle chiome. Sentivano Circe
cantare dentro con voce soave, mentre tesseva una tela grande,
immortale, come sono i lavori delle dee, sottili e splendenti e pieni di
grazia.
«Tra
loro prendeva a parlare Polite, capo di uomini, che mi era il più caro
e il più fidato dei compagni. Diceva: ‹Amici, dentro c'è una che
tesse una grande tela e canta con bella voce: tutta la campagna ne
risuona. O è una dea o donna mortale. Via, mandiamo un grido subito!›
«Così
parlò. Ed essi con un grido la chiamavano.
«Ella
ben presto uscì aprendo i lucidi battenti della porta, e li invitava
dentro. Ed essi tutti insieme nella loro semplicità la seguivano. Ma
Euriloco non si mosse, ebbe il sospetto che ci fosse un inganno.
«Li
faceva entrare. Li mise a sedere sulle sedie e sugli alti seggi. E' per
loro mescolava formaggio e farina d'orzo e miele verde con vino di
Pramno, e univa a quel cibo droghe malefiche: voleva che si scordassero
completamente della patria.
cibo droghe malefiche: voleva che si scordassero
completamente della patria.
«E
dopo che glielo diede ed essi l'ebbero bevuto, subito poi li colpiva con
la sua verga e li chiudeva nei porcili. Ed essi avevano, dei maiali, le
teste e la voce, le setole e l'aspetto, ma la mente era immutata, come
prima.
«Così
stavano rinchiusi e piangevano. A loro Circe gettò innanzi ghianda di
leccio e ghianda di quercia e il frutto del corniolo, da mangiare: sono
i cibi consueti dei porci che si sdraiano a terra.
«Euriloco
giunse ben presto alla nave a dire la novità riguardo i compagni e
l'amaro destino che era loro toccato. Ma non poteva pronunciare neppure
una parola, benché lo desiderasse e volesse, colpito com'era da grande
dolore. Gli occhi gli si riempivano di lacrime, dentro di sé non
pensava che a piangere.
«Ma
quando noi tutti stupiti lo interrogammo, allora finalmente raccontò la
morte degli altri compagni. Diceva: ‹Andavamo, come tu comandavi,
Odisseo, su per le boscaglie. Trovammo nelle valli un bel palazzo
costruito con pietre lisce, in un luogo isolato. Là c'era una che
tesseva una grande tela e cantava ad alta voce: una dea o donna mortale.
E i compagni con un grido la chiamarono. Ella ben presto uscì aprendo i
battenti della porta, e li invitava dentro. Ed essi tutti insieme nella
loro semplicità la seguirono. Ma io non mi mossi: ebbi il sospetto che
ci fosse un inganno. Sparirono tutti insieme, nessuno di loro comparve
più. A lungo io sedevo là e spiavo.›
«Così
diceva. Ed io mi cinsi all'omero la spada dalle borchie d'argento - era
una grande spada di bronzo - e mi misi l'arco in spalla. E a lui ordinai
di condurmi indietro per la stessa strada.
«Ma
egli mi prendeva le ginocchia con tutte e due le mani, mi supplicava, e
con voce di pianto mi rivolgeva parole: ‹Non menarmi là contro
voglia, o discendente di Zeus, ma lasciami qui! So che neppure tu farai
ritorno indietro e non riuscirai a condurre via alcun altro dei tuoi
compagni. Ma con questi qui, subito, scappiamo! Possiamo ancora sfuggire
al giorno funesto.›
«Così
parlava. Ed io gli rispondevo e dissi: ‹Euriloco, tu sta' pure qui, in
questo luogo, a mangiare e a bere, accanto alla nave. Ma io andrò: ne
ho un'imperiosa necessità.›
«Così
dicevo. E dal mare salivo verso l'interno.
«Ma
quando camminando per le sacre valli stavo per giungere alla grande casa
della maga Circe, allora mi si fece incontro Ermes dalla verga d'oro.
Somigliava ad un giovinetto al quale spunta la prima barba, e la cui
adolescenza è piena di grazia.
«Mi
prese per mano, si rivolgeva a me e disse: ‹Dove vai, infelice, per
queste alture da solo, ignaro come sei del luogo? I tuoi compagni qui
stanno rinchiusi nel palazzo di Circe, come porci, e occupano solide
stalle. Vai forse là per liberarli? Neppure tu, te lo dico, farai
ritorno, ma resterai invece dove sono gli altri. Ma via, io ti voglio
liberar dai guai e salvare. To', con questo farmaco benigno vai dentro
il palazzo di Circe: esso terrà lontano dal tuo capo il giorno funesto.
E ora ti svelo tutte le malizie e le astuzie di Circe. Ti preparerà un
beveraggio, ci metterà dentro delle droghe: ma neppure così riuscirà
a stregarti. Non lo permetterà il farmaco che intendo darti: e ti dirò
anche ogni cosa che tu devi fare. Quando Circe ti percuoterà con la sua
lunghissima verga, tu traiti dal fianco la spada e avventati contro di
lei, come se volessi ucciderla. Ella t'inviterà, spaurita, a giacere
con lei. Allora tu non rifiutare il letto della dea, se vuoi che ti
liberi i compagni e ti accolga ospitalmente: ma imponile di giurare il
solenne giuramento degli dei beati, che non vorrà a tuo danno tramare
qualche altra sventura. Eviterai che, una volta spogliato, ti renda vile
e imbelle.›
«Così
parlava l'Argicida, e mi diede l'erba che aveva strappato da terra, e mi
mostrò com'era fatta: era nera nella radice, bianco come latte il
fiore. Moli la chiamano gli dei. Ma è difficile per gli uomini mortali
trarla fuori dal terreno scavando: gli dei invece possono tutto.
«Ermes
poi se n'andò su per l'isola selvosa all'alto Olimpo: ed io camminavo
verso la casa di Circe e il cuore nell'andare mi batteva forte.
«Mi
fermai alla porta della dea dalle belle chiome. E là diedi un grido: la
dea udì la mia voce.
«Ella
ben presto uscì aprendo i lucidi battenti e m'invitava dentro. Io la
seguivo rattristato.
«Mi
fece entrare, mi mise a sedere su di un seggio dalle borchie d'argento:
era bellissimo, lavorato con arte. E sotto, per i piedi, c'era uno
sgabello.

«Mi
preparava il beveraggio in una coppa d'oro; e dentro ci mise una droga,
meditando la mia rovina.
«E
dopo che me lo diede ed io l'ebbi bevuto - e non mi stregò -, mi
colpiva con la sua verga, si volgeva a me e disse: ‹Va' ora nel
porcile e coricati in mezzo agli altri compagni!›
«Così
diceva. Ed io mi trassi dal fianco la spada acuta e m'avventai contro
Circe come se volessi ucciderla.
«Lei
gridava forte e corse di sotto e mi abbracciò le ginocchia, e con voce
di pianto mi rivolgeva parole: ‹Qual è il tuo nome? di che paese sei?
Dove hai la città e la famiglia? Sono qui piena di stupore: a bere
queste droghe, tu non rimanesti stregato. Nessun altro uomo tollerò
queste droghe, a berle, non appena gli passarono in gola. È in te una
mente che non si lascia affascinare. Certo tu sei Odisseo. E sempre mi
andava dicendo l'Argicida dalla verga d'oro che saresti venuto qui, al
ritorno da Troia con la nave. Ma via, riponi la spada nella guaina e noi
due poi saliamo sul nostro letto! Uniti in amore, avremo fiducia l'uno
nell'altro.›
«Così
parlava. Ed io le risposi: ‹O Circe, ma come! M'inviti a essere buono
con te, tu che mi hai reso porci nella sala i compagni e mi trattieni
qui meditando un inganno e mi dici di venire in camera e di salire sul
tuo letto per rendermi così, una volta spogliato, vile e imbelle! Ma io
non intendo salire sul tuo letto, a meno che tu non consenta, o dea, a
farmi un solenne giuramento, che non vorrai a mio danno tramare qualche
altra sventura.›
«Così
dissi. E lei subito giurava come volevo.
«Quando
ebbe pronunciato il giuramento, allora andai sopra il letto bellissimo
di Circe.
«Intanto
nella sala si affaccendavano le quattro ancelle che le fanno i lavori
per casa. Esse sono figlie dei fonti e dei boschi, e dei sacri fiumi che
scorrono al mare.
«Una
metteva sui seggi belle coperte color porpora e sotto vi stendeva panni
di lino; l'altra collocava davanti ai seggi le mense d'argento e vi
posava sopra canestri d'oro; la terza mescolava con acqua dentro un
cratere d'argento un vino delizioso, dolce, e distribuiva le tazze
d'oro; la quarta portava acqua e accendeva un gran fuoco sotto un grosso
recipiente, e l'acqua si scaldava.
«E
quando prese a bollire entro il rame lustro, mi faceva, Circe, sedere
nella vasca da bagno e mi lavava con l'acqua della grande caldaia,
versandomela piacevolmente tiepida giù per il capo e le spalle, finché
mi tolse dalle membra la stanchezza mortale. E dopo che mi ebbe lavato e
unto abbondantemente di olio, mi mise indosso una tunica e un bel manto
e mi menava nella sala. Lì mi fece sedere su di un seggio dalle borchie
d'argento: era bellissimo, lavorato con arte. E sotto, per i piedi,
c'era uno sgabello.
«Un'ancella
recava acqua in una brocca d'oro, assai bella: la versò sopra un bacile
d'argento per la lavanda alle mani. E dinanzi stese una mensa di legno
levigato.
«La
dispensiera portò il pane, lo mise davanti: recò ancora molte vivande,
dando con larghezza di quello che c'era in serbo.
«E
m'invitava, Circe, a mangiare. Io non ne avevo voglia, ma sedevo
pensando ad altro. Il mio cuore presagiva sventure.
«Circe,
come s'accorse che io stavo là e non stendevo le mani sui cibi e che
avevo un forte dolore, mi si faceva vicina, mi rivolgeva parole: ‹Come
mai, Odisseo, siedi così, simile a un muto, rodendoti l'animo, e non
tocchi né vivande né vino? Certo tu sospetti qualche altro inganno. Ma
non devi temere: ti ho già fatto il solenne giuramento.›
«Così
parlava. Ed io le rispondevo: ‹O Circe, e quale uomo che sia giusto e
assennato, può aver cuore di saziarsi di cibo e bevanda, prima di
liberare i suoi compagni e vederseli davanti agli occhi? Ma se tu
davvero m'inviti premurosa a bere e a mangiare, scioglili, fammeli
vedere coi miei propri occhi, i cari compagni.›
«Così
parlavo. E Circe era già andata via attraverso la sala tenendo in mano
la sua verga. Aprì le porte del porcile e li fece uscire: erano simili
a maiali ingrassati di nove anni.
«Le
si fermarono di fronte: e lei passava in mezzo ad essi e li ungeva uno
per uno con un farmaco diverso. E dalle loro membra cadevano le setole
che prima aveva fatto spuntare la droga malefica: gliel'aveva data lei
stessa, Circe sovrana. E uomini tornarono di nuovo, più giovani che non
fossero prima, e molto più belli e più grandi di statura a vedersi.›
___________________________
L’Isola
di Circe. Nel X Libro dell’Odissea Omero narra le vicende che vedono l’approdo
di Ulisse e dei suoi compagni sull’Isola di Eea, abitata da Circe. Ulisse, con i
suoi compagni, sbarcati nella notte, riposarono per due giorni e due notti, al
terzo giorno:
Questi
riferimenti, e il percorso successivo con direzione Nord-Est, condurrebbero a
Ustica, l’isola in cui Omero e la mitologia classica fanno risiedere Circe,
l’affascinante maga che trasformava in animali gli sprovveduti che le si
accostavano, chiamata dai Greci “Ostèodes”, l’Isola delle Ossa degli Uomini
Morti e legata alle sirene che, racconta il poeta, stavano sedute su un prato, o
appollaiate su una roccia, con tutt’attorno “un gran cumulo di ossa umane”. Le
sirene si narra che cantino ancora a Ustica, ammaliando l’uomo e le forze della
natura. Fonte: Viaggiando in Sicilia con Ulisse, il più arguto degli eroi -
Giusi Patti Holmes

_________________________________
"L'isola di Eea (in greco antico: Αἰαίη, Aiáiē oΑἰαία, Aiáiā, in latino: Aeaea)
viene nominata nell'Odissea come dimora della maga Circe e prendeva il nome da
Eos, l'aurora. Che la sede di Circe fosse un'isola è ben chiaro nel libro X
dell'Odissea in quanto Ulisse, salito su una roccia scorse nella sua interezza
il contorno dell'isola: e il pelago tutto d'intorno la stringe e ghirlanda. Tale
isola è stata identificata, fin dall'antichità (lo testimonia Strabone), con
l'attuale promontorio del Circeo. Tuttavia il Circeo non è che un promontorio e
in passato era una penisola; si è ipotizzato quindi che in epoca antica dovesse
essere separato dalla terra e circondato dal mare o collegato alla terra da una
spiaggia. A ricordo di questa sede ipotetica esiste ancora una grotta indicata
come "della Maga Circe", dove il termine maga (di uso popolare e letterario non
greco) sostituisce quello originario di dea, nonché le rovine del cosiddetto
"Tempio di Circe (o di Venere)", dove fu rinvenuta una testa di una statua,
attribuita alla divinità.
La
dimora di Circe era al centro dell'isola, in un'aprica pianura e in giro si
vedevano ampie strade. Come si può notare sia l'isola che le ampie strade
lasciano dei dubbi sull'identificazione di Eea con il Circeo, tuttavia il
promontorio del Circeo, visto da Gaeta o Sperlonga, può sembrare proprio
un'isola. Alcuni storici hanno ipotizzato che l'isola corrispondesse
all'acropoli di Terracina o comunque in una zona vicina a Terracina. Inoltre a
Terracina il tempio della dea Feronia sembra potersi identificare proprio con
Circe. Altri hanno ipotizzato, invece, che fosse l'isola di Ponza. Più di
recente altri ancora, come il professore e storiografo neozelandese L.G. Pocock,
studiando e ripercorrendo approfonditamente gli eventi descritti nell'Odissea di
Omero, hanno identificato Eèa nell'Isola di Ustica, la quale, anche per lo
scrittore Marco Carlo Rognoni, sembra corrispondere al luogo più plausibile a
motivo della sua particolare storia, posizione e morfologia.
Qui
vive la maga Circe che trasforma i compagni di Odisseo in porci. Il dio
Ermes, però, salva l’eroe e i suoi compagni dai sortilegi della maga
che, diventata un’ospite generosa, li trattiene presso di sé per un
anno.
fonte: historicaljourney.it

La nave si avvicina allo stretto; il silenzio del mare è rotto a poco a poco da
un rombo che ruggisce sempre più forte, sino a diventare assordante. Eccola là,
Cariddi, divora paurosamente l'acqua facendo vedere il fondo del mare turbinante
di sabbia nera e quando la rigetta ribolle tutta, mugghiando, e la
spuma ricade sulle rocce. Mentre i marinai di Ulisse tentano di evitare Cariddi,
Scilla sporge le sue teste e afferra sei uomini; il mostro li trascina nel suo
antro, e gli sventurati si dimenano nell'aria, urlano, chiedono aiuto al loro
capo. Nel suo covo Scilla li divora vivi. "Fu la cosa più triste", ricorda
Ulisse, "tra tutte quelle che vidi navigando sul mare." La nave passa e approda
in una baia di acque calme, vicino a una grotta dove danzano le Ninfe.
È l'ultima prova. Circe aveva predetto che sarebbero sbarcati su un'isola
chiamata Trinachia (ossia Trinacria) dove pascolano pacifiche le mandrie del
Sole. Sono incustodite, ma guai a ucciderne una!
Non partoriscono né muoiono mai, perciò il loro numero resta sempre identico.
"Non toccate quelle bestie", aveva ammoni- to Circe, "se riuscirete a farlo
potrete tornare a Itaca. Altrimenti sarà la vostra fine."
fonte
“La sicilia degli Dei” di G. Guidorizzi e S. Romani – Raffaello Cortina Editore

Scilla ivi alberga, che moleste grida
Di mandar non ristà.
La costei voce altro non par che un guaiolar perenne
di lattante cagnuol: ma Scilla è atroce
Mostro, e sino a un dio, che a lei si fesse,
Non mirerebbe in lei senza ribrezzo.
Dodici ha piedi, anteriori tutti,
Sei lunghissimi colli e su ciascuno
Spaventosa una testa, e nelle bocche
Di spessi denti un triplicato giro, e la morte più amara di ogni dente.
Scilla e Cariddi Sono i
due mostri a cui Odisseo riesce a sfuggire pur perdendo alcuni uomini.
"Geograficamente Cariddi è collocabile sulla punta messinese della Sicilia, a
Capo Peloro. Scilla è situata sull'omonima punta, che sorge 22 km a nord del
capoluogo: il Promontorio Scillèo, proteso sullo Stretto di Messina, che
anticamente veniva infatti denominato Stretto di Scilla.
Il
toponimo scylla (cagna) richiama un misterioso mostro che sarebbe il
responsabile di tempeste scatenatesi sul mare che determinarono la fine di molti
naufraghi. Descritta da Strabone come uno scoglio simile a un'isola, Scilla
mantiene tutt'ora i tratti di questo paesaggio. I suoi pochi abitanti furono
degli abili navigatori e conoscitori delle rotte, notizia questa confermata da
San Girolamo".
fonte: historicaljourney.it
_____________________
Scilla, “colei che dilania”, e Cariddi, “colei che
risucchia”, i due mostri a cui Ulisse riuscì a sfuggire, pur perdendo
dei preziosi compagni di avventura, per tradizione corrispondono allo
Stretto di Messina. Tra le leggende, appartenenti al patrimonio
culturale dell’antica Messina, la più nota ricorda l’esistenza del
mostro Cariddi, mitica personificazione di un vortice formato dalle
acque dello Stretto.
Per
alcuni, infatti, Cariddi era la ninfa, figlia di Poseidone e Gea, tormentata da
una grande voracità, che avrebbe rubato e divorato i buoi di Eracle, passato
dallo Stretto coll’armento di Gerione e, per punizione, trasformata da Zeus in
un orribile mostro. Omero fu il primo a parlarne nel canto XII dell’Odissea,
dicendo che ingoiava tre volte al giorno un enorme quantità d’acqua per poi
sputarla trattenendo, però, tutti gli esseri viventi che vi trovava.
fonte:
Viaggiando in Sicilia con Ulisse, il più arguto degli eroi - Giusi Patti Holmes

“altro scoglio, più basso tu lo vedrai, Odisseo, / vicini uno all’altro, /
dall’uno potresti colpir l’altro di freccia. / Su questo c’è un fico grande,
ricco di foglie; / e sotto Cariddi gloriosamente l’acqua livida assorbe. / Tre
volte al giorno la vomita e tre la riassorbe / paurosamente. Ah, che tu non sia
là quando riassorbe”.
SCILLA
(mitologia greca)
Figlia di Niso, re di Megàra. Innamoratasi del nemico Minosse, che
assediava la città di Megàra, lo aiutò nell'impresa; per fare ciò,
recise al padre il fatale capello d'oro che aveva in testa e dal quale
dipendevano la sua vita e il destino della Patria. Niso infatti morì;
Minosse conquistò la città, ma fece lapidare l'innamorata parricida
che gli dèi mutarono poi in allodola. (Cfr. Virgilio, Georgiche, I.)
Figlia
di Tifone e di Echidna; in origine Ninfa bellissima, di cui s'invaghì
il dio marino Glauco, il quale, non riamato, per vendetta, dalla maga
Circe fece mutare la bella Ninfa in un orribile mostro latrante con sei
teste e le bocche dotate ciascuna di una triplice fila di denti. Per
l'orrore che ebbe di se stessa, Scilla si precipitò in mare e si
nascose in uno scoglio di fronte all'antro dove dimorava l'altro mostro
marino Cariddi. Da quel sito Scilla sporgeva le sue teste per spaventare
i naviganti o per rapirli quando le si avvicinavano. Secondo un'altra
versione, Scilla subì quella trasformazione per opera di Anfitrite,
gelosa della Ninfa perchè amata da Poseidone. Nella realtà Scilla e
Cariddi sono due scogli tra Reggio Calabria e lo Stretto di Messina. (Cfr.
Virgilio, Eneide, I, VII; Ovidio, Metamorfosi, XIII, XIV; Igino, Favole,
CXCIX.)
Cioè
la costa siciliana a destra.
Ulisse
decise di intraprendere questa seconda via, verso Sud. Partendo da Imera
lo Stretto di Messina offre la più breve via marina per raggiungere la
Grecia, nella durata indicata.
La
nave trascinata per nove giorni, alla decima notte si avvicinò
all'isola di Ogigia, dove abita Calipso.
A
Nord dello Stretto di Messina, l'unica isola in cui può essere
trasportato un naufrago, è il gruppo delle isole Lipari. Determinare
quale isola di questo gruppo sia l'isola Ogigia di Omero è difficile.
Secondo
Omero, l'isola si trova là dove si trova l'ombelico del mare; forse
questo farebbe concludere che si tratti dell'isola principale del gruppo
e cioè Lipari, o, a causa della forma del vulcano, Vulcano.
Ma
forse Omero si riferisce con la sua descrizione della ricchezza delle
piante a Panarea, anche qui si trovano insediamenti preistorici.
Sull'isola di Calipso, Ulisse si costruì una zattera con cui riuscì a
raggiungere la terra dei Feaci, che, finalmente, lo accompagnarono ad
Itaca.

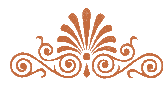
CARIDDI
- "Tra Punta
Pezzo in Calabria e Capo Peloro o Capo Faro in Sicilia la soglia
sottomarina s'innalza fino a raggiungere i cento metri sotto il livello
del mare. Accade che quando nel mar Tirreno, a nord, c'è alta marea, a
sud della soglia, nel mare Ionio, c'è bassa marea e viceversa. Questo
continuo alternarsi di basse ed alte maree, origina alterni flussi e
riflussi d'acque dall'uno all'altro mare che generano maree dal
dislivello medio di 15-20 cm., con punte massime anche di 50 cm., in un
ciclo completo di 24 ore e 50 minuti.
Si
creano così violenti spostamenti di masse d'acqua in senso orizzontale
e rapide emersioni di acque profonde, che creano estesi e vorticosi
gorghi detti refoli (garofuli), mitologicamente identificabili nei
mostri di Scilla e Cariddi.La rema montante, ovvero la corrente di
flusso che dal mare Ionio va al mar Tirreno, inizia nello Stretto circa
due ore prima del passaggio della luna sul meridiano di Messina, corre
ad una velocità di circa 9 km. all'ora ed ha una durata media di circa
6 ore. Il riflusso o rema discendente inizia una lenta discesa verso il
mare Ionio 4 ore prima di tale passaggio e genera una corrente di circa
156
 mt. al minuto. "Tanto durante il dominio dell'una o
dell'altra di queste correnti, si generano lungo le due rive dello
Stretto due contro correnti secondarie che formano nei seni lungo le
coste predette alcuni piccoli gorghi; tre gorghi principali, veri
vortici, si producono lungo lo Stretto; l'uno presso la Lanterna di
Messina ove si incontrano la corrente principale con la controcorrente
che esce dal porto e la controcorrente costiera; altro vortice si forma
alla Punta Pezzo in Calabria ove la corrente dominante è obblígata a
ripiegare per la configurazione dello Stretto e quindi a far resistenza
alla controcorrente lítoranea; un terzo vortice si forma presso la
spiaggia di Ganzirri ed è di minore importanza degli altri"'.Di
questo fenomeno naturale parla anche lbn Gùbayr nel suo libro
"Viaggio in Sicilia, ecc." (1183-1185), così descrive il suo
naufragio avvenuto nelle acque dello Stretto di Messina: "In questo
Stretto, il quale giace tra la Terra grande e l'isola di Sicilia, la
distanza fra le due coste è ridotta a sei miglia, e nel punto più
breve a tre. Il mare si precipita furioso in questo passo angusto come
la fiumana di al-'Arím, e bolle come una caldaia, tanta è la veemenza
della pressione e della spinta. Molto difficile riesce alle navi il
traversarlo..."'.
mt. al minuto. "Tanto durante il dominio dell'una o
dell'altra di queste correnti, si generano lungo le due rive dello
Stretto due contro correnti secondarie che formano nei seni lungo le
coste predette alcuni piccoli gorghi; tre gorghi principali, veri
vortici, si producono lungo lo Stretto; l'uno presso la Lanterna di
Messina ove si incontrano la corrente principale con la controcorrente
che esce dal porto e la controcorrente costiera; altro vortice si forma
alla Punta Pezzo in Calabria ove la corrente dominante è obblígata a
ripiegare per la configurazione dello Stretto e quindi a far resistenza
alla controcorrente lítoranea; un terzo vortice si forma presso la
spiaggia di Ganzirri ed è di minore importanza degli altri"'.Di
questo fenomeno naturale parla anche lbn Gùbayr nel suo libro
"Viaggio in Sicilia, ecc." (1183-1185), così descrive il suo
naufragio avvenuto nelle acque dello Stretto di Messina: "In questo
Stretto, il quale giace tra la Terra grande e l'isola di Sicilia, la
distanza fra le due coste è ridotta a sei miglia, e nel punto più
breve a tre. Il mare si precipita furioso in questo passo angusto come
la fiumana di al-'Arím, e bolle come una caldaia, tanta è la veemenza
della pressione e della spinta. Molto difficile riesce alle navi il
traversarlo..."'.
Allora
la nave di Gùbayr, è utile ricordarlo, urtò con la chiglia contro la
costa ed affondò. I naufraghi furono salvati dalle barche paesane,
subito accorse.Nel linguaggio popolare Cariddi cambiò nome e divenne
"u Galofuru o u Calofuru" per la somiglianza del suo ribollire
e dello spumeggiare delle sue crestine d'onda con la corolla a petali di
un garofano.
Di
parere contrario è lo Spallanzani il quale, nella descrizione di un suo
viaggio nel centro di Cariddi, sostiene che il gorgo "dai paesani
è chiamato Calofaro" non già dal ribollimento delle onde ma da
"Kalos e Pharos", cioè "bella torre, per esister Cariddi
presso la Lanterna".
Ed
ecco la descrizione che egli ne fa.
"La
barca che mi ci conduceva, era corredata da quattro sperimentatissimi
marinai, che all'accorgersi che dentro io vi entrava con qualche
ribrezzo, m'incoraggiarono, e mi promisero di farmi da vicinissimo
vedere il Calofaro, anzi di menarmici sopra, senza che avessi nulla a
temere. Osservato dal lido, mi appariva in sembianza d'un gruppo d'acque
tumultuanti, e a mano a mano che mi ci appressava, il gruppo diveniva più
esteso, più agitato, più eminente. Fui condotto fino ai lembi, ove
alquanto mi arrestai per farvi sopra i dovuti esami. Scopersi allora
senza ombra di dubbio non esser questo altrimenti un vortice. Insegnan
gl'ídrologi che per vortice nell'acqua corrente s'intende quel corso in
giro che ella prende in certe circostanze, e che questo corso o
rivoluzione genera nel mezzo una cava conoide capovolta, più o meno
profonda, la cui base all'íntorno colmeggia, e le interne pareti girano
a spira.

Ma niente di questo ravvisai nel Calofaro. Era esso
circoscritto da un giro circolare, tutto al più di cento piedi: ed
entro quei limití non eravi cavo di sorta, non moto vertiginoso, ma un
incessante ribollimento di acque agitate, che ascendevano, discendevano,
si urtavano, si respignevano. Questi irregolari movimenti, però, eran
placidi in guisa, che non vi era a paventar di nulla nell'andarvi sopra,
siccome feci. Solamente per la continua agitazione barcollava il mio
picciol legno, e conveniva far uso indefesso de' remi, perchè stesse
ritto, né spinto fosse fuori dal Calofaro. Alcuni corpi da me
lasciativi dentro cadere, se erano specifícatamente più gravi
dell'acqua, vi si attuffavano, né più ricomparivano: se più leggieri,
restavano a galla, ma d'indi a poco l'agitamento dell'acqua gli spingea
fuor di quel giro. Quantunque da queste osservazioni convinto io fossi,
che sotto al calofaro non si apriva alcun baratro o voragine, concíossíacché
allora vi dovesse essere un vortice atto ad ingojare i galleggianti, pur
m'invaghj di rintracciarne il fondo con lo scan aglio, e trovai che la
maggiore s a profondità non oltrepassava li 500 piedi: di più con
meraviglia appresi, che al di là del calofaro, verso il mezzo dello
Stretto, la profondità ne è doppia..."'.

MESSINA: SOPRA CARIDDI
Quando navigherai tra due scogli affacciati", disse Circe a Ulisse "vedrai che
uno è altissimo e liscio, e la sua cima affonda tra le mobi. Li è appostata
Scilla, nessuno la può vedere, tanto è capace di mimetizzarsi tra le rocce. Ma
d'improvviso, quando scorge una preda, un delfino, una balena o anche una nave,
balza fuori con teste mostruose irte di denti affilati, la ghermisce e la divora
É inutile tentare di opporsi, nessuno scampa. Ma se per evitarla avvicini
all'altra parte dello stretto c'è un pericolo altrettanto mortale: un gorgo che
inghiotte ogni cosa sino al fondo delle ac que. Per tre volte in un giorno
risucchia, per tre inverte la rotazione e rigetta i rottami. E una creatura
divina anch'essa, la chiama no Cariddi.
Tu naviga nel mezzo, ma sta' attento quando meno te lo aspetti Scilla balzerà
fuori con le sue teste e ti mangerà sei compagni. Però è meglio piangere sei
uomini che piangerli tutti." Cariddi sta proprio davanti alla costa siciliana,
vicino a Messina. Questa energia del profondo sembra simboleggiare la ribel
lione del sottosuolo contro quella infelice città, sotto cui la terra ha tremato
rante volte distruggendo tutto.
fonte
“La sicilia degli Dei” di G. Guidorizzi e S. Romani – Raffaello Cortina Editore

MESSINA
Capoluogo
della provincia, sulla costa nord-orientale, davanti allo stretto di
Messina, tra la Sicilia e la Calabria. Economia: agricoltura (agrumi),
industrie alimentari, di arredamenti, chimiche, edili, metalmeccaniche,
navali, plastiche, trasporti e varie. Il suo antico nome è Zancle, in
greco falce, ricorda la sua particolare forma fa lcata che ne fece sin
dall'antichità un sicuro approdo naturale.
lcata che ne fece sin
dall'antichità un sicuro approdo naturale.
In
età pre-greca fu abitata da popolazioni autoctone, forse Siculi. Nell'VIII
sec. a.C., Ioni e Calcidesi fondarono il primo nucleo urbano tra la
penisola di San Raineri e la zona del porto. La città cominciò a
crescere, favorita dai commerci e dai traffici portuali. Dal V sec. a.C.,
travagliata da lotte intestine,
conoscerà alterne vicende. Popolazioni messeniche cambiano il suo nome
in Messina. Dopo un periodo di dominio cartaginese (426 a.C.), la città
riusci a ritornare libera e ad allearsi con Siracusa, ma, ripresa dai
Cartaginesi, fu distrutta da Imilcone nel 396 a.C. La nuova città,
riedificata in età ellenistica da Dionigi di Siracusa, ricadde
ancora
sotto i Cartaginesi dai quali la liberò Timoleonte. Nel 289 la città
fu occupata da un gruppo di mercenari campani cacciati da Siracusa, i
Mamertini. Passata ai Romani nel 263 a.C., Messina divenne città
federata. Fino alla caduta dell'lmpero romano d'Occidente (476 d.C.), si
mantenne ricca e vitale. Dopo l'oscurità delle invasioni barbariche,
ritornò a splendere in età bizantina, quando furono ravvivate le
attività commerciali legate al porto. Nell'843, cedette all'invasione
musulmana e gli abitanti si rifugiarono in massa a Rometta, cercando di
resistere. Capitolarono soltanto nel 965 e, ritornati in città, ne
riorganizzarono la struttura urbana e la vita sociale ed economica. Con
l'età normanna, Messina divenne uno dei centri maggiori della Sicilia.
Fu
costruito il palazzo reale, attivato l'arsenale e potenziata la
fortificazione con mura lungo tutta la costa. Il fervore costruttivo
continuò nella successiva età sveva, con una nuova pianificazione
urbanistica e nuovo sviluppo verso nord. Dopo l'età angioina e la
guerra del Vespro, nella quale Messina ebbe parte attiva, un nuovo
ordine socio-economico e urbanistico verrà imposto da Federico
d'Aragona. Nel 300 e nel 400 cominciò a formarsi una nuova classe
borghese imprenditoriale, dedita particolarmente al commercio della
seta, delle pelli e della lana.
Nel 400, e più ancora nel 500, al
notevole sviluppo economico si uni l'apertura di nuove strade e piazze e
la sistemazione dei nuovi quartieri di espansione. La rivolta
antispagnola del 1674-78, violentemente stroncata, cancellò l'idea di
fare di Messina la capitale del viceregno di Sicilia. La repressione
della rivolta, l'esilio di molte famiglie, il peso di nuove tasse e
ripetute epidemie causarono l'impoverimento della città. Il terremoto
del 1783 fece il resto. La ricostruzione fu molto lenta anche a causa
dei continui rivolgimenti politici e cambiamenti di regime. Nell'800,
Messina era una città in decadenza. L'arrivo dell' unità d'Italia, con
l'evidente divario tra nord e sud, rese la situazione più grave. Il
segnale di una rinascita, almeno delle attività portuali, si avrà con
l'istituzione del servizio di traghetti per la Calabria.

Il
28 dicembre del 1908 un nuovo violento terremoto distrusse quasi
completamente Messina, causando circa 60 mila vittime. Il programma di
ricostruzione, lungo e laborioso, volle riconfigurare l'immagine della
città con una moderna pianta a griglia, salvaguardando e restaurando le
testimonianze architettoniche e artistiche che avevano resistito al
sisma e, soprattutto, badando all'antisismicità dei nuovi edifici. Tra
gli anni '30 e '50 sorsero i palazzi sulla cortina del porto che si
proponevano quali nuclei individuali e segno delle vivaci tendenze
artistiche e architettoniche di quegli anni. L'espansione degli ultimi
anni, caotica e priva di logica urbanistica, ha interessato soprattutto
le aree meridionali e settentrionali, dando origine ad ampie zone
periferiche.
Giungendo
a Messina dallo Stretto si vede, quasi al centro della penisola di San
Rainieri, la lanterna o torre di San Rainieri, di G. Angelo da
Montorsoli (1555), e, continuando, si incontra un'altra opera difensiva:
il forte di San Salvatore, progettato da Antonio Ferramolino nel 500.
Dalla stazione, entrati nella via I Settembre (tracciata nel sec. XVI),
all'incrocio con via U. Bassi è il palazzo della Banca d'Italia (1924).
Il vicino edificio della Dogana, costruito dopo il terremoto del 1908,
conserva alcune strutture originali e alcuni motivi in stile liberty.
Tra via I Settembre e via Garibaldi, asse principale della città,
caratteriz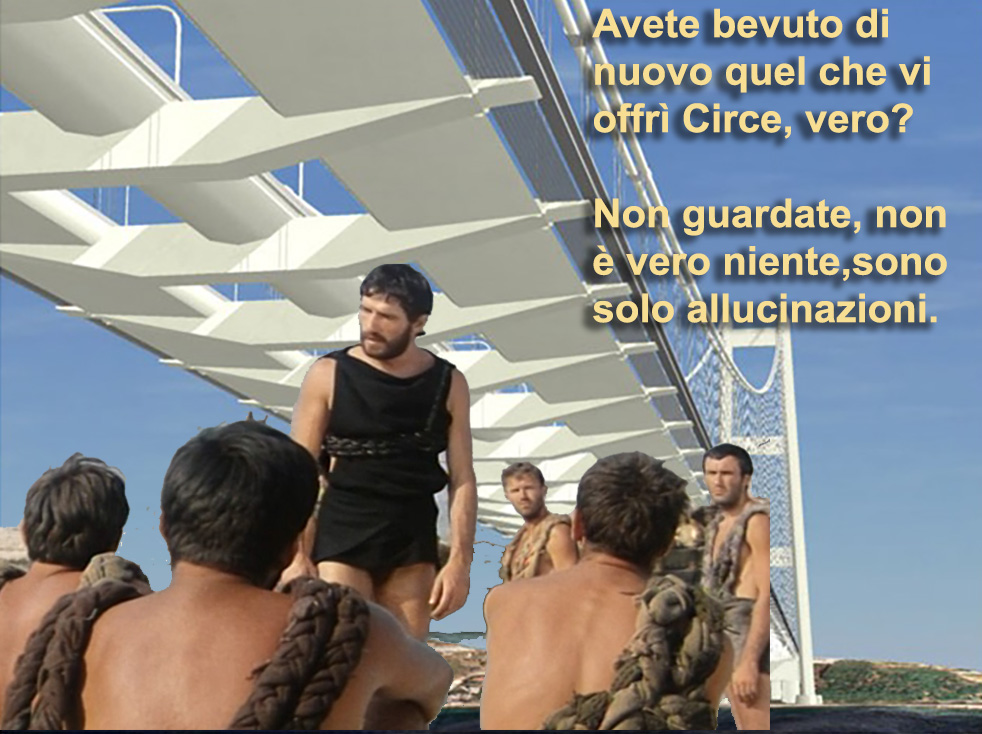 zato da un'edilizia dei primi del '900, si trova la chiesa di
Santa Maria degli Alemanni, d'età sveva, forse degli inizi del XIII
sec. Appartenne all'Ordine dei cavalieri di Gerusalemme. Gravi danni
furono causati alla chiesa dai terremoti del 1783 e del 1908. Soltanto
in questo secondo dopoguerra furono avviati i lavori di restauro. I
caratteri stilistici della chiesa denunciano un'attenzione verso modelli
gotici da parte di architetti venuti forse dal nord, al seguito degli
ordini religiosi. L'interno ha pianta basilicale a 3 navate e 3 absidi.
Delle parti scultoree, rimangono alcuni elementi e i due portali (quello
laterale quasi del tutto integro). Voltando per via Sant'Elia, si arriva
all'omonima chiesa, edificata verso la fine del Seicento.
zato da un'edilizia dei primi del '900, si trova la chiesa di
Santa Maria degli Alemanni, d'età sveva, forse degli inizi del XIII
sec. Appartenne all'Ordine dei cavalieri di Gerusalemme. Gravi danni
furono causati alla chiesa dai terremoti del 1783 e del 1908. Soltanto
in questo secondo dopoguerra furono avviati i lavori di restauro. I
caratteri stilistici della chiesa denunciano un'attenzione verso modelli
gotici da parte di architetti venuti forse dal nord, al seguito degli
ordini religiosi. L'interno ha pianta basilicale a 3 navate e 3 absidi.
Delle parti scultoree, rimangono alcuni elementi e i due portali (quello
laterale quasi del tutto integro). Voltando per via Sant'Elia, si arriva
all'omonima chiesa, edificata verso la fine del Seicento.
Gli stucchi e
gli affreschi dell'interno, danneggiati dalle calamità naturali,
mostrano chiari i segni dei restauri. Ritornati in via Garibaldi, si
incontra la chiesa di Santa Caterina di Valverde che all'interno
conserva alcuni elementi scultorei del Sei e del Settecento. Il
crocifisso sull'altare maggiore (sec. XVIII) è attribuito a Santi
Siracusa. Salendo dal viale San Martino fino all'incrocio con la via
Maddalena per raggiungere via Cesare Battisti, di fronte al largo
Avignone, è possibile vedere una parte dell'area della necropoli (V-ll
sec. a.C.) su cui fu edificata questa zona della città. Si continua
sulla via Cesare Battisti e, attraversando piazza Padre Francia, via A.
Martino, piazza Lo Sardo e via Santa Marta, si giunge alla chiesa di San
Paolino. Edificata agli inizi del 600, costituisce l'unico esempio quasi
integro dell'architettura di quest'età. La decorazione interna è
arricchita da stucchi e affreschi del 700. Tra piazza Carducci e piazza Maurolico, si arriva al Palazzo di Giustizia, edificato nel 1928 su
progetto di Marcello Piacentini. La facciata principale dà su piazza
Maurolico, dove prospetta anche l'Università di Messina che vanta una
lunga e illustre tradizione. Fondata nel 1548, fu soppressa nel 1679
dagli Spagnoli e ricostituita nel 1838. Imboccando la via G. Venezian,
si giunge in piazza del Duomo. L'impianto originario risale alI'età
normanna, agli ultimi anni del regno di Ruggero II.
Il
terremoto del 1908 lo distrusse quasi totalmente. Fu ricostruito tra il
1919 e il 1929 per opera di Francesco Valenti e poi fu ancora
danneggiato dai bombardamenti dell'ultima guerra, sicchè oggi si
presenta profondamente riconfigurato nella struttura, con qualche
elemento originario. Alla sinistra del Duomo si innalza l'alta mole del
campanile, un'opera stupefacente, progettata negli anni '30
dall'architetto Francesco Valenti e contenente uno straordinario
congegno meccanico ad orologio. Nella parte alta della torre, entro un
quadrante, sono indicate le ore. Negli ordini inferiori si susseguono
suggestive composizioni e figure semoventi, che sono tutto uno
spettacolo quando rintocca il mezzogiorno. Entriamo nel Duomo.

L'interno
ha schema longitudinale con tre lunghe navate divise da 28 colonne.
Totalmente riconfigurato, presenta alcuni elementi decorativi aggiunti
nel corso dei secoli. In corrispondenza della navata destra si apre la
scala che porta alla Cripta. Della grande mostra marmorea denominata
"Apostolato", che correva lungo le pareti laterali della
chiesa, rimane la statua di san Giovanni Battista, attribuita ad
Antonello Gagini. Il grandioso organo del transetto è opera moderna
(1948). Gli elementi scultorei e decorativi del presbiterio sono
totalmente ricostruiti sugli originali distrutti: il baldacchino del
Quagliata del 1628, l'altare maggiore, il coro ligneo di Giorgio
Veneziano. I mosaici absidali sono anch'essi rifatti. Vicino al Duomo,
è da ammirare la Fontana di Orione, opera di Giovanni Angelo Montorsoli
(15471551). Nella vasca inferiore sono figure rappresentanti i fiumi
Tevere, Nilo, Ebro e Camaro, attorniati da putti, conchiglie e vari
altri elementi decorativi. Il fusto è composto da figure di donne e di
tritoni. In alto vi è Orione con delfini e putti.
Come
raggiungere Messina
Treno:
La stazione FS di Messina costituisce punto obbligato di fermata per
tutti i treni provenienti da altre località italiane che approdano in
Sicilia. Da
Palermo: linea Palermo-Messina. Da Catania: linea Catania-Messina.
Auto:
Messina costituisce il primo punto d'approdo per il transito veicolare
proveniente dalle altre località italiane. Da
Palermo: autostrada A19 direzione Messina. Da Catania: autostrada A18
direzione Messina.
Aereo:
aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria e aliscafi-navetta per
Messina.
Aeroporto
di Catania Fontanarossa e autobus di linea Etna Trasporti da Catania a
Messina via autostrada.
Manifestazioni
Fiera
Campionaria Internazionale
(1 - 15 agosto).
Sfilata
dei giganti Mata e Grifone (13 e 14 agosto).
Processione
della "Vara "(agosto).

l'Etna dal Lungomare Reggio Calabria
(foto Nino Gemmellaro)

Il
Dio marino Glauco, innamorato della ninfa Scilla, decide di ricorrere
alle arti magiche della Maga Circe. Dalla Sicilia… con valide braccia
poscia
solcando il Tirreno pervenne all'erbose colline ed al palazzo di Circe,
la figlia del Sole, ripieno
tutto di belve. La
salutò nel vederla,
risultato, dicendo:
"Pietà, ti scongiuro, d'un Dio! Poiché tu sola, se degno ti
sembro, mi puoi alleviare
la passione amorosa.
Nessuno sa meglio di Glauco
quanto
sia grande la forza dell'erbe, che m'hanno mutato. … non farmaco
chiedo
che la ferita mi
sani: non questo m'occorre; ella senta
parte del fuoco che
m'arde! "Ma Circe (nessuna di lei è
meglio adatta agli amori improvvisi)… …
così gli rispose:
"Faresti
meglio a seguire
qualcuna che voglia te pure, infiammata
dalla medesima
passione"…
ecco
io stessa, una diva, la figlia del nitido Sole, che tanto posso con
carmi e pur anche con l'erbe, vorrei
essere tua. Lei
sprezza che spregia e seconda chi t'ama;
e in un tratto
soltanto fa' la vendetta di due".
Glauco
così rispondeva alla diva che lo lusingava: "Prima le fronde nel
mar nasceranno o su l'alte montagne
l'alghe,
ch'io muti, vivendo, l'amore che nutro per Scilla".
Ne
fu sdegnata la Dea, che nuocere non gli potendo
e non volendo, perché
n'era presa, s'adira con quella
che
l'è preposta; ed offesa per tale rifiuto d'amore,
subito trita erbacce
d'orribili succhi, e,
nel tritarle, sussurra dei carmi acatei; un'azzurra
veste si mette e,
tra mezzo alle belve che fannole festa, esce
dall'atrio e va verso Reggio, di fronte a Messina…In un'insenatura,
dove Scilla è solita bagnarsi, Circe infetta
le
acque del mare con veleni spremuti da radici ripetendo parole
magiche. Scilla poco
dopo entra nell'acqua e subito si vede la
parte
inferiore del corpo bruttata da cani ringhiosi; in seguito viene mutata
in rupe.
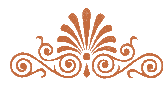
Il
figlio di Nettuno.
Si
contendono la paternità di questa leggenda diverse località del
Mediterraneo. Noi la collochiamo nell'area del Peloro, seguendo una
delle tradizioni più diffuse.
Racconta
un'antica leggenda che nell'era grande della preistoria, venne a Capo
Peloro, nella cuspide nord-orientale della Sicilia, un giovane della
Beozia di nome Glauco, ritenuto figlio di Nettuno. Aiutato da alcuni
amici, tagliò sui monti intorno alcuni alberi di pino e con il legno
ricavato costruì una barca snella e veloce che dipinse con i colori del
mare, e cioè di azzurro e di verde. Allora, come mestiere, si mise a
fare il pescatore e divenne così bravo e così abile che le sue reti,
alla fine di ogni pesca, risultavano sempre piene di una quantità
enorme di pesci. Glauco non tratteneva mai per sè tutta quell'abbondanza
di pescato, ma la ripartiva con gli amici e per sè teneva solo quanto
bastava per nutrirsi e vivere alla giornata. Oltre ad essere generoso e
di buon cuore, Glauco era anche bello come un dio. Aveva gli occhi
azzurri, con sopracciglia folte e arcuate, il naso dritto e regolare, e
la bocca rosea e morbida come quella di un fanciullo, mentre una barba
corta e riccioluta gli incorniciava il mento, deliziosamente. I suoi
capelli erano lunghi e sottili come fili di seta e gli scendevano sulle
spalle morbidi e carezzevoli, e quando camminava oscillavano ad ogni suo
movimento e sotto al sole cambiavano di colore, passando dal biondo al
ramato.
barba
corta e riccioluta gli incorniciava il mento, deliziosamente. I suoi
capelli erano lunghi e sottili come fili di seta e gli scendevano sulle
spalle morbidi e carezzevoli, e quando camminava oscillavano ad ogni suo
movimento e sotto al sole cambiavano di colore, passando dal biondo al
ramato.
Tutte
le nereidi, Tetide, Anfitride, Panope e la stessa Galatea bianca come il
latte, assieme alle sirene ammaliatrici e alle sorridenti ninfette delle
acque, venivano dalle parti del Peloro per conoscerlo e parlargli.
Spesso, alcune di esse, si spingevano fin sulla spiaggia e più d'una,
avvinta dal suo fascino, gli sorrideva con invitante simpatia. Glauco
era gioioso con tutte e scherzava come fa un buon compagno di giochi. Ma
in particolare non guardava nessuna, contento solo di godersi la
scanzonata libertà della sua verde giovinezza e quel senso giocondo di
disporre pienamente e liberamente del suo tempo e dei suoi pensieri.
Un
giorno, assieme alle sirene e alle ninfe, dalle parti di capo Peloro
venne la figlia di Forco, la dolce e romantica Scilla, fanciulla
bellissima e soave, piena di vita e desiosa d'amore. Nel suo piccolo
cuore pulsavano i sogni di giovinetta e tutta lei stessa, ancora,
s'infiammava al pensiero del suo ipotetico futuro amore.
Quando
Scilla vide Glauco, sentì il cuore batterle più forte e il sangue le
salì alle gote e le imporporò il viso di desiderio. Da quel momento,
ogni giorno, sul far dell'alba, lei cominciò a venire alla riva del
Peloro ad aspettare con il cuore innamorato e palpitante che il biondo
Glauco venisse a preparare la sua barca per la pesca. Poi se ne restava
ansiosa ad attenderlo fino al tramonto, fino a quando non lo vedeva
tornare con le ceste colme di pesci ed avviarsi poco distante, alla sua
piccola dimora. Scilla era timida e mai avrebbe osato dichiarargli il
suo amore. Perciò si accontentava solo di guardarlo, di sorridergli e
di sperare. Glauco, invece, la guardava e le sorrideva con simpatia. E
qualche volta, forse, dovette anche rivolgerle un sorriso più
affettuoso o accennarle una carezza, e Scilla s'infiammò ancora di più,
cullandosi nel sogno di quel suo ingenuo amore, puro e sincero come è
sempre puro e sincero il primo amore.
Un
giorno passò dalle parti del Peloro la maga Circe, la bianca fanciulla
dalla pelle vellutata come un petalo di rosa, ma volubile come una
frasca al vento, sempre languida e desiosa di ebbrezze d'amore. Scilla
l'ebbe per amica, e assieme andarono a fare i bagni nel laghetto dei
Margi. A sera, poi, andavano a passeggiare lungo le rive dei Ganzirri,
ad ammirare il verde-azzurro fluttuare delle onde del mare che dal
Tirreno correvano lente ma costanti verso il mare Ionio.
Scilla,
un giorno, confidò a Circe il suo amore per Glauco e in cambio ebbe
consigli e una promessa d'aiuto.
-
Fammi vedere questo tuo straordinario giovane! - le disse la maga - Ed
io t'insegnerò il modo di conquistarlo...
Il
giorno dopo Circe e Scilla si recarono sulla spiaggia. Glauco giunse
poco dopo. Nella lucentezza dell'alba alle due donne egli apparve bello
come un dio, agile come un'atleta e smagliante in tutta la sua
giovinezza, esaltata dai capelli biondi e dagli occhi azzurri, profondi
come il mare. Circe ne rimase ammaliata e se ne innamorò.
-
Bello è Glauco, figlio di Nettuno! - pensò estasiata nella sua mente -
È l'essere più bello che io abbia mai visto... Ho deciso! Egli fa
giusto al caso mio... È l'uomo adatto al mio furente amore... Lo farò
mio amante!...
-
E tu! - disse poi a voce alta, rivolta a Scilla - Cercati un altro uomo,
perchè Glauco dai capelli biondi e dagli occhi di mare, ora appartiene
a me!...
Scilla
tremò. Quelle parole furono per lei una sentenza di morte. Come poteva,
l'ingrata maga, rubarle il suo amore? E non s'accorgeva che Glauco per
lei rappresentava la vita? Male aveva fatto a confidarle i suoi
sentimenti. Sentì il cuore quasi fermarsi e poco mancò che non
morisse.
E
continuò invano a supplicarla. Per farle piacere la chiamò con tutti
gli aggettivi più belli che conosceva. Si fece umile e piccola,
strisciando quasi ai suoi piedi. Dapprima Circe l'ascoltò ridendo,
beffandosi dei suoi sentimenti di fanciulla.
Poi,
seccata, avvelenò il fonte in cui Scilla sovente veniva a bagnarsi e
quindi, impugnata una bacchetta magica, la toccò su una spalla. E
avvenne l'incredibile. Ingannata dalla maga, Scilla cominciò a
trasformarsi in un mostro marino, con sei teste latranti e dodici
orribili e deformi gambe. La sua pelle, prima liscia e delicata come un
petalo di rosa, cominciò a coprirsi di squame ruvide e lucenti, e la
sua voce, prima melodiosa e dolce, ora divenne rauca e abbaiante.
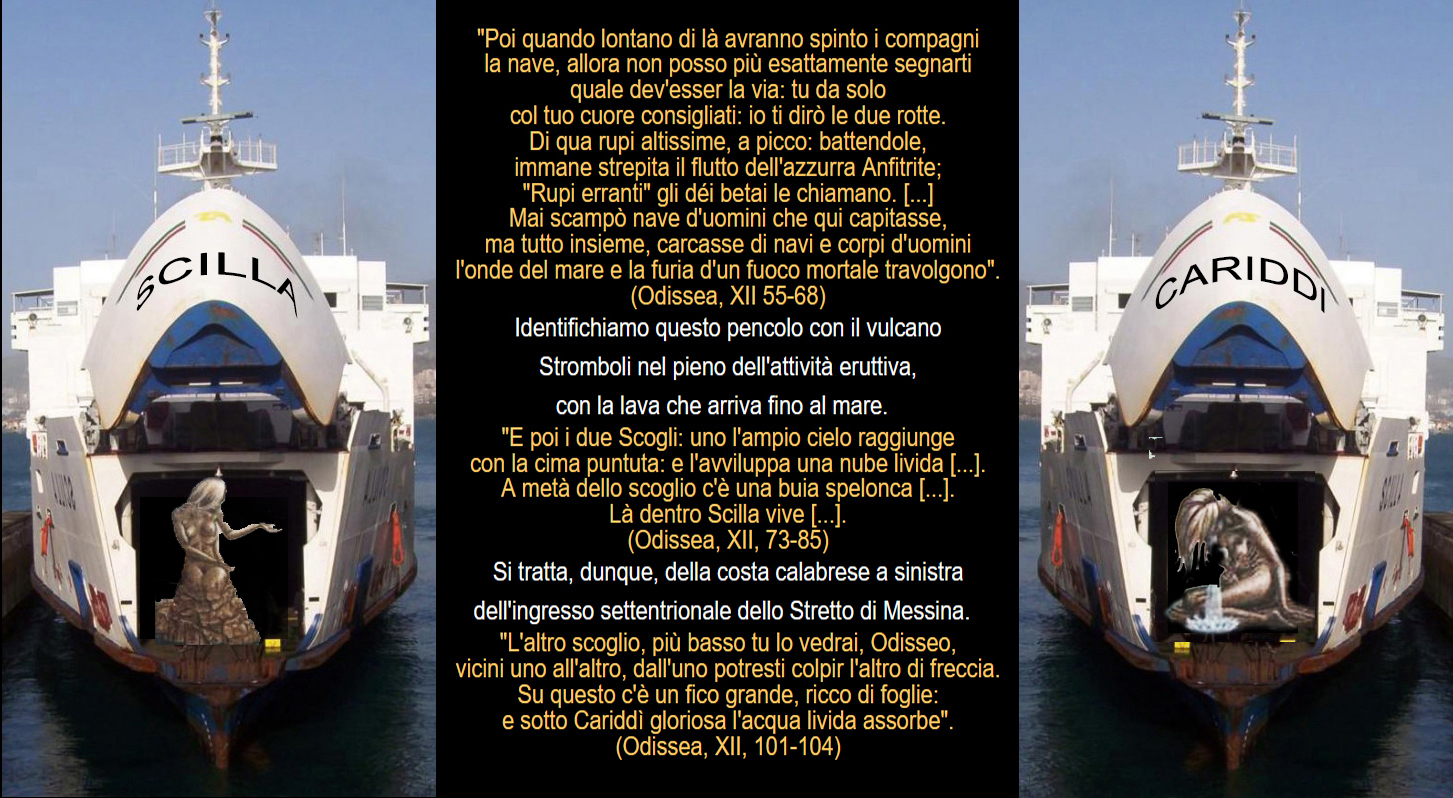
Appena
Scilla s'accorse d'essere divenuta un mostro, non resse alla
disperazione e si gettò in mare. Il suo cuore si trasformò in macigno
e s'incrudelì al punto da costringerla a far strage dei naviganti che
avevano la ventura di passare dalle parti della sua caverna. La stessa
Circe, più tardi, descrivendola ad Ulisse, la definì un: "...prodigio
immortale uno spavento, un orrore selvaggio con cui non si lotta: contro
di lei non c'è riparo bisogna fuggire".
Intanto
la perfida Circe se la spassava con Glauco. Ma quando venne la
primavera, volubile com'era, si stancò del suo amore e lo lasciò.
Prima voleva tramutarlo in un animale, come aveva fatto con i suoi
passati amanti, ma non potè farlo perchè Glauco era figlio di Nettuno.
Perciò lo lasciò senza neanche dirgli addio e se ne tornò nella sua
isola di Eea. Quando Glauco s'accorse d'essere stato abbandonato, cadde
in una tristezza profonda. Ma la sua amarezza divenne sofferenza quando
seppe della brutta fine di Scilla, di quella piccola creatura dalla voce
melodiosa che tutte le mattine per tanto tempo, lo aveva atteso sulle
rive del Peloro e che la perfida Circe, per gelosia e con l'inganno,
aveva cambiato in un orrido mostro marino.
-
Oh grandi dei! - inveì in cuor suo - Perchè mi dannaste a così
crudele destino?
Ora,
ogni giorno, Glauco aveva preso l'abitudine di uscire con la barca fuori
dalle acque dello Stretto e di avvicinarsi all'antro di Scilla. Quando
giungeva nei pressi, la chiamava per nome e cominciava a rammentarle il
tempo felice dei loro primi incontri. L'orrido mostro, più di una
volta, fu sul punto d'avventarsi contro con le sue bocche latranti ed
inghiottirlo. Ma, pur se soggetta alla demenza canina, forse, nel cuore,
manteneva ancora qualcosa del suo amore di donna. Così, dopo aver
latrato minacciosa, finiva per acquietarsi e rientrava nelle buie
caverne marine mentre Glauco, afflitto e disperato, tornava alla
spiaggia dello Stretto.
E
intanto passarono gli anni. Glauco, sempre più malinconico, divenne un
vecchio curvo, pieno di ricordi e di rimorsi. Egli, non si allontanò
mai più dalle rive dello Stretto e continuò a vivere solitario ed
eremita, vivendo solo del prodotto della sua pesca, per fortuna, sempre
abbondante. I capelli e la barba gli erano incanutiti, ma gli occhi
erano rimasti vivi e lucenti, forse un poco tristi a causa del tenero e
mai scomparso ricordo di Scilla quando, ancora giovinetta, dolce e
bellissima, si era perdutamente innamorata di lui.

Glauco,
ora, era anche stanco. Ogni giorno, tornando dal mare, remava sempre più
lentamente e con più fatica. Una volta, mentre tornava da una pesca
lontana, vide in mezzo al mare un'isola bellissima piena d'alberi e di
fiori. Persino sul bagnasciuga vi cresceva un'erbetta verde e argentata,
soffice e molle come un bellissimo tappeto di Persia.
Glauco,
improvvisamente, si sentì stanco e triste. Accostò con la barca a
quell'isola sconosciuta, tirò a secco le reti e sedette sulla soffice
erbetta, cominciando a selezionare i pesci pescati. E allora egli vide
una cosa incredibile, meravigliosa. Quei pesci, appena toccavano quell'erba,
tornavano a vivere, e a piccoli balzi saltellavano verso il mare, e vi
si tuffavano dentro riacquistando vita e vigore.
Glauco
restò sbalordito. Mai, in vita sua, aveva visto o sentito parlare di
cose simili. Ora era vecchio e stanco, e anche un tantino miope. Ma
quello che vedeva era realtà e non sogno. Colse un ciuffo di quell'erba
e lo mangiò. Oh, che sapore bellissimo aveva quell alga! Nella sua
mente tornò il ricordo degli aromi dei cibi mangiati nella prima
fanciullezza, e gli parve d'avere in bocca zucchero e miele ed elisir, e
tutte le leccornie che aveva mangiato da bambino. E allora colse altri
ciuffi di quell'erba e li mangiò e così di seguito, con ingordigia,
fino a divenire sazio.
E
allora in lui s'avverò il miracolo. D'un tratto il suo corpo ebbe un
fremito. I suoi piedi cominciarono a colorarsi di verde e poi le gambe,
le braccia, il busto e la faccia, divennero verdi come il colore di
quell'alga che aveva mangiato.
La
sua barba cominciò ad assumere un bel colore verde e su tutto il corpo
gli spuntarono peli verdi e lunghi, sottili e fini come fili di seta. II
cuore di Glauco s'empì di gioia, mentre una forza incontenibile, più
grande della sua stessa volontà, lo fece alzare da terra e correre
verso il mare, dentro al quale s'immerse con un gran salto.

Scilla (RC ) - foto di Antonio Treccarichi
Oh,
il grande dolce sapore del mare, l'cstasi sublime in cui ogni sentimento
s'annulla e la pace si confonde con la gioia! Lievi le onde lo
accarezzarono sfiorandolo e Glauco, il biondo ceruleo Glauco, divenne un
tritone del mare, immortale e profetico.
Sul
fondo egli vide una casa attorniata da un giardino bellissimo, pieno di
alghe e di coralli, un caleidoscopio di colori stupendi, mentre attorno
si udiva una musica dolcissima e allettante. Vi entrò e ne fece la sua
reggia.
Da
quel giorno Glauco volle restare per sempre nel mare dello Stretto. Si
rivide con Scilla? Le parlò? Cessò, per questo, Scilla, di far strage
dei naviganti? Dice la leggenda che anche ai tempi nostri, quando
infuria la tempesta, Glauco solleva il capo al di sopra delle onde e
subito, il mare si fa calmo e diventa invitante, come lo era nella
preistoria, quando Scilla era ancora una fanciulla bellissima e non un
feroce mostro mari no, con dodici gambe e sei latranti teste canine.
Tratto da: Miti e Leggende di Sicilia
di Salvino Greco e Dario Flaccovio
Editore.

LA TERRA DEL SOLE
In quest’isola i compagni di Odisseo, affamati, mangiano le
vacche sacre al dio Sole. Zeus scatena allora una tempesta e li fa naufrgare. Si salva solo il nostro eroe che giunge naufrago a Ogigia da
Calipso.
Secondo
la maggior parte degli studiosi, Omero chiamava la Sicilia “Trinacria“,
Θρινακίη, da τρεῖς «tre» e ἄκρα «promontorio»; secondo il noto professore
settecentesco di lettere greche, Giacomo Martorelli, che scrive: «Ora è d’uopo
ravvisare il sito di quest’isoletta, la quale sì misera ci vien descritta da
Omero, e solo di qualche fama, perché in essa pascevansi gli armenti del Sole.
E
certamente non poteva esser altra, che quella, che vedevasi avanti Siracusa, che
col falso nome i figli di Omero l’appellarono Ortigia, dimentichi affatto del
suo vero nome di Θρνακίη (-α)».
fonte: Viaggiando in Sicilia con Ulisse, il più arguto degli eroi -
Giusi Patti Holmes
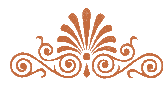
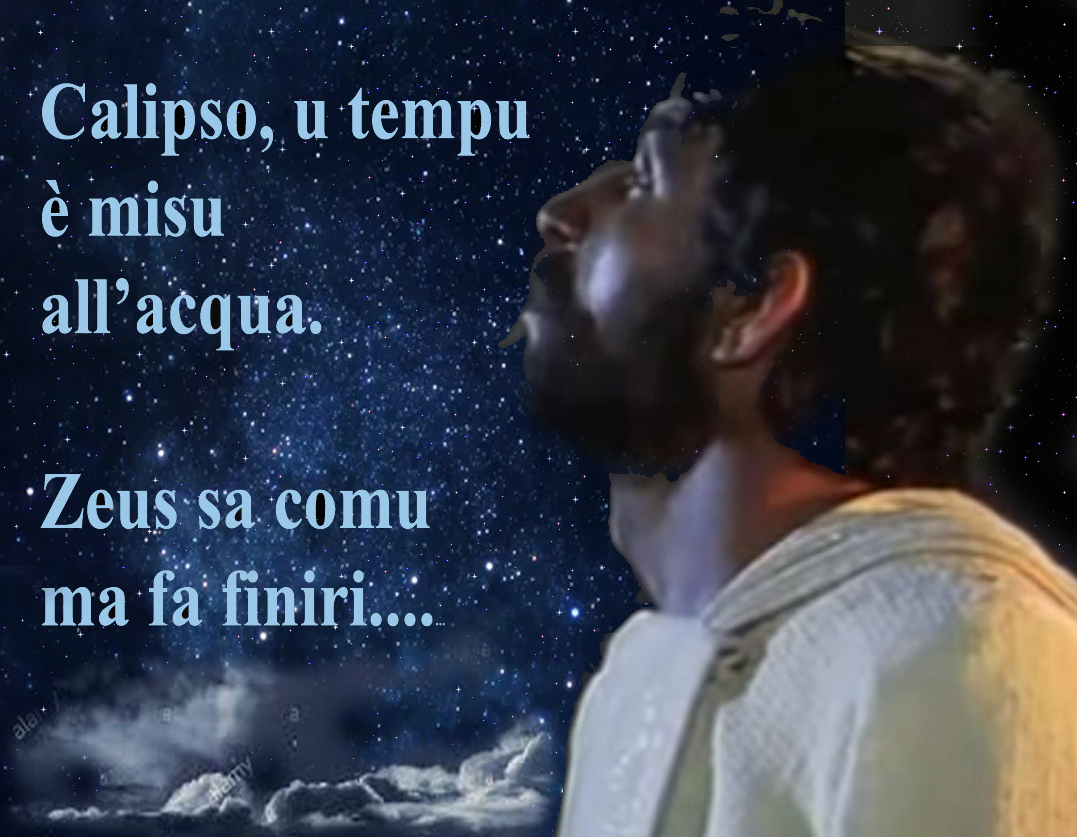 CALIPSO
(
il cui nome vuol dire la Nascosta) è la Ninfa che nell’Odissea
trattiene
Ulisse con sé per dieci anni, inutilmente offrendogli
l’immortalità perché rimanesse con lei. Ermes le ordinerà
di
lasciarlo partire per volere di Zeus. In realtà Calipso è
una delle
antiche dee mediterranee,una delle Madri Venerande,
relegata
lontana dal
potere, che ora detengono gli dei Olimpici. E' una figura della
mitologia greca, Oceanina (ovvero figlia di Oceano e Teti), regina
dell'isola di Ogigia. Secondo altri figlia del sole e sorella della maga
Circe, o anche figlia del gigante Atlante. Viveva in una grotta
incantata, tappezzata da zolle erbose, con fiori d'acqua e ninfee.
CALIPSO
(
il cui nome vuol dire la Nascosta) è la Ninfa che nell’Odissea
trattiene
Ulisse con sé per dieci anni, inutilmente offrendogli
l’immortalità perché rimanesse con lei. Ermes le ordinerà
di
lasciarlo partire per volere di Zeus. In realtà Calipso è
una delle
antiche dee mediterranee,una delle Madri Venerande,
relegata
lontana dal
potere, che ora detengono gli dei Olimpici. E' una figura della
mitologia greca, Oceanina (ovvero figlia di Oceano e Teti), regina
dell'isola di Ogigia. Secondo altri figlia del sole e sorella della maga
Circe, o anche figlia del gigante Atlante. Viveva in una grotta
incantata, tappezzata da zolle erbose, con fiori d'acqua e ninfee.
_____________________
Questa
isola viene descritta da Ulisse come un posto paradisiaco della felicità e
dell'immortalità.
Sono
diverse le collocazioni attribuite ad Ogigia nella geografia reale: appena fuori
dallo stretto di Gibilterra oppure, secondo tradizioni locali della Dalmazia,
l'isola di Meleda; secondo altri autori invece è l'isola di Gozo nell'arcipelago
maltese, dove è possibile visitare la grotta "di Calipso" che sovrasta la
spiaggia rossa della Baia di Ramla; ancora, l'isola di Gavdos a sud della
Grecia. Secondo alcuni recenti studi, Ogigia si troverebbe di fronte ai
monumenti alla costa calabra del Mar Ionio, in corrispondenza della Secca di
Amendolara o nei pressi di Punta Alice a Cirò Marina. Per altri ancora si
tratterebbe dell'isola di Pantelleria.
Incerta
è l'ubicazione che la tradizione letteraria greca assegna a questo popolo:
accanto alla immaginaria Iperia, vi è la collocazione che li vorrebbe gli
antichi abitanti di Corcira (l'odierna Corfù), accolta da Tucidide. Strabone,
nella sua Geografia, la colloca invece nel mezzo dell'Oceano Atlantico, al pari
di Ogigia, l'isola della ninfa Calipso.
Qui vive la ninfa Calipso, che
invaghita si di Odisseo, gli impedisce per sette lunghi anni di
riprendere il mare. Al settimo anno, però, per volere degli dèi, Odisseo
lascia l’isola a bordo di una zattera.
fonte: historicaljourney.it
si di Odisseo, gli impedisce per sette lunghi anni di
riprendere il mare. Al settimo anno, però, per volere degli dèi, Odisseo
lascia l’isola a bordo di una zattera.
fonte: historicaljourney.it
_____________
Ogigia, in lingua greca Ὠγυγίη, è l’isola di Calipso, dove Ulisse si
ferma per ben otto anni. La ninfa si innamora a tal punto dell’eroe itacese da
non volerlo più lasciar partire
se non a seguito di un ordine esplicito di
Hermes, a sua volta inviato da Zeus. Ogigia, per alcuni identificata appena
fuori dallo stretto di Gibilterra, per altri nell’isola di Gozo, dove è
possibile visitare la “grotta di Calipso”, per noi siciliani, sposando la tesi
di Butler, invece, è l’isola di Pantelleria. Omero, per Ogigia è categorico, si
tratta di una terra solitaria, che non ne ha altre vicine, ombelico del mare, “omphalos”,
isola sacra sede di una divinità. Il misterioso nome di Calipso,
personificazione della preistorica Dea dell’Amore, che a Pantelleria era
presente, conduce a uno dei suoi luoghi più magici, lo Specchio di Venere.
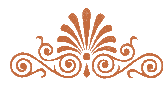
ISOLA DEI FEACI
Lo
scrittore Ph. Champault, nel suo libro 'Phéniciens et Grécs en Italie d'après l'Odyssée'
dimostra che la terra dei Feaci, la loro città Scheria ed i Feaci stessi si
identificano con l'isola d'Ischia e con quella colonia di Fenici ellenizzanti
che vennero primi a stabilirsi in essa. Armin Wolf, docente di Storia medievale
presso l'università di Heidelberg e ricercatore presso il Max Planck Institute
di Francoforte, sostiene che Ulisse, prima del suo imbarco per ritornare a
Itaca, abbia attraversato via terra l'Istmo calabrese e ritiene che la terra dei
Feaci sia da identificare con l'attuale territorio compreso tra il golfo di
Sant'Eufemia e quello di Squillace.
Altri individuano sempre il territorio
calabrese, ma localizzano la terra dei Feaci nella punta meridionale della
Calabria. Uno studio ne teorizza addirittura l'esatta ubicazione collocandolo a
Palmi, lungo le coste Calabre della Costa Viola.
Altri
ancora identificano l'isola di Scheria con la Sardegna, in quanto anch'essa
collocata nel mare occidentale, popolata da abili navigatori e con usanze simili
a quelle di Scheria come la lotta tra i pugilatori (attestata dai bronzetti
nuragici e dai "giganti" di Monte Prama) e il famoso ballo tondo, inoltre anche
la Sardegna nuragica era probabilmente dominata da diversi sovrani. Sono altresì
da menzionare le ipotesi degli studiosi Pietro Sugameli (1845-1922) e Ciro
Scotti (1883-1943), secondo le quali la terra dei Feaci sarebbe da identificare,
rispettivamente, con la Sicilia occidentale (si veda il saggio di Sugameli del
1892 Origine trapanese dell'Odissea) e con l'isola di Ischia (si confronti
l'opera di Scotti datata 1908 Omero e l'isola d'Ischia).
Attribuibile in Grecia, altri dicono a Trapani.
fonte: historicaljourney.it
____________________________
Ultima
suggestione di Samuel Butler (1835 – 1902), scrittore inglese e autore del libro
“The authoress of the Odyssey”, pubblicato nel 1897, è quella secondo cui la
Scheria, terra dei Feaci, dell’Odissea, fosse in realtà la città di Trapani,
destando nel suo paese incredulità e sconcerto.
Dopo
aver tradotto dal greco l’Odissea, e aver compiuto una serie di viaggi in
Sicilia, si convinse, inoltre, che l’Odissea fosse stata scritta da una giovane
donna siciliana celatasi nel personaggio di Nausicaa, la figlia di Alcinoo, re
di Scheria, avendo riscontrato nella civiltà siciliana i requisiti descritti nel
poema. Fonte: Viaggiando in Sicilia con Ulisse, il più arguto degli eroi -
Giusi Patti Holmes


Greche
sono le focacce, il pane nero di Castelvetrano, la ricotta salata indispensabile
nella gustosa catanese pasta alla Norma.
Siciliana è a
ricotta 'nfunnata l pastori che vivevano sul Nebrodi, salle
Madonie e sui Peloritani durante gli Inverni nevosi, non potendo scendere a
valle per vendere la ricotta, la salavano o la ponevano nel forno a legna per
disi dratarla. Si realizzava bensi un prodotto saporito e non deteriorabile: a
ricotta nfunnaata
Anche
il nostro
maccu (purea di fave) ha origini greche.
Aristofane (430 aC 195 aC) nella commedia te rane lo descrive. A Bronte lo
chiami amo frattu (fractus). Lo stesso Aristofane ne elogia le doti
afrodisiache e riferisce che Ercole poté stuprare in una notte diecimila vergini
sole dopo aver mangiato un'enorme zuppa di
fave. Anche Tarabo al-Arbüli (XI
sec.) sosteneva che, sebbene astringenti e produttrici di gas, le
fave
fornivano buon nutrimento e producevano seme. Vittorio Consoli nei Viaggiatori
in Sicilia scive: «Anche le fave fresche in Sicilia sono buone e i contadini,
generosi e cordiali nell'offrirle ai viaggiatori, permettono scrive Goethe -
che se ne mangino quante se ne vuole».
amo frattu (fractus). Lo stesso Aristofane ne elogia le doti
afrodisiache e riferisce che Ercole poté stuprare in una notte diecimila vergini
sole dopo aver mangiato un'enorme zuppa di
fave. Anche Tarabo al-Arbüli (XI
sec.) sosteneva che, sebbene astringenti e produttrici di gas, le
fave
fornivano buon nutrimento e producevano seme. Vittorio Consoli nei Viaggiatori
in Sicilia scive: «Anche le fave fresche in Sicilia sono buone e i contadini,
generosi e cordiali nell'offrirle ai viaggiatori, permettono scrive Goethe -
che se ne mangino quante se ne vuole».
Al
banchetto funebre greco risale u
cúnzolu siciliano,
pranzo offerto da parenti ed amici alla famiglia colpita da un grave lutto per
intrattenerla e consolarla. Omero chiude l'Iliade con il banchetto funebre in
onore di Ettore: «Nella vasta eccelsa reggia di Priamo adunati, funebre celebrar
tanto banchetto». (Iliade, libro XXIV). Giovanni Verga ne I Malavoglia descrive
u cunsolu tra gli abitanti di Acitrezza «Gli amici portavano qualche cosa, com'è
l'uso, pasta, ova, vino e ogni ben di Dio, che ci sarebbe voluto il cuor
contento per mangiarsi tutto, e perfino compar Alfio Mosca era venuto con una
gallina per mano. Il banchetto funebre in Grecia si concludeva con il Koliva un
dolce preparato con frutta secca, semi ed il tutto amalgamato con il miele.
cunsolu tra gli abitanti di Acitrezza «Gli amici portavano qualche cosa, com'è
l'uso, pasta, ova, vino e ogni ben di Dio, che ci sarebbe voluto il cuor
contento per mangiarsi tutto, e perfino compar Alfio Mosca era venuto con una
gallina per mano. Il banchetto funebre in Grecia si concludeva con il Koliva un
dolce preparato con frutta secca, semi ed il tutto amalgamato con il miele.
In
Sicilia i rituali funerari ricordano quelli dell'antica Grecia dove il morto.
come oggi in Sicilia, veniva posto con i piedi verso la porta pronto per uscire.
Greca
era l'usanza di coinvolgere le donne del vicinato per decantare con struggenti
lamenti le doti del morto
Epicarmo elenca anche i frutti di mare offerti ad Eracle: «Egli porta qui specie
di conchiglie, patelle, aspidi, crabizi, cicibolli, ostriche, pittignoni,
ghiande, porpore, chiocciole e spaguzze, che sono dolci al palato ed aguzzi nel
conficcarsi
Nella commedia Le Sirene si ipotizza che Ulisse non fu incantato dalle
sirene ma
dal profumo dei pesci di Sicilia arrostiti e dalla fragranza che
sprigionava la porchetta sulla brace.

________
Fonte: SPIGOLATURE STORICHE
SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne editrice 2019 -
©
tutti i diritti riservati - esclusiva
concessione del Prof. Schilirò per il sito web mimmorapisarda.it
La
cucina messinese
Nell'area dello Stretto, la tradizione millenaria
della pesca del pescespada è alla base di una cucina, quella messinese
appunto, famosa per i tanti piatti che esaltano la tenerezza e l'aroma
della sua carne. Già nell'antichità il pescespada figurava nelle mense
più raffinate, come attesta il gastronomo e poeta Archèstrato di Gela
(IV secolo a.C.) Una ricetta tipica è quella del pescespada a gghiotta,
cucinato cioè in una gustosa salsa di pomodoro, cipolla, arricchita con
capperi, sedano e olive verdi snocciolate. Secondo gli intenditori per
esaltare la carne del pescespada bisogna arrostirne le trance sulla
brace e condire col sammarigghiu, cioè con un battuto di olio,
limone, sale aglio, prezzemolo tritato e molto origano. Squisite sono
poi le braciole di pescespada ottenute dal caciocavallo, cioè dalla
parte anteriore dell'addome che viene tagliata a fettine, le quali
vengono poi riempite di pan grattato condito con poco olio, prezzemolo,
aglio e pepe.
Le
braciole si possono arrostire alla griglia o cucinare a gghiotta.
Col
pescespada si farcisce nel messinese anche un pasticcio di pastafrolla
in cui oltre alla polpa del pesce cucinata a gghiotta si possono
aggiungere zucchine fritte, piselli, carciofi affettati, e che è detta
impanata di pescespada. Col sugo di pescespada a gghiotta si può
condire naturalmente la pasta che nel messinese trova i suoi sapori più
originali nel condimento a base di pesce o frutti di mare.
Tra
i primi piatti tradizionale è la pasta ncasciata tipica di
Messina; tra i secondi piatti rinomato è lo stoccafisso alla messinese
o a gghiotta. Per quanto riguarda la carne, il falsomagro, gli
involtini, la carne alla pizzaiola e, come piatto pasquale tradizionale,
l'agnello.

https://www.stoccoestocco.it/
http://www.accademiadellostoccafisso.it/
https://www.stoccomammola.it/Stocco.php
Al
tradizionale allevamento ovino e caprino è legata una rinomata
produzione di formaggi, il pecorino pepato e no, la ricotta fresca,
salata e al forno, la tuma, il caciocavallo nelle tradizionali forme a
pera.
Accanto
ai piatti che rimandano ad una cucina più ricca, ve ne sono altri nella
tradizione gastronomica che si servono di condimenti piu' poveri
e
che
 sono legati non solo all'alimentazione quotidiana tipica del mondo
contadino ma anche a certi rituali festivi. Così le varie zuppe di
verdura, finocchietti, borragini, condite con olio crudo, le minestre di
riso con ceci e con le verdure, il maccu saporita pietanza a base di
fave secche che per la lunga cottura si riducono in una morbida crema.
sono legati non solo all'alimentazione quotidiana tipica del mondo
contadino ma anche a certi rituali festivi. Così le varie zuppe di
verdura, finocchietti, borragini, condite con olio crudo, le minestre di
riso con ceci e con le verdure, il maccu saporita pietanza a base di
fave secche che per la lunga cottura si riducono in una morbida crema.
Notissimo
dolce di Messina è la pignolata bianca e/o nera di difficile
preparazione e vanto delle migliori pasticcerie della città insieme
alla non meno rinomata frutta martorana di pasta reale.
Le ricette per gustare il "pesce spada": Tantissime le ricette
che ne esaltano la bontà, poiché le carni sono molto ricercate già
dall’antichità. Archèstrato, gastronomo del IV secolo a.C, detto
“il cuoco degli Dei” , compose dei versi e una vera e propria
“raccolta gastronomica” indicando per ciascuna pietanza il luogo, la
stagione migliore, le caratteristiche, la ricetta più appetitosa.
All’analisi di Archèstrato non sfugge il pesce spada, del quale,
esaltandone le
qualità, segnala i diversi modi per prepararlo. E ben
sappiamo che, tenero come il burro, si presta alla preparazione di
eccellenti primi piatti, di fantasiosi secondi, ma anche di appetitosi
antipasti.
 La
cucina messinese, con la “ricetta alla messinese” ne fa il suo
trionfo di gola. Nel palermitano, oltre a preparare degli ottimi primi,
si utilizza in particolare la parte tra la nuca e il dorso, la "scozzetta"
e la "scarpa", quella vicina alla coda, che il più delle
volte sono associate alle verdure di stagione: melanzane e peperoni.
La
cucina messinese, con la “ricetta alla messinese” ne fa il suo
trionfo di gola. Nel palermitano, oltre a preparare degli ottimi primi,
si utilizza in particolare la parte tra la nuca e il dorso, la "scozzetta"
e la "scarpa", quella vicina alla coda, che il più delle
volte sono associate alle verdure di stagione: melanzane e peperoni.
Tra
le preparazioni più rinomate spiccano senza dubbio gli involtini di
pesce spada alla palermitana, sottilissime fettine arrotolate su se
stesse, arricchite con aromi intriganti, passate nell’olio e panate
nel pan grattato. Gustare per credere !
Il
carpaccio è la maniera più semplice per assaporarne la freschezza:
tagliato a fettine sottilissime, si lascia macerare alcuni minuti in un
largo piatto con olio, limone e un pizzico di sale e pepe. Viene poi
gustato con una spruzzatina di prezzemolo tritato o di mentuccia.
Arrostito
alla brace o sulla piastra ardente, tagliato a "ruota" e
insaporito da una salsetta composta da abbondante olio e limone,
cosparso di foglie di menta, sprigiona il suo ineguagliabile profumo.
Alcuni
pescivendoli del mercato del Capo si sono cimentati nella realizzazione
della “salsiccia di pesce spada”, macinandone le carni, insaporite
con gli aromi e insaccate nel classico budello. La cottura alla brace ha
dato ottimi risultati. Di recente, da Lampedusa, alcuni produttori
locali commercializzano, già confezionato, il pesce spada affumicato,
la ventresca, le uova, in diverse combinazioni.
foto
ristorante da Giovanni (consigliatissimo)

 Numerosi poeti, scrittori e pittori hanno cantato e rappresentato questa
terra, lasciando una traccia indelebile nella nostra memoria. Talvolta,
durante la pesca, l’attesa è lunga e può durare parecchie ore;
quando il pesce è avvistato, l’uomo di vedetta lancia uno strano
grido in dialetto greco, così come tutti i termini marinari usati dai
pescatori durante la loro attività. Lo strumento usato per colpire il
pesce è detto ferru, ed è impugnato dal fariere, che se
ne sta a prua pronto al colpo. Il resto dell’equipaggio è impegnato a
dirigere l’imbarcazione nel punto segnalato. Dal dopoguerra le piccole
imbarcazioni sospinte dai rematori sono state sostituite con quelle a
motore, lunghe oltre 12 metri, dalla cui prora si diparte una lunga
passerella su cui si muove il fiocinatore, ma lo spettacolo della
pesca del pesce spada conserva tuttora il suo aspetto folkloristico.
Numerosi poeti, scrittori e pittori hanno cantato e rappresentato questa
terra, lasciando una traccia indelebile nella nostra memoria. Talvolta,
durante la pesca, l’attesa è lunga e può durare parecchie ore;
quando il pesce è avvistato, l’uomo di vedetta lancia uno strano
grido in dialetto greco, così come tutti i termini marinari usati dai
pescatori durante la loro attività. Lo strumento usato per colpire il
pesce è detto ferru, ed è impugnato dal fariere, che se
ne sta a prua pronto al colpo. Il resto dell’equipaggio è impegnato a
dirigere l’imbarcazione nel punto segnalato. Dal dopoguerra le piccole
imbarcazioni sospinte dai rematori sono state sostituite con quelle a
motore, lunghe oltre 12 metri, dalla cui prora si diparte una lunga
passerella su cui si muove il fiocinatore, ma lo spettacolo della
pesca del pesce spada conserva tuttora il suo aspetto folkloristico.
La “corrente” che rende il pesce più “lavorato” e quindi anche
più gustoso è determinata dalle fasi lunari: la luna piena causa una
corrente forte che trasporta pesci “di passa” (di passaggio)
mentre la seconda luna favorisce una corrente portatrice di grandi
quantità di “mangianza” (pesci piccoli). Nello Stretto si
trovano numerosi tipi di pesce: alalunghe, costardelle, alici, sarde,
aguglie, viole, scorfani, cicirielli, calamari, tonno, pescecane,
dentice, cernie, ope, occhiate, minule, smirine. Sotto le rocce si
trovano pesci pregiati come il merluzzo, il sarago, la spinola e i
cefali per i quali è necessario praticare la pesca subacquea.
Pesci provenienti da altre zone sono le anguille e le murena, chiamate
dai greci plotoe e dai latini flutoe. Esse rappresentavano un cibo
prelibato per i romani ed hanno perfino ispirato alcuni poeti come Marziale
e Archestrato. Quest’ultimo, nei suoi versi, ha lodato
soprattutto l’anguilla che si pesca nel mare di Reggio: “tienila in
onore tra tutte le altre”. Giovenale rivolgendosi a Virrone
ritenuto un goloso di pesci, confonde qui il pesce spada con la murena:Virroni
muraena datur que maxima venit gurgide de siculo (lo stretto); nam dum
se co ntinet auster, dum sedet et siccat madidas in carcere pinnas
contemnunt temeraria lina Charybdim" (Cariddi).
ntinet auster, dum sedet et siccat madidas in carcere pinnas
contemnunt temeraria lina Charybdim" (Cariddi).
Al
mercato troneggia elegante sul banco di marmo del pescivendolo: il pesce
spada, il nobile dei pesci. Quarti di esso, tagliati a trance, giacciono
tra le teste esposte come trofei, incoronate da un’arma ormai inutile.
Nello
stretto lo chiamano il pesce cavaliere, per il rango nobiliare che gli
conferisce la luminosa spada e, ancora di più, per il coraggio e la
fierezza nella lotta e la fedeltà alla sposa, prima di cadere, nobile
combattente, vinto dal ferro dell’uomo.
Spesso,
nelle reti, si catturano i piccoli, che in dialetto si chiamano "puddicineddi",
equivalente di pulcinella, per il semplice ma grottesco fatto di
assomigliare in tutto e per tutto al pesce adulto.
Diversamente
dal tonno, il pesce spada non ha avuto la stessa diffusione commerciale:
niente scatole né barattoli; solo in tempi recenti i mercati si sono
arricchiti di alcuni prodotti privilegiati, come i tranci di pesce spada
affumicati o congelati o le uova preparate in "bottarga"
(dall’arabo batarikh) che si presentano, pressate e salate, in "sasizzuni"
o "carrubbeddi", data la somiglianza con le salsicce o con le
carrube.
Si
racconta che i pescatori siciliani, per catturare il pesce spada,
"gli sussurravano una filastrocca grecale, e in questo modo il
pesce rimaneva fermo ed incantato, divenendo facile preda da
catturare".
Durante
la dominazione arab a furono affinate le tecniche di cattura, adottate
per molto tempo, sino ai giorni nostri: si svolgeva con un rituale assai
complicato, basato sulla prontezza dei pescatori che utilizzavano un
metodo semplice e arcaico: l’arpione, una piccola
fiocina a due punte,
detta "draffinera", legata ad una lunghissima sagola, lanciata
da una passerella montata a prua di un’agile barchetta da inseguimento
denominata "luntri", dalla forma esile e veloce, dava al pesce
infilzato la possibilità di nuotare fino a quando, stremato, si
lasciava tirare a bordo.
a furono affinate le tecniche di cattura, adottate
per molto tempo, sino ai giorni nostri: si svolgeva con un rituale assai
complicato, basato sulla prontezza dei pescatori che utilizzavano un
metodo semplice e arcaico: l’arpione, una piccola
fiocina a due punte,
detta "draffinera", legata ad una lunghissima sagola, lanciata
da una passerella montata a prua di un’agile barchetta da inseguimento
denominata "luntri", dalla forma esile e veloce, dava al pesce
infilzato la possibilità di nuotare fino a quando, stremato, si
lasciava tirare a bordo.
Da
quando è catturato in mare aperto la sua pesca si è estesa anche nel
golfo di Palermo, con il sistema più ingegnoso della pesca artigianale:
il "palangaro" di superficie. Ciò ha permesso ai pescatori di
modificare i loro armamentari.
la
grossa barca dall'insolita sagoma avanza
pigramente fendendo l'azzurra
distesa del mare resa più luminosa dai tiepidi raggi di un sole
primaverile. Dall'alta vetta dell'albero centrale, audacemente proteso
verso il cielo, gli acuti occhi dell'avvistatore, 'u falerotu (anche 'ntinneri),
scrutano la calma superficie dell'acqua nella speranza di intravedere,
ancora una volta, la scura sagoma del pesce spada.
Improvvisamente
un secco comando, istantaneamente eseguito dal motorista:
"Aumenta!" e lo scafo sotto la potente spinta del motore
portato al massimo dei giri scatta verso il punto dove il pesce, ignaro
del suo fatale destino, nuota pigramente cullando il suo sogno d'amore.
Ormai la strana agitazione, che si verifica puntualmente ad ogni
avvistamento, regna sulla barca e l'esultanza dell'equipaggio è frenata
solo dal timore che il pesce possa immergersi sfuggendo alla cattura.
Il
lanciatore, dal cui viso non traspare alcun segno d'emozione, si erge
maestoso, qua si polena di antica nave,
sull'estremità della "passerella" brandendo con
braccio fermo la lunga asta munita dell'arpione. Ancora qualche istante
d'attesa e poi, dopo la tradizionale invocazione a "San Marcu
binidittu" protettore di questo tipo di pesca, scaglia con forza e
precisione il suo mortale attrezzo che, con un tonfo sordo, penetra
nella preda incuneandosi profondamente nelle sue carni.
si polena di antica nave,
sull'estremità della "passerella" brandendo con
braccio fermo la lunga asta munita dell'arpione. Ancora qualche istante
d'attesa e poi, dopo la tradizionale invocazione a "San Marcu
binidittu" protettore di questo tipo di pesca, scaglia con forza e
precisione il suo mortale attrezzo che, con un tonfo sordo, penetra
nella preda incuneandosi profondamente nelle sue carni.
L'animale,
superati i primi attimi di smarrimento ed impazzito per il lancinante
dolore, cerca scampo nella fuga inabissandosi, ma una sottile e robusta
sagola, 'a caloma, saldamente assicurata all'arpione, si dipana
velocemente dal capace cesto di vimini dove è riposta spira sopra
spira, precludendogli ogni speranza di salvezza.
La
lotta è disperata, il pesce avverte che per lui è finita ma, mentre il
sangue sgorga copioso dalla ferita rubandogli le forze, tenta con un
estremo guizzo di liberarsi dal ferro che gli lacera le carni. Il suo
cuore, che ha tenacemente lottato, cede di schianto e 'u pisci viene
issato di peso a bordo.
L'acqua,
muta testimone del dramma, ritorna immobile, il motore riattacca il suo
borbottio. Ricomincia la ricerca di una nuova preda.
La
pesca con i pescherecci dotati di "passerella" è molto più
redditizia rispetto a quando il pescespada veniva inseguito da un "luntro"
a remi guidato a voce dall'avvistatore sulla "barca madre"
(feluca) ormeggiata sulla "posta" assegnata: fu introdotta
agli inizi degli anni sessanta da alcuni marinai siciliani recatisi a
pescare nel Mar dei Caraibi mutando radicalmente una millenaria
tradizione.
La
"passerella", una barca molto più grande, è fornita di un
potente motore che, oltre a rendere l'avvicinamento più veloce,
risparmia ai pescatori la disumana fatica di una giornata di voga; il
lungo ponte che si protende dalla prua per parecchi metri, porta il
lanciatore a trovarsi quasi a perpendicolo sul pesce, condizione
vantaggiosa per colpirlo.
La
maggiore altezza dell'albero centrale ha eliminato la vedetta da terra,
'u bandiaturi, riuscendo l'avvistatore dalla barca a spaziare per un
maggior tratto di mare e, una volta avvistato il pesce, a manovrare
dall'alto il timone dell'imbarcazione.
Il
pesce spada uno dei più grossi teleostei viventi (un esemplare
catturato nel 1956 in Cile raggiungeva i quattro metri di lunghezza ed i
250 kg. di peso, e nelle tonnare siciliane sono stati catturati
esemplari fino a 300 chilogrammi) è anche un veloce nuotatore,
raggiungendo facilmente la velocità di oltre 70 km orari.

Appartiene
all'ordine dei Perciformi, sottordine Scombroidei, famiglia Xiphidae. Il
nome del genere, Xiphias (in greco "spada", denominazione
attribuitagli anticamente da Aristotele), è rimasto immutato per 2.400
anni. Successivamente Linneo (1758) nell'introdurre la nomenclatura
binomiale, aggiunse al nome greco il termine latino di gladius per
indicare la specie.
Chiamato
dai greci anche Galeotas, viene definito dal Fiore - che fa riferimento
a Plinio II, Thaureanus, dal nome della città di Taureana presso Palmi,
distrutta nel 1500 dalle invasioni saracene, dove fin da quei tempi se
ne praticava la pesca.
In
alcuni frammenti a noi pervenuti, Archestrato di Gela (presso Ateneo),
parlando anche dell'anguilla e della murena, decanta la bontà
gastronomica del pesce spada definendolo "cibo divino", mentre
Oppiano di Cilicia nel suo De piscatione ne descrive i comportamenti.
Il
fiorentino Paolo Giovio paragona le carni di questo pesce a quelle dello
storione, mentre di parere diverso è Aldovrandi che, meravigliandosi di
quanto asserito dal Giovio, afferma che la sua carne è "di
malissima digestione, di difficile cottura e chiunque deve astenersi dal
mangiarne". Dopo queste affermazioni, sorge legittimamente il
dubbio che anche nel passato agli ignari degustatori venisse ammannito
come pescespada qualche altro tipo di pesce molto meno appetibile.
La
combattività: La combattività di questo pesce è documentata fin
dall'antichità da notizie di attacchi alle imbarcazioni, a volte con il
ferimento dei marinai. Il 6 luglio 1967 un esemplare di 89 kg. attaccò
il sommergibile oceanografico "Alvin" che si trovava immerso a
610 m. di profondità al largo di Savannah nell'Atlantico, restando
incastrato con la spada in una giuntura dello scafo; gli operatori di
una nave-fattoria russa hanno trovato, infisso nelle carni di una
balena, un troncone di spada lungo 70 cm.
Nello
Stretto di Messina nel corso delle
 sue migrazioni primaverili percorre
il tratto di mare tra Scilla, Bagnara e Palmi in Calabria, per la
riproduzione, poi all'inizio dell'estate inverte la rotta costeggiando
lo stretto dal lato della Sicilia.
sue migrazioni primaverili percorre
il tratto di mare tra Scilla, Bagnara e Palmi in Calabria, per la
riproduzione, poi all'inizio dell'estate inverte la rotta costeggiando
lo stretto dal lato della Sicilia.
La
sua pesca è una tra le più antiche che si conoscano: viene descritta
da Omero nel canto XII dell'Odissea (vv.98-98), menzionata da Strabone e
descritta dettagliatamente da Polibio; ne parla anche il Barrio.
Verso
la fine del 1660 il gesuita napoletano Nicolò Giannattasio, ospite del
principe Francesco Maria Ruffo, ebbe modo di assistere dall'alto del
castello di Scilla a questa pesca, cantata in seguito in esametri latini
nella sua opera Halieutica; l'argomento venne trattato successivamente
nello stesso stile, apprezzabilmente, dallo scillese Diego Vitrioli nel
suo poema Xiphia.
Fino
agli anni '60: Fino agli anni '60 del XX secolo questa pesca veniva
praticata come descritta da Polibio e quindi con le stesse modalità
dell'epoca greca, ed ancora oggi molti termini dialettali usati dai
pescatori non sono altro che inequivocabili corruzioni dei
corrispondenti termini greci.
In
questo tipo di pesca ormai non più praticata le barche dette "luntri"
o "schifi" erano manovrate da cinque robusti rematori, che
facevano procedere la barca con la poppa, sopra la quale stava il
lanciatore - 'u lanzaturi; due dei quattro lunghissimi remi, quelli più
verso poppa, poggiavano su scalmi ricurvi sporgenti circa un metro dai
bordi della barca per meglio equilibrarne il movimento ed imprimerle una
maggiore velocità.
Il
rematore centrale, detto "mezziere", a differenza degli altri
impugnava i due remi insieme; il "falerotu", o "ntinneri",
dalla cima del piccolo albero posto al centro della barca, dirigeva le
operazioni di avvicinamento alla preda seguendo le indicazioni che la
vedetta, appostata su un'altura in riva al mare ("guardiola")
o sulla antenna della feluca ("ntinneri") - gli trasmetteva a
voce agitando una bandierina bianca.
Ritto
in piedi stava 'u lanzaturi con la lancia in mano, che generalmente era
il capociurma, "u patruni", a cui tutto l'equipaggio doveva
cieca ubbidienza, dato che su di lui incombeva la responsabilità del
felice esito del lancio, effettuato anche a distanza di sette, otto
metri dalla preda.
La
fase che precedeva la cattura: Questa
fase era caratterizzata dal continuo vociare della vedetta e poi del
"falerotu" che, oltre a dare le necessarie indicazioni sulla
rotta, incitava i compagni alla voga.
La
lancia d'elce, e non di quercia o di abete come ai tempi i Polibio, era
incastrata con una estremità al corpo dell'arpione; a circa dieci o
quindici centimetri dalla punta di questo erano - ed il sistema di
costruzione viene adottato ancora oggi - collocate quattro alette, che
una volta penetrate nel corpo del pesce impedivano all'arpione di
sfilarsi.
Appena
arpionato il pesce, l'uomo del faliere scendeva dall'albero del "luntro"
e correva ad aiutare il lanciatore a manovrare la sagola a cui era ormai
attaccato il pesce spada (o tonno, o anche squalo o aguglia imperiale).
La
pesca con l'arpione oggi è quasi soppiantato da quella con i "palangresi",
lunghe lenze con centinaia di ami che operano in tutte le stagioni e
catturano anche gli "spadelli" ("puddicinedda"), i
piccoli pesci spada di pochi chilogrammi.
Finché
furono adoperati i "luntri" e le "feluche" fu vera
caccia, Domenico Modugno descrive la tragedia di due pesce spada, "lu
masculu e la fimminedda" incappati nella pesca con l'arpione (Clicca
sulla foto per il suo sito ufficiale); poi con le "passerelle"
divenne pesca, mentre con i "palangresi" oggi è un'industria;
poi vennero anche le "spadare", enormi reti galleggianti che
hanno ucciso tutto quanto capitava vicino, pesci spada grandi e piccoli,
tonni, delfini, balenotteri.... Domani potrebbe non esserci più né
caccia, né pesca, né industria.

TAORMINA.
Splendidamente adagiata sull'altopiano roccioso a 200 m di altitudine.
Taormina occupa una posizione stupenda, a balcone sul mare e di fronte
all'Etna. Meta di viaggi fin dal '700, è solo verso l'ultimo trentennio
del XIX sec, che conosce un notevole sviluppo turistico. Molti gli
stranieri, soprattutto inglesi e tedeschi, che decidono di costruire
ville nella città e molte le personalità ospitate, dall'imperatore
Guglielmo II a Edoardo VII a famiglie conosciute (i Rothschild, i Krupp).
Il clima mite, la bellezza del paesaggio e la calma che regna tutt'intorno
hanno reso Taormina famosa in tutto il mondo.
Il
centro di Taormina, pedonale, si costruisce intorno a corso Umberto I,
principale arteria della città, dal quale è possibile raggiungere
tutti, o quasi, i punti di maggior interesse.

Corso
Umberto E' piacevole passeggiare lungo questa via tranquilla, leggermente in
salita, chiusa a valle da Porta Messina ed a monte da Porta
Catania e fiancheggiata da bei negozi, ristoranti e caffè. Ai
lati della via (soprattutto nel primo tratto sulla sinistra) si dirama
un intrico di stradine che offrono inattesi scorci e profumi, come
quello della frutta di marzapane e della pasta di mandorle della
laboratori di pasticceria. Prima dell' inizio del corso, appena fuori
Porta Messina, si trova la secentesca Chiesa di S. Pancrazio,
secondo la tradizione primo vescovo di Taormina, che fu edificata sui
ruderi di un tempio dedicato a Zeus Serapide (notare i resti di muro
inglobati nella parete sinistra della chiesa). Possiede un grazioso
portale in pietra di Taormina, affiancato da due nicchie con statue di
santi. Lungo il corso si aprono tre belle piazze.
Piazza
Vittorio Emanuele - Coincide con l'antico foro della città. Dietro
la Chiesa di S. Caterina, dal bel portale barocco in marmo
rosa e pietra di Taormina, sono ancora visibili delle vestigia antiche.
Si tratta dei resti di un Odeon, un piccolo teatro coperto
risalente al periodo romano (I sec. d.C.) in mattoni rossi.
Palazzo Corvaja - Il nucleo originario, la torre cubica
riconoscibile nel corpo centrale (nel cortile interno) risale al periodo
arabo. Nel XIII sec. viene aggiunta l'ala laterale sinistra e la scala
che conduce al piano nobile, mentre l'ala destra risale al XV sec.
Abbandonato e in stato di degrado per diversi anni, viene completamente
restaurato alla fine della seconda guerra mondiale. Si possono notare i
differenti stili che si sono succeduti. Arabo è il coronamento della
torre, gotico-catalane le bifore del salone (che risale al XIII sec.) ed
il bel portale d'accesso al palazzo (la scala che lo precede è ornata
da bassorilievi con scene della Genesi, purtroppo rovinate), normanna la
sala del Parlamento (ala destra) così chiamata perchè sede, nel
quattrocento, del Parlamento siciliano. All'interno del cortile, sulla
destra si trovano i locali occupati dall'APT, ove si possono ammirare
bei pupi e bellissimi carretti siciliani, dal ricco intaglio in legno e
ferro battuto. L'osservazione attenta di questi capolavori della
tradizione permette la scoperta di mille particolari che sfuggono ad una
prima occhiata.
Naumachie
- Sono in una stradina laterale sulla sinistra. Il nome ricorda la
simulazione dei combattimenti navali amati dai Romani. Qui però ci si
trova di fronte ad una serie di arcate cieche, in mattoni rossi di epoca
romana. Era probabilmente il muro di sostegno di una grossa riserva
d'acqua e faceva parte di una costruzione rettangolare, forse un
ginnasio.

Piazza
IX Aprile - E' una deliziosa piazzetta a balcone sul mare dalla
quale si gode di una bella vista sul golfo e sull'Etna. Gli altri tre
lati sono racchiusi dalla chiesa di S. Giuseppe (XVII sec.), dalla nuda
facciata, di S. Agostino (oggi biblioteca) e dalla torre dell'Orologio,
che si apre ad arco sulla strada e che dà accesso al borgo del XV sec.
La costruzione che vediamo oggi è della fine del '600, epoca in cui
venne anche aggiunto l'orologio, ma le fondamenta della torre sembrano
risalire addirittura al VI sec. d.C. quando la torre faceva forse parte
di una cinta difensiva. La piazza è uno dei luoghi di ritrovo e di
sosta più affollati, data anche la presenza di numerosi caffè con
tavolini all'aperto.
Piazza
Duomo - Al centro si erge una bella fontana barocca in
pietra di Taormina a base circolare. La vasca più grande che si apre ad
Oriente fungeva un tempo da abbeveratoio. AI centro, in posizione
elevata, si trova l'emblema della città, un centauro, qui però
raffigurato nella versione femminile e dotato, al posto delle classiche
quattro zampe, di due braccia che reggono una sfera ed uno scettro,
simboli del potere.

Duomo
- La costruzione, dedicata a S. Nicola di Bari, risale al XIII sec. La
facciata, molto semplice. E' ornata da un portale rinascimentale tra due
monofore e sovrastato da un rosone. Il coronamento a merli le ha valso
il nome di cattedrale-fortezza, il lato sinistro presenta un bel portale
a sesto acuto ornato da un tralcio d'uva che segna il bordo e, in
corrispondenza del transetto, un rosone. Interno - La struttura è gotica, a croce latina con una
navata centrale che si raccorda alle laterali tramite archi a sesto
acuto. Questi ultimi, sorretti da colonne monolitiche in marmo rosa,
sono sormontati da monofore che rischiarano la navata centrale. Sul 2°
altare della navata laterale destra si può ammirare un bel polittico
cinquecentesco di Antonello de Saliba
I
palazzi Il
centro storico di Taormina è costellato di bei palazzi che presentano
alcuni tratti in comune: stile gotico con influssi arabo-normanni:
utilizzo della pietra lavica nera, in alternanza a pietra bianca di
Siracusa per formare disegni decorativi geometrici, sottolineare archi,
arcatelle e portali. Questi intarsi movimentano la facciata dei più
interessanti palazzi di Taormina.

CLICCA PER VEDERE LE ALTRE FOTO
Palazzo
di S. Stefano - Appena prima della Porta di Catania, imboccare, a
sinistra, via del Ghetto. Il bel palazzo risale al XV sec. Costruito
per i Duchi di S. Stefano, la famiglia De Spuches, di origine spagnola,
ha una mole massiccia che ricorda una casa-fortezza. L'elemento
decorativo che lo caratterizza è una fascia che corre lungo il bordo
superiore, a due colori (in pietra lavica nera e bianca di Siracusa) che
forma un bel motivo geometrico a losanghe. I due ordini in cui è
suddiviso sono scanditi da bifore che si arricchiscono, in quello
superiore, di un arco elaborato. Il palazzo è sede oggi della Fondazione
Mazzullo, con un'esposizione permanente di sculture e disegni
dell'artista di Graniti (ma ospita anche mostre temporanee, nel periodo
natalizio quella dei presepi in terracotta). Nelle opere in pietra
lavica, granito e bronzo. E' ricorrente la nota del dolore, in
particolare nella serie delle Fucilazioni, torsi mutilati ed incompiuti,
ricchi di espressività e nel Gatto ferito, forma abbozzata nella
pietra, mentre colpisce l'impenetrabilità dei volti dei busti femminili
a volte appena sbozzati, a volte perfettamente modellati come
nell'elegante Amazzone e in Saffo.
Badia
Vecchia
- Si trova lungo via Dionisio I. Il nome le deriva
forse dall'errata supposizione che fosse una abbazia. L'edificio ricorda
molto quello dei Duchi di S. Strano nella struttura massiccia, nello
stile e nel fregio bicolore che qui corre tra il primo ed il secondo
piano formando quasi un pizzo floreale. Sul fregio poggiano belle
bifore.
Palazzo
Ciampoli - Fa da sfondo alla scalinata della salita Palazzo Ciampoli,
a destra di corso Umberto I, poco prima di piazza Duomo. La facciata di
questo palazzo, purtoppo in stato di degrado e svilita dall'insegna di
una discoteca, che vi si trovava fino ad alcuni anni fa (oggi è invece
un hotel), è suddivisa in due ordini da una fascia decorativa in pietra
cesellata, il bel portale a sesto acuto è sormontato da uno scudo che
riporta la data di costruzione del palazzo: 1412.
I
giardini di Villa Comunale - Via Roma. Fiori e piante di una
grande varietà, dai più banali a quelli esotici, crescono in questo
parco un tempo privato, ove i proprietari fecero innalzare singolari
edifici in stile eteroclita con un tocco di esotismo. Il più
particolare è tutto ad archi ed arcatelle che lo fanno sembrare, ad un
primo colpo d'occhio, simile a un alveare, nome che in effetti gli è
stato dato (The Beehives) dalla proprietaria, Lady Florence Trevelyan
che, appassionata di ornitologia, utilizzava questi luoghi per osservare
gli uccelli. Dal vialetto che lo delimita dalla parte del mare, si gode
di un bel panorama sull'Etna e la costa Sud.
Escursioni
Le
spiagge - Taormina sorge alta sul promontorio, ma ai suoi piedi si
stendono belle spiagge. La piccola baia di
Mazzarò
è
chiusa a sud da
Capo Sant'Andrea, ricco di grotte, tra le
quali spicca la Grotta Azzurra. Le voci dei pescatori che invitano alla
gita risuonano su tutte le spiagge. Oltre il capo si estende la
deliziosa baia chiusa dall'Isola Bella
che un'esilissima
lingua di terra collega alla riva. Le spiagge più estese, Spisone
e Mazzeo, si trovano invece a nord di Mazzarò.

Dalla
leggenda alla storia Narra
una leggenda che un'imbarcazione greca, in navigazione nel tratto
davanti alla costa orientale, avesse l'impudenza di commettere
disattenzioni nel fare un sacrificio al dio del mare Nettuno . Questi,
tremendamente adirato, avrebbe allora fatto alzare un vento così forte
da causare un naufragio. Uno solo dei marinai, scampato alla morte e
all'ira del dio, sarebbe riuscito ad approdare sulla spiaggia di capo Schisì. Affascinato da questi luoghi, Teocle, il naufrago, avrebbe
dunque deciso di fare ritorno in Grecia per convincere alcuni suoi
compatrioti a venire in Sicilia e a fondare una colonia: Naxos.
. Questi,
tremendamente adirato, avrebbe allora fatto alzare un vento così forte
da causare un naufragio. Uno solo dei marinai, scampato alla morte e
all'ira del dio, sarebbe riuscito ad approdare sulla spiaggia di capo Schisì. Affascinato da questi luoghi, Teocle, il naufrago, avrebbe
dunque deciso di fare ritorno in Grecia per convincere alcuni suoi
compatrioti a venire in Sicilia e a fondare una colonia: Naxos.
Castello
- 4 chilometri lungo la strada verso Castel Mola. Il sentiero è
sulla destra. E' possiblle raggiungere il castello anche a piedi,
attraverso la "salita Castello", un sentiero a gradoni che
parte da Taormina, da via Circonvallazione (1 km circa AR) o la Salita
Branco che parte da via Qietro i Cappuccini. Si consiglia di evitare
l'escursione a piedi nei mesi più caldi.
Il castello si erge isolato sulla cima del monte Tauro (m 398). Poco più
sotto si trova il
Santuario della Madonna della Rocca. Dal
terrazzino che precede la chiesa si gode di una bella vista sul teatro
di Taormina e sulla città. Si prosegue a piedi per il castello: una
fortezza ricostruita in epoca medievale sui resti dell'antica acropoli.
Dell'edificio, di forma trapezoidale, sono ancora visibili
essenzialmente i muri di cinta ed i resti di una torre. Anche da qui si
gode di una suggestiva vista sul teatro e su Taormina.
Castel
Mola - 5 km a Nord-Ovest. Questo paesino arroccato alle
spalle di Taormina in posizione panoramica si sviluppa intorno alla
deliziosa piazzetta del Duomo dalla quale si dirama un intrico di
stradine pavimentate. Da diversi punti, in particolare dalla piazzetta
di S. Antonino, si gode di un bel panorama suIl'Etna, sul Litorale Nord
e sulle spiagge che si estendono ai piedi di Taormina. Sulla destra
della suddetta piazza, una scalinata, il cui accesso è costituito
dall'antico arco d'ingresso alla città qui spostato per costruire la
strada, porta ai ruderi del castello, di cui si conservano
tratti delle mura cinquecentesche e da dove si gode una bella vista sui
monti Venere, alle spalle del cimitero, e Ziretto, più in basso.
Di origini normanne è la Chiesa dell'Annunziata, attigua
al cimitero, che, pur totalmente ricostruita, conserva un portale
finemente lavorato in pietra bianca. Tipica della zona è la produzione
di vino alla mandorla, un vino liquoroso di cui alcuni abitanti di
Castel Mola si attribuiscono la paternità dell'invenzione.

Il
teatro Greco
in origine (periodo ellenistico) venne trasformato ed ingrandito in
epoca romana. L'edificio che possiamo ammirare oggi è infatti quello
del II sec. dC. Il teatro è stato costruito sfruttando la naturale
conformazione del terreno: alcuni gradini della cavea sono stati
ricavati direttamente dalla roccia, Il teatro greco rispettava i canoni
classici, con un'orchestra semicircolare per i musici, i conisti ed i
danzatori, I Romani eliminarono le prime file di gradini per trasformare
l'orchestra in arena (circolare), più adatta ad ospitare i giochi
circensi, ed aggiunsero un corridoio per l'entrata dei gladiatori e
delle belve feroci.
Il rosso dei mattoni, il bianco delle colonne marmoree che ancora ornano
la scena, l'azzurro intenso del cielo sono i colori dominanti di quest'oasi
di pace. Dall'alto della cavea si può ammirare in tutto il suo
splendore il bellissimo quadro che si offre alla vista: la maestosa
presenza dell'Etna, dalla cima spesso innevata, che digrada dolcemente e
sembra quasi congiungersi con il mare che qui lambisce la costa formando
deliziose baiette. La magia si ripete costeggiando la parte alta della
cavea fino all'estremità sinistra, da cui si riesce ad abbracciare con
lo sguardo anche Taormina.
Il teatro, perfettamente funzionante, ha ospitato in passato il premio
David di Donatello, una delle più importanti manifestazioni
cinematografiche italiane, ed oggi è sede di Taormina Arte, rassegna
internazionale di cinema, teatro, balletto e musica sinfonica che si
svolge nei mesi estivi.
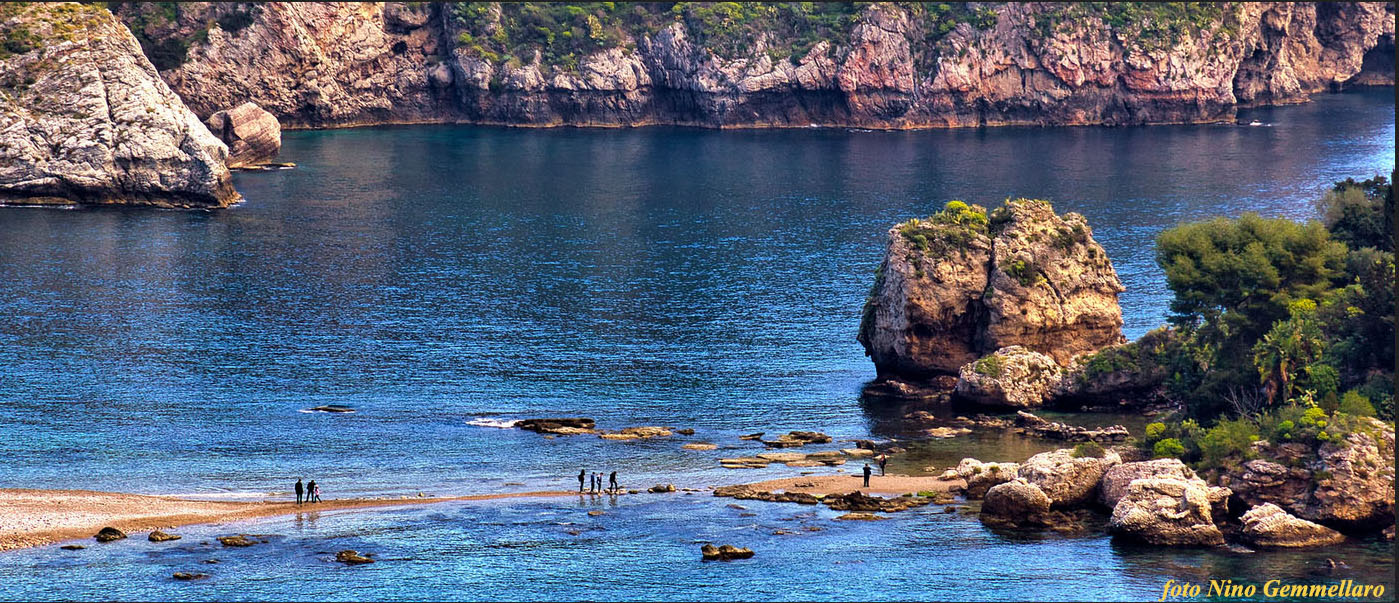
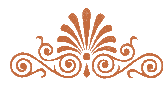
C'era una volta la dolce vita di Taormina
Di Gianni Nicola Caracoglia
Chico
Scimone, l'inventore siciliano del night club e della night life, racconta gli
anni d'oro quando nella cittadina le star erano di casa
"Ok
ya, quelli erano proprio altri tempi".
L'accento yankee dà subito l'idea del personaggio Francesco Scimone, da tutti
conosciuto come Chico, musicista e nightclubber ante-litteram, porta dentro di sè
un modo di concepire la vita e il divertimento molto vicino allo stardom di
chiara matrice americana. E non a caso, visto che Chico gli Usa li conosce bene
in quanto vi ha vissuto a lungo - tra Boston e New York - e dove ha incamerato a
pieni polmoni l'aria gaudente e un po' viziata del night club.
Esperienza vissuta a partire dal 1928, a soli diciassette
anni, tra gestione di locali e big band di jazz e che Chico ha pensato bene di
trasferire anche nella sua Taormina quando vi ritornò nel 1953, aprendo la
Giara, uno dei locali che in Sicilia, diventarono sinonimo per antonomasia di
divertimento notturno. Anni, quelli, in cui la località turistica più famosa
dell'isola viveva una parentesi di dolce vita che poco o nulla aveva da
invidiare alla capitale.
E in linea con i tempi, l'anno dopo il ritorno in patria,
Scimone sposò in pompa magna l'attrice spagnola Aurora De Alba, con tanto di
coreografia di carretto siciliano. Scene queste che recentemente sono state
riprese alla tv in un programma sui matrimoni celebri dei secolo, al pari di
quello di Carlo e Diana. Non l'unico matrimonio della sua vita: Chico si è
sposato altre quattro volte (mai con una italiana) ed oggi, divorziato, non
considera finita la sua carriera sentimentale.

"In quel periodo a Taormina - ricorda Scimone – tra
il Festival del Cinema, il David Di Donatello e vari film girati in Italia,
venivano molte star che immancabilmente passavano dal mio locale che è stato il
primo night club di Taormina". Subito dopo ne ha aperto un altro con lo
stesso nome a Catania, a Villa Manganelli (oggi semidistrutta ndr), e fu il
primo night della città etnea. "Nel 1958 alla Giara di Catania, una
signora mi chiese se potevo insegnare i passi del cha cha cha alla figlia. Bene,
quella ragazza era Mina". Episodio simile 10 anni prima, tornando da New
York: sulla nave fu invitato da una signora ad ascoltare la voce del figlio
aspirante cantante: il giovanotto era Johnny Dorelli.
Seduto, come ogni pomeriggio, ai tavolini del
Mocambo,
Scimone guarda il fiume di persone che affolla il corso e con un pizzico di
nostalgia snob non riesce a non fare un confronto con il Passato. "Una
volta quando c'erano meno macchine, c'era un turismo più selezionato. Al San
Domenico, per esempio, si pranzava in smoking. Era facile incontrare star del
cinema come Greta Garbo o grandi scrittori come Truman Capote o Tennessee
Williams che passavano lunghi periodi a Taormina".
Lo spartiacque a cavallo dei '70: "Quando sono tornato
definitivamente in Italia nel 1973 (dopo una nuova parentesi americana
cominciata nel 1961 ndr) ho capito che tutto era cambiato. Le celebrità erano
scomparse". Anche la passione per la Giara andò scemando fino a quando lo
cedette nel 1988. Da allora non vi è più entrato. "Come quando finisce un
amore non si torna più indietro".
La passione per la musica, ereditata dalla madre anch'ella
pianista, è nata molto presto in Scimone e d ha contagiato anche la sorella
Amelia che, ancora oggi, spesso suona con lui a quattro mani al piano del San
Domenico.
d ha contagiato anche la sorella
Amelia che, ancora oggi, spesso suona con lui a quattro mani al piano del San
Domenico.
Hotel in cui Chico suonò per la prima volta poco prima di
partire per l'America, nel lontano 1928. "Allora si suonava nel pomeriggio,
yah, perché c'era il the danzante. La sera, poi, andavo al cinema e facevo la
colonna sonora dei film muti di Greta Garbo e Rodolfo Valentino".
Nel celebre hotel vi è tornato a partire dal 1980.
"Ho sempre amato 1'atmosfera elegante dei San Domenico. A fine serata, però,
mi spostavo alla Giara e suonavo là". Il repertorio di oggi viaggia tra le
colonne sonore dei film americani più famosi e pezzi di autori dei calibro di
autori del calibro di George Gershwin o Cole Porter. Non dimenticando le canzoni
italiane,, dagli immortali classici napoletani fino a Umberto Bindi e Domenico
Modugno. "Anche i giapponesi mi chiedono canzoni come "Core 'ngrato"
o "Santa Lucia" e il bello è che le cantano pure". Una colonna
sonora vivente, non c'è dubbio. Oggi, a 88 anni, Scimone si permette anche di
dirigere l'orchestra a
Plettri di Taormina conosciuta in tutto il mondo avendo
fatto numerose tournée all'estero.
Stretto è il rapporto con il cinema. Innumerevoli attrici
e attori hanno reso visita al suo locale – Greta Garbo è venuta a Taormina un
paio di volte - e non sono mancate le partecipazioni in prima persona di alcune
pellicole. Da protagonista ne "Il cappotto di di legno" di Gianni
Manera della fine degli anni '70; come ospite ne "Il piccolo diavolo"
e "Johnny Stecchino" di Roberto Benigni. "Ero il pianista nella
scena di piazza con Walther Mattau – ricorda ridendo -. Un Oscar meritato per
Roberto".
Scimone, dalle mille risorse, è anche uno sportivo. Non
manca mai all'appuntamento catanese di Capodanno o della San Silvestro a Mare ed
ogni 3 febbario sale correndo gli 86 piani (1565 gradini) dell'Empire State
Building di New York nella caratteristica gara.


Il
basalto è una roccia magmatica effusiva che si forma dal raffreddamento
di masse fuse. Si presenta di colore grigio, ed è costituito da una
massa vetrosa in cui sono immersi diversi cristalli tra cui si possono
riconoscere facilmente i pirosseni di colore nero, i plagioclasi, che si
presentano come piccoli aghetti trasparenti e l'olivina di color bruno
giallo simile al vetro di bottiglia di birra.
Nella
Valle dell'Alcantra e alla Gole del Simeto, ci sono state periodiche
sovrapposizione di più colate laviche di grande entità che hanno
formato un considerevole spessore di basalto anche in un singolo
episodio eruttivo. la parte superficiale di questa massa si è
raffreddata rapidamente, mentre a parte interna ha impiegato per farlo
centinaia di anni. la contrazione della massa di roccia ha originato
delle fratture intersecantisi a formare prismi pseudoesagonali: i
basalti colonnari. L'erosione del fiume ha poi messo in risalto la
geometria dei prismi.
Storia
geologica I
più antichi affioramenti vulcanici dell'area etnea sono le lave
basaltiche delle zone di Aci Castello e Aci Trezza. Questi si sono
formati su quello che allora era il fondale di un ampio golfo pre-etneo
che si apriva allora lungo la costa orientale della Sicilia e che
separava l'altopiano Ibleo dai Peloritani (600 000 - 200 000 anni fa).
Le caratteristiche di questi primi basalti erano quelle tipiche delle
effusioni sottomarine: lave a cuscino (pillow) con croste vetrose e
ialoclastiti. In seguito all'emersione della regione le manifestazioni
eruttive assumono un carattere subaereo come quelle attuali dell'Etna.
Circa 200 000 anni fa si verifica il passaggio da un vulcanismo di tipo
fessurale, espandimenti estesi di lava lungo fratture lineari della
crosta, ad un vulcanismo di tipo centrale con la costruzione di un vero
e proprio cono vulcanico. L'attività del primo vulcano etneo, il
Calanna, termina con il collasso del cratere e la formazione di una
caldera. A questa fase dell'attività dell'Etna, da 200.000 a 150.000
anni fa, possono essere riferiti gli espandimenti lavici presenti lungo
i corsi dei fiumi Simeto e Alcantara cioè i basalti colonnari.

La
formazione delle gole.
Circa
200 000 anni fa al posto dell'attuale valle dell'Alcantara era una valle
che si sviluppava su argille del Cretaceo e su arenarie dell'Oligocene -
Miocene. Questa valle accolse nel suo letto la lava proveniente
dall'attività dei primi centri eruttivi dell'Etna. Era una lava molto
fluida che si incanalò nella vale e giunse a mare. Le colate erano di
notevole spessore e accadeva che le parti interne si raffreddassero
molto lentamente. Quando il raffreddamento di una massa magmatica
avviene in un tempo di parecchie centinaia di anni si possono formare
fessurazioni colonnari. Infatti, passando dal fuso al solido la materia
si contrae generando fratture si intersecano con angoli di 120° che
formano dei prismi che in sezione si presentano come maglie esagonali.
L'esagono è infatti la figura geometrica che meglio riempie il piano.
La
valle dell'Alcantara ha ricevuto nel tempo diverse colate in successione
ed è accaduto che
queste sbarrassero il fiume originando un lago di sbarramento lavico. In
questo lago la massa d'acqua finiva col tracimare ed erodere la massa
lavica formando le forre che oggi possiamo vedere (gole). Tra queste le
più note sono quelle di Larderia, dello Sciambro e di Mitoggio.
Testi
di Salvina Abbadessa e Giuseppe Ippolito, scritti in occasione di una
escursione svolta con un liceo di Catania il 18 dicembre 2003

Al
Qantarah In un periodo che si perde alle radici della storia, un piccolo
vulcano a nord dell'Etna si sveglia ed erutta un'enorme massa di lava
che si fa strada fino al mare ed immergendosi forma capo Schisò. Il
percorso tortuoso del fiume di lava viene in seguito solcato da un corso
d'acqua che vi si insinua levigando e pulendo i massi lavici dalle
scorie.
Verso
la fine del suo percorso, l'acqua incontra forse una massa di terreno più
friabile e si fa strada liberando due alte pareti di durissimo basalto
caratterizzate da affascinanti forme prismatiche. Sono le gole, di cui
solo un tratto è oggi facilmente accessibile.
Quando
andare.
Le
gole sono percorribili quando l'acqua è bassa per un tratto compreso
tra i 50 e i 200 m. All'entrata è possibile munirsi di
stivali-salopette (tipo da pescatore) da indossare per evitare di
bagnarsi nelle acque, sempre molto fredde, del fiume. Normalmente il
letto del fiume è praticabile da maggio a settembre. Il resto dell'anno
si può solo arrivare all'imbocco delle gole. La risalita può essere
fatta in ascensore. E' possibile fare agricampeggio in apposite
piazzole. Il nome del fiume, e della valle omonima, risale al periodo di
dominazione araba, Al Qantarah, e si riferisce ad un ponte ad arco
costruito dai Romani e capace di resistere
alle
irrompenti piene del fiume che ancora oggi offrono uno spettacolo
impressionante.
La
discesa a piedi permette di avere una bella vista d'insieme della parte
iniziale delle gole. Arrivati al letto del fiume le pareti, alte più di
50 m.stringono in mezzo una lingua d'acqua e si presentano in tutta la
loro ambigua bellezza: nere strutture geometriche che si ergono una di
fronte all'altra e si rincorrono verso il cielo. Le linee si
intersecano, formando prismi pentagonali e esagonali o figure irregolari
che giocano con la luce disegnando forme mostruose o leggiadre. I
contrasti sono forti e sembrano rafforzarsi
man
mano che si penetra all'interno, quando non restano che tre elementi: la
roccia, l'acqua, il cielo. Ed il sole, a disegnare i contorni tra il
nero delle parti in ombra e quelle chiare, illuminate, ed a rifrangere
in mille piccoli specchi le gocce delle cascatelle che a tratti scendono
lungo le pareti.






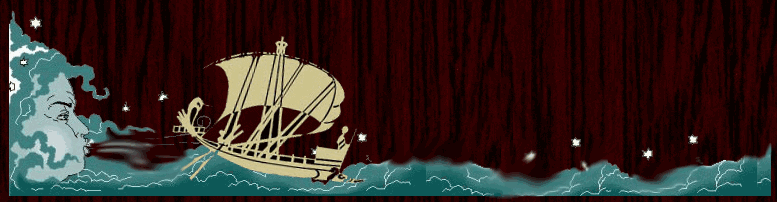



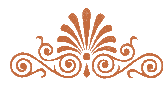













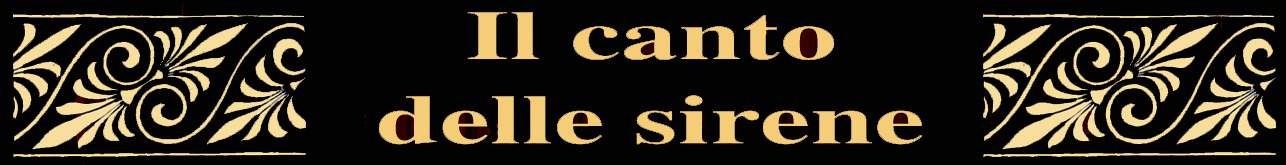
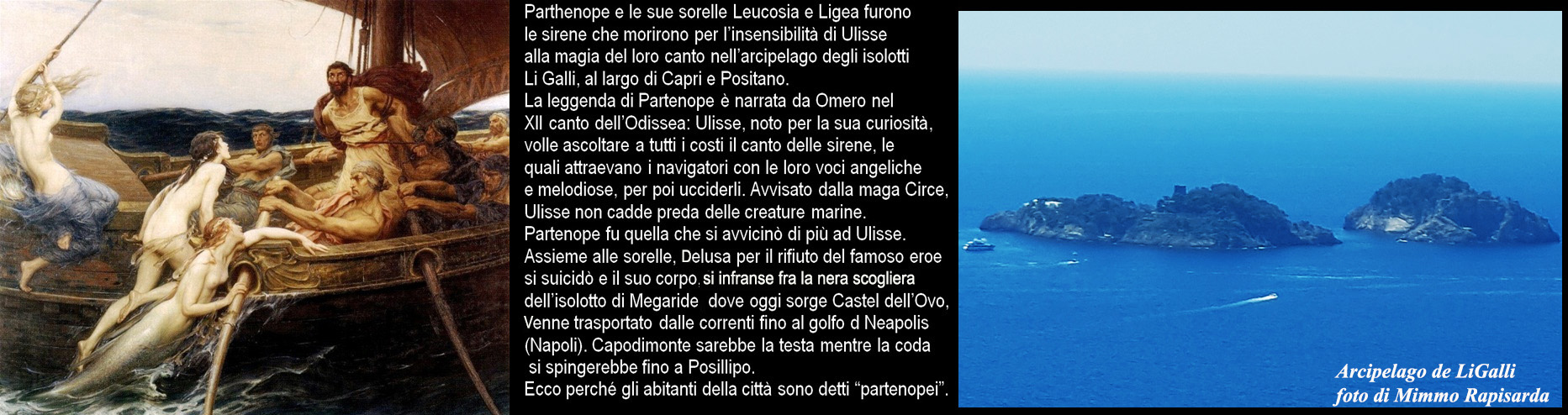

 o il
sopravvento.
o il
sopravvento. go,
cetaceo erbivoro dell’Oceano Indiano. Entrambi hanno grandi seni
rotondi privi di peli; quando allattano emergono dall’acqua con il
tronco.
go,
cetaceo erbivoro dell’Oceano Indiano. Entrambi hanno grandi seni
rotondi privi di peli; quando allattano emergono dall’acqua con il
tronco.
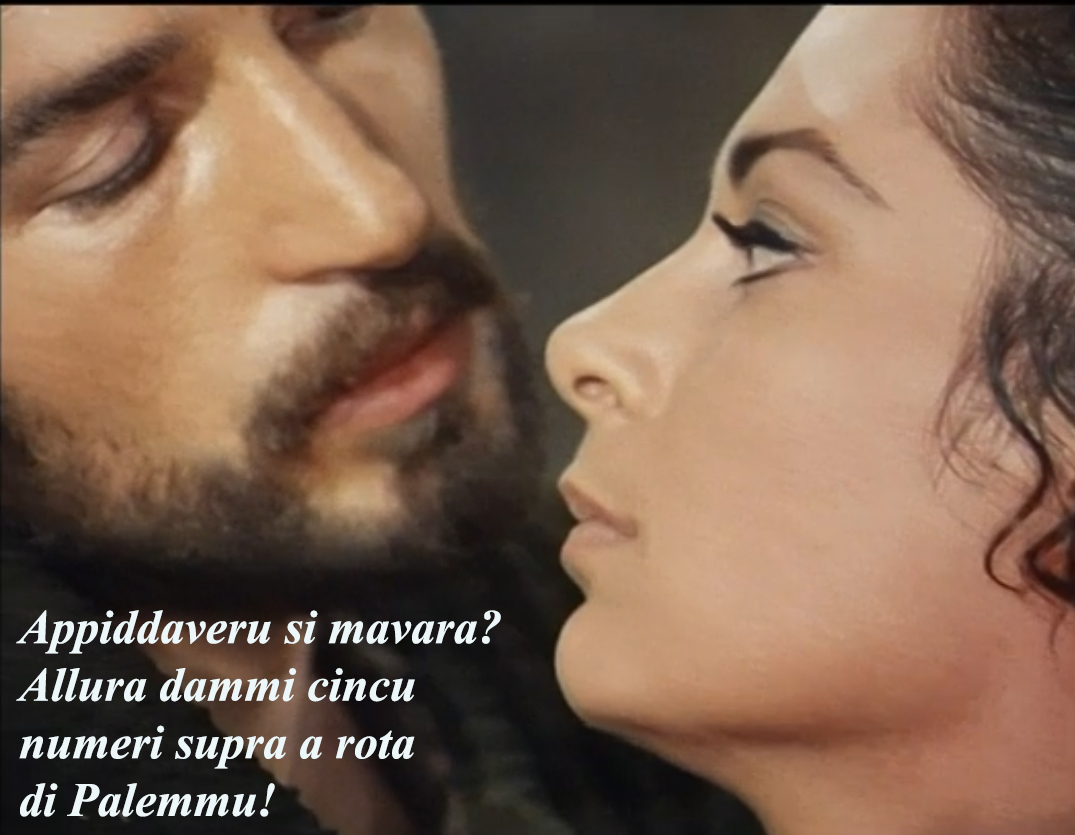 gra, giovane (stava nuda, giocava a
palla...) è Nausicaa, grazie a Dio è n'ata cosa.
gra, giovane (stava nuda, giocava a
palla...) è Nausicaa, grazie a Dio è n'ata cosa. 
 cibo droghe malefiche: voleva che si scordassero
completamente della patria.
cibo droghe malefiche: voleva che si scordassero
completamente della patria.











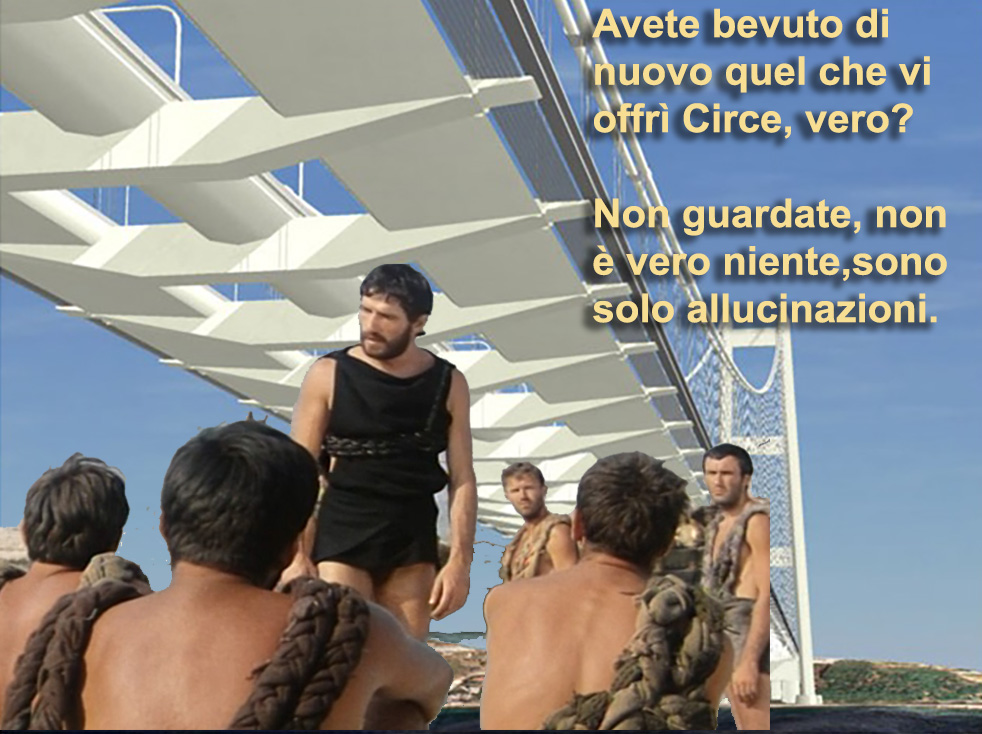 zato da un'edilizia dei primi del '900, si trova la chiesa di
Santa Maria degli Alemanni, d'età sveva, forse degli inizi del XIII
sec. Appartenne all'Ordine dei cavalieri di Gerusalemme. Gravi danni
furono causati alla chiesa dai terremoti del 1783 e del 1908. Soltanto
in questo secondo dopoguerra furono avviati i lavori di restauro. I
caratteri stilistici della chiesa denunciano un'attenzione verso modelli
gotici da parte di architetti venuti forse dal nord, al seguito degli
ordini religiosi. L'interno ha pianta basilicale a 3 navate e 3 absidi.
Delle parti scultoree, rimangono alcuni elementi e i due portali (quello
laterale quasi del tutto integro). Voltando per via Sant'Elia, si arriva
all'omonima chiesa, edificata verso la fine del Seicento.
zato da un'edilizia dei primi del '900, si trova la chiesa di
Santa Maria degli Alemanni, d'età sveva, forse degli inizi del XIII
sec. Appartenne all'Ordine dei cavalieri di Gerusalemme. Gravi danni
furono causati alla chiesa dai terremoti del 1783 e del 1908. Soltanto
in questo secondo dopoguerra furono avviati i lavori di restauro. I
caratteri stilistici della chiesa denunciano un'attenzione verso modelli
gotici da parte di architetti venuti forse dal nord, al seguito degli
ordini religiosi. L'interno ha pianta basilicale a 3 navate e 3 absidi.
Delle parti scultoree, rimangono alcuni elementi e i due portali (quello
laterale quasi del tutto integro). Voltando per via Sant'Elia, si arriva
all'omonima chiesa, edificata verso la fine del Seicento. 



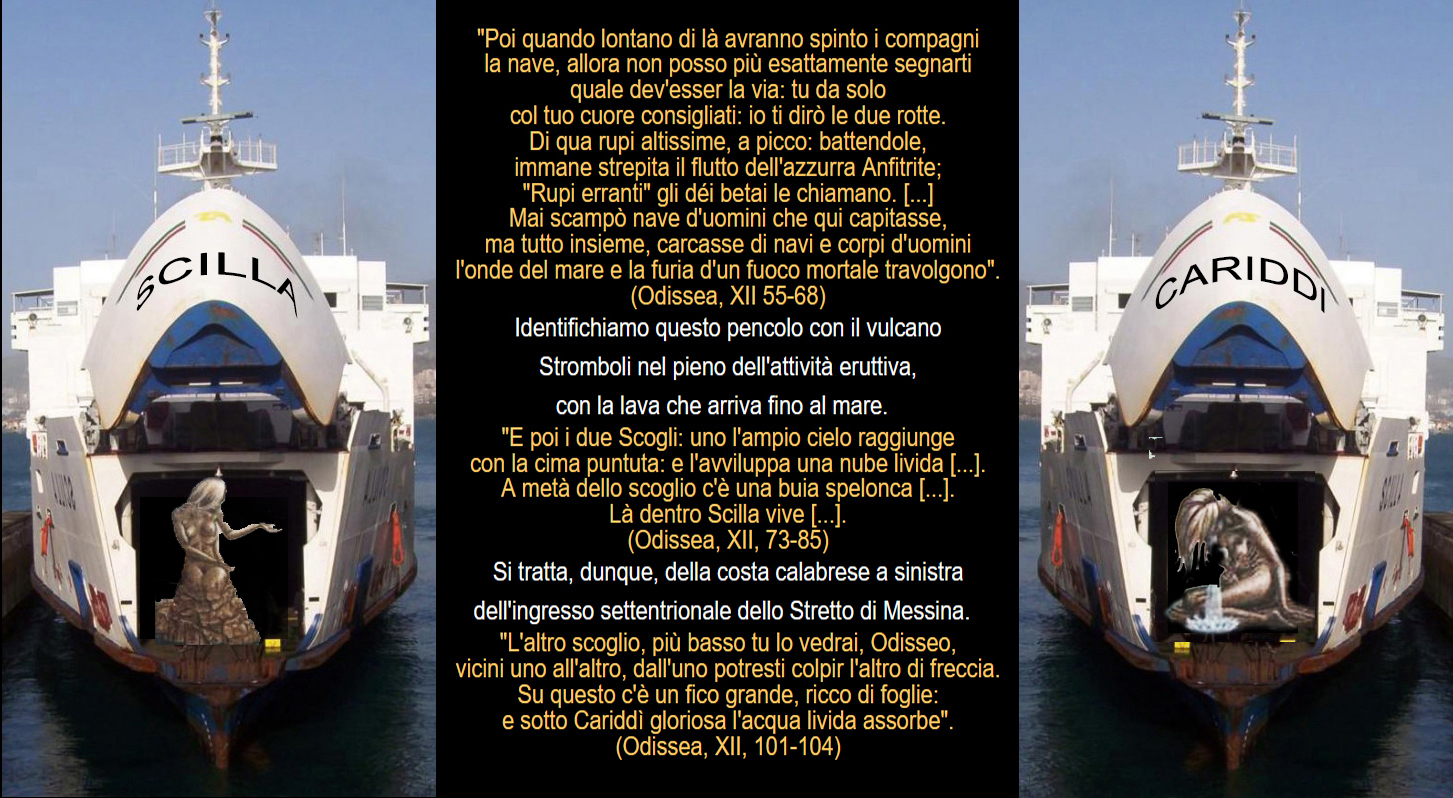



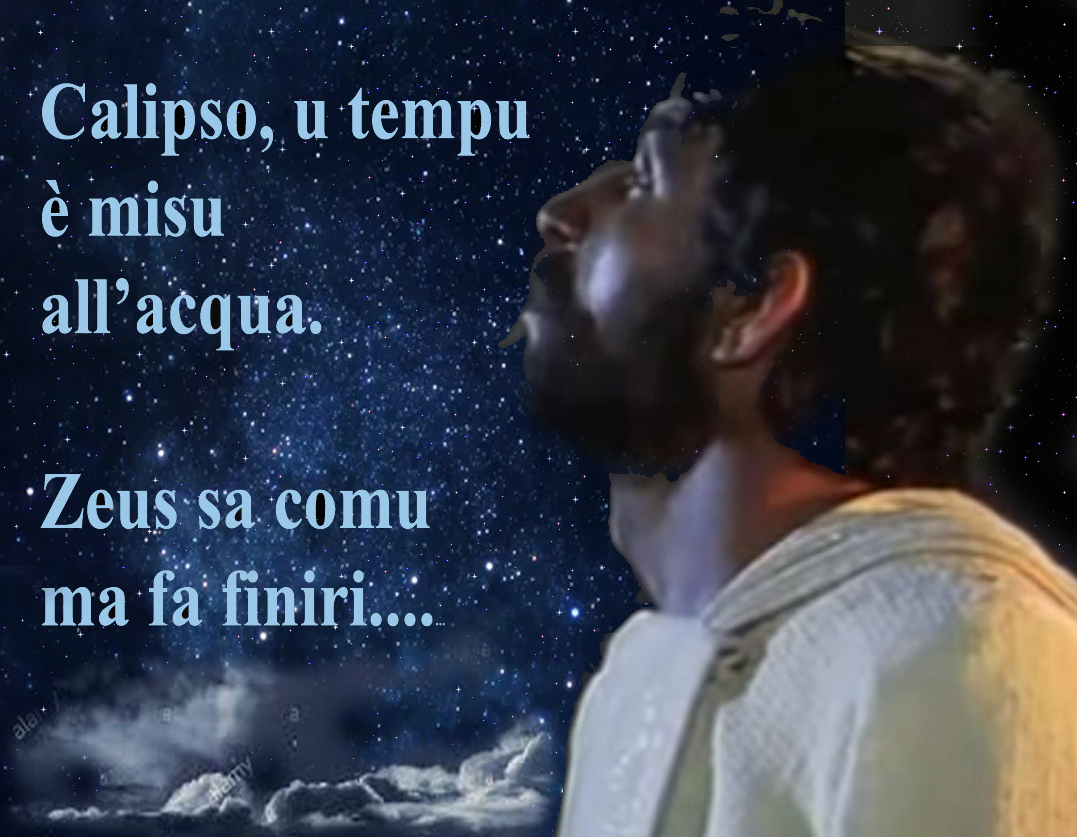 CALIPSO
(
il cui nome vuol dire la Nascosta) è la Ninfa che nell’Odissea
trattiene
Ulisse con sé per dieci anni, inutilmente offrendogli
l’immortalità perché rimanesse con lei. Ermes le ordinerà
di
lasciarlo partire per volere di Zeus. In realtà Calipso è
una delle
antiche dee mediterranee,una delle Madri Venerande,
relegata
lontana dal
potere, che ora detengono gli dei Olimpici. E' una figura della
mitologia greca, Oceanina (ovvero figlia di Oceano e Teti), regina
dell'isola di Ogigia. Secondo altri figlia del sole e sorella della maga
Circe, o anche figlia del gigante Atlante. Viveva in una grotta
incantata, tappezzata da zolle erbose, con fiori d'acqua e ninfee.
CALIPSO
(
il cui nome vuol dire la Nascosta) è la Ninfa che nell’Odissea
trattiene
Ulisse con sé per dieci anni, inutilmente offrendogli
l’immortalità perché rimanesse con lei. Ermes le ordinerà
di
lasciarlo partire per volere di Zeus. In realtà Calipso è
una delle
antiche dee mediterranee,una delle Madri Venerande,
relegata
lontana dal
potere, che ora detengono gli dei Olimpici. E' una figura della
mitologia greca, Oceanina (ovvero figlia di Oceano e Teti), regina
dell'isola di Ogigia. Secondo altri figlia del sole e sorella della maga
Circe, o anche figlia del gigante Atlante. Viveva in una grotta
incantata, tappezzata da zolle erbose, con fiori d'acqua e ninfee. si di Odisseo, gli impedisce per sette lunghi anni di
riprendere il mare. Al settimo anno, però, per volere degli dèi, Odisseo
lascia l’isola a bordo di una zattera.
si di Odisseo, gli impedisce per sette lunghi anni di
riprendere il mare. Al settimo anno, però, per volere degli dèi, Odisseo
lascia l’isola a bordo di una zattera.












 Numerosi poeti, scrittori e pittori hanno cantato e rappresentato questa
terra, lasciando una traccia indelebile nella nostra memoria. Talvolta,
durante la pesca, l’attesa è lunga e può durare parecchie ore;
quando il pesce è avvistato, l’uomo di vedetta lancia uno strano
grido in dialetto greco, così come tutti i termini marinari usati dai
pescatori durante la loro attività. Lo strumento usato per colpire il
pesce è detto ferru, ed è impugnato dal fariere, che se
ne sta a prua pronto al colpo. Il resto dell’equipaggio è impegnato a
dirigere l’imbarcazione nel punto segnalato. Dal dopoguerra le piccole
imbarcazioni sospinte dai rematori sono state sostituite con quelle a
motore, lunghe oltre 12 metri, dalla cui prora si diparte una lunga
passerella su cui si muove il fiocinatore, ma lo spettacolo della
pesca del pesce spada conserva tuttora il suo aspetto folkloristico.
Numerosi poeti, scrittori e pittori hanno cantato e rappresentato questa
terra, lasciando una traccia indelebile nella nostra memoria. Talvolta,
durante la pesca, l’attesa è lunga e può durare parecchie ore;
quando il pesce è avvistato, l’uomo di vedetta lancia uno strano
grido in dialetto greco, così come tutti i termini marinari usati dai
pescatori durante la loro attività. Lo strumento usato per colpire il
pesce è detto ferru, ed è impugnato dal fariere, che se
ne sta a prua pronto al colpo. Il resto dell’equipaggio è impegnato a
dirigere l’imbarcazione nel punto segnalato. Dal dopoguerra le piccole
imbarcazioni sospinte dai rematori sono state sostituite con quelle a
motore, lunghe oltre 12 metri, dalla cui prora si diparte una lunga
passerella su cui si muove il fiocinatore, ma lo spettacolo della
pesca del pesce spada conserva tuttora il suo aspetto folkloristico.



 sue migrazioni primaverili percorre
il tratto di mare tra Scilla, Bagnara e Palmi in Calabria, per la
riproduzione, poi all'inizio dell'estate inverte la rotta costeggiando
lo stretto dal lato della Sicilia.
sue migrazioni primaverili percorre
il tratto di mare tra Scilla, Bagnara e Palmi in Calabria, per la
riproduzione, poi all'inizio dell'estate inverte la rotta costeggiando
lo stretto dal lato della Sicilia.






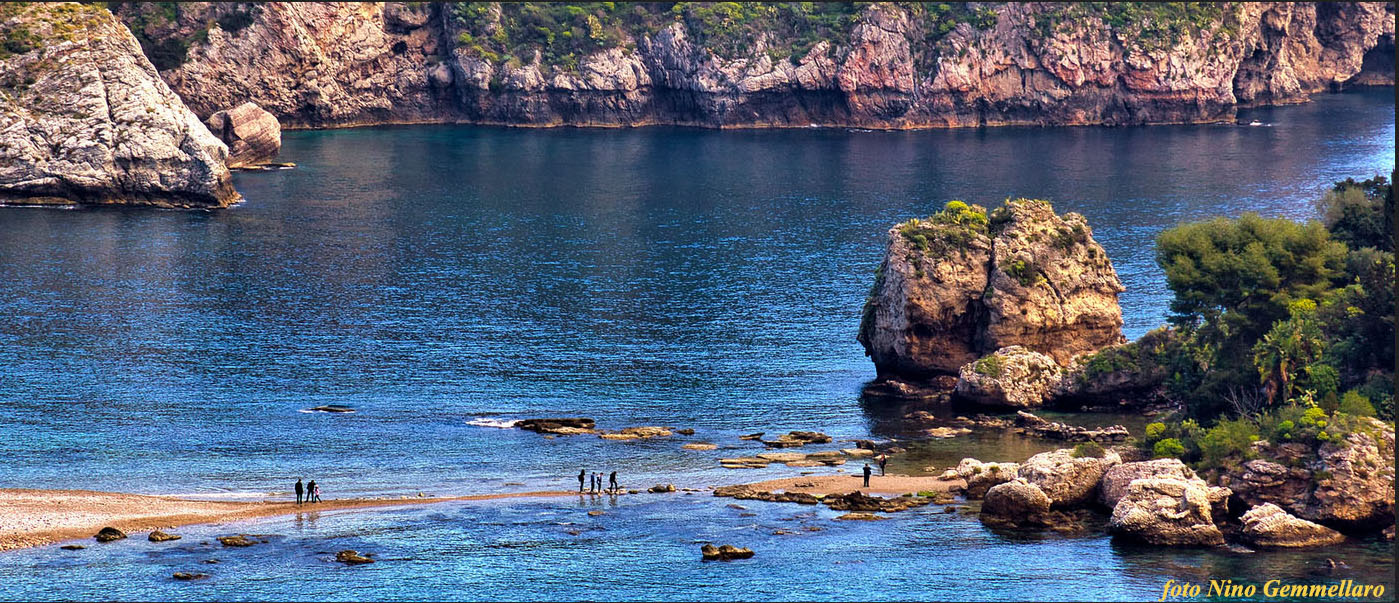

 d ha contagiato anche la sorella
Amelia che, ancora oggi, spesso suona con lui a quattro mani al piano del San
Domenico.
d ha contagiato anche la sorella
Amelia che, ancora oggi, spesso suona con lui a quattro mani al piano del San
Domenico.