|
 il
nome Navajo deriva dal termine Navahuu che in lingua Tewa,
parlata da alcune popolazioni del sud ovest, significa Campo
coltivato in un piccolo corso d'acqua. In lingua Navajo si usa
il termine Diné (talvolta citato nella letteratura come Dineh)
che significa Il popolo. il
nome Navajo deriva dal termine Navahuu che in lingua Tewa,
parlata da alcune popolazioni del sud ovest, significa Campo
coltivato in un piccolo corso d'acqua. In lingua Navajo si usa
il termine Diné (talvolta citato nella letteratura come Dineh)
che significa Il popolo.
Dal
punto di vista etnico i Navajo appartengono al ramo Athabaska
meridionale, originario dell'Alaska e del nord del Canada e in
realtà appartengono all'insieme delle nazioni Apache che
intorno al 1500, provenienti dal nord, si stanziarono in un
vasto territorio che si estende dall'Arizona al Texas
occidentale e dal Colorado al nord del Messico entrando in
conflitto con le popolazioni Pueblo che vivevano in quei
territori. A differenza delle altre popolazioni amerindie gli
Apache non avevano una sola identità di nazione o tribù, ma
erano distinti in clan o gruppi familiari estesi, fondati su
base matrilineare (gli uomini andavano a vivere presso la
famiglia della sposa). Ciascun gruppo si considera una nazione.
Dal
punto di vista linguistico appartengono al ramo Na-dené, la
stessa tipologia linguistica degli Athabaska del nord e degli
Apache in senso stretto.
I Navajo discesero dalle regioni fredde dell'America
settentrionale e si insediarono, poco prima del contatto con gli
Europei nel bacino del San Juan, affluente del fiume Colorado,
intorno al 1500 in parte dei territori degli attuali Colorado,
Nuovo Messico e Arizona. Da popolo di invasori si trasformarono
in una nazione seminomade vivendo principalmente di agricoltura
e secondariamente di allevamento. Col passare del tempo questa
attività li distinse culturalmente dal resto degli Apache, dal
momento che le altre popolazioni indiane e gli spagnoli
identificavano i Navajo come una tribù di abili coltivatori.
Una
prerogativa condivisa con il resto delle popolazioni Apache era
il frequente ricorso alla razzia ai danni di Europei e Pueblo
allo scopo di incrementare la proprietà in cavalli e pecore.
Contrariamente a quanto si racconta nell'epopea western, gli
Apache e i Navajo non avevano il culto della guerra e del
coraggio e nella loro struttura sociale mancavano associazioni
assimilabili a società di guerrieri come nelle popolazioni
delle Grandi Pianure: i fatti di guerra consistevano in realtà
in razzie e azioni di guerriglia tese a sfuggire alle
rappresaglie. Il valore individuale nella cultura Apache e dei
Navajo si misurava non nell'atto di coraggio bensì
nell'efficacia della razzia e nell'entità dei beni posseduti
(cavalli e bestiame). La guerra pertanto assumeva i caratteri di
una tattica di guerriglia in cui si evitava lo scontro fine a
sé stesso, ma solo dettato dalla necessità di giungere ad uno
scopo economico.
La
struttura sociale delle nazioni Apache e dei Navajo,
polverizzata in gruppi familiari estesi senza livelli di
organizzazione di grado più alto, il rifiuto della guerra
aperta, il ricorso alla razzia come attività economica resero
queste popolazioni avversari difficili per gli Stati Uniti e in
effetti furono tra le ultime nazioni indiane ad arrendersi
definitivamente.
In
prossimità della Guerra di secessione americana, il governo
degli Stati Uniti per garantirsi l'appoggio dell'Arizona e del
Nuovo Messico decise di porre fine al problema delle razzie e di
confinare le popolazioni più bellicose, in particolare i
Mescalero e i Navaho a Bosque Redondo, una riserva del Nuovo
Messico. L'operazione con i Navajo, di cui fu incaricato il
colonnello Christopher Carson, si sarebbe dovuta svolgere
pacificamente per mezzo di trattative, tuttavia la difficoltà
di trattare con un'organizzazione sociale polverizzata e
dispersa in un vasto territorio portò allo scoppio di una
campagna di guerra durata quasi un anno (1863-1864). Il
risultato fu una tragedia: agli oltre 1000 caduti durante la
guerra si aggiunse la deportazione a piedi di circa 8000 Navajo
verso Bosque Redondo con una marcia forzata di 300 miglia, nel
corso della quale persero la vita le persone più deboli.
Il
confinamento a Bosque Redondo, durato 5 anni, è segnato come la
pagina più nera della storia dei Navajo. La riserva era ubicata
in un territorio malsano, quasi privo di vegetazione e poco
vocato all'agricoltura. I rifornimenti di vettovaglie da parte
dell'esercito erano scarsi e di cattiva qualità ed erano
frequenti gli scontri con i Mescalero, con i quali si
condivideva il confinamento.
Il
ritorno ai territori d'origine segnò una drastica mutazione
nella storia dei Navajo. La popolazione tornò all'attività
agricola ma intensificò l'allevamento, l'artigianato (in
particolare la tessitura e la lavorazione dell'argento) e cessò
con le razzie. Diversi Navajo integravano il reddito, quando non
era sufficiente, con il lavoro salariale. Il nuovo corso fu
così favorevole che la ricchezza dei Navajo crebbe a livelli
tali da spingere il governo degli Stati Uniti a regolamentare
l'incremento dei capi di bestiame allevati a causa
dell'eccessivo numero.
Il
popolo dei Navajo conta oggi circa 250.000 persone e costituisce
il gruppo etnico più numeroso fra i nativi americani, stanziato
in un territorio del nord est dell'Arizona. Il territorio dei
Navajo, che supera in estensione ben 10 dei 50 stati degli USA,
gode di autonomia amministrativa e la nazione rappresenta uno
dei pochi esempi di conservazione di una forte identità
amerindia all'interno della società statunitense. Pur
mantenendo vivi i propri valori (lingua, cultura, tradizione), i
Navajo si sono adattati al progresso nell'ultimo secolo
organizzandosi in una struttura sociale autonoma moderna e
integrata come nazione all'interno di una nazione.
Uno
degli elementi di vanto dei Navajo come cittadini americani fu
l'uso della lingua dei Navajo come codice di comunicazione
durante la seconda guerra mondiale e il fondamentale apporto
dato ai risultati delle battaglie dell'esercito americano contro
i giapponesi da parte dei "code talkers" Navajo
(letteralmente "coloro che parlano il codice").
Durante
la seconda guerra mondiale un codice segreto delle forze armate
americane, mai decodificato dal controspionaggio giapponese, era
basato sul linguaggio navajo, una lingua complicata e a quel
tempo praticamente sconosciuta in tutto il mondo, al di fuori
degli Stati Uniti.
(fonte:
Wikipedia)

Le
guerre dei Navajo
Come
gli Apache che li avevano preceduti due secoli secoli prima,
anche i Navajo si staccarono dagli altri popoli del ceppo
atapascano, abitanti l'odierno Canada, per emigrare verso il
Sud-Ovest. La data approssimativa dell'arrivo dei Navajo nel
territorio compreso tra i tre fiumi, Rio Grande, San Juan e
Colorado, è quella del 1050 d. C. Come gli Apache, i Navajo
erano in origine un popolo nomade e guerriero, che integrava il
suo sostentamento ottenuto con la caccia, anche con incursioni
contro i Pueblo prima, e poi anche contro gli spagnoli.
Al contrario degli Apache il loro modo di vivere e la loro
economia si modificavano a seconda del contatto con i Pueblo e
con gli spagnoli: infatti adottarono certe attività come la
tessitura, la ceramica e l'agricoltura, dagli indigeni che a
volte vivevano in mezzo a loro. Inoltre, i Navajo non mangiavano
subito le pecore che ottenevano con le scorrerie sugli spagnoli,
come facevano invece gli Apache, ma le allevavano per ricavarne,
oltre al cibo, anche la lana, diventando dei veri esperti
allevatori. I Navajo avrebbero potuto così mantenersi
autonomamente, ma restavano comunque un popolo primitivo. Quando
i messicani si spinsero verso nord in frequenti scorrerie contro
i Navajo per rapire bambini da vendere come schiavi, i Navajo
reagirono energicamente e si vendicarono con incursioni ai
villaggi messicani. E questo ciclo continuò con soldati
messicani che arrivarono per punirli e Navajo che lasciavano i
loro villaggi per riprendere poi la vita di predoni non appena i
soldati si ritiravano. Quando nel secolo XIX i giovani Stati
Uniti cominciarono a portare molta attenzione verso l'Ovest si
ebbero le prime agitazioni con il Destino Manifesto, e i Navajo
attaccarono gli esploratori e i mercanti anglo-americani che
invadevano il loro territorio attraverso le vie di Santa Fe e di
Gila. Poi, durante l'usurpazione e l'occupazione del Sud-Ovest
da parte degli americani, i Dine, che era il nome usato dai
Navajo e che voleva dire "la gente", sfidarono
l'esercito degli Stati Uniti. punirli e Navajo che lasciavano i
loro villaggi per riprendere poi la vita di predoni non appena i
soldati si ritiravano. Quando nel secolo XIX i giovani Stati
Uniti cominciarono a portare molta attenzione verso l'Ovest si
ebbero le prime agitazioni con il Destino Manifesto, e i Navajo
attaccarono gli esploratori e i mercanti anglo-americani che
invadevano il loro territorio attraverso le vie di Santa Fe e di
Gila. Poi, durante l'usurpazione e l'occupazione del Sud-Ovest
da parte degli americani, i Dine, che era il nome usato dai
Navajo e che voleva dire "la gente", sfidarono
l'esercito degli Stati Uniti.
Nel 1846, durante la Guerra Messicana provocata dall'annessione
del Texas agli Stati Uniti, il colonnello Stephen Kearny guidò
un esercito di 1.600 uomini lungo il Sentiero di Santa Fe verso
la provincia messicana del Nuovo Messico. Durante la conquista
delle città messicane, tra cui Santa Fe, Kearny informò gli
abitanti, sia messicani che inglesi, che in futuro sarebbero
stati protetti come cittadini degli Stati Uniti, contro gli
indiani che invece sarebbero stati puniti per qualunque azione
compiuta contro di loro.
I navajo, che come indiani non vennero considerati cittadini,
non ottennero le stesse protezioni contro le continue razzie che
eseguivano i messicani per avere schiavi, e anzi il risultato di
questa assoluta mancanza di giustizia fu che i nuovi
conquistadores iniziassero presto campagne militari contro gli
indiani.
Il colonnello Doniphan organizzò i suoi volontari del Missouri
in tre colonne con un totale di trecento uomini. I Navajo non
avevano ancora mostrato ostilità contro le truppe americane,
che queste cominciarono le operazioni, adducendo la ragione che
gruppi di Navajo continuavano a rubare bestiame dai villaggi
Pueblo e messicani. Le truppe di Doniphan passarono dei momenti
difficili nelle alte zone del basso Plateau del Colorado durante
i mesi invernali. Pochi Navajo si fecero vedere e l'operazione
di Doniphan si ridusse in un'esercitazione di sopravvivenza
contro la stagione rigida come nemico. I Navajo si resero conto
di quanto stava accadendo, in quanto i loro esploratori
riferivano che gli americani erano venuti per restare. Firmarono
un trattato quell'anno e un altro nel 1849.
La situazione delle razzie e controrazzie continuava comunque, e
dal 1850 in poi i militari lanciarono una serie di campagne non
decisive contro i Navajo. Il fulcro della contesa tra esercito e
indiani era rappresentato dal terreno da pascolo intorno a Fort
Defiance in una valle alla fine del Canyon Bonito. I soldati
volevano il terreno per i loro cavalli e siccome i Navajo
continuavano ad usarlo come facevano da generazioni, i soldati
cominciarono a sparare contro gli indiani che razziavano le
mandrie dell'esercito per recuperare le loro perdite. Il 30
aprile 1860 i Navajo guidati da Manuelito e il suo alleato
Barboncito, assediarono Fort Defiance e quasi conquistarono il
posto, prima di essere respinti. Per vendicarsi il colonnello
Edward Canby condusse le truppe nelle montagne Chuska in cerca
dei Navajo. Questi attaccarono la colonna di fianco e fuggirono
prima del contrattacco dei bianchi. Era un insuccesso dei
bianchi, ma siccome gli indiani volevano badare ai loro campi e
ai loro greggi per assicurare cibo al popolo, i capi dei Navajo
furono d'accordo nel trattare una tregua che fu raggiunta nel
1861.
La fine della tregua, che durò ben poco, fu determinata da un
incidente verificatosi durante il periodo della Guerra Civile,
in occasione di una corsa di cavalli a Fort Fauntleroy. I Navajo
sostennero che un soldato aveva tagliato le redini di un loro
cavallo, ma i giudici militari non vollero ripetere la corsa.
Gli indiani si ribellarono, vennero bombardati e dodici di loro
furono uccisi.
Nel frattempo truppe confederate e dell'Unione combattevano per
il Nuovo Messico e verso la primavera del 1862 le giubbe grigie
erano state cacciate dalla regione e le giubbe blu, cioè la
colonna californiana, erano giunte per occupare il territorio.
James Carleton era stato designato nuovo comandante del
dipartimento del Nuovo Messico e rivolse innanzi tutto la sua
attenzione sulla pacificazione con gli indiani. Scelse come
comandante Christopher Carson.

Il problema consisteva, visto il persistere dei saccheggi e
delle scorribande degli Apache e dei Navajo, nel rimuovere gli
indiani dalle zone dell'ormai esteso insediamento messicano e
anglo-americano lungo le vallate e le piste. Come posto per il
trasferimento degli indiani fu scelto Bosque Redondo, nella
valle del fiume Pecos. Là, nella parte orientale del
territorio, gli indiani sarebbero stati sotto il controllo della
guarnigione di Fort Sumner che era molto ben fortificato.
Dopo contese con i Mescalero nel 1862, agli inizi del 1863
Carleton e Carson rivolsero la loro attenzione ai Navajo. Carson
inviò offerte, e alcuni capi come Delgadito e Barboncito, che
avevano constatato l'efficiente campagna dell'esercito contro
gli Apache, furono favorevoli alla pace, ma non alla cessione
dei loro territori in cambio dei piccoli terreni non fertili
delle pianure del Pecos, posti troppo vicini ai loro nemici
Mescalero. Così decisero di seguire la via del combattivo
Manuelito che non desiderava alcun accordo con l'esercito sin
dall'incidente di quella corsa coi cavalli.
Carleton mandò un ultimatum ai Navajo il mese di giugno 1863,
con scadenza un mese dopo. Il termine passò e Carson mobilitò
la sua truppa di volontari del Nuovo Messico. Invece di
effettuare inseguimenti di gruppi di Navajo attraverso tortuosi
canyon, Carson lanciò un'offensiva crudele ma efficiente contro
Dinetah, il "Paese dei Navajo". I suoi uomini
percorsero senza pietà il territorio, confiscando bestiame,
distruggendo campi e frutteti e vivendo con i prodotti degli
stessi indiani. Durante quella campagna, durata sei mesi, i
soldati uccisero solo 78 indiani su una popolazione stimata di
12.000 individui ed ebbero pochissime vittime tra loro. Ma
ottennero lo scopo di sconvolgere il modo di vivere degli
indiani e di abbattere il loro morale.
Poi nel 1864 Carson fece un'azione contyro l'inespugnabile
Canyon Chelly. Bloccò il Canyon che aveva pareti molto ripide
da un lato con soldati guidati dal capitano Albert Pfeiffer da
est. Gli indiani formarono sacche di resistenza e alcuni di loro
gettarono massi sulla rupe di Pfeiffer dai bordi del canyon, ma
dopo poco tempo i soldati snidarono i difensori e conquistarono
il "sacro forte" dei Navajo. Verso la metà di marzo
quasi 6.000 Navajo, affamati e demoralizzati, si erano arresi
all'esercito e iniziava così il loro trasferimento. I soldati
scortarono in una prima marcia forzata 2.400 Navajo attraverso
il Nuovo Messico. Alla fine dell'anno altri 2.000 indiani si
erano arresi e fu la resa più numerosa avvenuta in tutte le
guerre indiane. I 4.000 Navajo comandati da Manuelito fuggirono
verso i confini occidentali del loro territorio. Manuelito
stesso, il più intransigente dei capi navajo, cedette a quella
guerra di logoramento e si arrese a Fort Wingate il 1°
settembre 1866.
Bosque Redondo fu un disastro per i Navajo: suolo poco fertile,
scarsi rifornimenti, malattie, ostilità dei Mescalero.
Finalmente nel 1868, dopo il trasferimento del generale Carleton,
una delegazione di capi navajo, tra cui Manuelito e Barboncito,
ottenne il permesso di andare a Washington per patrocinare la
loro causa e ottenne, firmando un nuovo trattato con gli
ufficiali, una riserva nelle montagne Chuska. I Navajo tornarono
così nella loro patria e cominciarono a rifarsi una vita senza
più guerreggiare con l'uomo bianco. da
www.sentierorosso.com
ARTIGIANATO
Dagli
ultimi decenni del 1800 la ditta S.A. Frost's Son di New York
fondata nel 1858, che importava prodotti specifici per «Indian
Traders», intrattenne assidui contatti con il genovese Raffaele
Costa. .
L'immagine della libellula, insieme a rane, girini, lucertole,
serpenti, farfalle, creature emblematiche della sopravvivenza in
ambienti aridi, si ritrovano nei gioielli e negli oggetti
funzionali ai rituali, collegati alla pioggia e alla fertilità
del terreno.
Un'altra forma, comunemente modellata nei gioielli antichi e
rimasta nella contemporaneità, è quella dell'uccello volante,
con le ali aperte che ricordano una croce. Gli uccelli sono
sovente rappresentati perché considerati messaggeri tra la
terra e le entità sacre del cielo. Gli spiriti della pioggia
trovano diverse rappresentazioni nei «simbolismi magici della
pioggia» che propiziano il raccolto
Uno tra questi è il «serpente piumato», che dimora nelle
nuvole e ha lingua di luce. II serpente è anche collegato con
la terra e l'acqua, scivola come acqua ed emerge dal terreno,
incarnando le potenti forze del mondo.
Anche il kokopelli è un'altra figura emblematica delle culture
pueblo dell'Arizona e New Mexico. Giunse forse intorno al XIV
secolo importato dal Messico e presumibilmente in origine
rappresentava un mercante che porta conchiglie e piume, in
particolare le rosse piume dell'Ara Macao, dal Messico alle aree
delle popolazioni pueblo. Tra gli Hopi rappresenta un suonatore
di flauto che regge un sacco di semi e per questo è associato
alla fertilità, simbolo d'abbondanza e in genere di buon
auspicio.
Tra i più importanti italiani a commerciare con gli
statunitensi fu il genovese Raffaele Costa, di cui rimane
interessantissima corrispondenza, conservata oggi nell'archivio
storico della ditta Liverino, che la acquisì insieme ai beni
che gli eredi della fabbrica genovese misero in vendita negli
anni '60. Questa fortuita acquisizione può essere considerata
come un passaggio di testimone dalla tradizione genovese della
lavorazione e commercializzazione del corallo alla
intraprendenza degli imprenditori di Torre del Greco.
Negli anni '70 molte ditte torresi realizzarono importanti
affari con Navajo e Zuni, incrementando la valorizzazione e
l'utilizzo del corallo nel sud-ovest degli Stati Uniti e
favorendo la reciproca conoscenza delle tradizioni culturali.
Il Frost non fu l'unico commerciante del vecchio West a
stimolare la creatività dei nativi americani importando corallo
dall'Italia. Anche C.G. Wallace incoraggiò lo sviluppo
dell'artigianato ed esercitò una grande influenza sulla
produzione del corallo
Nel 1927 acquisto il suo -trading post» nel villaggio Zuni.
Sostenne l'impiego di tecniche innovative, il mosaico con
corallo, tra gli artigiani zuni e navajo residenti a Zuni ,
favorendo anche la collaborazione tra i due gruppi.
Fu lui ad iniziare un'importazione diretta di corallo
dall'Italia per i nativi, senza passare per la mediazione del
Frost. Durante la depressione del 1930, Wallace creò una base
economica per numerosi artisti e acquisì un gran numero di
lavori dei nativi, elevando le creazioni zuni da un livello
regionale a nazionale. In una lettera datata 27 febbraio1937,
inviata da Wallace sempre alla ditta Costa di Genova, è la
conferma d'ordine di quattro collane in corallo per un valore
complessivo di 48 dollari, con la richiesta supplementare di
poter avere collane con grani «più grandi, quanto i più
grossi delle collane ordinate».
In altra corrispondenza datata 13 gennaio 1940 Wallace
richiedeva i prezzi di collane in corallo che sappiamo dalla
risposta del Costa costare 14 dollari l'una, cifra in ogni caso
ragguardevole per l'epoca. La sua eredità contribuì
indubbiamente ad elevare il numero degli artigiani ad un
migliaio (gioiellieri, ceramisti, intagliatori di feticci) su
una popolazione di 9000 residenti a Zuni.
Negli ultimi sessanta anni l'innovazione dei gioielli del
sud-ovest fu determinata in massima parte da tre artisti: il
navajo Kenneth Begay e i due hopi Preston Monongye e Charles
Loloma, il cui talento artistico e le capacità tecniche hanno
inspirato generazioni di successivi designers indiani.
Kenneth Begay creò disegni innovativi, sempre ispirati ai
modelli navajo, utilizzando nuovi materiali e tecniche abbinate
alle tradizionali, turchese e corallo ad oro e diamanti,
ottenendo raffinate ed espressive creazioni. Preston Monongye
incorporò immagini katsina nei suoi lavori, famosi per la
tecnica di fusione nel tufo
I
gioielli di Charles Loloma combinano un profondo rispetto per la
tradizione con l'abilità di cambiare concetti stereotipati
degli Indiani d'America. Nato nel 1921 da una famiglia di Hopi
tradizionalisti, partì da una formazione di ceramista e pittore
ed arrivò alla gioielleria nella metà del 1950. Loloma
armonizza elementi del suo background hopi, come la tecnica
dell'intarsio di pietre dure a mosaico, con un senso estetico
contemporaneo. La sua abilità fu quella di rendere pregi le
imperfezioni della natura, sottolineando nel suo disegno le
ruvide proprietà del metallo. La sua eredità fu ripresa dalla
nipote Verma Nequatewa, che seppe abilmente disegnare il
gioiello attorno alla forma pura della materia, come il corallo.
I gioielli contemporanei del sud-ovest sono caratterizzati
dall'uso d'argento, turchese e corallo
Questo semplice accostamento racchiude in sé l'anima di due
tradizioni ornamentali: quella dei Pueblo, da millenni abili
lapidari e quella dei Navajo, valenti argentieri che per primi,
come abbiamo detto, dalla metà dell'800 praticarono e diffusero
l'arte anche ad altri gruppi nativi. Oggi i gioielli dei Navajo,
Zuni e Hopi hanno raggiunto fama mondiale e coprono una gamma
molto vasta di tipologie realizzate per le loro richieste e per
la domanda del mercato turistico e internazionale.
I gioielli zuni prodotti dalla prima metà del secolo scorso
divennero sempre più elaborati utilizzando oltre al turchese e
al corallo anche materiali compositi.
Oggi
la produzione orafa, che assicura un introito alla metà
dell'intera popolazione zuni, pone l'enfasi sul turchese e il
corallo, inserito in piccoli e sottili castoni (tecnica detta
needlepoint) o in mosaici con madreperla, turchese, corallo e
giaietto, estremamente elaborati e molto apprezzati dai
collezionisti di tutto il mondo. Molti sono oggi i Navajo che
indossano gioielli prodotti da Zuni.
Durante la Grande Depressione e nel dopoguerra, a causa delle
ristrettezze economiche, alcuni materiali preziosi furono
sostituiti con celluloide riciclata da batterie usate,
microsolchi e oggetti d'uso quotidiano. Nacquero così i monili
definiti « battery-backed jewelry» in cui la tradizionale
tecnica a mosaico veniva mantenuta, utilizzando per le piccole
tessere materiali riciclati o facilmente reperibili per i bassi
costi.
Potenti spiriti delle rocce sono i feticci, rappresentati in
diverse forme animali o umane che si pensa siano state
pietrificate dal soffio dello spirito stesso che vi dimora.
Agiscono come mediatori tra il soprannaturale e l'umano e donano
a chi li possiede la forza dell'animale rappresentato.
Per questo devono essere trattati in modo appropriato, secondo
rituali precisi. Hanno particolari funzioni nelle cerimonie e
sono decorati con specifici e significativi ornamenti. Sovente
recano frammenti di corallo e turchese. È impossibile definire
quanto antico sia l'uso di questi modelli. Tuttavia il modo in
cui i Pueblo e Navajo hanno continuato a fare uso di queste
forme nel tempo, ha rinsaldato il significato di molti esempi
del passato preistorico.
Molto popolari tra Navajo e Zuni sono le collane squash blossom,
esibite in numerose cerimonie del ciclo agricolo.
Composte da una mezzaluna centrale, o naja, hanno sempre un
numero variabile di boccioli di melograno in abbinamento. I
Navajo fecero propria la naja adottandola dalla simbologia
ispanico moresca, prima per le briglie dei cavalli, più tardi
come pendente delle collane
Questa
simbologia con il tempo prese una direzione del tutto propria
staccandosi dall'originale modello, arricchendosi di pietre e
altre lavorazioni.
L'associazione con le danze per la fertilità dei raccolti fa
tornare in mente la simbologia primigenia, comune a molte
culture antiche, della luna crescente come rappresentazione di
liturgie naturalistiche.
Non sembra tuttavia che gli Indiani abbiano assegnato un
significato simbolico a questo segno, anche se è tenuto in gran
considerazione.I Navajo usano il termine yo ne maze disya gi
(letteralmente «grano che sboccia») per indicare la collana
squash blossom, niente che si possa direttamente ricollegare al
melograno. Indipendentemente dai possibili significati
simbolici, la collana è testimonianza dei contatti tra i nativi
americani e gli spagnoli e tra i Navajo, che per primi usarono
questa tipologia, e i Pueblo, in particolare gli Zuni che la
adottarono, aggiungendo il turchese alle collane di solo
argento.
.jpg)

ALCUNI
PROVERBI NAVAJO
Attento
mentre parli. Con le tue parole tu crei un mondo intorno a te.
Evitate di dare dispiaceri ai vostri simili, ma al contrario,
vedete di procurare loro gioia ogni volta che potete
La lingua può impiccare l'uomo più veloce di una corda.
Lungo il cammino della vostra vita fate in modo
di non privare
gli altri della felicità.
Non ereditiamo il mondo dai nostri padri,
ma lo prendiamo in
prestito dai nostri figli.
Non giudicare il tuo vicino finché non avrai camminato
per due
lune nelle sue scarpe.
Quello che hai visto ricordalo perché quello
che non hai visto
ritorna a volare nel vento.
Un arco non dorme mai.
Meglio avere meno tuoni nella bocca e più luce nella mano.
Nei
fumetti, il popolo dei Navajo è la tribù a cui appartiene Tex,
di cui è il capo con il nome di Aquila della Notte. Ma
l'assistente di Tex si chiama Kit Carson, stranamente il nome
del più grande nemico del popolo Navajo.
c
cura di Sergio Mura
Entrato
a far parte della mitologia popolare persino da vivo, Kit Carson
fu un trapper, scout, agente indiano, soldato e autentica
leggenda del West.
Nato alla vigilia di Natale del 1809, Carson passò la maggior
parte della sua prima infanzia a Boone’s Lick, nel Missouri.
Suo padre morì quando lui aveva appena 9 anni e la necessità
di lavorare impedì al giovane Kit di studiare.
Divenne pertanto apprendista di un mastro sellaio a 14 anni, ma
lasciò la casa per trasferirsi a Santa Fe, nella zona del New
Mexico nel 1826.
Dal 1828 al 1831 Carson si appoggiò a Taos, New Mexico, come
campo base per continue spedizioni di caccia al fine di
procurare pelli da vendere e questa attività lo portò spesso
nel West, fino alla California.
Più tardi, nel corso degli anni 30 del secolo scorso la sua
vita da trapper lo condusse molte volte nelle Montagne Rocciose
e attraverso tutto l’ovest americano. Per un certo periodo,
nei primi anni 40, lavorò come cacciatore alle dipendenze di
William Bent a Forte Bent.
Come accadeva più volte ai cacciatori bianchi, anche Kit Carson
si trovò più volte integrato nel mondo dei pellerossa;
viaggiò e visse tra gli indiani al punto che le sue due prime
mogli furono una Arapaho e una Cheyenne. Carson era un
personaggio abbastanza inconsueto nel variegato mondo dei
trapper, soprattutto in virtù di un forte autocontrollo e per
il modesto stile di vita.
“Pulito come il dente di un segugio”, secondo l’opinione
di un conoscente, e uomo “la cui parola era più certa del
sorgere del sole”, così Carson veniva ricordato oltre che per
i suoi modi modesti e per il suo indomabile coraggio.
Nel 1842, mentre ritornava nel Missouri in visita alla famiglia,
Carson ebbe la ventura di incontrare John C. Fremont che presto
lo assunse come guida.
Negli anni successivi Carson aiutò Fremont facendogli da guida
verso l’Oregon e la California e attraverso gran parte delle
Montagne Rocciose e del Great Basin. La sua attività al
servizio di Fremont, celebrata nei reportage scritti da Fremont
stesso sulle sue spedizioni, ne fecero assai presto una specie
di eroe nazionale, rappresentato nella narrativa popolare come
un rude uomo di montagna capace di gesta sovrumane. La fama di
Carson crebbe a dismisura nel momento in cui il suo nome veniva
associato ad alcuni momenti chiave dell’espansione americana
verso ovest.
Era
ancora al servizio di Fremont come guida quando Fremont stesso
si unì alla rivolta dei cittadini americani in California, poco
prima dello scoppio della guerra con il Messico del 1846. Sempre
Carson guidò le armate del Generale Stephen Kearney dal New
Mexico alla California per rispondere alla sfida agli Stati
Uniti della banda di Andrés Pico in risposta all’occupazione
americana di Los Angeles.
Alla fine della guerra, Carson ritornò nel New Mexico con l’intenzione
di dedicarsi alla vita del canchero.
Nel 1853 lui e il suo socio portarono un enorme gregge di pecore
fino alla California dove i prezzi legati alla corsa all’oro
gli garantirono un buon profitto. Nello stesso anno fu nominato
agente indiano federale per il nord del New Mexico e tenne
questo incarico fino allo scoppio della guerra civile che lo
impegnò dal 1861. Carson giocò un ruolo piuttosto importante e
memorabile nella guerra civile nel New Mexico e diede una mano
ad organizzare i reparti volontari di fanteria dello stato che
si videro in azione a Valverde nel 1862.
La gran parte delle sue azioni militari, comunque, furono
condotte contro la popolazione Navajo che aveva rifiutato di
essere confinata in una lontana riserva inventata dai
governanti.
A partire dal 1863 Carson intraprese una brutale guerra per
distruggere l’economia alla base della vita dei Navajo,
marciando fino al cuore del loro territorio e distruggendo i
loro raccolti, i frutteti e il bestiame. Quando gli Ute, Pueblo,
Hopi e Zuni, che per secoli erano stati preda dei razziatori
Navajo, iniziarono a trarre vantaggio dalla debolezza dei loro
tradizionali nemici seguendo i bianchi nella guerra, i Navajo
non furono più in grado di difendersi. Così, nel 1864 la
maggior parte di loro si arrese a Carson che costrinse quasi
8000 Navajo, uomini, donne e bambini, a intraprendere quella che
sarebbe stata chiamata “la lunga marcia” di quasi 600
chilometri dall’Arizona a Forte Summer, New Mexico, dove
rimasero confinati e decimati dalle malattie fino al 1868.
Dopo la guerra civile, Carson si trasferì in Colorado con la
speranza di accrescere i suoi affari di allevatore e li morì
nel 1868.
Negli anni seguenti i suoi resti furono trasportati in un
piccolo cimitero vicino la sua vecchia casa a Taos
http://www.farwest.it/?p=238
 CI
HA SEMPRE INCURIOSITO L'INTERPRETAZIONE CHE LEI HA DATO DEL
PERSONAGGIO DI KIT CARSON. HA QUALCOSA DA DIRE IN PROPOSITO? CI
HA SEMPRE INCURIOSITO L'INTERPRETAZIONE CHE LEI HA DATO DEL
PERSONAGGIO DI KIT CARSON. HA QUALCOSA DA DIRE IN PROPOSITO?
Il mio Carson non ha nulla a che fare con il personaggio
storico. Il pard di Tex è un allegro compagno d'avventure, un
uomo mite anche se implacabile quando le circostanze lo
richiedono. Il vero Kit Carson, invece, era un individuo
spregiudicato e cinico, colpevole addirittura di aver combattuto
gli stessi Navajos con mezzi tutt'altro che leali.
(da
un'intervista a L.G. Bonelli, disegnatore di Tex Willer)
|









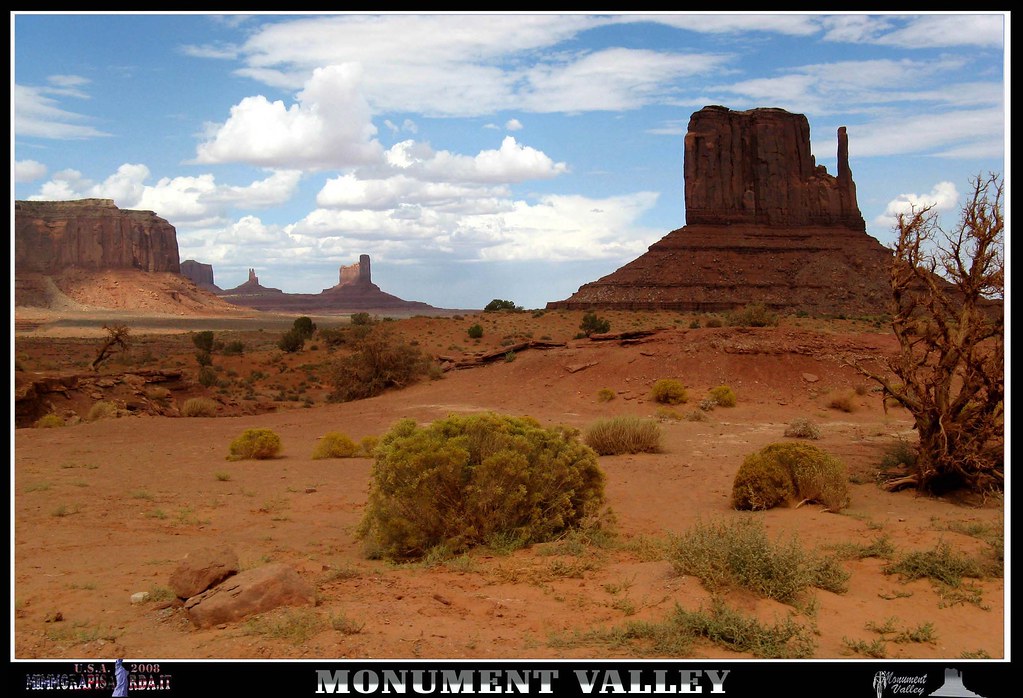
.jpg) essere valorizzata,
conosciuta, apprezzata. Oggi è famosa non tanto per il suo nome, ma per
la sua immagine (a conferma di quello che dicevo prima) diventata
leggendaria grazie all'opera di un
leggendario cineasta americano che plasmò le due forme di
granito con la storia americana fino a farle diventare le principali
icone del West. E poi, soprattutto, per un poco conosciuto Mr. Harry
Guildings che per aiutare
i Navajos sfruttò giustamente la bellezza di quelle pietre rosse facendole conoscere a John Ford,
certo che avrebbero fatto presa
nella fantasia del suo genio.
essere valorizzata,
conosciuta, apprezzata. Oggi è famosa non tanto per il suo nome, ma per
la sua immagine (a conferma di quello che dicevo prima) diventata
leggendaria grazie all'opera di un
leggendario cineasta americano che plasmò le due forme di
granito con la storia americana fino a farle diventare le principali
icone del West. E poi, soprattutto, per un poco conosciuto Mr. Harry
Guildings che per aiutare
i Navajos sfruttò giustamente la bellezza di quelle pietre rosse facendole conoscere a John Ford,
certo che avrebbero fatto presa
nella fantasia del suo genio.
 E
questa, credo, sia stata l'esatta sensazione che Ford
avvertì non appena si affacciò in questo paradiso che era un po' casa
sua. Infatti una zona della valle gli è stata dedicata proprio perchè
qui il grande regista
amava sedersi al tramonto per ripassare i copioni. Il posto si chiama John
Ford's Point.
E
questa, credo, sia stata l'esatta sensazione che Ford
avvertì non appena si affacciò in questo paradiso che era un po' casa
sua. Infatti una zona della valle gli è stata dedicata proprio perchè
qui il grande regista
amava sedersi al tramonto per ripassare i copioni. Il posto si chiama John
Ford's Point. emarginati
al più basso rango sociale e privati di ogni diritto civile. Monument Valley stessa era stata tolta
e poi, dopo tanto tempo, riconsegnata ai Navajo.
emarginati
al più basso rango sociale e privati di ogni diritto civile. Monument Valley stessa era stata tolta
e poi, dopo tanto tempo, riconsegnata ai Navajo.







 Non
è un parco nazionale, in quanto parte della riserva Navajo, dunque
territorio che appartiene ai nativi americani. La Monument Valley è l'icona degli Stati Uniti
occidentali; si trova al confine tra Utah e
Arizona in un'area isolata ed estesa che dista più di 70 km dalla
cittadina più vicina: Kayenta. Cercate quindi qui un hotel dove
pernottare, ve ne sono diversi, e fate rifornimento.
Non
è un parco nazionale, in quanto parte della riserva Navajo, dunque
territorio che appartiene ai nativi americani. La Monument Valley è l'icona degli Stati Uniti
occidentali; si trova al confine tra Utah e
Arizona in un'area isolata ed estesa che dista più di 70 km dalla
cittadina più vicina: Kayenta. Cercate quindi qui un hotel dove
pernottare, ve ne sono diversi, e fate rifornimento.







 prestigiosi set della storia del cinema. Prendetevi un paio di settimane
di ferie, e seguiteci. Si parte, ovviamente, da Los Angeles, la mecca.
Una visitina agli studios di Hollywood, tanto per gradire, e poi via
verso Santa Monica, magari passando per l’osservatorio posto dentro
Griffith Park, una location che ha ospitato scene di “Gioventù
Bruciata” e “Terminator”.
prestigiosi set della storia del cinema. Prendetevi un paio di settimane
di ferie, e seguiteci. Si parte, ovviamente, da Los Angeles, la mecca.
Una visitina agli studios di Hollywood, tanto per gradire, e poi via
verso Santa Monica, magari passando per l’osservatorio posto dentro
Griffith Park, una location che ha ospitato scene di “Gioventù
Bruciata” e “Terminator”. Perché visitare i teatri di produzione
è divertente, ma molto più chic e originale scoprire gli “esterni”
dove hanno preso luce e forma le pellicole da leggenda. Nei dintorni di
Santa Monica, ad esempio, a Rancho Las Virgenes, nel 1927 la Paramount
comprò 2400 acri di terreno, trasformandoli nel Paramount Ranch. Qui,
sullo sfondo delle montagne californiane, hanno “girato” e recitato
Cecil B. DeMille e John Ford, Gary Cooper e Marlene Dietrich, Cary Grant,
Henry Fonda, Glenn Ford, John Wayne e Diane Keaton, in pellicole come
“Il Virginiano”, “Sfida all’Ok Corral”e “Reds”. Dopo gli
Anni 50 il ranch è stato usato anche da produzioni televisive come “Rin
Tin Tin”, “Hazard”, “Mash” (quest’ultima soprattutto nella
zona di Malibù Creek) e “Charlie’s Angels”. Finito di curiosare,
mettere il timone verso nord-est, e dirigersi verso la Valle della
Morte, nel cuore del magnifico e per certi versi terribile parco
nazionale, dove sarà bene arrivare all’alba o – meglio – al
tramonto. Distese di sabbia come nel Sahara, campi di sale pietrificato,
picchi impressionanti alti fino a 4000 metri, canyon dai mille colori,
temperature che d’estate raggiungono facilmente i 60 gradi. La
varietà dei paesaggi offerti da questo incredibile ed estesissimo lembo
di terra, visitato ogni anno da milioni di turisti (prenotate in
anticipo a Furnace Creek o a Panamint Valley), ha ospitato praticamente
ogni genere di
Perché visitare i teatri di produzione
è divertente, ma molto più chic e originale scoprire gli “esterni”
dove hanno preso luce e forma le pellicole da leggenda. Nei dintorni di
Santa Monica, ad esempio, a Rancho Las Virgenes, nel 1927 la Paramount
comprò 2400 acri di terreno, trasformandoli nel Paramount Ranch. Qui,
sullo sfondo delle montagne californiane, hanno “girato” e recitato
Cecil B. DeMille e John Ford, Gary Cooper e Marlene Dietrich, Cary Grant,
Henry Fonda, Glenn Ford, John Wayne e Diane Keaton, in pellicole come
“Il Virginiano”, “Sfida all’Ok Corral”e “Reds”. Dopo gli
Anni 50 il ranch è stato usato anche da produzioni televisive come “Rin
Tin Tin”, “Hazard”, “Mash” (quest’ultima soprattutto nella
zona di Malibù Creek) e “Charlie’s Angels”. Finito di curiosare,
mettere il timone verso nord-est, e dirigersi verso la Valle della
Morte, nel cuore del magnifico e per certi versi terribile parco
nazionale, dove sarà bene arrivare all’alba o – meglio – al
tramonto. Distese di sabbia come nel Sahara, campi di sale pietrificato,
picchi impressionanti alti fino a 4000 metri, canyon dai mille colori,
temperature che d’estate raggiungono facilmente i 60 gradi. La
varietà dei paesaggi offerti da questo incredibile ed estesissimo lembo
di terra, visitato ogni anno da milioni di turisti (prenotate in
anticipo a Furnace Creek o a Panamint Valley), ha ospitato praticamente
ogni genere di pellicola. Ricordate la scena di “Guerre Stellari” in
cui Luke Skywalker contempla la pianura con il suo binocolo a
infrarossi? E’ stata filmata poco a sud di Furnace Creek, a Stovepipe
Wells, mentre da Dante’s View (occhio a non salire per i ripidi
tornanti durante le ore più calde, o rischiate di giocarvi il
radiatore!) sempre Luke e Obi Uan Kenobi contemplavano le lontane
frontiere “aliene”. Non ci sarà bisogno invece di spiegare agli
appassionati di Michelangelo Antonioni cos’è Zabriskie Point.
pellicola. Ricordate la scena di “Guerre Stellari” in
cui Luke Skywalker contempla la pianura con il suo binocolo a
infrarossi? E’ stata filmata poco a sud di Furnace Creek, a Stovepipe
Wells, mentre da Dante’s View (occhio a non salire per i ripidi
tornanti durante le ore più calde, o rischiate di giocarvi il
radiatore!) sempre Luke e Obi Uan Kenobi contemplavano le lontane
frontiere “aliene”. Non ci sarà bisogno invece di spiegare agli
appassionati di Michelangelo Antonioni cos’è Zabriskie Point. maledetto che riunì Marylin
Monroe, Clark Gable e Montgomery Clift, potete arrivare fin lassù e
dare un’occhio a Pyramid Lake, dove fu girata la scena dei cavalli
selvaggi. Non lontano, vicino a Carson City, sulla Route 28 costeggiando
il lago Tahoe potrete invece trovare il ranch che ha ispirato “Bonanza”.
Las Vegas vale invece sicuramente una visita, innanzitutto per il
divertimento e poi per scoprire qua e là le location de “Il Cavaliere
elettrico” (1979) con Robert Redford e Jane Fonda, o “Un Uomo da
marciapiede” (1969, con Jon Voigt e Dustin Hoffman) o ancora “Urban
Cowboy” (1980, con John Travolta). Il vero cuore del sogno americano a
35 mm, quello che è stato ribattezzato “Il paese di John Ford”, è
però senza dubbio la Monument Valley. Qui, in mezzo alle incredibili
cattedrali di roccia rossa (visitatele al tramonto, è un ordine!) che
sorgono improvvise al confine fra Arizona e Utah, vi sen tirete davvero
dentro un film, specie al “John Ford Point”. Emozione pura. L’elenco
dei western e dei film girati in questo angolo di Paradiso è infinito,
da “Ombre Rosse” a “Sentieri Selvaggi” (ricordate che panorami
mozzafiato, uscendo con John Wayne da quelle case nella prateria?), da
“Soldati a cavallo” a “I dannati e gli eroi” a “Sfida
infernale”. O ancora, uscendo dall’ambito western, “I dieci
comandamenti”, “2001- Odissea nello spazio”, “Easy Rider”, “Ritorno
al futuro”, “Indiana Jones e l’ultima Crociata” (non perdetevi
la visita guidata con gli indiani nei recessi più nascosti della valley),
fino a “Forrest Gump” e alla sua corsa sulla statale 163, appena a
sud di Redland Pass.
maledetto che riunì Marylin
Monroe, Clark Gable e Montgomery Clift, potete arrivare fin lassù e
dare un’occhio a Pyramid Lake, dove fu girata la scena dei cavalli
selvaggi. Non lontano, vicino a Carson City, sulla Route 28 costeggiando
il lago Tahoe potrete invece trovare il ranch che ha ispirato “Bonanza”.
Las Vegas vale invece sicuramente una visita, innanzitutto per il
divertimento e poi per scoprire qua e là le location de “Il Cavaliere
elettrico” (1979) con Robert Redford e Jane Fonda, o “Un Uomo da
marciapiede” (1969, con Jon Voigt e Dustin Hoffman) o ancora “Urban
Cowboy” (1980, con John Travolta). Il vero cuore del sogno americano a
35 mm, quello che è stato ribattezzato “Il paese di John Ford”, è
però senza dubbio la Monument Valley. Qui, in mezzo alle incredibili
cattedrali di roccia rossa (visitatele al tramonto, è un ordine!) che
sorgono improvvise al confine fra Arizona e Utah, vi sen tirete davvero
dentro un film, specie al “John Ford Point”. Emozione pura. L’elenco
dei western e dei film girati in questo angolo di Paradiso è infinito,
da “Ombre Rosse” a “Sentieri Selvaggi” (ricordate che panorami
mozzafiato, uscendo con John Wayne da quelle case nella prateria?), da
“Soldati a cavallo” a “I dannati e gli eroi” a “Sfida
infernale”. O ancora, uscendo dall’ambito western, “I dieci
comandamenti”, “2001- Odissea nello spazio”, “Easy Rider”, “Ritorno
al futuro”, “Indiana Jones e l’ultima Crociata” (non perdetevi
la visita guidata con gli indiani nei recessi più nascosti della valley),
fino a “Forrest Gump” e alla sua corsa sulla statale 163, appena a
sud di Redland Pass.  Nel Canyon de Chelly, quasi al confine fra Arizona
e New Mexico Sono stati girati “Il grande paese” e “L’oro dei
Mckenna” mentre nella vicina riserva degli indiani Hopi è stato
realizzato “La collina del demonio”. Se invece vi hanno emozionato
“Butch Cassidy , “Getaway” e “La più grande storia mai
raccontata” allora il vostro posto è lo Utah. John Ford ha girato
qui, a Professor Valley, nella zona di Moab, il suo “Rio Grande”,
Steven Spielberg “Indiana Jones e il tempio maledetto”, nello
strepitoso parco di Arches dove Sergio Leone ha diretto alcune scene di
“C’era una volta il West”. Attorno a Moab è stato filmato anche
quasi tutto “Thelma e Louise”: la scena finale, quella del salto nel
canyon delle due protagoniste braccate dall’elicottero della polizia
ha come scenografia uno strapiombo sotto Dead Horse Point, sul Potash
Trail (seguite la state route 279 verso ovest per 15 miglia). I
manichini usati per la scena sono conservati negli uffici della Moab to
Monument Valley film Commission. Se invece vi ha commosso la scena in
cui Paul Newman, in “Butch Cassidy”, porta sulla canna della
bicicletta Katharine Ross con in sottofondo “Raindrops keep fallin’
on my head” di Burt Bacharach, fiondatevi a Grafton, sul Virgin River,
vicino allo Zion Park (6 miglia a ovest di Springdale sulla state route
9). Anche il Colorado, fra Boulder, Gunnison e Durango, ha offerto molte
delle sue valli e dei suoi canyon a pellicole cult, da “Viva Zapata”
a “Il Dormiglione”, da “Cat Ballou” a “Il Grinta”, ma
siccome il tempo (e le righe) ormai scarseggiano, vi suggeriamo solo un
sopralluogo: a Estes Park, circa 30 miglia a nord di Boulder, sulla Us
numero 36. Troverete un vecchio hotel vittoriano, lo Stanley Hotel, dove
da giovane lavorò un certo Stephen King. Il nome non è quello del film
(Overlock), ma se il titolo “Shining” vi dice qualcosa, non
arrivateci con un maggiolino Volkswagen…
Nel Canyon de Chelly, quasi al confine fra Arizona
e New Mexico Sono stati girati “Il grande paese” e “L’oro dei
Mckenna” mentre nella vicina riserva degli indiani Hopi è stato
realizzato “La collina del demonio”. Se invece vi hanno emozionato
“Butch Cassidy , “Getaway” e “La più grande storia mai
raccontata” allora il vostro posto è lo Utah. John Ford ha girato
qui, a Professor Valley, nella zona di Moab, il suo “Rio Grande”,
Steven Spielberg “Indiana Jones e il tempio maledetto”, nello
strepitoso parco di Arches dove Sergio Leone ha diretto alcune scene di
“C’era una volta il West”. Attorno a Moab è stato filmato anche
quasi tutto “Thelma e Louise”: la scena finale, quella del salto nel
canyon delle due protagoniste braccate dall’elicottero della polizia
ha come scenografia uno strapiombo sotto Dead Horse Point, sul Potash
Trail (seguite la state route 279 verso ovest per 15 miglia). I
manichini usati per la scena sono conservati negli uffici della Moab to
Monument Valley film Commission. Se invece vi ha commosso la scena in
cui Paul Newman, in “Butch Cassidy”, porta sulla canna della
bicicletta Katharine Ross con in sottofondo “Raindrops keep fallin’
on my head” di Burt Bacharach, fiondatevi a Grafton, sul Virgin River,
vicino allo Zion Park (6 miglia a ovest di Springdale sulla state route
9). Anche il Colorado, fra Boulder, Gunnison e Durango, ha offerto molte
delle sue valli e dei suoi canyon a pellicole cult, da “Viva Zapata”
a “Il Dormiglione”, da “Cat Ballou” a “Il Grinta”, ma
siccome il tempo (e le righe) ormai scarseggiano, vi suggeriamo solo un
sopralluogo: a Estes Park, circa 30 miglia a nord di Boulder, sulla Us
numero 36. Troverete un vecchio hotel vittoriano, lo Stanley Hotel, dove
da giovane lavorò un certo Stephen King. Il nome non è quello del film
(Overlock), ma se il titolo “Shining” vi dice qualcosa, non
arrivateci con un maggiolino Volkswagen…

 gustosa parodia del genere gangster appena agli inizi ma già in
gran voga. L'anno successivo ottiene l'Oscar per Il traditore
(1935), un'opera che mette in scena la rivolta irlandese, la cui
drammaticità appare accentuata dalla scelta di una cifra
stilistica palesemente intrisa di tonalità espressioniste. Gira
poi, tra gli altri, un notevole Maria di Scozia (1936) e un
avvincente mélo di ambientazione caraibica, Uragano (1937). Nel
1939, esattamente a quindici anni di distanza dal suo western
più acclamato dell'epoca del muto, con Ombre rosse realizza uno
dei capolavori della storia del cinema, e si avvia a diventare
il più grande regista dei film della Frontiera. Una diligenza
in fuga, inseguita da un'orda di apaches, mentre scorrono
visioni sfolgoranti della celeberrima Monument Valley: tratto da
un breve racconto di E. Haycox, e forse vagamente ispirato a
Boule de suif di Maupassant, nella memoria storica dello
spettatore Ombre rosse si identifica tout court con il genere
western, di cui rappresenta una svolta decisiva. Anzi, per la
sua originalità, per il suo metro stilistico, per il profilo
esistenziale dei personaggi, si presenta come il paradigma del
western a venire. Lo sguardo di F. esplora il microcosmo che
popola la diligenza, luogo topico della vicenda, senza
complicità: una prostituta, un medico alcolizzato, un baro di
professione, un banchiere ladro, un venditore di liquori, la
moglie incinta di un ufficiale di cavalleria (che partorirà
lungo la strada), uno sceriffo e un fuorilegge raccolto lungo il
cammino; donne e uomini soli diversi, gettati in un ambiente
estraneo e ostile, di cui vengono messi a nudo le debolezze, le
paure, gli eroismi inaspettati. Mai prima di quest'opera
straordinaria i caratteri degli uomini della Frontiera erano
stati così nettamente delineati. Mentre con Ombre rosse
guadagna un altro Oscar, F. si avvia a diventare il poeta dei
grandi spazi, ma anche dei sentimenti, dei drammi, dei piccoli
eroismi quotidiani. Tenace, metodico, a volte aspro, ma anche
tenero, appassionato e ironico, alla fine della carriera
gustosa parodia del genere gangster appena agli inizi ma già in
gran voga. L'anno successivo ottiene l'Oscar per Il traditore
(1935), un'opera che mette in scena la rivolta irlandese, la cui
drammaticità appare accentuata dalla scelta di una cifra
stilistica palesemente intrisa di tonalità espressioniste. Gira
poi, tra gli altri, un notevole Maria di Scozia (1936) e un
avvincente mélo di ambientazione caraibica, Uragano (1937). Nel
1939, esattamente a quindici anni di distanza dal suo western
più acclamato dell'epoca del muto, con Ombre rosse realizza uno
dei capolavori della storia del cinema, e si avvia a diventare
il più grande regista dei film della Frontiera. Una diligenza
in fuga, inseguita da un'orda di apaches, mentre scorrono
visioni sfolgoranti della celeberrima Monument Valley: tratto da
un breve racconto di E. Haycox, e forse vagamente ispirato a
Boule de suif di Maupassant, nella memoria storica dello
spettatore Ombre rosse si identifica tout court con il genere
western, di cui rappresenta una svolta decisiva. Anzi, per la
sua originalità, per il suo metro stilistico, per il profilo
esistenziale dei personaggi, si presenta come il paradigma del
western a venire. Lo sguardo di F. esplora il microcosmo che
popola la diligenza, luogo topico della vicenda, senza
complicità: una prostituta, un medico alcolizzato, un baro di
professione, un banchiere ladro, un venditore di liquori, la
moglie incinta di un ufficiale di cavalleria (che partorirà
lungo la strada), uno sceriffo e un fuorilegge raccolto lungo il
cammino; donne e uomini soli diversi, gettati in un ambiente
estraneo e ostile, di cui vengono messi a nudo le debolezze, le
paure, gli eroismi inaspettati. Mai prima di quest'opera
straordinaria i caratteri degli uomini della Frontiera erano
stati così nettamente delineati. Mentre con Ombre rosse
guadagna un altro Oscar, F. si avvia a diventare il poeta dei
grandi spazi, ma anche dei sentimenti, dei drammi, dei piccoli
eroismi quotidiani. Tenace, metodico, a volte aspro, ma anche
tenero, appassionato e ironico, alla fine della carriera
 avrà
frequentato quasi tutti i generi, e la sua filmografia
consisterà di oltre 150 titoli. Intanto la sua vena non accenna
a esaurirsi.
avrà
frequentato quasi tutti i generi, e la sua filmografia
consisterà di oltre 150 titoli. Intanto la sua vena non accenna
a esaurirsi.  americani. Wayne riprende qualche anno
dopo il suo ruolo di cavaliere senza macchia e senza paura,
coriaceo, solitario, specchio delle «virtù» americane, in un
altro caposaldo del western, Sentieri selvaggi, girato nel 1956,
dopo incursioni di F. in altri generi, tra i quali la commedia
– con gli splendidi Un uomo tranquillo (1952) e Il sole
splende alto (1953) – e il dramma – con La lunga linea
grigia (1955). Senza abbandonare quello che è stato considerato
il genere principe del cinema americano, frequenta altre forme
della narrazione filmica, come nel drammatico Le ali delle
aquile (1957), nell'antirazzista L'ultimo urrà (1958), nel
poliziesco 24 ore a Scotland Yard (1958), oppure nella sapida
commedia I tre della Croce del Sud (1963), ma è ancora nei
paesaggi – reali e mentali – dell'amata Frontiera che la sua
tempra di inarrivabile artigiano della settima arte continua a
esaltarsi e a innovarsi.
americani. Wayne riprende qualche anno
dopo il suo ruolo di cavaliere senza macchia e senza paura,
coriaceo, solitario, specchio delle «virtù» americane, in un
altro caposaldo del western, Sentieri selvaggi, girato nel 1956,
dopo incursioni di F. in altri generi, tra i quali la commedia
– con gli splendidi Un uomo tranquillo (1952) e Il sole
splende alto (1953) – e il dramma – con La lunga linea
grigia (1955). Senza abbandonare quello che è stato considerato
il genere principe del cinema americano, frequenta altre forme
della narrazione filmica, come nel drammatico Le ali delle
aquile (1957), nell'antirazzista L'ultimo urrà (1958), nel
poliziesco 24 ore a Scotland Yard (1958), oppure nella sapida
commedia I tre della Croce del Sud (1963), ma è ancora nei
paesaggi – reali e mentali – dell'amata Frontiera che la sua
tempra di inarrivabile artigiano della settima arte continua a
esaltarsi e a innovarsi. 





 È
notte di luna piena alla Monument Valley e al calar della sera
si allungano le ombre rosse sulla terra infuocata d'arancio. Le
pietre monolitiche s'illuminano dei raggi di luna: diventano
ombre d'argento, poi ombre blu, poi nere, il silenzio si fa più
forte e tutto si trasforma in batticuore. Ma questo non è un
film. Questa non è Hollywood, anche se per anni, tanto tempo
fa, Hollywood qui ha raccontato i suoi sogni
più belli, questa
è la Monument Valley, è la Navajo Land. Questa è la terra
delle ombre lunghe attraversata dal confine di due Stati, Utah e
Arizona, giusto a ovest della frontiera tra Colorado e New
Mexico, "dove lo spazio è abbastanza e il tempo è
abbastanza", come usano dire gli indiani nativi e dove le
tre sorelle, il re sul trono, la roccia dell'aquila, la
proboscide dell'elefante, la diligenza e tutte le altre rocce di
sabbia indurita dal tempo ad ogni sguardo assomigliano sempre a
qualcosa, a qualcuno, ad altro.
È
notte di luna piena alla Monument Valley e al calar della sera
si allungano le ombre rosse sulla terra infuocata d'arancio. Le
pietre monolitiche s'illuminano dei raggi di luna: diventano
ombre d'argento, poi ombre blu, poi nere, il silenzio si fa più
forte e tutto si trasforma in batticuore. Ma questo non è un
film. Questa non è Hollywood, anche se per anni, tanto tempo
fa, Hollywood qui ha raccontato i suoi sogni
più belli, questa
è la Monument Valley, è la Navajo Land. Questa è la terra
delle ombre lunghe attraversata dal confine di due Stati, Utah e
Arizona, giusto a ovest della frontiera tra Colorado e New
Mexico, "dove lo spazio è abbastanza e il tempo è
abbastanza", come usano dire gli indiani nativi e dove le
tre sorelle, il re sul trono, la roccia dell'aquila, la
proboscide dell'elefante, la diligenza e tutte le altre rocce di
sabbia indurita dal tempo ad ogni sguardo assomigliano sempre a
qualcosa, a qualcuno, ad altro. Ma vennero gli anni della Grande Depressione e gli affari dopo
qualche tempo non bastarono più per vivere anche in una terra
dove non c'erano troppe distrazioni, così Harry Goulding ebbe
un'idea: cosa c'era di meglio come scenografia di quelle
montagne rosse che aveva imparato a conoscere roccia per roccia?
"Così un giorno del 1938 partì per Hollywood per tentare
l'ultima carta", ricorda il nativo americano navajo.
"Si presentò agli Studios, domandò di Mr. Ford, di John
Ford, ma il regista non c'era. Non si perse d'animo, ma lo
attese per tre giorni e tre notti davanti al suo ufficio e
quando Ford finalmente arrivò Goulding gli mostrò alcune foto
della Monument Valley. Per il regista fu un colpo di fulmine,
quello era il posto che aveva sempre cercato. Così tre giorni
dopo arrivarono cento persone della troupe e il mese successivo
stava già girando proprio qui tra queste montagne il suo
capolavoro Ombre rosse".
Ma vennero gli anni della Grande Depressione e gli affari dopo
qualche tempo non bastarono più per vivere anche in una terra
dove non c'erano troppe distrazioni, così Harry Goulding ebbe
un'idea: cosa c'era di meglio come scenografia di quelle
montagne rosse che aveva imparato a conoscere roccia per roccia?
"Così un giorno del 1938 partì per Hollywood per tentare
l'ultima carta", ricorda il nativo americano navajo.
"Si presentò agli Studios, domandò di Mr. Ford, di John
Ford, ma il regista non c'era. Non si perse d'animo, ma lo
attese per tre giorni e tre notti davanti al suo ufficio e
quando Ford finalmente arrivò Goulding gli mostrò alcune foto
della Monument Valley. Per il regista fu un colpo di fulmine,
quello era il posto che aveva sempre cercato. Così tre giorni
dopo arrivarono cento persone della troupe e il mese successivo
stava già girando proprio qui tra queste montagne il suo
capolavoro Ombre rosse".


 il
nome Navajo deriva dal termine Navahuu che in lingua Tewa,
parlata da alcune popolazioni del sud ovest, significa Campo
coltivato in un piccolo corso d'acqua. In lingua Navajo si usa
il termine Diné (talvolta citato nella letteratura come Dineh)
che significa Il popolo.
il
nome Navajo deriva dal termine Navahuu che in lingua Tewa,
parlata da alcune popolazioni del sud ovest, significa Campo
coltivato in un piccolo corso d'acqua. In lingua Navajo si usa
il termine Diné (talvolta citato nella letteratura come Dineh)
che significa Il popolo.

 punirli e Navajo che lasciavano i
loro villaggi per riprendere poi la vita di predoni non appena i
soldati si ritiravano. Quando nel secolo XIX i giovani Stati
Uniti cominciarono a portare molta attenzione verso l'Ovest si
ebbero le prime agitazioni con il Destino Manifesto, e i Navajo
attaccarono gli esploratori e i mercanti anglo-americani che
invadevano il loro territorio attraverso le vie di Santa Fe e di
Gila. Poi, durante l'usurpazione e l'occupazione del Sud-Ovest
da parte degli americani, i Dine, che era il nome usato dai
Navajo e che voleva dire "la gente", sfidarono
l'esercito degli Stati Uniti.
punirli e Navajo che lasciavano i
loro villaggi per riprendere poi la vita di predoni non appena i
soldati si ritiravano. Quando nel secolo XIX i giovani Stati
Uniti cominciarono a portare molta attenzione verso l'Ovest si
ebbero le prime agitazioni con il Destino Manifesto, e i Navajo
attaccarono gli esploratori e i mercanti anglo-americani che
invadevano il loro territorio attraverso le vie di Santa Fe e di
Gila. Poi, durante l'usurpazione e l'occupazione del Sud-Ovest
da parte degli americani, i Dine, che era il nome usato dai
Navajo e che voleva dire "la gente", sfidarono
l'esercito degli Stati Uniti.


.jpg)



 CI
HA SEMPRE INCURIOSITO L'INTERPRETAZIONE CHE LEI HA DATO DEL
PERSONAGGIO DI KIT CARSON. HA QUALCOSA DA DIRE IN PROPOSITO?
CI
HA SEMPRE INCURIOSITO L'INTERPRETAZIONE CHE LEI HA DATO DEL
PERSONAGGIO DI KIT CARSON. HA QUALCOSA DA DIRE IN PROPOSITO?


















