|

http://farm8.staticflickr
 Palazzo
Pancari Ferreri Palazzo
Pancari Ferreri
Via
Etnea, 306 - Anno Di Costruzione: 1881-1900/ inizio -
Architetto: Carlo Sada (1849-1924)
L'edificio
ubicato in Via Etnea, angolo Via Umberto I, insiste su un'area
coinvolta dalle ristrutturazioni urbane di fine Ottocento. E a
tale epoca (1875 prime proposte-1892 completamento) che risale
la decisione del Consiglio comunale per l'allargamento della Via
Santa Caterina, attuale Via Umberto I, in asse con l'ingresso
della Villa Bellini. A seguito di tale intervento urbanistico la
famiglia Fischetti commissiona nel 1881, all'architetto Carlo
Sada, la costruzione del proprio palazzo. Nel progetto
originario, come per le tre case signorili progettate
dall'architetto milanese, sono previsti oltre all'abitazione del
proprietario anche diversi appartamenti da destinare alla
famiglia o ad affitto. Tipologicamente l'autore adotta soluzioni
in uso nelle case di fitto milanesi, come la corte interna
aperta su di un lato () le anticamere di disimpegno delle stanze
raggruppate attorno alle scale principali di servizio. Nel 1885
è previsto un ampliamento del corpo di fabbrica a nord
della...ed alcune variazioni della copertura e alla fine
dell'Ottocento l'edificio risulta quasi interamente completato.
Agli inizi del Novecento il barone Pancari acquista il palazzo
ed affida allo stesso Sada l'incarico di apportare modifiche
all'esistente: il nuovo getto interessa la scala principale, il
salone dell'appartamento del primo piano, i soffitti a volta ed
infine viene richiesto all'architetto di completare
l'arredamento dell'appartamento del piano nobile.

|
 Il
loro habitat naturale era la via Etnea, con particolare preferenza al
tratto villa Bellini-piazza Stesicoro, ma il tempo maggiore lo
trascorrevano davanti a Caviezel, il bar-pasticceria ubicato di fronte
al cinema "Sala Roma", che da lì a poco sarebbe scomparso
per far posto all'attuale casermone della Rinascente, e a pochi metri
dall'Hotel CentraI Corona, oggi CentraI Palace. Davanti alle vetrine
della pasticceria svizzera si riunivano in gruppetti di cinque o sei e
lì, dalle undici alle quattordici circa, si svolgeva il quotidiano
rito della "sfurbiciata". Si tagliavano i vestiti addosso a
tutte le donne conosciute e non (tranne le madri e le sorelle,
ovviamente) e si raccontavano, con dovizie di particolari stuzzicanti,
avventure galanti vissute o ... sognate. Con linguaggio coloratissimo,
non proprio da educande o da seminaristi. Il
loro habitat naturale era la via Etnea, con particolare preferenza al
tratto villa Bellini-piazza Stesicoro, ma il tempo maggiore lo
trascorrevano davanti a Caviezel, il bar-pasticceria ubicato di fronte
al cinema "Sala Roma", che da lì a poco sarebbe scomparso
per far posto all'attuale casermone della Rinascente, e a pochi metri
dall'Hotel CentraI Corona, oggi CentraI Palace. Davanti alle vetrine
della pasticceria svizzera si riunivano in gruppetti di cinque o sei e
lì, dalle undici alle quattordici circa, si svolgeva il quotidiano
rito della "sfurbiciata". Si tagliavano i vestiti addosso a
tutte le donne conosciute e non (tranne le madri e le sorelle,
ovviamente) e si raccontavano, con dovizie di particolari stuzzicanti,
avventure galanti vissute o ... sognate. Con linguaggio coloratissimo,
non proprio da educande o da seminaristi.
LO
sproloquiare s'interrompeva solo quando passava una bella donna,
all'indirizzo della quale piovevano i complimenti più infocati. Ogni
tanto un "guerriero del sesso" si staccava dal gruppetto,
entrava da Caviezel, ne usciva poco dopo con un bicchiere di Campari
Soda e con questo, tenuto in mano come un trofeo, tornava al suo
posto, riappoggiava al muro le spalle e la pianta di un piede e
cominciava a centellinare il suo aperitivo con la non chalance di una
sofisticata nobildonna d'altri tempi.
Apparentemente
sembravano uguali ai coetanei che stazionavano poco più in là,
davanti a Savia e al giardino Bellini, ma, come detto, rispetto ai
più popolari "picciotti di vita" avevano sicuramente più
classe: provenivano quasi tutti dai licei classici cittadini, molti
avevano già letto il Brancati di Don Giovanni in Sicilia, Il
bell'Antonio e Paolo il caldo e alcuni anche il primo Patti di
Quartieri alti, ogni tanto si "sparavano" qualche frase
sentenziosa latina, citavano Cartesio e Kant, parlavano di Prévert,
Sartre e Juliette Greco.

Non erano, insomma, degli sprovveduti, tutt'altro: una generazione cui
la storia aveva assegnato il compito di concludere, con gli anni '60,
una mitologia di gallismo che letteratura e cinematografia non sempre
hanno saputo sfruttare adeguatamente; una generazione alla quale la
guerra aveva negato fanciullezza e adolescenza; una generazione di
ragazzi che, usciti dalla sfera erotico-letteraria di quel tempo,
trovarono ben presto la strada giusta per imporsi nella vita con i
frutti dei loro seri studi e della loro intelligenza. Molti di essi
occupano ancora oggi posti di grande prestigio e responsabilità
nell'amministrazione dello Stato o svolgono attività di liberi
professionisti; qualcuno sfortunatamente ci ha preceduti nell'ultimo
viaggio.
Fra tanti ne voglio ricordare particolarmente uno col quale giocavo a
calcio nel campetto del collegio Leonardo da Vinci, allora in viale
della Libertà; non giocava molto bene, anzi sarebbe più esatto dire
che era alquanto "scarso", ma, in compenso, non si stancava
mai quando parlava di donne e di sesso. Era eternamente disponibile e,
spesso, con sussiegosa aria professionale e con un pizzico di mal
celata civetteria, soleva definirsi modestamente un ''homo
eroticus".
da
"A Catania con amore" - di Lucio Sciacca - Edizioni Greco

In
una citta' golosa e raffinata come Catania, la Pasticceria Savia
incarna i fasti della dolcezza, tra cannoli invitanti e cassate
variopinte, tra paste di mandorla e l'esplosione di colori del
marzapane.
Come
consuetudine cittadina,da piu' di Un Secolo, dal caffe'
all'aperitivo,dall'arancina al pasticcino, a seconda dell'ora e degli
impegni, la Pasticceria Savia e' la meta preferita da giovani e meno
giovani impiegati e manager ranpanti nella pausa pranzo.
Fu
fondata nel 1897 dai coniugi Angelo ed Elisabetta Savia in quella zona
anticamente chiamata Piano di Nicosia. Da li' mosse i primi passi e
accrebbe la sua esperienza grazie all'intuito e alla sagacia di Alfio
e Carmelina Savia trovo' degna sistemazione nel cuore della citta';
Per
i pochi che non lo sapessero la Pasticceria Savia si trova incastonata
ad angolo tra la via Etnea e la Via Umberto, in quello che Federico de
Roberto battezzo' col nome prestigioso di Salotto di Catania.


|

In
quell'illustre angolo matura, grazie ad Angelo Savia, la tradizione
dolciaria che trova i suoi punti di forza nell'eccelsa qualità delle
materie prime, nella magistrale professionalita' e cortesia del suo
personale e nel confezionamento dei prodotti sempre freschi e
fragranti.
Forte
di questi capisaldi la Pasticceria Savia ha iniziato un nuovo capitolo
della sua storia Da oggi insieme ai nipoti Alessandro e Claudio, si
presenta alla clientela in una veste completamente rinnovata,
conservando sempre la qualita' e le tradizioni di un tempo.
da
www.savia..it

Il 13
feb 2015 il Signor Hood si accomodò al banchetto catanese di
Radio Radicale, di fronte al Bar Savia. Morì un anno dopo.
https://www.cataniatoday.it/cronaca/marco-pannella-radicali-catania-13-febbraio-2015.html
Mentre era lì, qualcuno commentava.
- il
monfiano: cara, come lo Speaker Corner che incontrammo ad
Hyde Park?
- il
mammoriano: minchia Cetty, talìa ccu c'è: Pannella!

|
|

|

|
|

seguilo
anche su Facebook


Pippo, il Re delle pernacchie
In
ogni articolo che si rispetti i ringraziamenti
si
scorgono in coda all’elaborato; nondimeno
viceversa si apre
oggi
il mio. Propriamente con un tributo di sincera gratitudine a cantautori,
poeti, scrittori e artisti che hanno solennizz ato un uomo vissuto nella
seconda metà del secolo scorso ai piedi del vulcano più alto d’Europa.
Immortalato dal pittore francese Cristian Bernard,
il
suo ritratto
spicca in un murales del bar Mokambo di Taormina mentre una sua foto
in primo piano la copertina del Times anni fa guadagnò. È grazie a
questi signori se tuttora egli sosta oltre i confini delle leggende
nostrane. ato un uomo vissuto nella
seconda metà del secolo scorso ai piedi del vulcano più alto d’Europa.
Immortalato dal pittore francese Cristian Bernard,
il
suo ritratto
spicca in un murales del bar Mokambo di Taormina mentre una sua foto
in primo piano la copertina del Times anni fa guadagnò. È grazie a
questi signori se tuttora egli sosta oltre i confini delle leggende
nostrane.
«Chi
era in realtà Pippo? -si
chiede Domenico Trischitta- Era l’ultimo testimone e, nello stesso tempo,
personaggio del mondo brancatiano. Percorreva in lungo e largo i marciapiedi
di via Etnea, dispensando sorrisi, ghigni beffardi e sonore pernacchie ai
pochi nobili decaduti o agli impettiti politici che facevano passerella per
elemosinare voti. Si era autodecorato con tre medaglie che gli penzolavano
sulla giacca nera e unta di grasso».«Non
sapremo mai
–prosegue Aldo Motta- se Giuseppe Condorelli detto ’Pippo pernacchia’
fosse veramente babbo. O non piuttosto troppo sperto. Se è vero che gli
occhi sono lo specchio dell’anima, i suoi proiettavano candore e furbizia,
dolcezza e scaltrezza; erano un insieme di sottile ingenuità mista ad una
gentile velatura di mascalzoneria. Il suo viso rotondeggiante era spaccato
da un sorriso permanente, bonario e forse anche misterioso.‘Frati mio –mi
disse una volta-cu sti quattru sordi ca mi dati, a pernacchia mi nesci
vascia e lenta’».«La pernacchia di Pippo –così Salvatore Scalia-
s’innalzò in un ultimo acuto che incrinò l’aria cristallina della sera
primaverile, sfiorò i balconi per perdersi tra i tetti bui, infine si esaurì
in un lungo malinconico lamento».
Ora
è sconfortata e ha smarrito il proverbiale humour ma, all’inizio
degli anni Sessanta, questa città chiamata Catania è l’opulenta Milano del
sud. L’atmosfera sognante della sua realtà urbana, dal salotto buono al
cuore pulsante, la innalza a una delle più belle del reame. Quivi
c’è
la pasticceria svizzera Caviezel che rimane
in
via Etnea, di fronte al piccolo gioiello liberty incastonato tra due antichi
palazzi: il
cine Sala Roma. Colà
un
giovanotto riccioluto e piccolo di statura ha creato il suo quartier
generale. Ha poco più di trent’anni, una rada peluria sul viso da simpatica
canaglia e un cappellino di paglia in testa. Indossa camicia a fiori e
giacca da yachtman con bottoni dorati, i suoi pantaloni di colore blu
son lisi e spiegazzati.
Pippo è un talento della natura, un personaggio la cui nomea s’estende dalla
costa ionica fin a Mascalucia, Belpasso e Sigonella.
Ha
una funzione sociale, perché quando qualcuno vola più in alto della quota di
competenza, scende in campo con arte e indirizza un chiaro messaggio al
destinatario. Delle pernacchie, in fin dei conti, è il Re ma anche un po’ il
Robin Hood. Porta pollice e indice alla bocca e con prepotenti deflagrazioni
gli fa capire che è il caso di ridimensionarsi. Tali spifferi irrispettosi
costano poche lire ma se paghi il doppio, può darsi che tremi tutta la via
Etnea dai Quattro Canti fin al Duomo e a Porta Aci. L’intera città è
sbeffeggiata
dai
frastuoni stravaganti del suo irridente trombone; per il suo esser senza
tempo e convenzioni, per gli stentorei virtuosismi e la vita randagia
suscita un oscuro turbamento nei concittadini. «Pernacchie così –ripetono
i passanti- non ne fabbricano manco alla Fiat di Torino». «Chissà
chi – dicono-gli prepara da mangiare e chi gli assicura un tetto e
un letto». Se gli si domanda «Pippo, ma perchè non ti sposi?» il
giovanotto s’accarezza la barbetta e poi fa: «No, perchè poi mi si sciupa
il viso».«Pippo pernacchia –parola di Piero Corigliano- è un vecchio
fanciullo con gli occhietti da topolino, l’espressione un po’ beffarda, un
po’ trasognata e un segno particolare sul labbro inferiore, una specie di
tumefazione come quella del grande Armstrong. La sua popolarità supera
quella di un deputato. Pippo è un grosso commerciante. Vende pernacchie. Ci vive. Potrebbe diventare ricco se lo volesse. La sua
produzione fragorosa, inconfondibile e, fortunatamente, inodore, trova
numerosi acquirenti. Un non siciliano stenterebbe a credere che si possa
campare tranquillamente prendendo a pernacchie il prossimo. Pippo non è un
filosofo che protesta contro una società sperequata e malefatta; né
s’intende di politica: è soltanto un istintivo che dileggia il prossimo per
servirlo. A suo modo, è un uomo felice».
Vende pernacchie. Ci vive. Potrebbe diventare ricco se lo volesse. La sua
produzione fragorosa, inconfondibile e, fortunatamente, inodore, trova
numerosi acquirenti. Un non siciliano stenterebbe a credere che si possa
campare tranquillamente prendendo a pernacchie il prossimo. Pippo non è un
filosofo che protesta contro una società sperequata e malefatta; né
s’intende di politica: è soltanto un istintivo che dileggia il prossimo per
servirlo. A suo modo, è un uomo felice».
È
un sicario, ma non uno comune: un giullare buono camuffato da esecutore.
Gli
autobus di linea e quelli dell’Etna Trasporti lo portano con sè e lo
mostrano come un trofeo: i conducenti alleviano la noia e si donano uno
sfizio. Non appena
scende giù, quello comincia a spernacchiare uomini e cose da un marciapiede
all’altro. Come
una stella del varietà, dapprima accenna un lieve inchino poi allarga in
modo solenne le braccia; avvicina la mano alle labbra, gonfia le guance e
s’esibisce con maestria. Col viso stravolto e grottesco, sorride beato e
s’illude di aver il mondo ai piedi. Con la bella stagione si spinge in quel
di Taormina e lo si vede bazzicare in corso Umberto a incuriosir i turisti
americani che lo pagano bene per sbeffeggiare connazionali e travestiti di
 passaggio.
Quando scompare dalla circolazione, la gente di Catania sta in angoscia fin
quando Pippo non fa di nuovo capolino alla stazione, alla plaja o in
via delle Finanze. passaggio.
Quando scompare dalla circolazione, la gente di Catania sta in angoscia fin
quando Pippo non fa di nuovo capolino alla stazione, alla plaja o in
via delle Finanze.
Passano gli anni, il signor Pernacchia invecchia e si trasforma in una
specie di clochard con barba grigia, braccia mulinanti e consueto sguardo
di lince. Cappello da cowboy, aspetto trasandato, giubba scura con
patacche lucenti: non più super-eroe ma fenomeno da baraccone.
Ora
l’andatura è caracollante come quella delle galline, indossa una stella da
sceriffo sul petto e va in giro vestito più modestamente. In città
l’atmosfera si fa nuvolosa, da tempo il volto fiero e ironico della Milano
del sud non c’è più.
Giuseppe Condorelli ha l’animo d’un bambino e i catanesi lo amano ancora; se
qualcuno, però, gli grida «Talia cu c’è Pippo ‘Sala Roma’», perde le
staffe e risponde con parolacce. Nessuno ha mai capito il perché.
«Mille
lire una pernacchia, -ripete per le strade- duemila lire due
pernacchie». Le sue vittime sono sempre i palloni gonfiati e -oggi come
ieri- più importante è il bersaglio, più alta la tariffa.
«Se
non sei nell'attenzione delle pernacchie di Pippo, -è
vox populi negli anni ottanta- non sei nessuno».
Epperò i suoi motteggi hanno ancora un suono struggente, quasi celestiale
che si ode a cento metri di distanza.
«A
chi si congratulava con lui
–insiste Aldo Motta- per le tante onorificenze ricevute, rispondeva con
modestia, mentre i suoi occhi birbanti lampeggiavano di contentezza: ’Sugnu
sulamenti cavaleri’». «Quel giorno –riprende Domenico Trischitta-
era felice, era il 27 settembre, e ogni 27 andava a riscuotere lo
stipendio dal suo datore di lavoro, il capo redattore de La Sicilia Piero
Corigliano, che gli elargiva generosamente una somma per la sua singolare
professionalità di artista dello sberleffo sonoro. Ma mentre gli dava il
denaro, il giornalista si accorse che il fazzoletto di Pippo era sporco di
sangue, gli chiese come mai e lui disse di essere raffreddato. Erano i primi
sintomi di un tumore alla gola che lentamente gli avrebbe spento lo
strumento e la vita».
«Quando Pippo morì,
-congiunge il cerchio Santo Privitera- nella sua bara ci entrò così: con
i suoi ‘allori’ conquistati grazie alle ‘colonne sonore’ intonate con
maestria ai più meritevoli».
È il
quindicesimo giorno del mese di marzo dell’anno domini
millenovecentonovantatre.
«Ma
vu ricordati a Pippo –canta Vincenzo Spampinato- ca calava a
via Etnea ca so stidda da sceriffu, sutta o suli o si chiuveva. Era bonu
era cuntentu ca so funcia e li mustazzi, chi pirnacchi a lu guvernu ca
trimavunu i palazzi. Pippu su lu purtau lu ventu cu nu sgrusciu di
carrozza, u distinu nfamu e tinti ci manciau li cannarozza»
Alessandro Russo - La Sicilia, 1 ottobre 2016 (il disegno è di Enzo
Salanitro)

_______________________
Qualche consiglio su dove ripararsi dall'alta
temperatura, onde evitare svenimenti per strada e concludere la serata la
pronto soccorso.
Un piccolo segreto di Via Etnea. Non so se vi siete
mai chiesti perché, nel tratto che va dal fotografo Marino fino a Palazzo
Cantarella, un gruppetto di uomini sosta sempre proprio sul marciapiedi
antistante l’ingresso del Palazzo delle Poste.
Nei caldi pomeriggi estivi sono sempre lì, ogni
giorno, a sollevare al cielo i loro antichi racconti pregni di avventure a
Taormina, delle serate al Lido dei Ciclopi negli anni Sessanta, delle loro
carriere, di conquiste mai avvenute ma raccontate nei minimi dettagli, ma
soprattutto di minchiate, tante minchiate che si sollevano al cielo come
palloncini alla festa di Sant’Agata e che li fanno sentire ancora giovani
quando arriva il momento di prendere il bus (se arriva) per tornare a casa.
Perché le sollevano proprio lì? Perché mi hanno
raccontato che proprio in quei dieci metri di Via Etnea circola una corrente
d’aria proveniente da Via Litrico, complice l’androne del Palazzo delle
Poste, che genera un gradevole venticello che si incanala in quel tratto di
strada come se fosse aria condizionata, capace di asciugare in un attimo
qualsiasi indumento offeso dall’afa catanese.
Ecco (come da foto) perché stanno sempre lì, quasi a
darsi spallate per ricevere ogni alito di brezza proveniente dalla Villa
Bellini.
(M.R.)


Palazzo Carnazza Cocuzza




|
.jpg) |
 |
|
 |
| Via
Etnea negli anni Sessanta
.jpg)
|
| |
IL RINAZZO.
-Quando la più importante strada della
città non si snodava lunga e diritta come ora,ma dopo breve e ondulato corso
andava a morire sui muraglioni della Porta di Aci,quel tratto di periferia
che ne restava fuori, altro non era che aperta campagna. Una campagna
formata da terreni privi di rocce laviche alla superficie, permeabili e in
prevalenza sabbiosi,dove la vegetazione s'infoltiva facilmente e dove, fino
alla metà dell'Ottocento, prosperarono i cosiddetti ORTI DEL SALVATORE.
Forse per la natura stessa di quei
terreni, il quartiere che via via andò formandosi a oriente del giardino
biscariano, fra il Vico delle Fosse e l'ex Villa Maiorana (attuali via Sant'Euplio-palazzo
delle Poste),la via Stesicorea, il vico Santa Caterina e la Grotta Bianca,
si chiamò RINAZZO.
<<......Chi non lo conosce ancora, vada a
vederlo nel suo interno, questo quartiere del Rinazzo;troverà un'intrigata
tela di luride catapecchie, aggruppate senz'ordine e senza regola,
attorniate da strette viuzze, ove regna l'umidità permanente, perché non vi
penetra aria nè luce;ed è addirittura una succursale della vecchia CIVITA
trapiantata al RINAZZO >>(M.Scammacca Asmundo-Appello al pubblico catanese
sull'apertura d'una nuova strada dirimpetto la Villa Bellini- Catania, 1876)
Insomma un quartiere malandato nel cuore
della città, un quartiere per il quale i tempi buoni sembrava non dovessero
mai arrivare.
Invece, un bel giorno arrivarono;e
arrivarono quasi contemporaneamente all'unità della Patria.

Fra il 1858 e il 1890 (il tempo non si
misura ad anni,in fatto di opere pubbliche) maturarono eventi determinanti
per la rinascita del Rinazzo.
Il primo di questi fu la trasformazione
del LABERINTO biscariano in villa pubblica, cui fecero seguito la
sistemazione della via Etnea fino al Borgo,l'illuminazione a gas,l'apertura
della via Santa Caterina, la costruzione di alcuni grandiosi palazzi di
fronte e di fianco al giardino Bellini, il conseguente spostamento del
centro cittadino più a nord rispetto alla Marina e a piazza Duomo.
Per incidenza e vistosità, il fatto che
merita di essere particolarmente ricordato è quello che ruota attorno
all'apertura di via Santa Caterina (attuale via Umberto),ricco di spunti
polemici e d'interventi politici,di proposte e di contropoposte;ricco,soprattutto,
d'episodi nei quali l'interesse privato ebbe parte preminente, spesso a
scapito di quello pubblico, e perciò stesso della Città.
Devesi premettere che i lavori di
livellamento della via Etnea fino all'ingresso principale della Villa,
iniziati in quello stesso scorcio di tempo, erano stati di non facile
attuazione, specialmente nel raccordo delle varie pendenze;e, come al
solito, avevano suscitato discussioni, critiche, interventi a livello di
tecnici, di amministratori comunali, di privati.Si arrivò persino alle
offese scritte,quando - per citare un esempio - l'ing. Ignazio Landolina,
in un suo opuscolo stampato nel 1870 per i tipi della Gazzetta di Catania,
diede del somaro all'ingegnere Eligio Sciuto,capo dell'ufficio tecnico
comunale, colpevole, secondo lui,d'avere sbagliato tutto in quei lavori, i
cui risultati furono <<così infelicissimi e mostruosi,da dare la esatta
sensazione anche ad un cieco che per salire all'Etna la strada cominciasse a
discendere......>>.

Al progetto d'apertura d'una strada
dirimpetto l'ingresso centrale della Villa Bellini si perveniva dunque con
gli animi ancora accesi e con le discordie fra i vari gruppi politici,
dentro e fuori l'aula consiliare, più vive e insanabili che mai.
L' esito del risanamento del RINAZZO
dipendeva in gran parte dalla realizzazione di questa strada, che si
presentava complessa e delicata per gli oneri finanziari, i risvolti
politici, le interferenze private che ne derivavano.
Per restare nei limiti di tempo e di
spazio - la questione comporterebbe più lungo esame - diremo in succinto
che le soluzioni presentate in Consiglio Comunale furono tre:
1) apertura d'una grande strada di 34
metri di larghezza in asse con l'ingresso della Villa;
2) apertura d'una strada, sempre
dirimpetto all'ingresso della Villa, con larghezza costante di metri 14,e
soppressione di gran parte della tortuosa via Santa Caterina;
3) allargamento della detta via Santa
Caterina.

Il Rinazzo
Nel 1875 una commissione di esperti, dopo
lungo e accurato studio, propose al Consiglio la soluzione numero due.
Ma,andando le cose alle lunghe,un anno e
mezzo dopo, il consigliere comunale Michele Scammacca, che della prima
soluzione era tenace assertore, dà alle stampe un opuscolo col quale mette
in chiaro i retroscena, gli errori, i difetti della spinosa questione.
Rivolgendosi ai catanesi, il nobile
Scammacca pone sotto accusa i colleghi del Consiglio, il Sindaco, gli
Assessori, i quali non avvertono l'incidenza di un'ordinata espansione
urbanistica, mentre << I nostri padri,prevedendo uno sviluppo non
facilmente rilevabile a quei tempi, prepararono l'avvenire grandioso ed
estetico della città, con le bellissime strade della Stesicoro-Etnea, della
Garibaldi, del Corso, dei Quattro Cantoni, della Vittoria.
Noi,"civilizzati posteri", abbiamo
permesso, invece, il sorgere di quartieri come quelli del Carmine e di San
Berillo, la fabbrica di case antigieniche e malsane, la costruzione di
strade anguste e tortuose.....>>

Si scaglia, poi,contro i sostenitori
degli interessi privati e contro i proprietari delle aree entro cui cadono
opere di pubblica utilità, i quali << salvo poche,laudabili eccezioni, hanno
scarso gusto estetico, ed anziché sollecitare, o spingere la civica
amministrazione ad eseguire certe opere pubbliche, la osteggiano o
profittano della sua scarsa energia per ottenere assegni di linea favorevoli
soltanto ai loro ciechi interessi......>>.Conclude auspicando che <<dal
fronte della Villa Bellini, nella direzione dell'est, s'apra una grande
arteria larga non meno di 34 metri, che dia respiro alla città, accresca
l'importanza della Villa, risollevi le sorti di un quartiere
desolato......>>
Cinque anni dopo la nobile sortita dello
Scammacca, precisamente il 21 dicembre 1881,nel palazzo di città si riunisce
la commissione consiliare per discutere <<sui tre differenti progetti
elaborati dall'ufficio tecnico per l'apertura d'una strada nel lato
orientale del RINAZZO, di fronte al giardino Bellini >>.
Dopo ampia discussione, durata non
sappiamo quanto,prende piede e si afferma il Voto ragionato del consigliere
Carmelo Sciuto Patti,membro della detta commissione.
Signori - dice pressappoco lo Sciuto
Patti - perché lambiccarsi il cervello?Perché perdere tempo prezioso?Uno
solo è il progetto da prendere in considerazione, quello che prevede
l'allargamento della via Santa Caterina. Aprire una grande arteria?A qual
pro?E perché?

VIDEO DELLA
PASTICCERIA SAVIA
<<.....Quale sarebbe lo scopo di questa
larghissima strada?A mio avviso, nessuno. Se si eccettui l'idea di aversi
una larga via di riscontro all'ingresso del giardino Bellini, nessun'altra
circostanza di utilità pubblica, sia d'igiene, sia d'estetica od altro,
potrà mai giustificarla. L' igiene vi guadagnerà tanto con una strada larga
trenta metri quanto con l'altra larga dieci......>>.
L' appassionato consigliere chiama quindi
a sostegno del suo assunto le spese cui si andrebbe incontro, le difficoltà
tecniche, le inutilità di una strada che si apra in asse con l'ingresso
della Villa;la stoltezza di certi lussi,lo sperpero del pubblico danaro, se
mai si dovesse optare per altra soluzione.
Con l'allargamento della via Santa
Caterina, invece, tutto diverrà più semplice e più facile;non si
affronteranno che spese irrilevanti e sacrifici lievi,non si avrà alcuna
espropriazione di proprietà privata.
Il dibattito fu acceso, vivaci le
polemiche.
L' anno successivo, per i tipi di Eugenio
Coco,e forse ad iniziativa del giornale IL PLEBISCITO, veniva stampato altro
opuscolo nel quale, rimescolandosi ancora la minestra della costruenda
strada, si passavano in rassegna le interminabili tappe e le varie prese di
posizione di tecnici e di politici.

<<......Noi non sappiamo se il Voto
ragionato del prof. Sciuto Patti....sia stato ispirato dalla Curia
Arcivescovile, nè se egli sia membro della Società Pia o Circolo di
Sant'Agata o Circolo di Sant'Euplio o altro sodalizio, sappiamo però che
l'egregio professore non doveva subordinare i suoi doveri di consigliere
comunale alle esigenze della Curia che non doveva essere tirata in ballo,
sebbene ne conosciamo la prevalenza nelle elezioni politiche ed
amministrative.....>>.
Dopo lunga dissertazione, l'opuscolo
conclude con l'auspicio che la bella e grande via dirimpetto l'ingresso del
giardino Bellini sia al più presto realizzata, com'è nei voti d'ogni persona
amante della propria città.
Sul finire del 1883,finalmente la
decisione. Il Consiglio, disattesa ogni altra decisione, approvò il progetto
per l'allargamento di via Santa Caterina fino alle Grotte Bianche (la strada
successivamente e in periodi diversi,venne prolungata fino a piazza
Iolanda).
Per la gioia dei pochi,la montagna aveva
partorito il classico topolino, e la grande arteria di 34 metri vagheggiata
dai molti, in asse con l'ingresso centrale della Villa Bellini, venne così
trasformandosi in un budello, di fianco alla Villa stessa.
Ad alleggerire il peso di tanto
affronto,s'incaricò Carlo Sada,realizzando per il RINAZZO una delle sue più
rappresentative opere, il palazzo Pancari.
(di Lucio Sciacca, da "Catania
com'era",edizione Ì Faraglioni, 1974)

Palazzo Delle Poste (Francesco Fichera
1881-1950)
Un corpo decorativo coinvolge all'esterno
l'edificio con motivi déco, classici e neobarocchi, visibili nel
cornicione, nei capitelli, nei bottoni posti sotto di esso,
nella trama dei cancelli, negli ordini architettonici, nei
barocchi mascheroni che fuoriescono dalle chiavi di volta degli
archi, ma soprattutto nel pesante bugnato rustico che corre
lungo la parte basamentale della facciata. All'interno, una
grande fascia periferica, destinata agli utenti, circonda un
cortile centrale su cui affacciano gli uffici e gli sportelli.
Sebbene l'opera di Fichera possa sembrare stilisticamente non
interessante, in realtà le sue architetture, mascherate secondo
il gusto eclettico alla moda, frutto di approfonditi studi,
esprimono il rigore formale nella concezione degli spazi, la
necessità della gerarchizzazione degli ambienti e della
distinzione delle parti della facciata, nonchè un repertorio
vasto di tipologie e di elementi architettonici a cui dare un
nuovo stile, oppure... tutti gli stili.



|

Il Teatro Metropolitan di
Catania è stato inaugurato nel 1954, gli architetti furono gli
stessi del Sistina di Roma del quale ricorda molto la struttura,
con i maggiori spazi disponibili. Si trova al centro della
città.
Dopo una programmazione mista
di Cinema e Teatro da 10 anni ormai la sua attività è
esclusivamente teatrale, ospita una rassegna che è ormai
arrivata alla trentatreesima edizione e varie altre rassegne,
concerti e spettacoli vari organizzati dalla stessa gestione o
da altri.
Attualmente gli abbonati
della rassegna principale sono circa 9.000, mentre le presenze
complessive durante l'anno si aggirano sulle 200.000
Per maggiori informazioni:
Tel.: 095 322323 - Fax 095 316596 E-mail: info@metropolitan.catania.it

SUGLI AUTOBUS CITTADINI
A Catania c’è un modo molto
divertente per passare il tempo libero. No, non parlo di noiosi
Happy Hour (più noiosi dell’aggiornamento di Adobe), di cineforum
degni del Prof. Caligaris o di giri in bicicletta in una città che,
per sua conformazione “piroclastica”, non è per niente adatta al
ciclismo. Si tratta dell’AMT: Azienda Municipale Trasporti, con sede
in Catania. Con tutti gli sforzi che si fanno per eguagliare i
colleghi europei, forse non dovrei scrivere questo. Ma qui siamo a
Catania, siamo speciali. E il percorso, specie quello popolare, è
uno sballo!
Quelli dell’AMT sono da anni in
crisi cosmica, non sanno più che pesci pigliare e forse la
penserebbero diversamente se sapessero che le loro vetture sono
invece popolate da veraci attori che trasformano i loro sedili in
tribune e i corridoi del mezzo in palcoscenico. Mancherebbe solo
Musco a far da controllore ai clandestini e saremmo completi!
Pensandola in maniera più
ingegnosa, il servizio potrebbe diventare fruttuoso. Che voglio
dire? Che per passare un sano pomeriggio di autentica “cultura
catanese” basta acquistare un biglietto di un’ora e mezza ad appena
1 euro (che vuoi di più, con un euro?), salire su certe, tipiche,
linee che già al solo nome dei loro capolinea ti fanno intuire il
favoloso tragitto – per niente bello, visto che attraversa triste,
malfamata e abusiva periferia - e chi potrebbe salirci sopra per
allietarlo e renderlo …. diciamo, più colorito!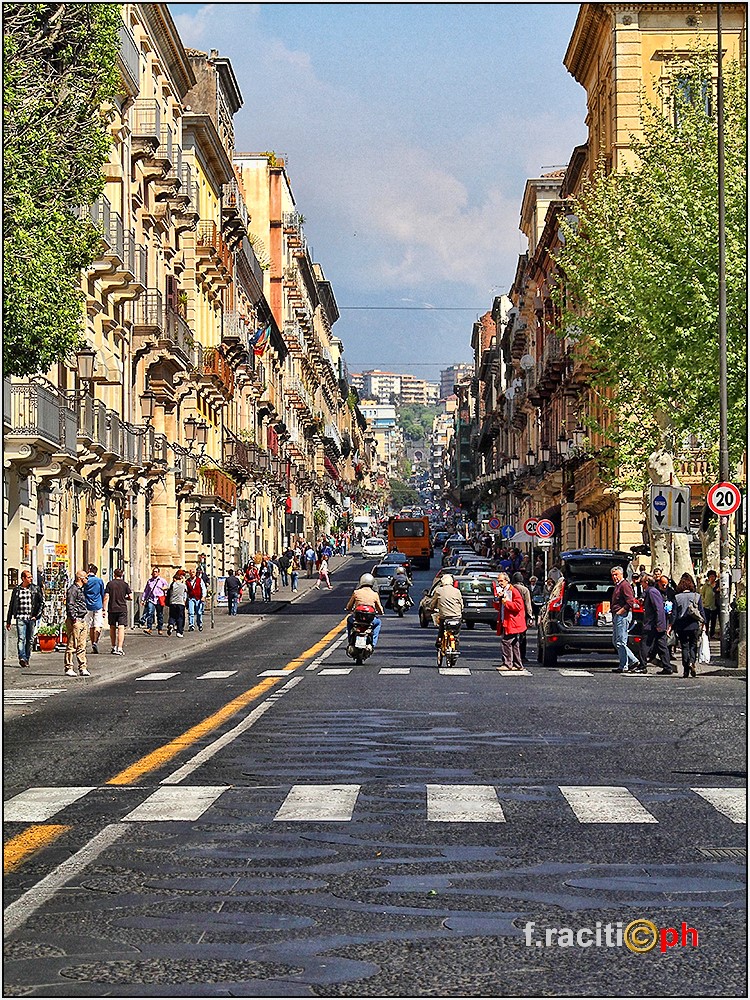
Provateci, obliterate il ticket e
mettetevi comodi su una sedia, se la trovate. Non fate caso ai loro
ritardi mostruosi, da scriverci pure un romanzo durante le attese, o
alle cose che non funzionano all’interno, oppure ai monitor che
vedete davanti ai vostro occhi e che vi dicono “next stop: “….
puntini puntini. Volete il sollazzo a un euro? E allora allungate le
antenne delle vostre orecchie e ascoltateli bene: sono i pensionati
che tornano dalla Pescheria e che si lamentano dei prezzi alti e del
Governo ladro; grandi saggi che si trasformano in grandi oratori
sfoggiando arringhe interminabili contro Berlusconi, Monti, Bersani
(dai, anche Lo Monaco!); e poi personaggi incredibili che raccontano
a qualunque sconosciuto, senza nessuna vergogna, le loro disgrazie
quotidiane; vecchie pazze (più di quelle di Trastevere) che non
hanno più niente da chiedere alla dignità, niente da perdere negli
ultimi chilometri della loro vita e quindi tanto da offrire in
termini di lecite volgarità agli astanti; madri quindicenni già con
due bimbi alle ginocchia, che sembrano suoi fratelli, intente a
guardare l’ultimo messaggio FB o a rispondere all’ultima
prenotazione del loro ambitissimo lavoro: ricostruttrice di unghie!
I più riservati sono sempre gli
extracomunitari, sempre zitti in dignitoso contegno. Ma gli indigeni
sono slavine di fatti personali, valanghe di storielle e fatti
privati da regalare a chiunque ne sappia o voglia coglierne il
valore!
Ma questo è niente. Basta
allungare un po’ di più l’antenna per captare ancora di più: il menù
dell’indomani, le scenate di gelosie, gli scontri con la suocera, le
vendette col vicino sulle scale, le corna e i tradimenti, le
cambiali andate in protesto, le promesse del candidato a Consigliere
di quartiere (vedi che autorità!), i candidati a Sindaco di Catania
ca su “unu cchiu latru di n’autru!”
Una ragazzina tredicenne in
rigoroso abbigliamento alla Tatangelo racconta alla sorella del suo
fidanzatino di un "pretendente" multimediale: “n’somma, mi visti
accussi bedda e scrissi “mi piaci la voglio, la voglio conoscere”.
Sempre rivolta alla ipotetica cognata: “U sai comu finiu? Ca sti rui
s’ammazzanu e iu eru a bambula, ndo menzu!”. La cognata: C'è capaci
ca ti voli?
Autentico teatro. L'autobus
(specie quello catanese) è un palco. Osservando i suoi passeggeri
riesci a immaginare le loro esistenze, dagli sguardi fantastichi le
loro giornate allegre o dolorose che siano, addirittura riesci a
captare il motivo per cui stanno rientrando a casa e .... cosa ci
porteranno, o ci troveranno.
A volte guardo le loro buste
della spesa e dal contenuto immagino già tanto, tantissimo.
Se poi cominciano a parlare (in
questo caso) comincia il primo atto come in una commedia di
Martoglio e alla fine occorrono pure gli applausi. E se li meritano!
Man mano che mi avvicino ai
Capolinea, gli attori scendono dal bus, mentre vanno incontro alle
loro vite disgraziate. Ma forse disgraziate le vediamo solo noi,
fragili pessimisti del nuovo millennio, perché …. forse i nostri
eroi sono felici lo stesso così, perché forse non capiamo come siano
indistruttibili ed immuni alle più catastrofiche crisi economiche,
insensibili alle più menegrame previsioni. Perché forse non
immaginiamo che vivono alla giornata e il loro obiettivo pro-capite
giornaliero è costituito da un etto. Di pasta, di qualsiasi taglio.
Forse (anzi, è certo) di tutto il
resto non gliene frega nulla. Domani si vedrà, e dopodomani pure.
All’arrivo rimango solo io, col
divertito autista, e rifaccio il percorso all’incontrario. Per
arricchirmi ancora di più.
I requisiti del divertimento?
Conoscere il dialetto e tanta, tanta, tanta curiosità di conoscere
la vera Catania.
M.R.
|

angolo Via Andronico
La necropoli sotto la
Rinascente
di Livio Mario Cortese
CATANIA - C'è un mondo nascosto sotto la
città. Un mondo che trasuda storia, coperto da altra storia. Catania
nasconde un cuore archeologico spesso sconosciuto ma che vale la pena di
scoprire, addentrandosi sotto la superficie dove si trovano le testimonianze
delle vite precedenti di una città rinata più volte su se stessa, che si
intrecciano con la città moderna.
La Rinascente, via Etnea, pieno giorno.
Si scende di qualche piano e, superato lo scarico merci, una porta introduce
in un ambiente spoglio e piuttosto freddo, di cemento grezzo. Qui inizia uno
spezzone della vastissima necropoli romana di Catania: è venuto alla luce
oltre mezzo secolo fa, durante la costruzione dell’edificio. Le sepolture,
vuote, si intervallano a tubature e pilastri delle fondamenta; in mezzo si
apre un pozzo artesiano. Sulle pareti dei loculi, dove ancora resiste
l’intonaco, si possono osservare tracce di colore giallo e rosso. Colpisce
il contrasto tra queste pietre e il cemento. “Il ritrovamento risale agli
anni ‘50”, ci racconta il dott. Andrea Patanè, della Soprintendenza ai Beni
Culturali. “Fu demolito il palazzo Spitaleri-Trigona, danneggiato dai
bombardamenti, e sostituito dallo stabile attuale: questo necessitava di
piani molto interrati, anche per i pilastri delle fondamenta. Le tombe
furono scoperte in quell’occasione, ma già nel 1928 se n’erano rinvenute
altre durante la costruzione del palazzo delle Poste”.
Il centro di Catania sorge quindi su un
antico cimitero romano. Negli anni ’60, in epoca di speculazione edilizia,
non erano rari episodi simili. “Sotto la zona di via Dottor Consoli e via
Androne, scavando altre fondamenta, fu dissotterrata un’altra grossa area
sepolcrale, dove spiccava una piccola basilica. Il mosaico pavimentale è
stato restaurato ed esposto al Castello Ursino, finché la ristrutturazione
degli anni ’90 non ci ha costretti a smontarlo per conservarlo in un
deposito, dove si trova tutt’ora”. Il rinvenimento del mosaico riveste una
certa importanza storica. “Risale al V secolo d.C., al periodo
dell’invasione dei Visigoti; denota tuttavia una forte disponibilità
economica per l’ingaggio di artigiani qualificati, in un’epoca pur critica”.
Altri siti notevoli, l’ipogeo romano di
via Ipogeo e quello entro il perimetro di villa Modica: l’uno visitabile,
l’altro chiuso al pubblico. Diversi fattori, ci viene spiegato, non ne hanno
favorito la visibilità. “Negli anni del boom edilizio”, prosegue Patane’,
“la coscienza collettiva su questi fatti era scarsa. Del resto la prima
legge sulla tutela dei beni archeologici risale al 1939. Tuttavia, proprio
nella necropoli della Rinascente il professor Rizza procedette a operazioni
di restauro. I ritrovamenti in viale Regina Margherita sono avvenuti sui
terreni già di proprietà dei domenicani, espropriati dallo Stato unitario e
poi acquistati dalle famiglie borghesi per costruirvi le famose ville
liberty. Oggi, i beni sarebbero tutelati in modo ben più rigoroso, anche se
nel caso di villa Modica i proprietari hanno sempre avuto la massima
disponibilità verso la Soprintendenza in caso di sopralluoghi”.
Nell'insieme, la necropoli catanese si
estende su tutta la zona a nord dell’anfiteatro e fuori dalle antiche mura,
tra Palazzo Tezzano (dove altre sepolture romane sono emerse una ventina
d’anni fa) e piazza S.Maria di Gesù. Alcuni luoghi, come quello sotto le
Poste, non sono oggi fruibili; altri stanno conoscendo diversi processi di
valorizzazione. “Un’idea potrebbe essere quella di proseguire, su questi
siti, la collaborazione con l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali
del CNR. Grazie a loro è stato già allestito un modello 3D dell’anfiteatro.
Anche le ricostruzioni interattive possono essere utili a mostrare punti non
altrimenti visitabili dal pubblico, come alcune parti dell’anfiteatro
impiegate come fognatura fino ad epoche recenti”.
Nell’immediato, la mostra “Catania
all’epoca di Agata”, presso il Museo Diocesano, ospiterà alcuni pannelli
esplicativi nei quali si parlerà anche delle sepolture sotto la Rinascente.
Pannelli analoghi saranno posti nel grande magazzino in via Etnea, vista la
volontà della società di rendere partecipi i clienti. Sul piano divulgativo,
proseguiranno i piani didattici presentati alle scuole dalla Soprintendenza,
comprendenti lezioni frontali e visite guidate nelle aree archeologiche di
Catania e provincia.
31 Gennaio 2017
http://catania.livesicilia.it/2016/01/31/la-necropoli-romana-e-la-citta-da-valorizzare-viaggio-nella-catania-sepolta-sotto-i-palazzi_366640/
 |
 |
| Palazzo Majorana |
Palazzo Papa |

|
CHIESA E RECLUSORIO DEL LUME
Ciò che rimane della struttura di beneficenza
oggi è solo la via Reclusorio del Lume traversa di piazza San
Domenico. Sorgeva al posto di questo palazzo un istituto che
ospitava le fanciulle disagiate in gran parte orfane che venivano
istruite ed educate .Il reclusorio era stato fondato nel 1812 da un
gruppo di sacerdoti e finanziato dal duca di Carcaci .L'istituito
ospitava oltre 200 fanciulle .
Costruito dai F.lli Costanzo nel 1967/68, dal
1969 il pianterreno e parte del primo pinao divennero la sede della
nuovissima facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania.
Annessa al Reclusorio una chiesa:
-Non ha prospetto perché è nell'interno del
Reclusorio, però nel portone della via Androne che guarda a levante
si osserva la seguente iscrizione :Reclusorio di M.SS.Del Lume .Su
di questa sono le sigle di Maria sormontate da una corona di pietra
calcare e da una croce più su.Innanzi agli stipiti del portone sono
sculti da un lato due uccellini sotto una stella e dall'altro
un'ancora e la iniziale M.
Passato il portone segue una scala di marmo,
indi un uscio a destra che introduce nella sagrestia ove vedesi una
lapide con la seguente iscrizione latina :
(Il sacerdote Martino Ursino consacrò questa
cappella più decente dell'anteriore, sé stesso, e questa famiglia
alla Madre SS. Del Lume il 10 agosto del 1824 ,anno 22* dalla
fondazione dell'asceterio ).
Dalla sagrestia si passa nella sacra
edicoletta di forma esagona ,la quale serve esclusivamente per le
sole donzelle orfane ammesse nel Conservatorio.
Qui ammiransi un altarino sul quale è posta
una grande tela rappresentante M.SS.Del Lume, due confessionari, un
organo posticcio ed alcuni piccoli quadri .
A qualche metro dal pavimento si osserva tre
grandi gelosie ,ed altre ancora ve ne sono più in su.Sulla volta,
dalla quale pende un lampadario, vedesi il monogramma di Maria.
Nel dopoguerra (credo primi anni 60)il
Reclusorio, non essendo più in uso da anni,fu abbattuto per la
realizzazione di questa struttura
Nelle foto collage le prime due immagini sono
riferibili alla posizione in cui sorgeva il Reclusorio del Lume,
mentre nella foto sotto è ben visibile a destra l'edificio non più
esistente
La tela di Maria Santissima del Lume è
attualmente conservata nell'omonimo edificio del Corso Indipendenza
 |

|
I
giardini pubblici
dedicati al Cigno di Catania
L'ingresso
monumentale del giardino Bellini da via Etnea.Il giardino Bellini è il
più antico dei quattro giardini principali di Catania. Dai catanesi è
chiamato a villa e rappresenta la villa per antonomasia.
Il
giardino risale al Settecento ed apparteneva al principe Ignazio
Paternò Castello, che lo aveva voluto secondo le tipologie di allora
con labirinti di siepi, statue e fontane a zampillo di foggia tale da
creare giochi d'acqua. Venne acquistato dal comune di Catania nel 1854
dagli eredi del principe e venne dato incarico all'architetto catanese
Landolina di renderlo atto al nuovo tipo di uso. Per far questo vennero
acquistati degli orti privati adiacenti che incorporati ne ampliarono la
superficie. Il Viale degli Uomini Illustri ad ovest venne inaugurato nel
1880 con i busti posti su colonne dei personaggi più famosi della
storia italiana e catanese, ma già nel 1875 all'inizio del viale era
stata posta la statua in bronzo di Giuseppe Mazzini.

I lavori vennero
conclusi nel 1883. Il giardino divenne l'abituale meta delle famiglie
catanesi che vi portavano i bambini a giocare mentre passeggiavano
conversando con gli amici. L'ingresso monumentale di Via Etnea venne
realizzato ed aperto nel 1932 e l'anno dopo, alla sommità dello
scalone, nel piazzale soprastante il tunnel di via Sant'Euplio vennero
collocate le statue monumentali che rappresentano le arti opera dello
scultore Domenico Maria Lazzaro. Alla fine degli anni cinquanta venne
riordinata la zona del tunnel di Via Sant'Euplio e quelle adiacenti. In
quegli anni venne curato ampiamente l'aspetto floreale ed esperti
giardinieri creavano veri e propri disegni ed iscrizioni nelle aiuole
delle collinette gemelle. Poco tempo dopo venne incrementato il numero
di voliere e di volatili esotici, quindi acquisiti ed allevati anche
volatili acquatici come anatre e cigni, il cui habitat era stato
attrezzato nelle grandi vasche e fontane di cui il giardino era dotato.
Verso il 1960 il giardino divenne anche un piccolo zoo con volatili
stanziali in libertà ed animali, come varie specie di scimmie, ed
infine anche elefanti.

il
padiglione cinese è andato distrutto per un incendio.A partire dalla
metà degli anni settanta iniziò un progressivo ridimensionamento dei
fondi stanziati per la manutenzione e la decadenza non tardò a
manifestarsi. Le piogge rovinarono ampiamente le aiuole in pendenza
della parte sud del giardino e le piante mal curate inselvatichirono.
Quelle stagionali scomparvero addirittura. Non miglior sorte toccò agli
animali che lentamente si ridussero. L'elefante indiano donato alla
città dal circo Orfei, ultimo sopravvissuto del piccolo ma ricco zoo
del Bellini, morì alla metà degli anni ottanta. Il giardino Bellini di
oggi è classificabile piuttosto come semplice parco alberato;
nell'ultimo decennio è stato usato per manifestazioni culturali e
religiose, per concerti canori ma non è più la meta di famiglie e
bambini.

Dopo anni di incertezza e abbandono in cui un incendio di
origine non chiara ha distrutto totalmente il padiglione cinese posto
alla sommità della collinetta nord, assieme al suo contenuto in libri e
documenti, di recente si è ventilata la voce di una sua cessione a
privati nell'ambito delle nuove politiche economiche del comune. Oggi la
sua fruibilità è del tutto ridotta a causa di transenne e ponteggi che
permettono solamente il transito nel senso della lunghezza nel viale
alberato adiacente la via Sant'Euplio.
Uno
dei quattro gruppi scultorei di D. M. Lazzaro (lato nord-ovest).Già di
proprietà privata, ha la forma di un rettangolo piuttosto regolare e
venne aperto al pubblico nel gennaio del 1883. Situato nel centro
storico della città con l'ingresso principale sulla via Etnea, il
giardino Bellini si estende su di una superficie di circa 72.000 metri
quadri. L'ingresso da via Etnea avviene attraverso uno scalone,
fiancheggiato da aiuole fiorite, che conduce ad un piazzale con al
ce ntro una grande vasca nella quale nuotano degli eleganti cigni. Sulla
collinetta che fa da sfondo alla vasca, con un effetto scenografico
molto apprezzabile, è sistemato un grande orologio il cui quadrante è
costituito da piantine sempreverdi. Sopra di esso un calendario, che i
giardinieri modificano ogni giorno, indica mese giorno ed anno. ntro una grande vasca nella quale nuotano degli eleganti cigni. Sulla
collinetta che fa da sfondo alla vasca, con un effetto scenografico
molto apprezzabile, è sistemato un grande orologio il cui quadrante è
costituito da piantine sempreverdi. Sopra di esso un calendario, che i
giardinieri modificano ogni giorno, indica mese giorno ed anno.
La
vasca dei cigni, l'orologio floreale ed il calendario; in alto sullo
sfondo il padiglione della musica.La struttura del giardino nel suo
complesso è costituita al suo interno da due colline simmetriche e da
un grande viale che circonda, ad anello allungato, la collinetta nord.
Concentrico ad esso vi è un altro viale pedonale collegato mediante
vialetti contornati da siepi a labirinto alle varie piazzole ed aree
nelle quali insistono grotticelle con giochi d'acqua e luoghi appartati
con panchine. Alla sommità della collinetta sud è posto un chiosco in
ferro battuto che contiene un palco per la musica nel quale fino agli
anni sessanta venivano tenuti dei concerti di musica classica. Alla
sommità dell'altra vi era un caratteristico chiosco in legno di forma
circolare orientaleggiante in cui era ubicata una biblioteca. Il chiosco
era un dono dell'imperatore della Cina. Questo si incendiò alla fine
degli anni novanta e venne completamente distrutto. Lungo i viali
secondari sono poste delle statue, fontane, vasche, voliere e chioschi.
Sul lato ovest, parallelo alla via Salvatore Tomaselli, esiste il Viale
degli Uomini Illustri, italiani e catanesi, che è fiancheggiato da
busti, posti su colonne, rappresentanti le maggiori glorie della città.
Una caratteristica, oggi perduta, erano le numerose grotte in pietra
lavica al cui interno erano ricavate delle fontane con giochi d'acqua,
spesso con pesci rossi nella vasca.
La
flora è molto varia e presenta delle specie di provenienza subtropicale
che si sono acclimatate molto bene. Esistono oltre cento specie diverse
nelle quali si distinguono le palme presenti in un numero di varietà
fuori dal comune. Molto presenti anche gli alberi di alto f usto come i
platani ed enormi ficus magnolia dell'età di centinaia di anni oltre a
numerose altre varietà di pini e di alberi sempreverdi. usto come i
platani ed enormi ficus magnolia dell'età di centinaia di anni oltre a
numerose altre varietà di pini e di alberi sempreverdi.
Vista
della vasca dei cigni guardando verso via Etnea dalla parte superiore
dell'orologio floreale.Intorno agli anni sessanta, per oltre un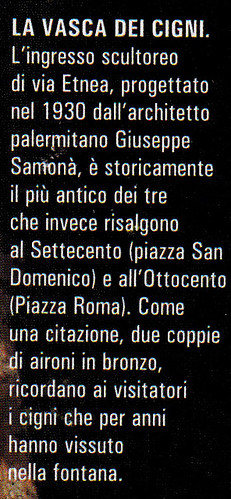 decennio, al suo interno venne inserito un vero e proprio zoo con
voliere ricche di molte varietà di uccelli, anatre, oche e cigni nelle
varie vasche del giardino e pavoni in libertà, rettili e serpenti in
apposite gabbie e varietà di scimmie ed altri piccoli animali, in un
apposito recinto, anche alcuni elefantini tra cui un elefante indiano
donato da un circo di passaggio, come simbolo della città di Catania.
Le difficoltà economiche e una certa dose di insensibilità tuttavia
depauperarono lentamente il prezioso patrimonio zoologico che piano
piano si ridusse a zero e ridussero quello botanico.
decennio, al suo interno venne inserito un vero e proprio zoo con
voliere ricche di molte varietà di uccelli, anatre, oche e cigni nelle
varie vasche del giardino e pavoni in libertà, rettili e serpenti in
apposite gabbie e varietà di scimmie ed altri piccoli animali, in un
apposito recinto, anche alcuni elefantini tra cui un elefante indiano
donato da un circo di passaggio, come simbolo della città di Catania.
Le difficoltà economiche e una certa dose di insensibilità tuttavia
depauperarono lentamente il prezioso patrimonio zoologico che piano
piano si ridusse a zero e ridussero quello botanico.
Recentemente
nel piazzale principale, posto fra le due collinette, nei mesi estivi
sono stati organizzati concerti e spettacoli di vario genere ai quali
potevano assistere anche 20.000 spettatori.
Nel
2006 è stato approntato un progetto di recupero funzionale[1] molto
contestato perché stravolgerebbe l'aspetto globale architettonico e
botanico del giardino Bellini[2].
Dopo
4 anni di chiusura al pubblico per lavori, il giardino Bellini è stato
riconsegnato alla città il 23 settembre 2010, anniversario della morte
di Vincenzo Bellini, con una pomposa cerimonia inaugurale che ha visto
un concerto della banda dei carabinieri nel chiosco della musica da
lungo tempo inattivo. Lo splendore dell'antico giardino è tuttavia
offuscato dalla mancanza delle decorazioni floreali che ne costituivano
l'attrazione e dall'assenza dei cigni di un tempo della grande vasca di
ingresso, sostituiti da una scultura che rappresenta un gruppo di gru di
cui molti hanno sottolineato la mancanza di alcuna attinenza col
passato.[3]
Viale
degli Uomini Illustri [modifica]
Il Viale degli Uomini Illustri, posto ad ovest del giardino, fu
inaugurato nel 1880 con i busti dei personaggi più famosi della storia
italiana e catanese posti su colonne; già nel 1875 all'inizio del viale
era stata posta la statua in bronzo di Giuseppe Mazzini. I lavori si
conclusero nel 1883. Nel corso degli ultimi decenni, a causa
dell'incuria e della scarsa vigilanza, i busti sono stati oggetto di
vandalismi ed asportazioni furtive. Dopo la riapertura del 23 settembre
2010 sono presenti:
Luigi
Capuana Francesco Paolo Frontini Mario Rapisardi Gaetano Emanuel Calì
Federico De Roberto Nino Martoglio Giovanni Verga Giovanni Grasso
Angelo Musco Francesco Pastura Stesicoro Il busto di Francesco Paolo
Frontini, opera di Mimì Maria Lazzaro del 1957, trafugato negli anni
ottanta.
|

|
Il
Giardino del tempo ritrovato
di
Carmela Grasso, foto di Antonio Parrinello - da In Viaggio allegato a La
Sicilia del 30.10.2010
Speriamo
proprio di non sbagliarci se, passeggiando in questo autunno al Giardino
Bellini - la "Villa" appena restituita ai catanesi e a tutti
quei forestieri che, da tre secoli, vi si rifugiano in cerca di quiete -
ci viene in mente quella frase "La città del tempo ritrovato"
il claim, lo slogan, di uno dei tanti centri commerciali sorti come
funghi nella provincia etnea. Spazi irreali, non-luoghi identici a
Bolzano come a Ragusa, sfavillanti paesi dei balocchi dove il tempo è
scandito dagli acquisti di tutti i generi, fatti o rimandati per ragioni
di portafoglio. Spazi dove non è concesso pensare, tale è
l'accanimento degli altoparlanti piazzati in ogni angolo.
Il tempo ritrovato, invece, crediamo sia qui e adesso, al Giardino
Bellini dove in una calda mattina d'autunno scopriamo che la Catania
sempre più frenetica e arrogante sa ancora cedere all'antico sortilegio
di Madre Natura. Varcati i cancelli della Villa, c'è ancora una città
che sa ascoltare il silenzio e il fruscio delle foglie all'ombra di
alberi altissimi, sa rallentare i suoi ritmi, sa guardare in alto o spingersi lontano, fermarsi a leggere
sotto i platani nella mega-panchina in ghisa che abbraccia il piazzale
centrale, o spingersi più in alto, su quella piccola acropoli che è il
piazzale del Chiosco della Musica. La sua seduta circolare è un
irresistibile invito a divenire protagonisti dello spazio. Intorno è il
bianco di gelsomini e boccioli di candide rose botaniche.
 Quanti amori e
promesse immaginiamo dentro questo cerchio magico. L'Etna, con il suo
filo di fumo, giganteggia immobile sempre a nord, mentre questo
monumento vegetale vivente, muto testimone delle stagioni, questo
"bene da vivere" che è il Giardino Bellini racconta nuove
storie: se i giovani siciliani la percorrono al ritmo della corsa -
isolati dal mondo nel limbo del proprio Ipod - almeno tre continenti si
danno appuntamento fra i suoi viali profumati di lavanda. Le lingue
straniere si intrecciano fra loro, mentre i più giovani - bianchi, neri
o gialli - hanno già assimilato la sicula cadenza. Un tempo, quello da
"ritrovare" alla Villa Bellini, che lo contiene tutto:
passato, presente e futuro. È memoria collettiva - di un'intera
comunità - e memoria individuale quella singola la singola, e a volte
intimissima, di ognuno di noi, legata com'è alle persone care della
nostra vita e agli istanti intensi trascorsi con loro fra il verde di
questi viali.
Quanti amori e
promesse immaginiamo dentro questo cerchio magico. L'Etna, con il suo
filo di fumo, giganteggia immobile sempre a nord, mentre questo
monumento vegetale vivente, muto testimone delle stagioni, questo
"bene da vivere" che è il Giardino Bellini racconta nuove
storie: se i giovani siciliani la percorrono al ritmo della corsa -
isolati dal mondo nel limbo del proprio Ipod - almeno tre continenti si
danno appuntamento fra i suoi viali profumati di lavanda. Le lingue
straniere si intrecciano fra loro, mentre i più giovani - bianchi, neri
o gialli - hanno già assimilato la sicula cadenza. Un tempo, quello da
"ritrovare" alla Villa Bellini, che lo contiene tutto:
passato, presente e futuro. È memoria collettiva - di un'intera
comunità - e memoria individuale quella singola la singola, e a volte
intimissima, di ognuno di noi, legata com'è alle persone care della
nostra vita e agli istanti intensi trascorsi con loro fra il verde di
questi viali.
Un tempo e una storia "ritrovate" anche per il Giardino
Bellini che, frutto dell'accorpamento in tre periodi diversi di tre
differenti parchi privati, ha portato l'autrice del progetto di
restauro, l'architetto romano Marina Galeazzi, a condurre
quell'indagine storica e scientifica su genesi e trasformazioni del
giardino mai redatta in quasi trecento anni di vita del parco. Una
ricerca tra biblioteche civiche, archivio di Stato e collezioni private,
con il supporto del Dau, il Dipartimento d'Architettura dell'Università
di Catania, recuperando documenti storici e inediti che hanno fatto da
viatico alla stesura di quello che è il primo restauro filologico dal
1854 a oggi. "Un'operazione complessa - spiega la Galeazzi - alla
costante ricerca di un ragionevole equilibrio tra la conservazione del
giardino, storicamente inteso, e il progetto di architettura quale
strumento privilegiato in grado di rivelare l'istanza contemporanea e,
al tempo stesso, l'essenza del luogo-giardino".
Un
restauro, tuttavia, che nonostante il plauso di uno fra i maggiori
paesaggisti italiani come Marco Dezzi Bardeschi e di uno storico come
Giuseppe Giarrizzo, si è scontrato con la memoria personale di un
attivo comitato di cittadini che, dopo lunghe trattative, è riuscito ad
apportare modifiche, nel segno della tradizione, all'originario progetto
della Galeazzi più dinamico e creativo tanto da essersi conquistato un
posto di rilievo nella graduatoria europea del bando. Per quanto ci è
dato ricordare, gli ultimi quarant'anni sono stati i più infelici per
la Villa: animali in gabbia e cigni trucidati da balordi, auto in
transito e in sosta, statue sfigurate, chiassose bancarelle per la Festa
dei morti, giostrino dalle musiche assordanti e infine, nel 2001,
l'incendio della palazzina cinese e della sua biblioteca, dove - si
spera presto - potrebbe nascere un'esclusiva caffetteria circondata dal
verde e in pieno cen-tro storico. Un po' di nostalgia la vivono di certo
quei vecchietti che, tra le panchine del grande piazzale centrale -
destinato a concerti ed eventi della città -rimpiangono quei
curatissimi decori vegetali dove figurava sempre "la musica" -
come ce l'ha definita in confidenza uno di loro - ovvero la chiave di
violino, il simbolo dell'arte di Vincenzo Bellini. Se è vero che
occorre aspettare la primavera perché il fianco della collina si
ricopra per bene - le essenze appena trapiantate sono ancora basse e non
in fioritura - è anche vero che di maestri giardinieri, come i dieci in
dotazione alla villa fino a qualche decennio fa, non ne esistono quasi
più.
Fra le novità introdotte dal restauro ecco scoperchiata la scala a
lumaca dell'antica casina del principe Biscari che finora è stata
celata alla vista ed era accessibile, a discrezione dei custodi, da un
portoncino al piano inferiore.
Rinvenuta
poi un'altra scala che conduceva alla stessa dimora e che adesso,
sottoposta a un accurato intervento di recupero, è percorribile da
tutti i visitatori e costituisce una emozionante "ascesa" al
grande piazzale. Sfoggiano un bel naso nuovo, infine, le statue dei 47
uomini illustri deturpate dai vandali. Le associazioni di volontariato e
le istituzioni si preparano a una inedita "gestione condivisa"
della Villa, mentre i bambini attendono la primavera per testare i nuovi
giochi loro promessi. Adesso che la città ha ritrovato la
"sua" Villa - e uno spazio dove recuperare la qualità della
vita - sarà il caso di cedere il passo a Madre Natura e lasciarle tutto
il tempo di esprimersi. Come ha già fatto con il secolare Ficus
Magnolioides, il grande patriarca vegetale dalle possenti radici aeree
eletto dai bambini delle ultime generazioni - quelle che non si fanno
più ritrarre immobili, con l'abitino della festa e le aiuole ornate
alle spalle - il "più fantastico gioco" della Villa.

|
a
Il
ristoro del Principe
In origine tu il giardino privato del
Principe di Biscari Ignazio Paternò
Castello, che nel 1719 edificò su una delle collinette anche una casina
di cui non si hanno più tracce eccetto la scala riportata alla luce nel
corso dei restauri oltre a un labirinto a cielo aperto con schiere di
cipressi che in altre epoche è stato confuso con il criptoportico
sotterraneo, la cui pianta - dopo l'intervento di restauro - è
identificabile oggi al piano della passeggiata da un percorso di
ciottoli bianchi. Quindi l'area ottocentesca definita dall'architetto
Filadelfo Fichera con il sistema dei tre viali sull'antico impianto
dell'orto benedettino del San Salvatore e evidenziata lungo la via
sant'Euplio dalle cancellate in ghisa il cui cromatismo rimanda allo
stile francese come il marchio di fabbrica delle straordinarie e
aggraziate statue muliebri che ai lati del chioschetto della musica
indicano le quattro stagioni. Ultimo ambito spazio-temporale quello del
Novecento, con il "giardino di pietra", all'ingresso da via
Etnea, progettato da Giuseppe Samonà, l'architetto e urbanista palermitano che nel 1930 vinse il
concorso per la sistemazione della Villa per la quale realizzò anche il
ponte sulla via Sant'Euplio.
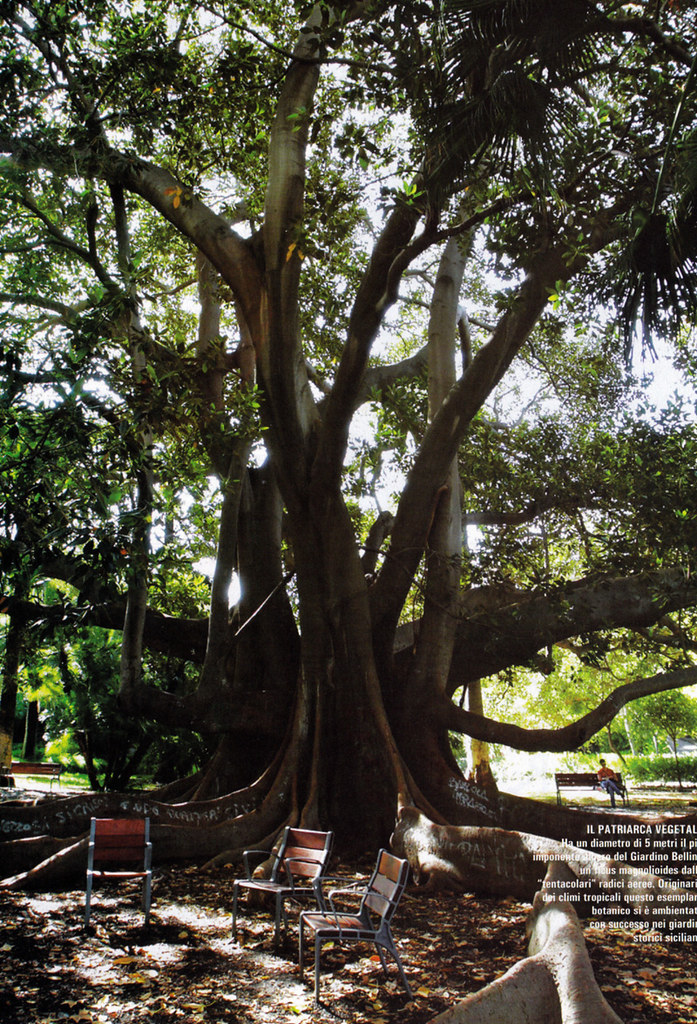
Se si esclude una perizia realizzata da
Sebastiano Ittar nel '700 l'ultimo atto ufficiale, colto e di rilievo
sul Giardino Bellini è quello di Guido Libertini dei 1931, in occasione
della Mostra del Giardino Italiano di Firenze. Una guida di Catania dei
1899 paragona infine la veduta dalle due colline, quelle dell'ex
palazzina cinese e del chiostro della musica, all'emozione che si prova
a Roma dalla spianata del Pincio o a Firenze da Piazzale Michelangelo.
"I viali di questo giardino - è scritte. - sono diversi e
tortuosi, fittamente ombreggiati e tracciati tanto sul pendio delle due
collinette come nei punti piani della villa. Diversi ponticelli,
costruiti con vera eleganza, i sottopassaggi, un tunnel, le aiuole
fiorite, i praticelli erbosi e ricchi di ogni specie di fiori, la
fontana, il piazzale che divide le due colline, tutto si fonde per
trasformare questo meraviglioso giardino in un luogo di delizie".
(c.g.)
|



COME
LA VEDE FRANCESCO RACITI

BREVE STORIA PER I 60 ANNI DI UN GRANDE OROLOGIO
di
GIOVANNI SAGUTO (dalla pagina Facebook di Franz Cannizzo)
https://www.facebook.com/franz.cannizzo
Era l’autunno del
1961, avevo appena compiuto 14 anni, mio fratello Alberto studiava a
Roma e, come ogni pomeriggio, non avendo altro da fare dopo i compiti e
dopo la tv dei ragazzi, mia madre mi spediva in negozio da papà con un
perentorio “vai ad aiutare tuo padre”.
Allora papà aveva
aperto da qualche anno un piccolo negozio di fronte la Villa Bellini e
solo da poco eravamo andati ad abitare a pochi passi, bastava
attraversare la via Etnea ed ero già arrivato.
Uno di questi
pomeriggi venne in negozio il sindaco di allora,
l’avv. Salvatore
Papale, con la sua signora. Dopo i convenevoli di rito, il sindaco cavò
da una tasca del cappotto una cartolina a colori con un magnifico
orologio floreale ritratto sulla sponda del lago di Ginevra. “Cavaliere,
disse il sindaco, desidero che provveda all’istallazione di un orologio
identico a questo sopra la vasca dei cigni al Giardino Bellini”.
Immagino che papà, a
queste parole, abbia avuto un sussulto non indifferente, ma,
conoscendolo, non si scompose minimamente e con grande sicurezza disse
che avrebbe provveduto nei tempi stabiliti e prima della Festa di S.
Agata.
Fino a quel momento
la nostra famiglia si era interessata alla produzione di orologi da
campanile e poi da salone, ma mai di orologi “floreali”.
Papà chiese subito
consiglio a suo fratello,il mitico zio Mimì, trasferitosi a Roma da
molti anni, ex professore di orologeria nonché orologiaio del Quirinale,
il quale lo indirizzò ad una fabbrica svizzera, la Favag di Neuchatel.

In brevissimo tempo
ricevette il preventivo che fu subito approvato dal Comune di Catania;
fatto l’ordine, finalmente, dopo un paio di mesi, arrivarono diverse
casse di legno con all’interno i vari componenti dell’impianto ed i
manuali del montaggio rigorosamente in francese.
Toccò a me
intervenire, visto che l’avevo studiato a scuola e poi avevo anche fatto
la Scuola Radio Elettra per corrispondenza, quindi due fili li sapevo
pure giuntare senza fare danni.
Ricordo con grande
affetto il direttore del Giardino Bellini, dott. Malerba, personaggio
sanguigno ed autoritario, che, con grande efficienza, attivò tutte le
maestranze disponibili per la collocazione del macchinario, i
collegamenti, e la realizzazione del quadrante con vari tipi di
piantine.
Questo orologio fu
collocato al posto del calendario il quale fu spostato un po’ più su
sulla collinetta e, per renderlo più visibile, fu accorciata la colonna
che regge il busto di Bellini.
Prima della messa a
dimora del macchinario bisognava fare le prove di funzionamento,
cosicché mio padre ed io, con l’aiuto del dott. Malerba e di alcuni
giardinieri, dopo la chiusura al pubblico della Villa, montammo tutto
l’impianto in un angolo del piazzale del palco della musica.
Non potrò mai
descrivere l’emozione che provai nel vedere partire quelle enormi
lancette per posizionarsi all’ora stabilita ed andare avanti, dopo la
collocazione definitiva nella sua dimora, secondo dopo secondo, fino ai
giorni nostri.

I festeggiamenti in
onore della Santa erano già cominciati, era il pomeriggio del 2 febbraio
del 1962, le enormi luminarie erano state collocate, bisognava accendere
il tutto ed inaugurare l’orologio floreale. Fu una cerimonia breve ed
intensa e qui i miei ricordi si confondono tra i discorsi di circostanza
del Sindaco Papale, dell’assessore ai Giardini Pubblici La Rosa ed i
flash dei fotografi quando si scopre che il quadrante era completamente
buio ed i piccoli faretti istallati per renderlo più visibile non erano
sufficienti.
Panico totale, ma
non c’era nulla da fare, io ero comunque strafelice per la riuscita del
mio lavoro e con me mio padre, ma lui, come era suo stile, non lo dava a
vedere".

LA MERIDIANA POLIEDRICA TRA GLI UOMINI
ILLUSTRI.jpg)
Percorrendo il Viale degli Uomini Illustri,
giunti nello slargo che sovrasta il Piazzale delle Carrozze, ci
imbattiamo in una colonna che sorregge uno strano poliedro. Si tratta di
un orologio solare invero particolare, perché ha la forma, insolita per
una meridiana, di un dodecaedro regolare, cioè di un poliedro con dodici
facce marmoree pentagonali.
Le due facce orizzontali non possiedono
indicazioni: quella inferiore perché di appoggio sulla colonna; quella
superiore perché non visibile da chi osserva l’orologio. Su ciascuna
delle restanti dieci, sono incisi gli alloggi per gli gnomoni (le
asticciole di opportuna lunghezza la cui ombra indica le ore sulle
meridiane) e i quadranti solari (le meridiane e le relative indicazioni
orarie). Gli gnomoni originali, andati perduti o trafugati, non sono
stati rimpiazzati; le meridiane e le ore sono invece ancora ben marcate
e visibili.
Invece che di un singolo orologio, sarebbe dunque
più corretto parlare di dieci distinti orologi solari, che, grazie alla
loro diversa inclinazione, potrebbero fornire le indicazioni orarie per
l’intero arco diurno e per tutto l’anno solare. Tuttavia, ad oggi,
l’orologio non è utilizzabile, sia perchè privo degli gnomoni, sia
perchè posizionato ignorandone il corretto orientamento.
Alcuni studiosi ritengono che la manifattura sia
ottocentesca, attribuendo l’opera agli astronomi tedeschi Peters e
Sartorius, autori di importanti meridiane ad Acireale e a Catania, nel
periodo dal 1840 al 1843. Altri invece ritengono più probabile la
provenienza dal sistema delle decorazioni del preesistente,
settecentesco, “Labirinto Biscari”. Quest’ultima ipotesi sembra
avvalorata sia dallo stile dei numeri incisi sul poliedro, sia dalla
fattura e dal materiale della colonna di sostegno. E’ molto probabile
infatti, per quest’ultima, una provenienza archeologica, verosimilmente
dal Teatro Romano di Catania, indagato, negli anni '70 del settecento,
proprio dal principe di Biscari.
(foto e testo di Roberto Leone)

IL FICUS MONUMENTALE DELL’INGRESSO
NORD
Il Giardino Bellini ospita alcuni alberi di
provenienza subtropicale che si sono acclimatati molto bene. Accedendo
al Giardino dall’ingresso prospiciente la Piazza Roma, sulla parte
destra dello slargo d’ingresso, è possibile ammirare un maestoso
esemplare di Ficus magnolioides (specie nota anche come Ficus
macrophylla). Quest’albero, ormai più che centenario, fu messo lì a
dimora attorno al 1860. Esso sovrasta in altezza tutti gli alberi
circostanti e il diametro del suo fusto misura quasi 6 metri.
La specie è originaria delle foreste pluviali
dell’Australia Orientale e, nel proprio habitat naturale, può
raggiungere i 60 metri di altezza. E’ stata introdotta in Italia nella
prima metà dell’Ottocento, trovando dimora in diversi orti botanici e
parchi cittadini, a scopo soprattutto ornamentale. Le sue dimensioni, la
conformazione e gli intrecci della chioma e del fusto, lo sviluppo di
radici aeree, rendono infatti suggestiva la sua presenza nel verde
urbano.
In Sicilia questi alberi hanno trovato condizioni
climatiche e di luminosità particolarmente favorevoli. Oltre a quello di
Catania, si possono ammirare altri imponenti esemplari a Siracusa nella
zona archeologica, a Trapani presso la Villa Margherita, e a Palermo
presso la Villa Garibaldi e l’Orto botanico.
(testo di Roberto Leone)
SOTTO QUEST'ALBERO FU GIRATA UNA SCENA
DEL FILM "MIMI' METALLURGICO"


.jpg) LA
FONTANA OTTAGONALE DELL’INGRESSO SUD LA
FONTANA OTTAGONALE DELL’INGRESSO SUD
Numerose fontane artistiche impreziosiscono, con i
loro giochi d’acqua, il verde del Giardino Bellini. Entrando nel
Giardino dall’ingresso di Via Salvatore Tomaselli, ci accoglie la
fontana ottagonale riportata in fotografia.
La fontana è semplice nelle forme, ma elegante ed
eclettica nel gusto. Il basamento e la vasca di terra hanno sezione
ottagonale; il profilo della vasca presenta una parete liscia, con un
accenno di gradino, ed un parapetto con modanature curve. Dalla vasca si
erge una colonna decorata con tori e scozie, che regge un catino
polilobato quadrangolare da cui l'acqua deborda raggiungendo la vasca di
terra. Lo zampillo sommitale scaturisce da un ulteriore elemento
sagomato, posto al centro del catino. Il materiale impiegato per tutti
gli elementi pare essere un tipo di travertino o comunque una pietra
dura.
Si intuisce subito che questa fontana, semplice e
al contempo elegante, abbia avuto un nobile passato e che sia stata
probabilmente smontata e ricollocata in quel punto per decorare
degnamente il Giardino. Incerta è però la sua provenienza: alcuni
studiosi ritengono che essa sia il riciclo di una perduta fontana
ottagonale che fu prezioso elemento del preesistente “Labirinto Biscari”;
altri invece che un tempo essa ornasse il chiostro del Convento di San
Giuliano in Via Crociferi.
(foto e testo di Roberto Leone)


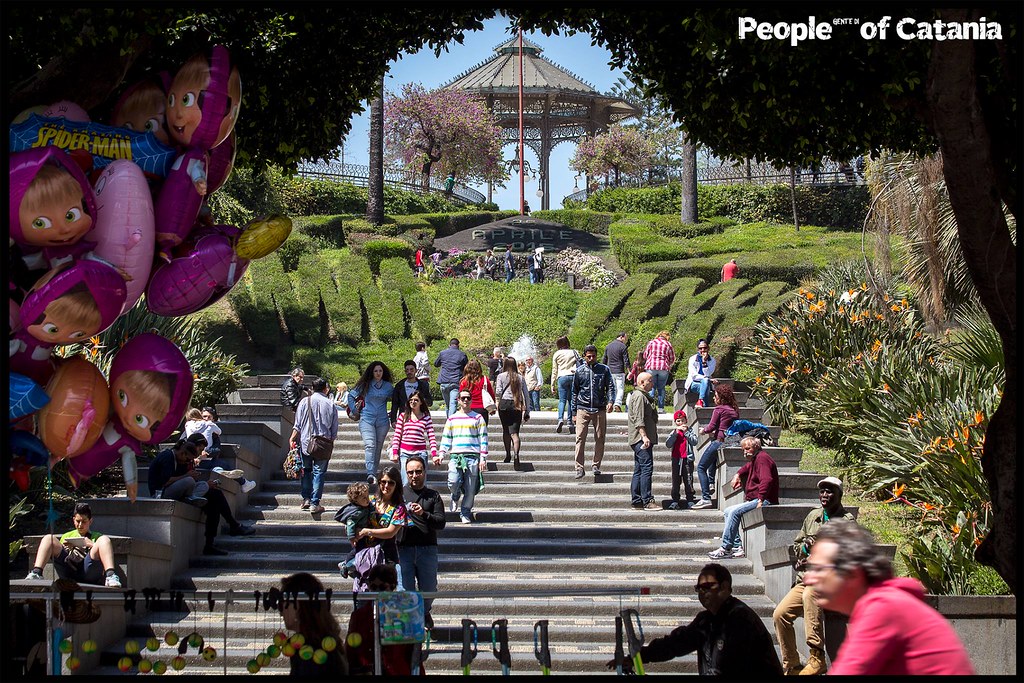





IN
MEMORIA DI GINO E TONY
la
Villa nella mente (di
Tano Giuffrida )
http://www.psicogiardinaggio.it/alberta/la%20villa%20nella%20mente.htm
La
Villa nella mente del Catanese è il luogo della fanciullezza, dell’oasi
in cui rifugiarsi durante la calura estiva, dove rilassarsi e svagarsi a
contatto con la natura, con le cose belle e pacifiche, con il
sonnecchiare, con il dolce schiamazzo dei giochi dei bimbi; il luogo
dove meditare sull’umana esistenza e sul suo senso.
Ma
non solo, la Villa è anche il luogo dei primi amori, delle coppiette
abbracciate su panchine tranquille e appartate, delle fontane, delle
vasche d’acqua con ninfee e papiri, delle fontanelle con acqua fresca
dove d’estate prendere un sorso di refrigerio.
Il luogo dove andare quando si marina la scuola, il luogo dove dare un
appuntamento ad un caro amico e con lui trascorrere dei piacevoli
momenti, magari sorseggiando un selz con sciroppo e limone seduti vicino
il chiosco delle bibite.
Un
giardino amorevolmente progettato, sapientemente coltivato e amato dai
rispettosi visitatori, un punto d’incontro all’interno di una città
in perenne scontro, un punto di tregua e pace fisica e spirituale.
Al
suo interno, un tempo, il gazebo era il luogo dei concerti di musica d’arte,
e la palazzina cinese il tempio della cultura, dove venivano raccolti e
messi a disposizione di tutti i libri... i libri, questi strani oggetti,
destinati a bruciare con tutto il loro contenitore, come accade alla
famosa biblioteca di Alessandria: anche Catania ha avuto il suo rogo
forse meno famoso, ma altrettanto significativo del degrado mentale. In
una palazzina
 completamente costruita in legno ripiena di libri,
lasciata all’incuria del tempo con scarsissima manutenzione e nessun
sistema antincendio, come si fa a pensare che un bel giorno non bruci
tutto? no, non può accadere... e se per caso dovesse accadere, certo
non si tratterebbe di un evento calcolato bensì di una disgrazia! completamente costruita in legno ripiena di libri,
lasciata all’incuria del tempo con scarsissima manutenzione e nessun
sistema antincendio, come si fa a pensare che un bel giorno non bruci
tutto? no, non può accadere... e se per caso dovesse accadere, certo
non si tratterebbe di un evento calcolato bensì di una disgrazia!
Per ogni Catanese di una certa età la scimmia Gina era più famosa di
Cita, la scimmia di Tarzan: sì, è vero Gina era prigioniera in una
gabbia, ma era coccolata e corteggiata più di una star e questo di
sicuro la faceva vivere bene.
In
quella Villa i pavoni erano animali domestici come le galline, liberi di
girare tra gli altri abitanti del giardino; i cigni sguazzavano
tranquilli nella grande fontana, mentre in altre vasche c’erano
trampolieri e pellicani, e grandi voliere ospitavano svariati pennuti di
ogni specie. La cronaca racconta che molti di quei volatili diventarono
prede di caccia notturna per cittadini bracconieri improvvisati.
Grande
evento fu l’arrivo di un elefante. Per lui fu costruito un recinto
senza sbarre, e solo un piccolo fossato lo separava dai visitatori. La
solita imbecillità umana non tenne conto che quello non era il suo
habitat ideale: il fatto che il simbolo della città di Catania fosse un
elefante non servì a proteggerlo per nulla e il tentativo di
trasformare la villa in zoo finì con la morte del povero elefante poco
tempo dopo.
Oggi
accade spesso che si organizzino all’interno della Villa
manifestazioni, anche valide, ma che attirano migliaia di partecipanti
tutti insieme e per svariati giorni consecutivi, al termine dei quali
tutti si meravigliano e gridano allo scandalo che non è rimasto più un
filo d’erba, addossando la colpa dell’inciviltà ai partecipanti, di
sicuro vandali o unni.
Tony vi fu portato
anestetizato perchè la prima volta si pensò di portarlo alla
Villa in "corteo", lo ricordo perchè ero presente, corteo
che partì da piazza Alcalà (odierna piazza
Falcone-Borsellino) - dove stanziava il circo Togni - ma
giunto in piazza duomo, l'elefante si imbizzarri e vi fu un
fuggi fuggi generale, io e mia nonna, assieme ad altri
catanesi che assitevano al corteo, ci rifugiammo all'interno della villetta
della cattedrale chiudendo i cancelli
.L'elefante inferocito
distrusse alcune macchine parcheggiate vicino palazzo dei
Chierici e dopo un bel po' i domatori del circo Togni
riuscirono a prenderlo e quindi portarlo di nuovo nella
gabbia del circo sita in piazza Alcalà. Per questo si decise
di portare l'elefante al Giardino Bellini così come lo si
vede nella foto.
Turi Salvatore Giordano

Gli elefanti pervenuti a Catania
furon due. cominciamo con il piu' noto e cioe' ""tony da villa"",
regalato dal circo darix togni(poiche' era gia'avanti con l'eta',arrivo'
a ct nell'agosto del 1965 e mori' quasi due anni dopo nel maggio del
1967.
Solo pochi sanno e' il fatto che a
catania prima diedero il nome tony (maschilismo imperante) e solo dopo
si accorsero che si trattava di un'elefantessa...pertanto..tony da villa
era una antonina.ma fu il secondo elefante arrivato a ct, infatti nel
1890 l'imperatore dell'etiopia """menelik""regalo' al re d'italia
umberto I ,un elefantino,poiche' si trattava di un dono molto
ingombrante da gestire,venne regalato a catania visto che' era l'emblema
del suo stemma. i catanesi lo accettaron benissimo e lo chiamaron in
onore di menelik """minnulicchiu""".ma ahime' duro' solo pochi giorni e
mori.per finire rispondo a coloro che confondevano tony da villa con
gino da villa.

sempre negli anni 60,quando catania
era chiamata"" la milano del sud"" e la nostra villa era
bellissima,pulitissima ed ospitava tantissimi animali,c'eran pure delle
scimmie.la piu' famosa fu proprio ""gino"" ginu da villa""era un
esemplare maschio infatti venne pure chiamato ""u vastasu"""poiche'
amava sempre grattarsi....i gioielli di famiglia .
per finire ,da queste nostre
meravigliose storie di animali a catania , son venuti fuori due modi di
dire tipicamente catanesi"""minnulicchiu"" e ""si chiu lariu di ginu da
villa""....sperando di esser stato chiaro ...esaustivo ed aver risposto
alle vostre domande
Gianni Sineri.

O
piuttosto la colpa non è degli organizzatori, o di chi ha dato il
permesso criminale di realizzare là dentro certe attività di massa?
Villa
Bellini. A Catania tutto è dedicato a Vincenzo Bellini, grande
musicista... ma Bellini ha vissuto e composto la sua musica a Parigi,
avendo passato ben poco tempo nella città etnea. Non basta aver dato la
natività ad un uomo illustre per potersene vantare, bisogna aver gli
dato anche qualcos’altro per poterlo osannare come rappresentativo del
buon Catanese e per dedicargli ogni cosa, piazze, palazzi, monumenti,
ville, pizze, pasta e torte. gli
dato anche qualcos’altro per poterlo osannare come rappresentativo del
buon Catanese e per dedicargli ogni cosa, piazze, palazzi, monumenti,
ville, pizze, pasta e torte.
Oggi
la Villa ha la sua importanza solo nell’immaginario collettivo del
Catanese, poiché sembra che ormai non importi più a nessuno di lei.
Magari prima o poi qualcuno proporrà di fare in sua vece un bel
posteggio, così utile in pieno centro... o meglio ancora, un centro
commerciale... questo sì che sarebbe un servizio di pubblica utilità!!
Tanto
a Catania il verde è sempre stato scarso e se si elimina il poco
sopravvissuto si aiuta a completare un processo naturale di
desertificazione.
L'elefante Menelik
Il primo elefantino ospitato
all'interno del Giardino Bellini.
Nel 1890, dopo il trattato di
Uccialli, il negus Menelik II, in segno di amicizia, inviò in dono al re
d'Italia Umberto I un piccolo elefante.
Il sovrano, a sua volta, regalò il
pachiderma alla città di Catania, perchè nel suo stemma ha appunto un
elefante.
La notizia della decisione reale
venne accolta con entusiasmo dai catanesi, pochissimi dei quali avevano
mai visto un elefante, ma con minor giubilo dalle autorità comunali,
alle quali il dono del re pose subito dei gravi problemi: dove sistemare
il bestione?
Fu allestito alla meglio un recinto
in uno spiazzo del giardino Bellini in attesa di costruire un gabbione.
L'elefante, subito battezzato dalla popolazione con il nome di Menelik,
giunse in treno a Catania nella prima metà di giugno. Sfilò, seguito
dalla folla, per le vie della città fino al giardino Bellini dove fu per
pochi mesi motivo di curiosità.
Morì prima dello scadere dell'anno
perchè- si scoprì poi- la sua cella era umida e buia, e perchè lo
cibavano di erbe malsane. Fu imbalsamato e sistemato nel salone
dell'istituto di Zoologia dell'università, in via Androne, dove ancora
oggi si trova.
Enc. di Catania Tringale Editore 1987

Piazzale delle Carrozze |

I
NUMERI DEL GIARDINO BELLINI
Superficie
totale Mq.61640
Illuminazione: a copertura totale buona.
Arredo: panchine e beverini omogeneamente
divisi lungo la superficie.
Pavimentazione strade e vicoli: 60% asfalto; 25
% mattonelle d'asfalto.
Pavimentazione con mosaici: 15% presenti lungo
i viali della collina nord e della collina del datario.
Attrezzature sportive: presenti lungo il
perimetro comprendente anche strutture per portatori di
Handicap.
Servizi igienici: siti presso collina nord lato
entrata piazza Roma.
Fontane:
entrata piazza Roma "Samaritana" entrata via Etnea
"Vasca dei Cigni".
Bambinopoli: sita di fronte collinetta nord.
Verde fruibile: parziale solo dove presenti
attrezzature sportive.
Alberate presenti in N°711: Platani, Schinus,
Ficus m., Ficus e., Ficus M., Nerium o., Ligustrum J., Ligustrum
v., Pino p., Pinus r., Chorisia s., Casalpina t., Sophora j.,
Sophora p., Araucaria e., Araucaria c., Araucaria b., Erytrina
f., Brachichiton a., Grevillea r., Ceratolina s., Citrus a.,
Phytolacca, Ulmus c., Magnolia g., Merita d., Cedrus d.. Albero
secolare :Ficus Magnolideis situato entrata lato Piazza Roma.
Palmizi presenti in N°247: Phoenix c., Phoenix d., Phoenix r.,
Phoenix ro., Chamaerops h., Trachicarpus f., Washigtonia f.,
washigtonia r., Livistona c., Livistona a., Erythea a., Howea
f., Cycas r., Dracena d., Cordyline i., Yucca e.
Aperture
e chiusura parco: a
cura del V° Servizio Tutela Verde Pubblico nei seguenti orari
estivo " 06.00-23.00 ", primaverile autunnale "
06.00-22.00 ", invernale " 06.00-21.00 ".
Impianto
d'irrigazione: automatico
telecontrollato

La
Villa Bellini
Per
i catanesi il Giardino Bellini è semplicemente ‘a Villa,
luogo di svago, di relax, di passeggiate e di incontri.
Occupa, nel suo complesso, una superficie di 70.942 mq
all'interno della quale si dispongono, aiuole fiorite, piazze
per manifestazioni sportive e musicali, panchine per il riposo e
la lettura, viali ombreggiati e fontane. Una parte dello spazio,
oggi occupato dalla villa, costituiva l'antico‘Labirinto',
pittoresco giardino che circondava un edificio realizzato, nel
‘700, da Ignazio Paternò Castello principe di Biscari.
L'abitudine di
costruire giardini con percorsi intricati nei quali gli ospiti
si potessero facilmente smarrire, era una delle tante mode
diffuse nell'Europa del Settecento quando si fondevano e
convivevano la razionalità e la fantasia, il gusto per le
‘meraviglie' e il rigore scientifico. Intorno alla metà
dell'Ottocento il Comune di Catania acquistò la villa della
famiglia Paternò Castello per costruirvi un parco pubblico.
Negli anni successivi furono acquisiti nuovi terreni per dare
ancora più spazio al giardino e consentire alla popolazione
catanese di recarsi in un grande luogo verde, ricchissimo di
decorazioni floreali, palmizi, alberi centenari e fontane.

Tra
le pagine di una breve ma essenziale guida di Catania, edita nel
1899, troviamo una gustosa descrizione del giardino che, sin
dalla sua apertura, fu considerato uno dei più belli d'Europa.
"Il Giardino Bellini - leggiamo nella guida - è il ritrovo
più simpatico e ameno della città. La sua posizione è
incantevole. Da due collinette, che si ergono nel centro e che
sono divise da un ampio piazzale, si domina buona parte della
città, la distesa del mare e lo spettacolo maestoso dell'Etna.
Per questa diversità di panorami che offre, il Giardino di
Catania è considerato come uno dei migliori d'Europa. Chi
guarda da una delle due colline, prova le stesse impressioni di
chi sta a guardare Roma dalla spianata del Pincio o Firenze dal
piazzale Michelangelo. I viali di questo giardino sono diversi e
tortuosi, fittamente ombreggiati e tracciati tanto sul pendio
delle due collinette, come nei punti piani della villa.
Diversi
ponticelli, costruiti con vera eleganza, i sottopassaggi, un
tunnel, le aiuole fiorite, i praticelli erbosi e ricchi di ogni
specie di fiori, la fontana, il piazzale che divide le due
colline, tutto si fonde per trasformare questo meraviglioso
giardino in un luogo di delizie. Nell'estate vi si godono
pomeriggi freschi, col riparo degli alti ed ombrosi alberi:
meravigliosi tramonti per la calda orientale vivacità dei loro
riflessi; le
 serate si passano deliziosamente, quando sciami di
signore popolano la villa illuminata fantasticamente e
riccamente". Queste parole possono, ancora oggi, essere
considerate pertinenti; l'atmosfera che si respira nella villa
Bellini è la stessa che animava l'entusiasmo del nostro
scrittore di guide. Nel 1932, l'antico ingresso sulla via Etnea
venne reso monumentale; sempre quell'anno fu innalzato il
cavalcavia sulla via Sant'Euplio e fu realizzata la grande vasca
circolare nella quale vennero messi a dimora alcuni bellissimi
cigni bianchi. serate si passano deliziosamente, quando sciami di
signore popolano la villa illuminata fantasticamente e
riccamente". Queste parole possono, ancora oggi, essere
considerate pertinenti; l'atmosfera che si respira nella villa
Bellini è la stessa che animava l'entusiasmo del nostro
scrittore di guide. Nel 1932, l'antico ingresso sulla via Etnea
venne reso monumentale; sempre quell'anno fu innalzato il
cavalcavia sulla via Sant'Euplio e fu realizzata la grande vasca
circolare nella quale vennero messi a dimora alcuni bellissimi
cigni bianchi.
Nel 1933 l'artista M.M. Lazzaro collocò nel piazzale
dell'ingresso principale le statue che personificano le arti.
Negli ultimi anni la villa Bellini accoglie spettacoli
prestigiosi che allietano le serate dei catanesi e dei
visitatori italiani e stranieri.
Bibliografia generale AA.VV., Enciclopedia di Catania, Catania
1987.
Guida di Catania e provincia, a c. di N. Recupero, Catania 1991.
Villa
Bellini è il principale giardino pubblico della città. Occupa
una superficie di 70.942 mq e deriva, attraverso vari processi
di ampliamento e riadattamento, da un antico giardino
settecentesco, del quale oggi restano poche tracce.
Il
patrimonio botanico di Villa Bellini consiste, tra alberi e
arbusti, in 106 specie di piante prevalentemente di origine
esotica. Diversi sono gli esemplari ultracentenari che, per la
loro maestosità, rendono pregevole il giardino.

Villa Bellini si presenta come un giardino formale e in parte
bisimmetrico. La flora, per lo più di tipo subtropicale, è
costituita da elementi che, tranne poche eccezioni, hanno ampia
diffusione nel paesaggio verde cittadino.
In
misura quantitativamente minore sono rappresentate specie del
contingente mediterraneo (Ulmus canescens,Quercus ilex, Pinus
halepensis, P. pinea, Cupressus sempervirens, Viburnum tinus).
La
forma biologica dominante è quella fanerofitica, sia arborea
che arbustiva la quale, nell'insieme, definisce
l'aspetto strutturale più significativo della copertura
vegetale.
Sono presenti 106 specie, appartenenti a 83 generi e 54
famiglie; tra queste meritano menzione le numerose palme
(Chamaerops humilis, Ph. canariensis, Ph. reclinata, Livistona
chinensis, L. australis, Washingtonia filifera, W. robusta,
Erythea armata, Trachycarpus fortunei, Howea forsteriana), varie
specie di Araucaria (A. heterophylla, A. bidwillii,, A.
columnaris A. cunninghamii) e Ficus (F. magnolioides, F.
microcarpa, F. elastica), imponenti esemplari di Sophora
japonica, Cupressus sempervirens, Phytolacca dioica, nonché
filari di Platanus x hybrida e Schinus molle, componenti
principali delle alberature dei viali.
Approfondimenti
Recupero
e valorizzazione del verde storico "Giardino Bellini",
per una migliore fruibilità anche ai fini ludico - spettacolari
|
GIARDINO BELLINI - gruppo facebook




Palazzo Cannizzaro

SALENDO
SALENDO........................
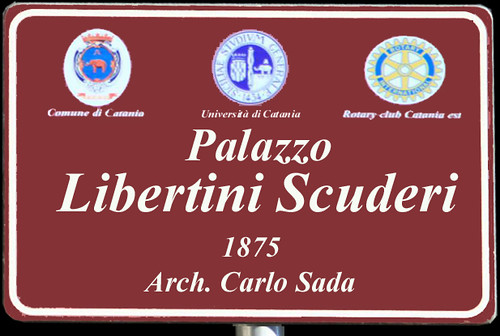 Il
Palazzo Libertini Scuderi fu progettato nel 1875 dal giovanissimo architetto
milanese Carlo Sada (1849-1924). Questi giunse a Catania dapprima come
collaboratore del più anziano arch. Andrea Scala, per progettare e dirigere
i lavori del Teatro Massimo Bellini, ma si rese ben presto autonomo rispetto
al maestro. Divenne progettista di successo, molto richiesto dalle famiglie
catanesi più facoltose, e rimase definitivamente a Catania, fino alla sua
scomparsa. La redazione del progetto per la “Palazzina Raddusa” impegna
l’Arch. Sada per un periodo piuttosto esteso, che inizia nell’aprile del
1875 e prosegue, per la redazione dei disegni esecutivi, fino al 1879. Il
Palazzo Libertini Scuderi fu progettato nel 1875 dal giovanissimo architetto
milanese Carlo Sada (1849-1924). Questi giunse a Catania dapprima come
collaboratore del più anziano arch. Andrea Scala, per progettare e dirigere
i lavori del Teatro Massimo Bellini, ma si rese ben presto autonomo rispetto
al maestro. Divenne progettista di successo, molto richiesto dalle famiglie
catanesi più facoltose, e rimase definitivamente a Catania, fino alla sua
scomparsa. La redazione del progetto per la “Palazzina Raddusa” impegna
l’Arch. Sada per un periodo piuttosto esteso, che inizia nell’aprile del
1875 e prosegue, per la redazione dei disegni esecutivi, fino al 1879.
Nel 1907 il progetto dell’edificio,
divenuto intanto “Palazzo Libertini”, è riportato in un album di disegni
destinati alla pubblicazione sulla rivista “L’Edilizia Moderna”.
Sono gli anni in cui, nel pieno della
temperie storico-critico-estetica del periodo romantico che permea per
intero l’Ottocento, l’Architettura rivolge il proprio interesse alla
rivisitazione degli stili e dei caratteri costruttivi del passato, i quali,
attraverso differenti linguaggi e variegati binomi stile-funzione adottati
per le varie tipologie di edifici pubblici e/o privati in ragione delle
specifiche destinazioni d’uso-ora, vengono rivisitati e riproposti con un
repertorio che spazia dal neoromanico e dal neogotico, attraverso il
neorinascimento, il neo barocco ed il neorococò di gusto francese, fino al
neoclassicismo del primo Ottocento.
E’ questo ciò che in Architettura viene
definito “Eclettismo”, un linguaggio espressivo composito che, attingendo
agli stili ed agli schemi decorativi del passato, li miscela e li declina in
varie forme, rendendoli persino compresenti anche nel medesimo edificio.
Fu commissionato al Sada dal cav.
Giuseppe Paternò di Raddusa nel 1875 ed è l’unico palazzo in città che
riecheggia nello stile il Rinascimento fiorentino, con un piano terra
interamente rivestito da grosse bugne a guanciale, sovrastato da un piano
primo intonacato in colore rosso-rosa antico. Successivamente, per un breve
periodo fu proprietà del sig. Giuseppe Schininà, marchese di Sant’Elia; poi,
nel 1901, fu acquistato dal Sen. Pasquale Libertini ed infine, nel 1941,
dall’armatore Matteo Scuderi, i cui eredi lo detengono. Curiosamente lo
stemma che compare sul fronte del portico antistante il giardino è quello
della famiglia che possedette il palazzo per il periodo più breve, e cioè
quello degli Schininà (una cometa sovrastante un giglio, su uno sfondo che
sarebbe azzurro, se non fosse di pietra).
L’architetto milanese realizza, ubicato
tra due vie principali della città, un volume che, per mezzo della simmetria
e della regolarità dell’impianto compositivo, attesta sulla Via Etnea la
severità del prospetto principale di rappresentanza, contrapposto ed
alleggerito, sulla secondaria Via Caronda, per mezzo del loggiato ad ampie
arcate al piano terra e del vuoto della terrazza sulla superiore elevazione,
al di sopra della quale parapetto e cornice di coronamento occultano il
piano in ammezzato con relativo terrazzo a livello.
Sicché dalle due elevazioni lungo la Via
Etnea si passa alle quattro sulla Via Caronda, se si tiene conto anche del
piano seminterrato che ospita alcuni servizi e le cantine.

Il prospetto principale si affaccia sulla
Via Etnea, con un portone centrale e tre luci su ognuno dei due lati.
Significativa la rinuncia alla realizzazione di botteghe al livello stradale
ed ai proventi che da esse sarebbero derivati.
Le sette luci così ottenute si ripetono
al piano primo, differenziate nei timpani, che si alternano nelle forme
triangolari e ad arco. Quella centrale è arricchita da un balcone protetto
da un grazioso parapetto con balaustre realizzate in pietra bianca. Le altre
luci sono di fatto delle finestre in quanto non consentono di uscire
all’aperto, ma si partono da terra e sono quindi anch’esse protette da una
breve balaustrata. L’edificio si conclude in alto con un cornicione
sostenuto da mensole a dentello, sormontato da un parapetto che nasconde
alla vista la copertura in tegole.
Gli spigoli (vero quello sulla Via
Cordaro, simulato l’altro), sono ben evidenziati con un gioco di bugne nella
stessa pietra bianca, alternate a maggiore e minore estensione.
Al piano primo il Sada dispose gli
ambienti di maggiore pregio allineati sulla Via Etnea, mentre sul retro, che
si affaccia su un giardino confinante con la via Caronda, dispose gli
ambienti minori o di servizio, a loro volta dotati di piano ammezzato. In
conseguenza di ciò, sulla Via Cordaro, il prospetto mantiene lo stesso
schema di quello presente sulla Via Etnea per metà della larghezza, per poi
cambiare schema in corrispondenza degli ambienti di minore pregio.
Gli ambienti che si affacciano sulla Via
Etnea sono cinque, tutti con funzione di rappresentanza e perciò riccamente
decorati, sia alle pareti, sia ai soffitti. Il salone più grande è quello
che corrisponde all’angolo con la Via Cordaro, dotato di una luce su
quest’ultima strada e due sulla Via Etnea. Di grandi dimensioni anche il
successivo vano, il secondo, dotato di due luci, tra cui quella che
corrisponde al balcone principale. Il terzo, il quarto ed il quinto vano
dispongono di una finestra ciascuna.
Dal portone sulla Via Etnea si accede ad
un lungo androne che sfocia, dalla parte opposta, nel giardino prospiciente
la Via Caronda. Lateralmente ad esso, sulla destra, è collocato lo scalone
che conduce al piano primo e che consente di accedere, tramite uno spazio di
disimpegno-guardaroba, sia all’appartamento, sia alla cucina non più in
funzione e da qui ad un terrazza creata nell’incavo che presenta l’edificio
sul lato di levante.
La terrazza poggia su un portico a tre
luci ad arcate, sostenute da colonne, di cui quelle intermedie binate. Un
gioco simile, ma con colonne dai capitelli più elaborati, si ripete sulle
pareti che chiudono da tre lati la terrazza. Sul quarto lato essa si
affaccia sul giardino sottostante, protetta da un’elegante balaustrata
costituita da plinti rettangolari alternati a gruppi di quattro colonnine.
Sui plinti centrali sono collocate quattro statue in terracotta, di
provenienza lombarda, ad altezza naturale, raffiguranti le quattro stagioni.
In definitiva la facciata di levante,
prospiciente la Via Caronda, benché meno visibile dal pubblico, è tutt’altro
che una facciata secondaria, presentandosi anch’essa elegante e riccamente
decorata, grazie anche al movimento determinato dal portico al piano terra,
dalla sovrastante terrazza e dai due corpi di fabbrica laterali che si
sporgono in avanti. I rivestimenti di questa facciata si ripetono uguali al
piano primo (intonaco di color rosso antico), mentre il bugnato a guanciale
di colore scuro utilizzato sulla Via Etnea è sostituito da un bugnato “a
bugne piatte” color crema.
Lo scalone
Lo scalone principale del palazzo (non è
il solo perché ne esistono altri due di servizio) è quello che conduce dal
piano terra al piano primo e, data la notevole altezza tra i piani, esso
consta di tre rampe.
E’ riccamente decorato in stile
assolutamente classico. Le pareti offrono superfici rivestite con intonaco
di gesso trattato magistralmente ad imitazione di marmi di varie tinte
(nero, bianco di Carrara e giallo Siena), con disegni a riquadri. Sono
minime le parti in marmo autentico.
In corrispondenza del piano primo (o
piano nobile) il vano scala è in buona parte circoscritto da numerosi
pregevoli infissi del tipo “a bussola” in legno e cristallo istoriato.
Alcuni di essi sono presenti solo a scopo decorativo, in quanto di fatto non
utilizzabili, ma riescono a portare un po’ di luce agli ambienti
retrostanti. Tra un infisso e l’altro, con lo stesso metodo dell’imitazione
del marmo, sono ricavate delle lesene (finte colonne a superficie piatta).
Al centro della parete che delimita il
vano dello scalone dal terrazzo, campeggia una figura femminile in stucco ad
alto rilievo, di grande eleganza, che rappresenta la Flora o la Primavera.
Lo stile di quest’opera, che risente dell’influsso dell’Art Nouveau, più
nota in Italia come “Stile Liberty”, fa ritenere che essa sia stata
realizzata in una fase successiva.

Al di sopra della fascia occupata da
questi infissi, interrotti dalle lesene, sono ricavati dei tableaux
contenenti dei bassorilievi in stucco bianco, raffiguranti figure femminili,
putti e temi mitologici.
Il soffitto del vano scala è anch’esso
decorato a stucchi, nei colori bianco, grigio, azzurro e ocra chiara, con un
grande riquadro al centro, riccamente lavorato a stucco con temi vegetali di
tralci e fiori, contornato da una cornice a sua volta costituita da riquadri
di minore dimensione.
Le decorazioni pittoriche dei saloni.
E’ possibile ipotizzare che per le
decorazioni degli interni del palazzo l’arch. Sada – il quale generalmente
nelle sue opere programmava, con la collaborazione di esperte maestranze,
anche l’apparato decorativo interno – sia per quanto attiene agli stucchi ed
alle dorature a porporina d’oro zecchino, copiosamente presenti nei saloni
di rappresentanza, sia per le volte dipinte, abbia fatto ricorso alle
medesime figure di decoratori che in quegli anni con lui collaboravano per
il teatro massimo “V. Bellini”, ovvero il triestino Andrea Stella per quanto
riguarda gli stucchi e le dorature ed il fiorentino Ernesto Bellandi per gli
affreschi delle volte; più verosimilmente per quelli della volta del salone
“rosso” d’angolo tra la Via Etnea e la Via Cordaro che, con l’Allegoria
della Flora, sia nell’impianto compositivo, sia nella tecnica pittorica,
richiamano il dipinto centrale della volta del Teatro, raffigurante
l’Apoteosi di Bellini.
Nei quattro angoli della volta sono
rappresentate 4 bellezze femminili dei quattro continenti: a sinistra di
Venere l’Egitto, a destra le americhe, a sinistra in basso l’oriente e a
destra in basso l’Europa.
Sala delle arti: al centro della volta,
immersi nel celeste chiarore di una giornata di primavera, puttini gioiosi e
amorini (uno porta in mano l’arco per scoccare le frecce) intrecciano
ghirlande di fiori; ai lati del pannello centrale della volta sono
rappresentate, nelle vesti di splendide fanciulle, le arti: in alto in
corrispondenza del pannello centrale, la scrittura, a sinistra del pannello
centrale la musica e la scultura, in basso la poesia, a destra del pannello
la pittura e l’architettura.
Sala della musica: pannello centrale con
fanciulla inghirlandata, amorini che suonano e spartiti musicali; ai lati
del pannello figure che si ispirano all’arte pompeiana e alle grottesche
rinascimentali con personaggi che suonano vari strumenti musicali; agli
angoli della volta sono rappresentate bellissime nature morte con strumenti
tra i quali si riconoscono: strumenti a fiato, a corda e a percussione.
Camera da letto: allegoria del sonno
nelle vesti di una bellissima fanciulla nuda addormentata sulle nuvole con
la luna piena sullo sfondo.
Il giardino
E’ un classico giardino all’italiana,
della superficie di circa 700 mq, che confina a nord con la Via Cordaro e ad
est con la Via Caronda.
Il fulcro attorno al quale si svolge il
giardino è una fontana di forma circolare, che ospita al centro una statua
in terracotta raffigurante un putto con un delfino, circondata da ciuffi di
falsi papiri (Cyperus alternifolius) immersi nell’acqua. La vasca è
circondata da un camminamento pavimentato con ciottoli bianchi e neri che
realizzano dei disegni geometrici. Nella posizione leggibile da chi proviene
dalla villa compare la scritta “M. Scuderi” che ci fa comprendere che il
pavimento è stato restaurato dopo il 1941, anno in cui il palazzo fu
acquistato dall’armatore Matteo Scuderi. Su una pubblicazione edita nel 1990
dalla Soprintendenza ai B.B.C.C.A.A. di Catania appare il disegno del
giardino differente da quello odierno, per cui si presume che l’Armatore
Matteo Scuderi modificò non solo il pavimento, ma l’intero disegno delle
aiuole.
Il resto del giardino è suddiviso in
tante isole di forma per lo più rettangolare e tra un’isola e l’altra si
insinuano altri camminamenti, o meglio altri vialetti, anch’essi pavimenti a
ciottoli bianchi e neri, grazie ai quali è possibile avvicinarsi ad ogni
angolo del giardino. Le isole sono circondate da una bordura realizzata con
l’impiego di una della più familiare delle piante grasse che troviamo sui
balconi di Sicilia, la portulacaria afra, priva di nome italiano, ma intesa
familiarmente come “ricchezza”, forse perché le piccole e numerose foglie
carnose ricordano tante lenticchie.
Queste bordure sono state lavorate
secondo la classica arte topiaria, che consiste nel potare alberi e arbusti
al fine di dare loro una forma geometrica, diversa da quella naturalmente
assunta dalla pianta, per scopi ornamentali.
All’interno delle isole troviamo varie
piante, tra cui la più vistosa è un magnifico ciuffo di Strelitzia augusta,
alto non meno di quattro metri, posto alle spalle della fontana rispetto
alla casa. Più vicina a questa troviamo due alberi ornamentali di notevole
altezza: una magnolia (Magnolia grandiflora), bella specie presente in
diverse piazze cittadine, e un’araucaria (Araucaria araucana), albero
proveniente dall’emisfero australe.
Oltre alla Strelitzia augusta troviamo
poi un esemplare di Strelitzia reginae e alcune cycas revoluta, una pianta
che viene spesso confusa con le palme, ma che appartiene ad una famiglia del
tutto diversa (le Cycadaceae) e che è nota, oltre che per la sua eleganza,
per il fatto di essere un vero e proprio fossile vivente, cioè una pianta
molto antica che ha conservato le sue caratteristiche nel tempo. Le cycas
sono originarie dell’Asia tropicale, della Polinesia, dell’Africa orientale
e dell’Australia.
(Ugo Mirone, Giambattista Condorelli,
Maria Teresa Di Blasi – delegazione Fai di Catania)
http://www.girasicilia.it/patrizi-e-palazzi-visite-guidate-catania/



|
 Catania,
primi del Novecento. Largo Paisiello è uno degli spazi più eleganti
della Catania sfarzosa ed artistica della Bell’Epoque. In questo
periodo, infatti, la via Pacini è un viale ampio ed alberato che fa
da monumentale scenografia ad uno dei teatri più in voga: l’Arena
Pacini appunto. Inaugurata nel 1877, costruita interamente in legno
con tre ordini di palchi, ospita spettacoli di notevole livello
artistico, dalla lirica alla prosa all’operetta. Poco distante vi è
l’Arena Gangi, grande cinema inaugurato nel 1918, capace di ospitare
ben 4500 persone. Vengono demolite la prima nel 1936 (ormai
abbandonata) e la seconda qualche anno più tardi (ultimo film
proiettato: “Il pugnale cinese” nel settembre ’38) . Catania,
primi del Novecento. Largo Paisiello è uno degli spazi più eleganti
della Catania sfarzosa ed artistica della Bell’Epoque. In questo
periodo, infatti, la via Pacini è un viale ampio ed alberato che fa
da monumentale scenografia ad uno dei teatri più in voga: l’Arena
Pacini appunto. Inaugurata nel 1877, costruita interamente in legno
con tre ordini di palchi, ospita spettacoli di notevole livello
artistico, dalla lirica alla prosa all’operetta. Poco distante vi è
l’Arena Gangi, grande cinema inaugurato nel 1918, capace di ospitare
ben 4500 persone. Vengono demolite la prima nel 1936 (ormai
abbandonata) e la seconda qualche anno più tardi (ultimo film
proiettato: “Il pugnale cinese” nel settembre ’38) .

LA TERRAZZA SQUIBB
Negli anni 60’ del
secolo scorso, a Catania, i campi di calcio scarseggiavano, cosa che
stimolava la fantasia dei ragazzi, che per giocare erano capaci di
trasformare in un campo qualsiasi spazio di qualsiasi forma, purché
fosse sgombro, vogghiu diri libiru di ‘mmarazzi, no pisci, no stummu!
‘U capisturu, veru?
Io giocavo
soprattutto nello slargo antistante la stazione Borgo della
Circumetnea, vicino la casa di mia nonna materna, in piazza Abramo
Lincoln e nella cosiddetta terrazza Squibb, che prendeva il nome
dalla grande insegna della nota casa produttrice di dentifrici e
detergenti vari.
Ora ci sunu ‘i
campetti di calcio a cinqu, ci sunu ‘i campi di palluni comunali, ci
sunu tanti impianti di tennis, di pallavolu, di squash, ma a ddì
tempi c’erunu sulu ‘i piazzi, ‘i strati lagghi e qualche cuttigghiu.
Eppuri ‘i carusi
bravi c’erunu, ma era difficili ca qualcunu si ‘n’accurgeva e quannu
qualcunu arrinisceva a fari ‘npruvinu cu’ ‘na squatra s’ava fari ‘a
valigia e si ‘n’ ava ghiri fora e si era piddaveru ‘n campiuni non
tunnava chiù.
Alla terrazza
Squibb, nei pressi dell’ingresso posteriore della Villa Bellini,
giocavano soprattutto i ragazzi che frequentavano le scuole vicine:
il Liceo Classico Spedalieri, l’Istatuto Tecnico Industriale
Archimede, l’Istituto Tecnico Commerciale De Felice e qualche altro.
Le partire erano
lunghissime, duravano fino allo sfiancamento dei vari giocatori i
quali, quando non ce la facevano più, lasciavano spazio a chi veniva
dopo.
Le porte si
facevano con gli zaini pieni di libri o con qualche grossa pietra,
ma tanto era sufficiente per farci giocare trascurando il dettaglio
che la terrazza era vagamente circolare, aveva un grosso gradino che
la divideva quasi a metà e aveva un ingresso molto ampio dal quale,
spessissimo, usciva il pallone che finiva tra le macchine in
transito, facendo rischiare i calciatori di caderci sotto.
‘I gol, a ddi
tempi, si cuntavunu a deci a deci, mentri nuddu vuleva fari ‘u
putteri, picchì erunu tutti attaccanti, tutti Gigi Riva e Petru ‘U
Tuccu.
Quegli anni erano
molto diversi da quelli che stiamo vivendo adesso. Non so se erano
più belli o più brutti, chi può dirlo, i processi alla storia sono
sempre difficili.
Dico che allora noi
eravamo più giovani, facevamo di necessità virtù e dico pure che
sapevamo accontentarci di quello che c’era, pur continuando a
sognare quello che non c’era.
E va beni,
tagghiamula cca, se no arriva ‘a nostalgia e pinsamu macari all’autri
cosi ca non si pone fari chiù, e macari a tanti amici e parenti ca
purtroppu non ci sunu chiù, ma ca pinsamu sempri.
(Salvo Fleres)
|

 AL PRIMO MAESTRO DELLA DANZA RITMICA, CATANIA
DEDICA UNA STATUA E UNA STRADA AL PRIMO MAESTRO DELLA DANZA RITMICA, CATANIA
DEDICA UNA STATUA E UNA STRADA
Vi è tra le opere decorative che adornano il
Giardino Bellini una statua di marmo,quella che rappresenta il quasi mitico
Androne, che per quanto non sia un'opera d'arte nel senso più nobile della
parola,è per molti aspetti pregevole;voglio dire che ha pregi di fattura---impostazione,proporzioni, studiata esattezza di particolari
anatomici che dimostrano come nell'Ottocento,anche per opere esclusivamente
decorative,alle quali l'artista faceva a meno di apporre la firma, i canoni
dell'insegnamento severo praticato allora nelle scuole d'arte, venissero
scrupolosamente applicati.
Giacché quest'opera non ignobile, non risulta
che sia firmata;lacuna anche questa che soltanto l'Archivio Comunale, distrutto
nel sacrilego incendio del 1944,avrebbe, per noi studiosi ,potuto colmare.
Comunque riferendomi al tempo in cui la statua venne collocata nel Giardino,
cioè all'anno 1863 ed a quelli che lo seguirono---un quindicennio---fino a
quando, come ho scritto altre volte, l'ingegnere Filadelfo Fichera, padre di
Francesco, sistemò definitivamente il vecchio Labirinto biscariano, può pensarsi
che autore dell'Androne sia stato lo scultore napoletano Tito Angelini,
esecutore anche della Fontana dell'Amenano all'ingresso principale della piazza
Alonzo Di Benedetto e del busto di Bellini nel Giardino stesso.
Debbo aggiungere, però, che anche osservando
con attenzione la maniera con cui la statua è scolpita, essa fornisce pochi o
punti addentellati perché si possa sicuramente affermare che sia dovuta
all'Angelini; anzi,il modo come la parte anatomica appare condotta e amorosamente
studiata ,è in palese contrasto con quanto vediamo nell'efebo rappresentante il
fiume Amenano della fontana suddetta. Ma tant'è, quel che importa si è che
l'opera, come ho detto, non è ignobile;ignobili invece sono stati coloro che in
un tempo non lontano l'hanno vandalicamente deturpata, infrangendone il piffero
e le dita delle mani. Da ciò il restauro recente, dovuto all'arte paziente dello
scultore Salvo Giordano.
Se Androne è un mito ,esso è un mito
squisitamente catanese,città musicale nel profondo e madre del più puro dei
melodisti;anzi,secondo quanto scrisse l'illustre filologo Consoli,un'autentica
gloria di Catania
Per Teofrasto,discepolo di Aristotele,
Androne è tutt'altro che un mito;esso fu un flautista catanese che per primo
applicò al corpo umano movimenti e ritmi suonando il flauto. Con buona pace però
dell'antichissimo storico, asserire che il nostro lontano concittadino sia stato
il primo a muovere ritmicamente il corpo sul suono del flauto, del piffero o
comunque di uno strumento, come dire l'inventore della danza, è ipotesi del
tutto azzardata;In quanto è pacifico che la danza nacque e nasce con l'uomo, e
che ove all'uomo manchi uno strumento qualsiasi, basta a lui la voce per
sostituirlo.
Ma i miti e le leggende valgono per quel che
in essi v'è di poesia, cioè di bellezza, e vanno accettati senz'altro. Androne
fu certamente, in remotissimi tempi, un danzatore famoso, se il nome di lui
venne a noi tramandato con sì lusinghieri attributi;e se esso,sulla
testimonianza del discepolo di Aristotele, fu come non dubito, un catanese;bene
ha fatto chi ne ha voluto onorare la memoria innalzandogli una statua e dando il
nome ad una via che è tra le più seducenti della città. -(Saverio Fiducia)
(di Saverio Fiducia da Passeggiate
Sentimentali)


|
 CONSIGLI
PER UNA SANA MATTINATA ....A CIOLLIARE! CONSIGLI
PER UNA SANA MATTINATA ....A CIOLLIARE!
A
Catania l’aria è sempre calda e quando scoppia la primavera sembra
già estate. Basta girovagare tra la Pescheria, vicino Piazza Duomo, e
‘a Fera o’ Luni, in piazza Carlo Alberto, e sarete subito
catturati da profumi e sapori che sgomitano tra loro, talvolta
scontrandosi, ma sempre lasciando un segno indelebile. E’ un vero e
proprio risveglio dei sensi quello che ogni volta si compie, che sia
una fritturina di pesce fresco o una classica pasta alla norma,
fragrante di melanzane fritte ed avvolta nella ricotta salata
spruzzata come neve calda, o delle frittelline di verdure, o i dolci
di frutta martorana, colorati più di un quadro di Van Gogh, esagerati
nel loro sapore unico.
- la mattina catanese non può che cominciare con una granita di
mandorla o di caffè, con la brioche calda, naturalmente. E’ uno dei
simboli della città, ottime quelle del Caffè Europa o di Ernesto, al
lungomare, ma praticamente ovunque a Catania si possono gustare ottime
granite. In qualunque momento della giornata e della notte.
- Assolutamente da non perdere un tuffo al mattino (l’ideale sarebbe
molto presto) alla Pescheria, tra i banconi del pesce e i venditori
dalla voce grossa che richiamano l’attenzione. Un quadro a tinte
forti dipinto ogni mattina e dal forte profumo di mare, dove ognuno
– compreso lo spettatore – ha la sua parte in primo piano. Se è
già mezzogiorno, aperitivo al baretto della piazza, tra polpettine
fritte di pesciolini, verdurine in pastella, o pesce freschissimo
crudo e marinato: il sushi catanese. Se siete fortunati potrete
scambiare quattro chiacchiere con il cuoco Carmelo Chiaramonte,
ragusano di Modica ma "cuciniere" a Catania ed habitué del
luogo.
- Da un teatro all’aria aperta ad un altro, ed eccovi in piazza
Carlo Alberto, ‘a Fera o’ Luni per i catanesi, a caccia di
occasioni e di piccoli affari. Un’esplosione di suoni, odori,
colori, sapori, frutta colorata, pesci boccheggianti, carne macellata
appesa a gocciolare e le urla dei venditori, poi, con la voce sempre
rauca per lo sforzo di gridare. Se a questo punto volete provare un’esplosione
di dolcezza dovete per forza assaggiare il cannolo di ricotta di
Savia, di Spinello o di Scardaci, tutti in via Etnea.
- E’ ora di pranzo e che peccato dover rinunciare a qualcosa!
Perdersi tra il profumo della ricotta calda e gli asparagi appena
raccolti all’ombra del maniero di Federico II (Castello Ursino).
Oppure deliziarsi con un piatto di spaghetti al nero di seppia o con i
ricci di mare all’Antica Marina, nella piazza della Pescheria ormai
vuota di banconi. Oppure sdraiati al sole sulle panchine della villa
Bellini (da poco restituita alla città) assaporando il mitico
arancino al sugo di Savia -quello con i pezzetti di bollito dentro - o
le crispelle di ricotta e acciughe di Stella, la più antica
crispelleria di Catania.

- Per dissetarsi, a Catania, è d’obbligo lo "sgriccio",
un seltz limone e sale inventato dai fratelli Giammona, titolari del
chiosco più famoso della città, quello in piazza Vittorio Emanuele
da tutti conosciuta come “Piazza dei Chioschi”, appunto. Oltre al
limone e sale, tanti sciroppi possono accompagnare le bollicine ma i
più gettonati rimangono mandarino verde e tamarindo. Praticamente in
tutte le piazze storiche di Catania c’è un chiosco per queste
bevande: alla Pescheria, alla Fiera,
in Piazza Jolanda, a San Cristoforo. Quello di Piazza Roma (di fronte
l’ingresso nord di villa Bellini) è
famoso per aver inventato il
frappè alla nutella con le brioscine Tomarchio frullate dentro. Una
bomba di dolcezza richiestissima dai giovanissimi e dai golosi di ogni
età. A notte fonda, preferibilmente, al rientro dalla discoteca o per
tirare tardi e sballarsi di Nutella.

- Cosa c’è di
meglio nel pomeriggio che passeggiare per le vie del centro storico,
inoltrandosi da Piazza Università nel dedalo di stradine che di notte
diventano il teatro affollatissimo della movida cittadina ed arrivare
a scoprire Piazza Duca di Genova, nel cuore del quartiere Civita oggi
“vestita in fiore” e sbirciare dalle vetrate dei piani bassi del
Palazzo Biscari, le pezze che diventeranno i vestiti opere d’arte
intorno ai quali si muovono giovani apprendisti della stilista Marella
Ferrera che proprio nel palazzo Biscari ha allestito il Museo della
Moda.

vecchia cartolina di Piazza Vittorio Emanuele
E dopo il museo è l’ora di un cono gelato leccato davanti al
bellissimo teatro Massimo in piazza Bellini. Pistacchio, mandorla,
nocciola, cioccolato, fragola con le fragoline di Noto sopra, fior di
latte, puoi sbizzarrire la tua scelta, il godimento è assicurato.
- Tra i piatti tipici della cena catanese non può mancare il
"masculinu con i piselli ed il finocchietto riccio", servito
con la mollica abbrustolita sopra; oppure la carne di cavallo
(bistecche o polpette) in via Plebiscito, nel cuore antico del
quartiere San Cristoforo; oppure la grigliata di carne e le sfiziose
“cipollate” (spiedini di pancetta e cipollina fresca alla brace)
sotto le luci del Castello Ursino. E poi tirare tardi a sorseggiare
cocktails seduti sulla scalinata Alessi, alle spalle della
meravigliosa via Croficeri ed a migliaia di decibel dalle vicine suore
Benedettine di clausura. Per chiudere, nel cuore della notte, con il
cornetto caldo al pistacchio nella vicina Etoile.
http://www.risiu.it/index.php?path=ct


 I
CIOSPI a
cura di Salvo L.G. (www.catanesidov.it) I
CIOSPI a
cura di Salvo L.G. (www.catanesidov.it)
A Catania, sparsi in tutti i quartieri e quasi ad ogni angolo
delle vie di maggior importanza, abbiamo i “Chioschi”. Non
sono, come nelle altre città, dei rivenditori di giornali o di libri;
a Catania i chioschi offrono ai loro clienti la possibilità di
dissetarsi e contemporaneamente ristorarsi assaporando innumerevoli
fragranze di sciroppi misti ad acqua seltz, cioè acqua
particolarmente frizzante e spruzzata freddissima e ad alta
pressione direttamente nei bicchieri. Tenterò in seguito di fare una
lista dei gusti, ma nonostante il mio impegno, sono sicuro di
dimenticarne qualcuno; mi scuso per ciò con chi abitualmente li
produce, inventa o consuma.Questa prelibatezza, esclusivamente
catanese, è la particolarità che un turista dovrebbe immediatamente
cogliere non appena viene a visitare la città. D ’altronde lo
ripeto, i chioschi o “ciospi” come si dice in dialetto, si trovano
dappertutto ed è facilissimo incontrarne a decine passeggiando per la
città.La struttura tipica del “ciospo” è generalmente a base
circolare, ma anche a volte ottagonale o rettangolare, con ampi
ripiani rivolti agli avventori nei quali questi ultimi sono soliti
appoggiarsi ad osservare la preparazione della bevanda appena
ordinata. All’interno della struttura i loro gestori si muovono con
grande abilità e destrezza, soddisfacendo rapidamente le richieste
dei propri clienti.

Sul
ripiano di lavoro non può mancare uno strumento fondamentale per la
preparazione della bevanda: lo spremiagrumi. Ormai quest’ultimo
è di tipo elettrico, ma qualcuno utilizza ancora una specie di
pinza-morsa che provvede a schiacciare il mezzo limone per prelevarne
il succo.La preparazione avviene così: in un bicchiere, generalmente
in vetro, del diametro di circa cinque centimetri ed alto circa
dodici, viene versata una quantità di sciroppo, ben calibrata dall’esperienza
del “barman”, viene quindi spremuto il limone e successivamente
aggiunta l’acqua seltz fino al riempimento del bicchiere.Questo è
soltanto una delle varie tipologie di bevande richieste dai tanti che
accalcano i chioschi in tutte le ore della giornata, sia nei periodi
estivi che in quelli invernali, a tal punto da essere diventati un
vero e proprio punto d’incontro e una tappa fissa dell’uscita
serale per i cittadini di Catania.Ma i chioschi non preparano
esclusivamente queste bibite, essi hanno una vastissima scelta di
bevande.

Il “frappé alla nutella“, per esempio, è uno dei preparati
preferiti dai più giovani che i chioschi di Catania si vantano di
aver ideato per primi.Il Tamarindo, utile per digerire dopo un’abbuffata.
Si beve fino a metà bicchiere facendo aggiungere solo allora una
punta i bicarbonato. A quel punto di corsa tutto giù d’un sorso e
la digestione è garantita.Un altro preparato tipico è il “Mistofrutta”
realizzato unendo insieme vari pezzetti ti frutta fresca tagliati a
cubetti irrorati da sciroppo alla frutta e seltz.Ogni chiosco ha una
sua specialità, ma posso affermare che tutti preparano delle ottime
bevande.
Ho visitato molte città d’Italia e da nessuna parte ho trovato un
“ciospo” come questi appena descritti, tuttalpiù ho trovato
piccoli bar con cornetti e caffé, ma mai un chiosco alla Catanese e
questo è un altro aspetto che ci rende orgogliosi di essere catanese.

PALAZZO MAZZONE
(Via Umberto angolo via Grotte
Bianche,anno di costruzione 1904 circa,autore Tommaso Malerba)
 Edificato
nel 1904 circa il palazzo Mazzone sorge in una zona di espansione
tardo ottocentesca. Edificato
nel 1904 circa il palazzo Mazzone sorge in una zona di espansione
tardo ottocentesca.
Realizzato in pieno eclettismo
catanese esso rappresenta una delle prime esperienze costruttive
documentate di Tommaso Malerba.
L' edificio si contrappone su via
Umberto a Casa Nicotra che Carlo Sada costruisce qualche anno prima
e che progetta a partire dal 1898.
La facciata viene liberamente
figurata secondo un originale stile moresco, consono al gusto
dell'esotico e del meraviglioso ,utilizzato maggiormente nelle
abitazioni con giardino.
Il Malerba accentua il tema del
contrasto con le architetture adiacenti utilizzando un linguaggio
ricco di chiaroscuri, di trafori,di archetti,di intrecci,di
superfici decorate,inscenando un paesaggio d'invenzione.
La caratterizzazione stilistica
rimane tuttavia decorativa e la tipologia distributiva dell'edificio
è tradizionale. Rilevante la connotazione ibrida del lessico che
Malerba utilizza per l'architettura della facciata. Il repertorio
formale eterogeneo dell'apparato decorativo attinge
indifferentemente da più stili accentuando la caratteristica
eclettica e sperimentale del suo autore. La struttura compositiva
della facciata principale è sorretta da una sequenza di pieni e
vuoti costituiti dalla presenza di piccole logge caratterizzate da
un arco polilobato.
Questo seguendo la logica
dell'ordine architettonico ,si arricchisce e si slancia mentre la
costruzione cresce fino a raggiungere l'ultimo piano. La geometria
complessiva viene imbrigliata verticalmente da paraste aggettanti e
orizzontalmente da un sistema di trabeazioni che marcano i livelli
di calpestio ,da cornici d'imposta degli archi delle aperture e da
un fastoso cornicione di coronamento.
L' aggetto dei balconi e della
cornice di coronamento è caratterizzato da mensole a stalattiti
secondo il tradizionale linguaggio dell'architettura araba. I fregi
sulla facciata interpretano stilemi ad intrecci sia di tradizione
islamica che di tradizione nord europea secondo la cultura eclettica
e anticonformista della fine dell'Ottocento.
(Descrizione della Soprintendenza
ai beni culturali)
Note e foto di Milena Palermo per
Obiettivo catania -
https://www.facebook.com/ObiettivoCatania/
|

|
 L'intitolazione
alla memoria dello scrittore e fotografo Giovanni Verga avvenne solo
in pieno XX secolo. In precedenza la piazza, del tutto periferica
rispetto alla città era un vero e proprio campo di addestramento
militare e portava il generico nome di "piazza d'Armi". La
piazza aveva un'estensione maggiore dell'attuale ed era di forma
rettangolare. Nei primi anni del XX secolo venne scelta per allestirvi
l'importante "Esposizione agricola siciliana del 1907" e in
seguito a ciò la piazza venne ribattezzata "piazza
Esposizione" nome rimasto nella memoria popolare fino a tempi
recenti. L'incarico dell'allestimento delle strutture che avrebbero
ospitato l'Esposizione venne affidato all'ingegnere Luciano Franco che
realizzò le opere, nello spirito del primo Novecento catanese,
secondo lo stile liberty. Il "Padiglione Reale" fu
realizzato da Salvatore De Gregorio, mentre Alessandro Abate si
occupò di decorare il Vestibolo, in corrispondenza del quale si
stagliava la cupola del "Grande Ottagono". Le decorazioni di
Abate raffiguravano scene di lavoro dei contadini etnei, colti dalla
grazia divina della dea Cerere. Da qui si aveva accesso al giardino,
abbellito da diversi chioschi, posizionato al centro, dal quale era
possibile addentrarsi nei quattro padiglioni, introdotti da archi. Il
Chiosco Inserra di Tommaso Malerba, riconosciuto come un capolavoro,
andò distrutto. L'intitolazione
alla memoria dello scrittore e fotografo Giovanni Verga avvenne solo
in pieno XX secolo. In precedenza la piazza, del tutto periferica
rispetto alla città era un vero e proprio campo di addestramento
militare e portava il generico nome di "piazza d'Armi". La
piazza aveva un'estensione maggiore dell'attuale ed era di forma
rettangolare. Nei primi anni del XX secolo venne scelta per allestirvi
l'importante "Esposizione agricola siciliana del 1907" e in
seguito a ciò la piazza venne ribattezzata "piazza
Esposizione" nome rimasto nella memoria popolare fino a tempi
recenti. L'incarico dell'allestimento delle strutture che avrebbero
ospitato l'Esposizione venne affidato all'ingegnere Luciano Franco che
realizzò le opere, nello spirito del primo Novecento catanese,
secondo lo stile liberty. Il "Padiglione Reale" fu
realizzato da Salvatore De Gregorio, mentre Alessandro Abate si
occupò di decorare il Vestibolo, in corrispondenza del quale si
stagliava la cupola del "Grande Ottagono". Le decorazioni di
Abate raffiguravano scene di lavoro dei contadini etnei, colti dalla
grazia divina della dea Cerere. Da qui si aveva accesso al giardino,
abbellito da diversi chioschi, posizionato al centro, dal quale era
possibile addentrarsi nei quattro padiglioni, introdotti da archi. Il
Chiosco Inserra di Tommaso Malerba, riconosciuto come un capolavoro,
andò distrutto.
Mappa cittadina dei primi anni del XX secolo nella quale risulta già
apposto il nome di piazza Esposizione alla vecchia "piazza
d'armi"
Nel 1936, sul lato nord della piazza, ebbero inizio i lavori di
costruzione del maestoso Palazzo di Giustizia (terminati nel 1953) a
cui si accede per mezzo di un'imponente scalinata in basalto lavico
dominata da una statua in bronzo raffigurante la dea della giustizia,
con bilancia e spada nelle mani, posta all'ingresso. La statua, alta
sette metri e mezzo, fu scolpita da Mimì Maria Lazzaro nel 1953 e
trasferita e posizionata tra i pilastri dell'ingresso nel 1955 a cura
del Genio civile. Sul lato a sud-ovest, fu realizzata una caserma dei
Carabinieri al posto della vecchia caserma.
La piazza acquisì progressivamente sempre più importanza in seguito
all'espansione della città verso nord
Nel 1975 al centro della parte sud della piazza, di fronte all'attuale
palazzo dell'hotel Excelsior, venne posizionata la Fontana dei
Malavoglia; questa incorpora un complesso scultoreo di grande impatto
emotivo, una delle ultime opere dello scultore catanese Carmelo
Mendola (1895-1976), che rappresenta il naufragio della
"Provvidenza" scena chiave del racconto verista verghiano I
Malavoglia.
http://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Giovanni_Verga

L'ex
Piazza esposizione.
Nel
1907 si inaugurò L'Esposizione agricola siciliana, in stile liberty,
alla quale intervenne il sindaco Consoli. Nel suo discorso inaugurale
sostenne che Catania era la seconda città d'Italia grazie ai traffici
del porto commerciale, e fra le prime città industrializzate, grazie
alle fabbriche degli zolfi e delle tintorie.

All'Espo
intervennero i primi artisti liberty della città. L'ingegnere Luciano
Franco si occupò della disposizione dell'insieme degli edifici nella
piazza d'Armi (odierna piazza G. Verga), costituendo una galleria
quadrangolare con al centro un giardino ornato da chioschi. Lo stile
scelto per il prospetto esterno e per le facciate prospicienti il
giardino fu quello dell'Arte Nuova. Egli volle introdurre anche uno
stile locale, il saraceno, nel grande arco d'ingresso che ha una curva
araba. Il vestibolo, a cui si giungeva attraversando l'arco, era a
pianta quasi quadrata.
Da
qui due porte conducevano alle gallerie della mostra. In asse con il
vestibolo sorgeva il grande Ottagono, con otto pilastri e otto guglie.
Dodici porte vi si aprivano. La cupola era alta trenta metri. Dal
vestibolo i visitatori entravano nel giardino, circondato da gallerie
su tre lati. Quattro archi arabi stilizzati si aprivano sui tre lati,
mentre dal quarto si accedeva al complesso delle Belle Arti.
Capolavoro dell'espò fu il distrutto Chiosco Inserra di Tommaso
Malerba. Esso aveva già il tipico elemento liberty della facciata,
l'apertura tripartita arcuata, inserita in una architettura eclettica
di gusto gotico- orientaleggiante. Alessandro Abate aveva decorato la
volta del vestibolo d'ingresso, ove apparivano ai quattro capi: Labor,
Ars, Voluntas, Aeconomia, insieme ad immagini di contadini al lavoro,
incorniciati da disegni floreali. Sullo sfondo troneggiava l'Etna e,
nell'azzurro del cielo, la dea Cerere, sopra una quadriga, distribuiva
corone ai contadini intenti al lavoro della mietitura e dell'aratura.
http://www.cataniatradizioni.it/storia/piazza%20esposizione.htm

L’odierna
Piazza Giovanni Verga è stata soggetta nel tempo a cambiamenti
determinati dall’azione degli uomini.
Originariamente chiamata Piazza Regina Bianca, dalla Regina Siciliana
Bianca di Navarra che nel 1402 sposò Re Martino I , successivamente
prese il nome di “Piazza d’Armi” perché pensarono di adibirla
per esercitazioni e manifestazioni militari. Conservò questa
denominazione fino al 1907 quando ospitò un’importante esposizione
agricola, da allora prese il nome di Piazza Esposizione, in ricordo di
quella fortunata manifestazione inaugurata da Re Vittorio Emanuele
III. Altri toponimi, ormai totalmente scomparsi, per Piazza Verga,
sono “O locu Asmundu”, dal casato degli antichi proprietari,
oppure “Massa-uà” perché i catanesi pronunciavano così il nome
di Massaua, che un certo Manara aveva dato ad una trattoria da lui
aperta in quel luogo verso il 1885, decorandola con scene della guerra
d’Africa. Poi la piazza fu lentamente circondata da edifici, uno dei
primi fu la caserma dei carabinieri. Intorno al 1930 il centro della
piazza fu adibito a campo di calcio. Oggi la Piazza Verga è una delle
più belle e luminose della Catania moderna. Tra il 1936 e il 1953 fu
costruito il grandioso edificio del Palazzo di Giustizia.
All’ingresso, tra i pilastri c’è la grande statua della Dea della
Giustizia scolpita dall’artista M. M. Lazzaro. Sopra la sua corona
è raffigurata la storia della Giustizia. La statua, alta 7 m. e mezzo
sostiene nelle palmi delle mani, due uomini per stabilirne la
colpevolezza o l’innocenza. Di fronte al palazzo di Giustizia si
trova il moderno ed elegante Hotel Excelsior. Al centro della piazza
si trova la bellissima fontana dei Malavoglia. L’opera è dello
scultore Carmelo Mendola ( 1895-1976 ) e fu inaugurata nel 1975. Il
gruppo scultoreo riproduce la scena del drammatico naufragio della “Provvidenza”
descritto nel romanzo di Verga “I Malavoglia”.
http://giornale.scuolacavourcatania.com/citt%C3%A0111.asp


Perchè si chiamava
anche Piazza Esposizione
Nel 1907 si inaugurò
L'Esposizione agricola siciliana, in stile liberty, alla quale
intervenne il sindaco Consoli. Nel suo discorso inaugurale sostenne
che Catania era la seconda città d'Italia grazie ai traffici del
porto commerciale, e fra le prime città industrializzate, grazie
alle fabbriche degli zolfi e delle tintorie.
All'Espo intervennero i primi artisti liberty della città.
L'ingegnere Luciano Franco si occupò della disposizione dell'insieme
degli edifici nella piazza d'Armi (odierna piazza G. Verga),
costituendo una galleria quadrangolare con al centro un giardino
ornato da chioschi. Lo stile scelto per il prospetto esterno e per
le facciate prospicienti il giardino fu quello dell'Arte Nuova. Egli
volle introdurre anche uno stile locale, il saraceno, nel grande
arco d'ingresso che ha una curva araba. Il vestibolo, a cui si
giungeva attraversando l'arco, era a pianta quasi quadrata.
Da qui due porte conducevano alle gallerie della mostra. In asse con
il vestibolo sorgeva il grande Ottagono, con otto pilastri e otto
guglie. Dodici porte vi si aprivano. La cupola era alta trenta
metri. Dal vestibolo i visitatori entravano nel giardino, circondato
da gallerie su tre lati. Quattro archi arabi stilizzati si aprivano
sui tre lati, mentre dal quarto si accedeva al complesso delle Belle
Arti. Capolavoro dell'espò fu il distrutto Chiosco Inserra di
Tommaso Malerba. Esso aveva già il tipico elemento liberty della
facciata, l'apertura tripartita arcuata, inserita in una
architettura eclettica di gusto gotico- orientaleggiante. Alessandro
Abate aveva decorato la volta del vestibolo d'ingresso, ove
apparivano ai quattro capi: Labor, Ars, Voluntas, Aeconomia, insieme
ad immagini di contadini al lavoro, incorniciati da disegni
floreali. Sullo sfondo troneggiava l'Etna e, nell'azzurro del cielo,
la dea Cerere, sopra una quadriga, distribuiva corone ai contadini
intenti al lavoro della mietitura e dell'aratura.
http://www.cataniatradizioni.it/storia/piazza%20esposizione.htm

Quando
il Catania giocava qui.
La
storia del calcio Catanese comincia nel 1908, anno per altri versi
infausto e triste in quanto il terremoto aveva spazzato via le città
di Messina e Reggio Calabria.E’ il 19 giugno quando il Corriere di
Catania annuncia la nascita, in riva allo stretto, di una società
sportiva pro educazione fisica per le province di Catania e Messina,
che grazie alla generosità dell’Amministrazione Comunale catanese
dell’epoca, avrà uno stadio in Piazza d’Armi o Piazza
Esposizione, (l’attuale Piazza Verga).La Società è la "Pro
Patria", guidata dal presidente comm. Francesco Sturso D’Aldobrando,
che promuove molte attività e molti sport: oltre il calcio anche la
ginnastica, la scherma, l’alpinismo, l’aeronautica, l’automobilismo,
ecc.

La prima partita ufficiale della squadra di football "Pro
Patria" si svolge a Catania il 30 giugno 1909, in onore dei
congressisti della Lega Nazionale e dei componenti della flotta del
Mediterraneo, contro la squadra della Corazzata "Regina
Margherita" che si trovava a passare dal porto di Catania. L’incontro
terminò con il risultato di parità ,una rete per parte. La
formazione schierata era la seguente:Vassallo: Gismondo Bianchi;
Messina Slaiter Caccamo; Gregorio Binning Cocuzza Ventimiglia
Pappalardo (Spedini), nomi che a quei tempi rappresentarono il
pionierismo del calcio catanese.

Da
quella partita in poi, ogni qual volta una nave arrivava a Catania i ragazzi
della Società si precipitavano a organizzare un incontro. Al seguito della
squadra c’era anche un fotografo animato da una tenacia incredibile, tale
da fargli trascinare dalla città fino a Fontanarossa quella pesante
macchina fotografica, con relativo cavalletto, per immortalare gli atleti
nelle loro fasi di gioco. Tra i calciatori di questa prima fase di
pionierismo ricordiamo il Generale Spedini, ala sinistra molto veloce, e il
portiere Roberto Nicotra
(entrambi saranno travolti dal ciclone della 1ª Guerra Mondiale e ricordati
come eroi), il dott. Cocuzza, valido centravanti, e il dott. Pappalardo, che
partecipò alla Coppa Lipton, una manifestazione che a quel tempo rivestiva
una certa importanza. Il 23 luglio si svolse un altro incontro al giardino
Bellini con i componenti di una nave inglese che si trovava alla fonda nel
porto di Catania, il "Broyser". I catanesi in quell’occasione
subirono una sonora sconfitta per sette a zero.A questo punto il calcio si
comincia a modificare: iniziano i campionati, nasce e si affianca alla
"Pro Patria", lo "Sport Club Trinacria", con l’intenzione
di forgiare nuovi atleti. Fu cosi che la "Pro Patria" si
trasformò in "Associazione Sportiva Catanese" e accolse parecchi
giovani alla ricerca di un sano svago.L’Amministrazione Comunale nel
mentre provvide a costruire in piazza Esposizione un campo di calcio con due
tribune, con una capienza di cinquemila posti.Il calcio a Catania aveva
superato la fase pionieristica e soprattutto la 1ª Guerra Mondiale, quindi
cominciò ad avere una sua collocazione in campo nazionale.Nel 1929 si
costituisce a Catania la Società "SS. Catania"



|

VENTUN ANNI PER UN MONUMENTO
Fra le opere pubbliche che negli anni
cinquanta presero il via ma non giunsero al traguardo ha un posto di rilievo,
per l'interesse emotivo e per le polemiche che suscitò,il completamento
artistico alla piazza Verga,cioè la fontana dei Malavoglia. Fu un capitolo
straordinariamente lungo e travagliato,insolito per un'era in cui gli atti
amministrativi si svolgevano con rapidità:durò ventun anni, uno sproposito.
Cominciò col "Bando di concorso per
l'erezione di un monumento a Giovanni Verga in Catania ", pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 10 novembre 1956.Premi:un milione
al vincitore. 500.000 lire al secondo, 300.000 lire al terzo;compenso per
l'esecuzione 16 milioni.
Quell'argomento era già stagionato:si pensi
ad esempio che, secondo il bando originario, fra il materiale documentario che
ai concorrenti sarebbe stato fornito era prevista una planimetria della zona
<<come sarà per risultare dopo il compimento delle costruzioni in corso nella
piazza >>.Ma quando dopo lunghi perditempo procedurali esso fu pubblicato, erano
<<state ormai ultimate le costruzioni in corso nella detta Piazza >>,per cui
quella planimetria risultava <<superata>>dagli eventi.
Al concorso parteciparono 20 fra artisti e
architetti. Rimasero infine in ballottaggio 4 bozzetti.Si diede luogo a un
concorso di secondo grado che indicò come vincente il progetto dello scultore
catanese CARMELO MENDOLA.Non era un monumento del tipo tradizionale, con
basamento e busto di Verga; neanche gli altri, del resto, erano tradizionali. La
proposta di Mendola raffigurava la fontana con la barca dei Malavoglia in preda
alla tempesta. Ma fra ricorsi,contestazioni, invalidazione dei giudizi della
commissione (per dimissioni di qualche suo membro),remore d'ogni genere,
riesami, persino uno storno del finanziamento regionale da un capitolo
all'altro,scioperi,aumenti di costo della manodopera, contrasti tecnici sulla
realizzazione dell'impianto idraulico, polemiche pseudo-dottrinali che fecero
ridere l'italia e indignare Catania, anticipazione da parte dello scultore delle
somme per la fusione dell'opera in una fonderia napoletana, passarono anni su
anni.
Mendola, presentato alla giuria il
modellino-progetto, ne realizzò in piccolo (un metro di diametro)una copia
funzionante, con gli effetti d'acqua e quelli di luce;lo sistemò nel bellissimo
giardino di casa sua, in via Ingegnere;e li accolse migliaia e migliaia di
visitatori. Ogni volta accendeva il suggestivo impianto di illuminazione e
metteva in movimento con un altro motore elettrico le acque del mare furioso;al
centro di quel turbine, la <<Provvidenza >><<stava per spaccarsi come un guscio
di noce sullo "scoglio dei colombi">>;e 'Ntoni, <<colla voce soffocata dalla
tempesta >>,col suo volto contratto e disperato,urlando <<Chi è?chi è che
grida?>>,riassumeva quel dramma del mare.
I visitatori ne restavano emozionati.Molti
erano colti da un brivido, come se i tre personaggi sulla barca, anziché di
bronzo, fossero di carne e ossa.Ma com'è mai possibile, essi si chiedevano, che
non si riesca a chiudere questo incantesimo?L' incantesimo si chiuse la sera del
25 ottobre 1975,quando finalmente la fontana fu inaugurata, con solennità. Mendola ci aveva impegnato un quarto della sua vita, un'ansia logorante e molte
decine di milioni, denaro che in massima parte, ancorché svalutato, i suoi eredi
avrebbero recuperato anni più tardi.
Dopo l'inaugurazione, ogni sera egli andava a
visitare la sua opera, pellegrino stanco e felice. Quattro mesi e mezzo dopo,il
5 febbraio 1976,mentre in lontananza rintronavano i <<baiocchi>>di Sant'Agata ed
egli montava in auto per tornarsene a casa,lo colse un'emorragia cerebrale, che
due giorni dopo lo stroncò.-(Salvatore Nicolosi)
Ps da anni la bellissima Provvidenza di
piazza Verga è <<morta>>,preda di vandali ,immondizia, senza più il mare in
tempesta e senza illuminazione......piange il cuore a chi come me ne ha un
vivissimo e caro ricordo
(articolo del giornalista Salvatore Nicolosi)
|

scena girata in
Piazza G. Verga
|
 |
 |
|
"LA STATUA DELLA POLEMICA "
È un titolo appropriato per la
meravigliosa statua della Giustizia posta davanti all'ingresso del
 Palazzo
di Giustizia di piazza G.Verga poiché non poche furono le polemiche
che si scatenarono al momento della sua collocazione.Se oggi noi
tutti possiamo ammirare questa scultura bronzea alta ben 7,50 metri
è solo grazie alla pazienza e perseveranza del grande Sindaco avv.
Luigi La Ferlita che per sedare ogni discussione, dispose la sua
collocazione nel posto in cui era stata destinata. Palazzo
di Giustizia di piazza G.Verga poiché non poche furono le polemiche
che si scatenarono al momento della sua collocazione.Se oggi noi
tutti possiamo ammirare questa scultura bronzea alta ben 7,50 metri
è solo grazie alla pazienza e perseveranza del grande Sindaco avv.
Luigi La Ferlita che per sedare ogni discussione, dispose la sua
collocazione nel posto in cui era stata destinata.
Le polemiche sorsero a causa
della rappresentazione operata dal maestro Domenico Maria Lazzaro
autore della statua bronzea che doveva abbellire l'ingresso del
nuovo Palazzo di Giustizia di Catania.
Erano gli inizi degli anni
Cinquanta e sulla rivista locale si inasprirono le polemiche con
toni piuttosto accesi e due schieramenti ben precisi e quindi c'era
chi la disprezzava dicendo " che razza di giustizia vuol
rappresentare questa statua senza spada e senza la tradizionale
bilancia?È un'infamia, un disonore per Catania e per i catanesi. Non
la vogliamo!".
Per contro ,i sostenitori
dell'opera rispondevano che aveva fatto bene lo scultore a rompere
gli schemi tradizionali "Ma quale spada!Quale bilancia!Qui abbiamo
la più moderna e,al tempo stesso, la più antica concezione della
Giustizia, nelle cui mani campeggia l'uomo :il reo a destra e
l'innocente a sinistra. È l'uomo che viene soppesato e giudicato
,non una qualsiasi mercanzia .E poi ,cosa vanno cercando gli
sprovveduti denigratori?Ignorano di certo l'illustre precedente di
Giotto .Vadano a vedere nella Cappella degli Scrovegni a Padova!"
Infatti l'illustre Mimì Lazzaro
si era proprio ispirato a Giotto per la statua che fu adeguatamente
esposta e spiegata sulla Rivista Catanese ma ovviamente l'ignoranza
la fa da padrona:
"La statua rappresenta una figura
di donna, alta sette metri e mezzo ,che sostiene, nelle palme delle
mani due uomini per stabilirne la colpevolezza e l'innocenza, il
tutto in bronzo fuso del peso di cinque tonnellate. L' artista si è
ispirato a una pittura di Giotto nella Cappella degli Scrovegni e ne
rappresenta le figure all'impiedi con un ricco manto a pieghe per
intonarsi al progetto dell'architetto Fichera che la vide appunto in
posizione verticale e in composizione ritmica con i pilastri del
progetto. La sua forma classicheggiante si armonizza perfettamente
con il complesso architettonico del Palazzo "
Fonte:Lucio Sciacca
 |
Largo dei Vespri
IL PALAZZO DI ALESSANDRO VUCETICH A
CATANIA
I catanesi non sanno chi sia questo
Carneade anche se tutti hanno ammirato il bel palazzetto che porta il suo
nome e che, affacciandosi sul largo dei Vespri insieme a quello progettato
dall’architetto Mascali, segna la quinta urbana dell’inizio di viale XX
Settembre.
Il bolognese Alessandro Vucetich,
medaglia di bronzo al valor militare nella prima guerra mondiale, venne
dunque a Catania nel ’23, ingegnere capo sezione e poi direttore
dell’ufficio tecnico del Comune , ma non si limitò al suo ruolo
“istituzionale”, sentendo di essere investito del compito di “dover
provvedere alle cure di questa bisognevole città”, anche, forse, nella
speranza di riuscire ad arrotondare lo stipendio comunale.
Catania, la sua vitalità, il suo nero e
tardo barocco, forse anche il vulcano, osservato a debita distanza dalle
belle terrazze delle ville di viale Regina Margherita, gli ispirarono una
serie di studi, spesso solo pensati, fermati sulla carta e non attuati, ma
iconoclasti e dissacranti, catastrofici nel senso greco del termine. Catania
fu per lui una palestra di sperimentazioni più che ardite, azzardate e
temerarie.
(Franz Cannizzo)
___________________________

Il Palazzo Vucetich (Largo dei Vespri,
12), realizzato intorno al 1930 dall’ingegnere Alessandro Vucetich, fa da
pendent a quello progettato di Silvestro Mascali: le due costruzioni che
presentano un fronte arrotondato sul loro punto focale, creano una soluzione
urbanistica interessante e movimentata che ha precedenti nella complessa
spazialità delle città barocche. E’ troppo ardito il riferimento alla piazza
del Popolo di Roma, ma i due palazzi hanno la stessa funzione delle due
chiese romane che, come questi palazzi, definiscono un’area di sosta
raccolta ma non rigidamente definita anzi aperta su diversi assi viari.
Palazzo Vucetich è uno dei più tipici esempi di architetture dèco a Catania.
La sequenza dei quattro piani è movimentata da diversi elementi decorativi:
le botteghe al piano terra hanno ampie aperture a tutto sesto, le finestre
del primo piano, anch’esse a tutto sesto, sono inserite entro due lunghe
paraste terminanti con una sfera piatta. Il secondo piano ha balconi più
lineari con cornici rettangolari e infine l’ultimo piano presenta una
sequenza di finestre con cornici mistilinee di ispirazione eclettica. Il
prospetto lungo il viale principale è decorato con leggeri rilievi scultorei
e movimentato dalla presenza delle bow windows, elementi tratti dal
repertorio architettonico dell’Europa centro-settentrionale.



|
 SICILIA
- Ville, palazzi e cappelle: dal Liberty al Déco SICILIA
- Ville, palazzi e cappelle: dal Liberty al Déco
LA SICILIA Sabato
21 Gennaio 2012 - Progetti e progettisti dal modernismo internazionale
al razionalismo di regime
Tra le sezioni della mostra
quella sull'architettura è la più
interessante e completa. Le foto di ville, palazzi, edifici pubblici e
cappelle funerarie - e la presentazione dei diversi stili ed autori -
raccontano «le esperienze e la personalità dei principali
protagonisti del dibattito architettonico catanese negli anni
1870-1939» e della tutela che la sovrintendenza ha assicurato a
questo patrimonio monumentale alla realizzazione del quale ha
contribuito anche una schiera di decoratori, stuccatori ed ebanisti
che hanno concorso a creare il particolare Liberty catanese e spinto
verso un'innovativa produzione industriale. monumentale alla realizzazione del quale ha
contribuito anche una schiera di decoratori, stuccatori ed ebanisti
che hanno concorso a creare il particolare Liberty catanese e spinto
verso un'innovativa produzione industriale.
Inumerosi pannelli raccontano gli eccessi dell'architettura di
quell'epoca, dal modernismo internazionale del Liberty ai tardivi eco
del Barocco, all'opposizione al moderno, al dèco, all'approccio
tradizionalista ed eclettico fino a quello razionalista d'impronta
fascista. E raccontano «di architetti e artisti sempre in bilico tra
modernità e conservazione, tradizione e innovazione, artisti che
hanno creato opere in grado di fotografare una società dinamica e in
continuo mutamento». Così sotto gli occhi del visitatore scorrono
immagini che parlano della nobiltà e dell'alta borghesia del tempo,
del palcoscenico delle loro ville e palazzi e degli architetti cui si
affidarono. E sono Francesco Fichera,
progettista della clinica
Vagliasindi di piazza Cavour, del garage Musumeci di piazza Bovio, del
palazzo della Società elettrica di piazza Trento, di casa Lazzara in
via De Felice e di tanti altri edifici. E poi i palazzi di
Tommaso
Malerba, il Monte di Pietà di
Luciano Nicolosi, e le opere di
Paolo
Lanzerotti
dal negozio Pirelli di Corso Italia, al cinema Diana, a
Villa Pancari ad Ognina. E ancora i progetti degli architetti
Carmelo
Aloisi,
autore del cine teatro Odeon, di Ernesto Basile, di
Filadelfo
Fichera,
e di tanti altri ancora. Discorso a sé meritano i tanti
palazzi e le cappelle funerarie progettate da
Carlo Sada,
il
progettista del Teatro Massimo Bellini, alcuni dei cui disegni
originari, di proprietà della sovrintendenza, sono esposti in uno
spazio a sé.

ex Garage Musmeci - Piazza Bovio
- arch. F. Fichera
Villa
Letizia, residenza dei Prefetti.
Nei
ricordi dello scrittore Saverio Fiducia (1878-1970) viene evocata una Catania del tempo perduto,
dei vecchi rioni, degli ampi spazi sciarosi “aspri e selvaggi” come le lave di Asmundo destinate,
con l’espandersi della città, ad assumere nomi diversi: Massaua, piazza d’Armi, Esposizione
e oggi piazza Verga.
L’asprezza dei luoghi viene testimoniata da vecchie foto della villa
di Gabriello Carnazza e della moglie Clementina von Rintelen dove il futuro corso Italia è appena
tracciato e le uniche costruzioni, sullo sfondo, sono quelle di via Umberto, nuova arteria portata a
termine dall’amministrazione del sindaco avvocato Giuseppe Carnazza Puglisi.
Sulla famiglia catanese dei Carnazza, che vanta eminenti giuristi, parlamentari e legami parentali
con lo storico Michele Amari, è prezioso il contributo di notizie e documentazioni fotografiche fornite
da Lucrezia Paternò del Toscano, moglie del defunto ingegnere Arturo Carnazza e madre di
Federico e Antonio, discendenti
del bisnonno Gabriello.
Dalla
nobildonna Paternò del Toscano apprendiamo che Gabriello e Carlo erano figli dell’avvocato e professore
Giuseppe Carnazza Amari e Carlo, sposato ad Ada Trewhell, diede vita nel 1915 al
“Giornale dell’Isola” poi affiancato da un supplemento letterario
che promuoveva la collaborazione di esordienti letterati.
nel 1923 si segnalò il giovane Vitaliano Brancati.
Erika Abramo - dalla rivista della Provincia di Catania

|
 |
|

|
Palazzo
Ferrarotto
Viale
XX Settembre, 5 - Mariano Falcini
«Attribuito all’architetto Mariano Falcini, palazzo
Ferrarotto, noto anche come Palazzo Paternò Landolina,
presenta un impianto a corte, articolato volumetricamente
su tre piani conclusi dalla copertura a terrazza. L’accesso
principale sul viale XX Settembre avviene attraverso un
grande portale recante in chiave uno scudo gentilizio
coronato. Al piano terra il prospetto è impostato su un
basamento lavico, mentre il piano mezzano è arricchito da
una fascia a bugnato a corsi orizzontali. Le aperture sono
regolari e simmetricamente distribuite. Il piano nobile è
distinto da decorazioni pittoriche a graffito tra le porte
finestre, di maniera vasariana, eseguite del 1874 da
Alfonso Orabona (attivo a Catania tra il 1874 e il 1960) e da
Giacomo Salvador. Lo stesso partito decorativo si ripete
nella fascia di coronamento del sottotetto. Il palazzo
Ferrarotto venne ultimato nel 1892, ma preesisteva al
piano di ampliamento di Gentile Cusa del 1886».
|
|
 |
Palazzo
Vinci
Viale
XX Settembre, 35 - Luigi Costantino
«Il commendatore Antonino Vinci, noto avvocato
catanese inserito nell’ambiente del Circolo Unione, fece
costruire il suo palazzo nei primi anni del Novecento
lungo il prestigioso viale XX Settembre, prolungamento
di viale Regina Margherita, dove, già dallo scorcio
dell’Ottocento, l’aristocrazia catanese esibiva le proprie
ricchezze erigendo eleganti ville urbane intonate
all’ecclettismo. Il palazzo, vincolato il 27 gennaio 1993,
fu progettato
dall’ingegnere palermitano Luigi Costantino.
Gli interni mantengono i loro arredi e decori originari:
nell’insieme risulta una dimora tipica dell’alta
borghesia ancora legata a un lessico storicista, fatti salvi i
motivi decorativi non figurativi nei quali gli artisti hanno
modo di esprimere idee rinnovate provenienti
dall’introduzione del modernismo in Sicilia».
|
|
 |
Villa
Feo
Via
Vecchia Ognina, 128 - autore sconosciuto
«Di autore sconosciuto, Villa Feo è una delle residenze di
villeggiatura realizzata a partire
dalla fine dell’Ottocento in direzione del borgo di Ognina.
Di modesta dimensione,
successivamente ampliata e abbellita a partire dai primi anni
del 1900 e sino agli anni Venti,
la villa presenta un impianto distributivo semplice e regolare
a cui contrapporre un
composito gioco di volumi che trovano nella torretta angolare,
che accoglie la scala interna
di distribuzione per tutti i livelli, la principale
espressione. La villa presenta una sobria
decorazione costituita da incorniciature che sottolineano le
aperture e da uno schematico
ordine architettonico che conclude i volumi principali con
lesene e trabeazioni. Singolare
l’apertura tripartita che caratterizza l’ultimo piano
della torretta belvedere dalla essenziale
conclusione merlata di sapore orientaleggiante. L’edificio
presenta una scala a tenaglia
rivestita in marmo bianco che costituisce l’ingresso
principale e conserva esempi di ringhiere
in ferro battuto alcune delle quali originali. E’ sottoposta
a vincolo da 12 aprile 1989».
|
|
 |
Villa
Consoli Marano (1885)
Via
Etnea, 569 - Salvatore Giuffrida
«La
villa, progettata da Salvatore Giuffrida su commissione dell’industriale
Consoli Marano, è composta da due corpi parallelepipedi
collegati da una serra in ferro e vetro. Il prospetto
principale è impostato su un alto basamento a ricorsi
intervallati da listelli orizzontali in pietra bianca. L’ingresso
dell’edificio, rialzato e accessibile attraverso una scala,
è collocato all’interno di un arco ribassato posto sul
prospetto principale. Le pareti esterne presentano la
superficie muraria liscia e sono arricchite da un balcone
continuo con ringhiera sul quale si affacciano finestre
incorniciate da pietre da taglio. Nel giardino della villa
sorge un padiglione (chalet) di fine Ottocento, attribuito
dagli eredi di famiglia all’architetto Filadelfo Fichera
(1850-1909), che si mostra a pianta rettangolare con copertura
spiovente, rialzato ed accessibile mediante una scalinata in
marmo. Il prospetto principale è riccamente decorato da
rilievi figuranti scene di caccia, elementi floreali e statue
di nudi femminili».
|
|

|
Palazzo
Zappalà Asmundo (1911)
Via
Etnea, 544 - Salvatore Sciuto Patti
«Tra
il 1909 e il 1911, l’ingegnere Salvatore Sciuto Patti
progetta per il barone Giuseppe Zappalà e la moglie, donna
Anna Grimaldi Asmundo, l’ultimo piano del loro palazzo posto
ad angolo tra via Etnea e piazza Borgo. I nuovi ambienti
vengono destinati ad una sorta di “laboratorio delle arti”
nei quali trovano posto il Teatro Minimo e il giardino d’inverno,
preziosi esempi di un rinnovamento culturale ed artistico nato
sulla scorta della corrente europea dell’art nouveau. La
luce e i colori che pervadono i nuovi ambienti sono ottenuti
dalle ricche finiture e dalle preziose decorazioni di
Alessandro Abate. A sud, aperta sulla terrazza, è la serra
per la quale l’architetto disegna diverse soluzioni seguendo
una moda travolgente in tutta Europa che, nello spirito delle
nuove correnti stilistiche, tende a contrapporre alle
classiche vetrate istoriate, tipiche delle decorazioni degli
edifici religiosi, la vetrata “profana” dai motivi liberty
e naturalistici. Sotto la spinta della creatività del
progettista lo spazio diventa un luogo di fusione delle arti,
una produzione che rappresenta
una vera e propria esperienza di coinvolgimento collettivo
delle maestranze locali».
|
|
 |
Villa
Bonajuto
Corso
Italia, 266 - Ing. Giovanni Severino - Arch. Paolo
Lanzerotti
Villa Bonajuto, costruita nel 1929 su progetto
dell’ingegnere Giovanni Severino, venne ultimata
nel 1934 dal geometra Domenico Corsaro,
collaboratore di Paolo Lanzerotti, come attesta il
progetto originario presente all’Archivio storico
comunale. L’impianto è costituito da due piani
fuori terra ed è formato da tre volumi degradanti
lateralmente. Il prospetto su corso Italia è
caratterizzato dalla loggia-terrazza ad arco
ribassato sorretta da colonne, a di sopra della
quale è l’attico a torretta con balcone centrale
decorato da una mostra mistilinea. Sul prospetto
si apre una loggia semicircolare delimitata da una
balaustra le cui colonne sono sostegno del
balconcino del piano superiore sul quale si
affacciano tre aperture affiancate. Nel 1985 la villa
venne in gran parte demolita lasciandola mutilata
quasi dell’intera parte ovest. La sospensione e
l’imposizione del vincolo il 3 luglio 1985 hanno
scongiurato la perdita dell’insigne esempio di
architettura. Sono in corso lavori di restauro».
|
|
 |
Palazzo
Musumeci
VIiale
XX Settembre 76 - Luciano Nicolosi
«Il
palazzo Musumeci, vincolato il 27 luglio 1984, di impostazione neoclassica, viene costruito ai primi del
Novecento su progetto attribuito all’ing. Luciano Nicolosi e
realizzato dall’impresa edile Alfio Distefano. L’edificio,
che si articola attorno ad un cortile interno, è costituito
da un piano rialzato e da un piano nobile, dalle facciate ad
intonaco rosa arricchite da paraste bugnate. L’ingresso all’edificio,
posto in posizione mediana rispetto alla facciata principale,
avviene attraverso un portale affiancato da colonne che
sorreggono il balcone del piano nobile, arricchito da una
balaustra a colonnine e sormontato da un frontone curvo
spezzato nel quale è posto uno scudo araldico. Le aperture
sono riquadrate da stipiti con cornici poco sporgenti e
balconi “alla romana” con balaustre, altre sono coronate
da un frontone triangolare spezzato e balconi aggettanti in
pietra, sorretti da mensole intagliate. Una ricca trabeazione
composta da un fregio decorato alternato a mensole intagliate
corre lungo il perimetro dell’edificio». |
|

|
Palazzo
Monaco
viale XX Settembre 39 - Proprietà attuale: INPS
Uso attuale: sede degli uffici dell’INPS
Anno di
costruzione: 1915 ca. Architetto: Luciano Nicolosi,
rifacimenti di Paolo Lanzerotti
Decoratori: Alessandro Abate (decorazioni pittoriche),
Salvatore Gregorietti (decorazioni pittoriche) Palazzo Monaco si presenta come un volume massiccio
vivacizzato più che nel disegno degli spazi nell’uso degli
elementi decorativi: le cariatidi e i telamoni dello scultore
Mario Moschetti, i vivaci inserimenti fitomorfi in ferro
battuto e i frontoni curvilinei spezzati da volute che cingono
i portali. All’interno il ruolo degli elementi decorativi
scultorei e pittorici è ancora più importante: gli ambienti
sono impreziositi dai ferri battuti, dagli elementi in ghisa,
dagli stucchi e soprattutto dai dipinti murari ai quali
lavorò Alessandro Abate, uno dei pittori più richiesti dalla
nobiltà e dall’alta borghesia di inizio Novecento, il
palermitano Salvatore Gregorietti e certamente altri anonimi
decoratori. Le stanze più importanti sono così animate da un
apparato che miscela linguaggi liberty e dèco: le
composizioni di figurine femminili e di puttini di intonazione
settecentesca, i paesaggi di gusto orientalista, i disegni di
fiori, nastri, foglie e animali di chiara impronta liberty
convivono con figure geometriche più tipicamente dèco come
il motivo dei dischi e delle onde.Curiosità: I Telamoni
derivano dal mito greco di Atlante che sorreggeva i pilastri
del cielo, la versione al femminile si chiama Cariatide e
cioè donna della Caria, regione dell'Anatolia conquistata dai
greci, le cui donne furono rese schiave per aver favorito i
Persiani.
Gli ambienti interni
sono impreziositi da un apparato decorativo che unisce
linguaggi liberty e déco. All’interno opere di Alessandro
Abate (1867-1957), Salvatore Gregorietti (1870-19529 e
sculture di Mario Moschetti (1879- 1960). Nel 1931 il palazzo
viene ceduto all’Inps che vi ha apportato alcune
modifiche».
|

 A Catania tra
gli autori più importanti del Liberty in architettura ricordiamo: A Catania tra
gli autori più importanti del Liberty in architettura ricordiamo:
Ernesto Basile: Con villa Manganelli in Corso Italia n ° 37 di stile
moderatamente Liberty (unica opera architettonica a Catania del
prestigioso autore), ancora presente nonostante l’intento, negli
anni ’50 del secolo scorso, dei nuovi proprietari di demolirla e l’incendio
doloso subito.
Francesco Fichera, allievo di
Basile, ma indipendente nel gusto e
nelle soluzioni creative, resta l’esempio più forte dell’architettura
liberty catanese anche che permea di individualistiche stravaganze.
Esempi architettonici di notevole pregio di questo autore li
ritroviamo in Villa Miranda al Viale XX Settembre n ° 64 (con la sua
opera più ‘’basiliana’’ quasi un compendio dei più noti
motivi stilistici del maestro), nella clinica Vagliasindi in Piazza
Cavour n ° 19, nella
Palazzina per la Società Elettrica in Piazza Trento e infine in villa
Majorana in via Androne n ° 36 .
Paolo Lanzerotti: Poche cose rimangono di questo autore dopo le
distruzioni delle sue opere migliori (Villa D’ Ayala che sorgeva
all’incrocio tra Viale Libertà e Corso Italia, Villa per Lina
Farnè alla Barriera e Villino Priolo in via Androne), ancora presenti
sono Villa Pancari in via Acque Casse , Casa Lanzerotti e Casa Benati
in via Oberdan 141 e 119 e la villetta in Via Vincenzo Giuffrida 35.
Tommaso Malerba: Ci rimane se pur continuamente irretito da insegne al
neon di tutti gli stili e da periodiche tinteggiature ‘’parziali’’
il graziosissimo negozio Frigeri, addossato all’abside della
Collegiata, inoltre ricordiamo il palazzo Marano in Via Umberto 272 e
Palazzo Abate in via Carmelo Abate 12.
Carlo Sada:
Milanese radicatosi a Catania, l’architetto
mieteva successi professionali in città e provincia, diventando in
breve l’architetto alla moda: non c’era famiglia altolocata che non
se ne servisse e anche la media borghesia ritenne qualificante poter
sfoggiare un edificio di sua mano. Oltre al Teatro Massimo, progettò
i prospetti sia per il Palazzo del conte del Grado, in via Etnea, e
del Palazzetto Nicotra, in via Umberto. Altrettanto ricchi e
ridondanti di motivi decorativi erano i suoi progetti per gli
arredamenti di alcune residenze. A Grammichele (CT) si trova un
edificio nobiliare costruito da Sada, oltre all'attuale palazzo
comunale. Esempio
modernista realizzato dall’autore lo ritroviamo nella Clinica
Clementi di Piazza Santa Maria del Gesù.
Carmelo
Malerba Guerrieri: Di questo autore ricordiamo Villa Ardizzone in
viale Mario Rapisardi 114 in cui si trovano riunite scenografia
barocca e ornamentazione liberty.
Vanno infine citati
Fabio Majorana (“Palazzo
Rosa” in via 6 Aprile n. 19) e Fabio Cantarella (palazzo in via
Caronda n. 90)
http://www.legambientecatania.it/Dossier/salvalarte/Salvalarte2008_%20Liberty.pdf

Villa De Luca - Via Androne
(anno di costruzione
1915 circa, autore Salvatore Giuffrida (attribuzione)
Controversa è l'attribuzione
dell'autore della villa De Luca, a tutt'oggi sconosciuto, ritenuto
da taluni opera del geometra Salvatore Giuffrida, da altri di un
allievo della scuola di Francesco Fichera.
L' architettura si mostra in uno
scorcio angolare, distribuita su due piani e caratterizzata da una
loggia ottagonale architravata le cui colonne con capitelli sono il
sostegno del terrazzo sovrastante delimitato da un parapetto in
cemento e ferro battuto. I prospetti, al piano terra, presentano un
bugnato orizzontale sul quale si aprono finestre ad arco ribassato
con piattabanda in pietra, mentre le pareti del piano superiore sono
trattate con intonaco bianco e aperture ad arco e bifore contornate
da raggiera bugnate.
Medaglioni e girali floreali
decorano le lunette delle aperture e la fascia sottotetto. L'
accesso all'edificio avviene attraverso un cancello in ferro battuto
che immette nel giardino che circonda la villa.
(Descrizione della Soprintendenza
ai beni culturali)
grazie a Milena Palermo per
Obiettivo Catania
https://www.facebook.com/ObiettivoCatania/
CASA EMANUELE - Via Androne, 15
(anno di costruzione
1922,autore Francesco Fichera)
In via Androne, nel tessuto
suburbano di fine '800 che ormai negli anni '20 comincia a prendere
spessore urbano, tra costruzioni neoclassiche e "moderne"tra cui la
Villa Majorana, lo stesso Francesco Fichera, a distanza di circa 10
anni dalla villa, progetta su un "lotto incluso ",allungato in
profondità e con breve affaccio su strada, una nuova tipologia di
palazzetto signorile a due elevazioni, con piano semicantinato,
interpretato formalmente in stile dèco.

Con ambiti giorno posti sulla via
Androne e ambienti notte e di servizio sviluppati in profondità,
prospicienti sul piccolo giardino interno e la chiostrina ,egli
adegua le necessità della committenza alla irregolare forma del
terreno a disposizione.
Nell'unico prospetto su strada,
ornato e configurato secondo il gusto del nuovo stile "Anni '20",il
Fichera "disegna"con citazioni neobarocche astrattizzate la veste
decorativa della costruzione che si inserisce nel contesto
ambientale classicheggiante in modo lieve,ma non di poca forza
figurativa.
L' impaginato del prospetto
,organizzato su una superficie regolare di forma geometrica
quadrata, viene dal progettista, di fatto,modellato da due ali di
fabbrica appena aggettanti, che non determinano alcuna articolazione
all'interno ma hanno solo lo scopo di suddividere il piano-facciata
in 3 parti.Determinate da ribaltamenti in V2,esse si pongono come
parti correlate di un insieme, reso in equilibrio complessivo non
più statico ma di tipo dinamico.
Il Fichera consapevole degli
"effetti "che i rapporti e i criteri di ragione logica in funzione
di numeri irrazionali imprimono alle configurazioni, determina con
successivi ribaltamenti in V2,V6,V8,V9 anche gli allineamenti in
verticale, gli orizzontamenti e gli assi su cui pone e relaziona gli
elementi funzionali e decorativi dell'edificio.
Con propria sensibilità e cultura
artistica, il progettista propone un'armoniosa facciata-superficie
dinamica, ordinata e di qualità architettonica che però non ha
alcuna relazione col disegno in pianta degli ambiti (vedi ad
esempio, le nicchie poste nel prospetto che non vengono denunciate
all'interno),che "si espone "e si "esibisce ":fatta per apparire ed
essere ammirata.
Tra continuità col passato e
modernità, forme classiche geometrizzate (lesene, capitelli,
nicchie, dentelli, forte cornicione, decori a spirale);richiami
"viennesi"e di cultura tessile semperiana;ideologie dèco (lanterna
sull'ingresso, compostezza secessionista, intonaco indagato in
spessore e forme diverse, intonaco
listato,arricciato,borchie,perline a collane)l'oggetto
architettonico ideato dal Fichera vibra di spazialità e tensione
"ricreata",ma come un "oggetto autoreferenziale ",si "mostra "nello
spazio ma non "vive"lo spazio.
L' edificio ,oggi, si ritrova
inserito all'interno di una cortina edilizia alquanto disomogenea,
costituita da alti palazzi speculativi costruiti negli anni '50-'60
che incombono al suo intorno, ma esso emerge per la sua compostezza
e rigore formale, per l'austero e leggiadro disegno della facciata e
la ricercatezza nel trattamento dei materiali e dei dettagli
decorativi. La costruzione, di fatto, manifesta il suo intrinseco
valore simbolico di arte e di architettura qualificando
culturalmente il contesto urbano e l'ambiente che lo include. -
(Testo descrittivo della
dottoressa Mariateresa Galizia)
grazie a Milena Palermo per
Obiettivo Catania
https://www.facebook.com/ObiettivoCatania/

Carlo
Sada (Milano, 1849 – Catania, 1924) è stato un architetto italiano.
Iniziò
gli studi presso le scuole serali dell’Accademia di Brera e in
seguito si spostò a Roma presso l’Accademia di Santa Lucia. dove
conseguì il titolo di architetto.
L’esperienza
determinante per la sua carriera è data dal “Progetto per il
completamento del teatro Nuovaluce" di Catania.
La
vera scuola per Sada è stata il cantiere. Il suo maestro Andrea Scala
riservava per sé la realizzazione dei progetti che redigeva, mentre
affidava ai propri collaboratori i disegni esecutivi e la
realizzazione delle proprie opere. Sada, anche da architetto
affermato, continuò, invece, a spendere grandi energie nella
direzione dei lavori, restringendo al minimo il margine di autonomia
delle maestranze, alle quali forniva grandi quantità di particolari
costruttivi e decorativi.
Nell’arco
della sua attività egli redasse ben sette progetti per edifici
teatrali e progettò anche un teatro per la città di S. Josè di Rio
Prado, in Brasile, ma fu realizzato solo il Teatro Massimo Bellini di
Catania. In realtà non si tratta di un progetto originale: in questo
caso si trattò di un complesso lavoro di interpretazione e sintesi
per il completamento di un’ opera già iniziata da altri.
Radicatosi
intanto a Catania, l’architetto mieteva successi professionali in
città e provincia, diventando in breve l’architetto alla moda: non
c’era famiglia altolocata che non se ne servisse e anche la media
borghesia ritenne qualificante poter sfoggiare un edificio di sua
mano. Progettò i prospetti sia per il Palazzo del conte del Grado, in
via Etnea, e del Palazzetto Nicotra, in via Umberto. Altrettanto
ricchi e ridondanti di motivi decorativi erano i suoi progetti per gli
arredamenti di alcune residenze. A Grammichele(CT) si trova un
edificio nobiliare costruito da Sada, oltre all'attuale palazzo
comunale.
Ha
progettato i prospetti della Basilica Collegiata "Maria SS.
dell'Elemosina", della Chiesa dell'Annunziata, della Chiesa del
SS. Rosario di Biancavilla (Ct). È anche l'autore di diverse cappelle
gentilizie nel Cimitero Monumentale di Catania: la cappella Sisto
Alessi (1884), la cappella Spampinato (1900) e la cappella Tomaselli
(1905).
|
LE
SUE OPERE PRINCIPALI |
|
 |
Ex
Clinica Clementi
Anno di
costruzione: 1901 - 1904 Architetti: Carlo Sada
-
L’edificio
venne realizzato su progetto di Carlo Sada, autore del Teatro
Massimo Bellini che in questo caso si esprime in un linguaggio
profondamente rinnovato dall’ondata art nouveau che aveva
conquistato la Sicilia insieme al resto d’Europa. Il risultato
è intelligente, moderno e armonioso: la facciata imponente è
svuotata da grandi aperture che consentono l’entrata da
protagonista della luce, simbolo di salute e di prosperità per
il sanatorio, uso originario dell’edificio. Il piano terra è
forato dal grande portale centrale circoscritto da sei balconi;
nel primo piano si ripete la stessa alternanza di vuoti e pieni
con due grandi finestroni che delimitano un balcone a tre luci
sormontato da un abbaino di forma circolare inserito entro
complesse volute ed elementi decorativi che ricordano un gusto
eclettico e un po’ pompier caro a Sada. Due grandi finestre
sul tetto spiovente accentuano il ruolo primario della
luminosità e concorrono a disegnare un corpo agile e vivace
intriso dai principi fondamentali dell’architettura liberty:
una struttura nella quale gli elementi portanti coincidono con
quelli decorativi e nella quale la massa è il più possibile
svuotata. |
|

|
Palazzo
Libertini Scuderi (1905)
Via
Etnea, 478 - Nella Palazzina Raddusa, poi di Schininà
marchese di Santelia, e in seguito Libertini, vincolata il 19
aprile 1984, Carlo Sada «si ispira al passato, ad un
rinascimento rivisitato con il barocchetto alla francese
semplificato nelle forme e nelle decorazioni. La redazione degli
elaborati di progetto impegna l’architetto milanese per un
lungo arco di tempo» e i disegni vengono pubblicati nel 1907
nella rivista «L’Edilizia Moderna». «Sada realizza, tra due
strade principali di Catania, un volume che con la sua massima
regolarità d’impianto e simmetria dichiara la severità del
prospetto principale di rappresentanza su via Etnea,
contrapposto ad una maggiore apertura prospettica su via
Caronda, dichiarata dal loggiato al piano terra, e da un’ulteriore
suddivisione in elevazione. Dai due piani su via Etnea si giunge
ai quattro su via Caronda. Su quest’ultima l’aspetto di
intimità è accentuato da un giardino all’italiana» |
|

|
Palazzo
del Grado (1907)
Via
Etnea, 193 - «Agli inizi del ventesimo secolo i conti Del
Grado incaricano l’architetto milanese Carlo Sada di redigere
il progetto per la propria abitazione su via Etnea. Non si
tratta di una costruzione ex novo, ma della ristrutturazione di
un edificio preesistente, probabilmente realizzato all’inizio
dell’Ottocento e articolato in due parti: un corpo destinato a
residenza padronale su via Etnea ed uno destinato all’affitto
su via Sant’Euplio. Tale scomposizione del volume è
rispettata nel progetto di Sada e nella realizzazione. L’edificio,
vincolato l’11 ottobre 2007, costituisce un esempio di
architettura eclettica annoverabile nell’ambito dello stile
Impero di impronta francese imposto a Parigi da Charles Garnier,
lo stesso che ha ispirato l’architetto milanese in molte sue
opere. Da sottolineare come Sada, nell’intervento di
ristrutturazione, ricorra alla tecnologia del ferro. Questo
materiale, con funzione di supporto alla muratura, gli consente
la realizzazione di spazi liberi». |
|
 |
Teatro
Massimo Bellini
Il
teatro fu inaugurato la sera del 31 maggio 1890, con l'opera
Norma del compositore catanese Vincenzo Bellini. Il progetto
iniziale del teatro è dell'architetto Andrea Scala, in seguito
vi apportò modifiche il suo collaboratore Carlo Sada, che gli
succedette nella direzione dei lavori.
La
facciata del teatro si ispira al classico sansoviniano della
Biblioteca di Venezia. Il resto dell'immobile, però, se ne
distacca nello sviluppo laterale, assumendo la forma di teatro.
La
sala a quattro ordini di palchi oltre il loggione, è di grande
ricchezza decorativa e di gusto aristocratico. Il soffitto è
affrescato dal pittore Ernesto Bellandi con immagini di Bellini
e delle sue maggiori opere: Norma, La sonnambula, I puritani e
Il pirata. Il sipario storico, illustrante la Vittoria dei
catanesi sui libici, è del pittore catanese Giuseppe Sciuti.
Nel ridotto, molto ampio ed elegante tutto marmi e stucchi,
notevole è la statua in bronzo di Vincenzo Bellini, opera di
Salvo Giordano. |
|

|
Villa
Letizia Corso
Italia
Le foto che riprendono la solitaria villa Carnazza, realizzata dall’architetto
Carlo Sada, risalgono al 1903-1904 perché non vi è ancora traccia del giardino impiantato
successivamente sulle rocce bonificate e della dependance adibita a studio professionale e per
accogliere la biblioteca (ancora esistente in via Gabriello Carnazza) di testi giuridici che conserva anche
i volumi scritti dallo stesso Gabriello che fu avvocato, docente di diritto romano all’università
di Catania e ministro dei Lavori pubblici dal 1922 al 1924.
Dopo la scomparsa dell’illustre personaggio, la villa venne acquistata
nel 1937 dall’Amministrazione provinciale per essere adibita a residenza del prefetto e prese
il nome di “Villa Letizia”. Ad abitarvi, per primo, fu il prefetto
conte Antonio Cesare Vittorelli.
Con l’acquisto dell’’ex villa Carnazza si erano raggiunti due obiettivi:
conferire maggiore dignità al prefetto con una sede di rappresentanza
prestigiosa e confortevole
e rendere disponibile agli uffici provinciali l’ultimo piano dell’ex
convento dei Minoriti adattato dal 1868 ad abitazione dei prefetti destinati alla città etnea.
Erika Abramo - dalla rivista della Provincia di Catania |
|
 |
Palazzo
Pancari Ferreri
Via
Etnea, 306 - Anno Di Costruzione: 1881-1900/ inizio -
Architetto: Carlo Sada (1849-1924)
L'edificio
ubicato in Via Etnea, angolo Via Umberto I, insiste su un'area
coinvolta dalle ristrutturazioni urbane di fine Ottocento. E a
tale epoca (1875 prime proposte-1892 completamento) che risale
la decisione del Consiglio comunale per l'allargamento della Via
Santa Caterina, attuale Via Umberto I, in asse con l'ingresso
della Villa Bellini. A seguito di tale intervento urbanistico la
famiglia Fischetti commissiona nel 1881, all'architetto Carlo
Sada, la costruzione del proprio palazzo. Nel progetto
originario, come per le tre case signorili progettate
dall'architetto milanese, sono previsti oltre all'abitazione del
proprietario anche diversi appartamenti da destinare alla
famiglia o ad affitto. Tipologicamente l'autore adotta soluzioni
in uso nelle case di fitto milanesi, come la corte interna
aperta su di un lato () le anticamere di disimpegno delle stanze
raggruppate attorno alle scale principali di servizio. Nel 1885
è previsto un ampliamento del corpo di fabbrica a nord
della...ed alcune variazioni della copertura e alla fine
dell'Ottocento l'edificio risulta quasi interamente completato.
Agli inizi del Novecento il barone Pancari acquista il palazzo
ed affida allo stesso Sada l'incarico di apportare modifiche
all'esistente: il nuovo getto interessa la scala principale, il
salone dell'appartamento del primo piano, i soffitti a volta ed
infine viene richiesto all'architetto di completare
l'arredamento dell'appartamento del piano nobile. |

Dopo
solidi studi di matematica, Filadelfo Fichera (Catania 1850-1909)
consegue, giovanissimo, nel Politecnico di Napoli la laurea in
Ingegneria civile e Architettura. Tornato
aCatania, acquista notorietà con la maestosa dimora realizzata per i
Trigona duchi di Misterbianco, nel viale Regina Margherita.
Per l'inadeguatezza dei progetti Gravina e Sciuto-Cusson, nel 1876 gli
viene affidato il difficile compito della sistemazione della nuova
villa comunale, dedicata a Bellini, che doveva unire il settecentesco
giardino-labirinto del principe di Biscari con i terreni dell'orto di
San Salvatore. Supera le irregolarità planimetriche della vasta area
di 7 ettari con brillanti soluzioni di ponti, di scalinate e con viali
ed ampi spazi privilegia al funzionalità e la fruizione del parco
valorizzandone la lussureggiante vegetazione che comprende le rarità
botaniche del "Labirinto".
Dal 1897 sino alla prematura scomparsa avvenuta nel 1909, il Fichera,
in qualità di direttore dell'Ufficio Tecnico Provinciale e Comunale
di Catania, si occupa di problemi urbani di risanamento e opere
pubbliche.
Con una autentica passione di
archeologo, si impegna nella scoperta di monumenti del passato con la
prospettiva di costituire una attrazione per il turismo. Espone queste
convinzioni, valide e attualissime, nell'opera "Sul movimento dei
forestieri in Catania". Tra i più importanti ritrovamenti
archeologici ricordiamo: i resti medievali della casa Platamone, il
portale della chiesa di S. Giovanni in Fleris nella via Cestaj, unica
testimonianza della presenza dell'Ordine di Malta.
Nel 1903, durante la campagna di scavi decisa dal sindaco De Felice
per riportare alla luce i ruderi dell'anfiteatro romano (II sec. a.C.)
muore un operaio e come presunto responsabile viene arrestato il
Fichera.
La notizia desta scalpore, molti pensano che l'incidente abbia fornito
occasione di vendetta a personaggi che nel rigore morale del direttore
dell'Ufficio tecnico avevano trovato ostacolo per lucrose speculazioni
edilizie.
Dopo le vicissitudini del processo il Fichera viene assolto ma muore
per i dispiaceri patiti e la tensione psichica con la quale seguiva le
costruzione dell Ospizio per Ciechi "Ardizzone Gioeni",
ultimato dal figlio Francesco ed inaugurato nel 1911 dai sovrani
d'Italia.
La grandiosa e severa struttura, concepita in un rivisitato stile
siculo-normanno con contaminazioni gotiche, interpreta felicemente le
disposizioni testamentarie di Tommaso Ardizzone Gioeni, barone di S.
Vito e ne esalta lo spirito filantropico. Viene considerata il
capolavoro dell'architetto Filadelfo Fichera, sensibile ed illustre
esponente della cultura eclettica e del funzionalismo.
Erika Abramo - da La Rivista della Provincia di Catania
|
LE
SUE OPERE PRINCIPALI |
|
 |
Villa
Duca Trigona di Misterbianco.
Viale
Regina Margherita, Piazza Roma - Anno Di Costruzione: 1909
circa Architetto: Filadelfo Fichera (1850-1909), attribuito
Ubicata
in posizione dominante, tra Piazza Roma e il Viale Regina
Margherita, la villa del Duca Trigona di Misterbianco viene
attribuita all'opera dell'architetto Filadelfo Fichera. Il
progettista raddoppia la partitura centrale del prospetto
principale realizzando un loggiato architravato ornata da
festoni, concluso da una balausttra con statuette
reggi-lampada, che anticipa il portale principale e
costituisce un trait d'union tra spazio interno ed esterno
conferendo alla villa cittadina un'area da residenza
suburbana. L'autore alterna con la stessa libertà progettuale
prospetti lisci a bugnati, finestre con cornici lineari e
balconi dal disegno più complesso. Infine corona il volume
con un fregio scultoreo di retaggio ottocentesco, decorata da
formelle con testine zoomorfe, patere e altorilievi con scene
di putti musicanti che sottolinea la grande terrazza di
copertura. |
|
 |
Istituto
per ciechi Ardizzone Gioeni
Via
Etnea, 595 - Catania
L'stituto
dei Ciechi "Ardizzone Gioeni" nasce negli anni '90
per un atto di liberalità del filantropo Tommaso Ardizzone
Gioeni che, con testamento segreto del 10 marzo 1884, erigeva
ad erede universale del suo ingente patrimonio un
Ospizio-Spedale "in sollievo dei Ciechi indigenti d'ambo
i sessi''. La costruzione doveva aver luogo secondo "il
miglior sistema che per dette opere avranno adottate le
primarie città d'Italia". L'Opera venne progettata da
due tra i migliori architetti dell'epoca, Filadelfo Fichera ed
il di lui figlio Francesco che, alla morte del padre, la
portò a compimento. L'Istituto fu consegnato ai catanesi il
30 maggio 1911, inaugurato dai Sovrani d'Italia Vittorio
Emanuele III ed Elena di Montenegro, alla presenza del
Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti e del Cardinale
Giuseppe Francica Nava.
|
|
 |
Villa
Bellini
Oggi questo giardino così com'era non esiste più, parte ne
fu interrata, parte fu distrutta, forse in seguito alla
decadenza che seguì la morte del Principe.
Il luogo venne riadattato ed i lavori proseguirono fino al
1865. In seguito il Comune riuscì anche ad acquistare terreni
limitrofi dai Padri Domenicani e dai Padri Cappuccini, allo
scopo di allargare l'area a disposizione.
Dal 1877 iniziarono i lavori per collegare le nuove sezioni al
corpo già consolidato dei giardini pubblici, lavori che si
svolsero sotto la supervisione dell'ingegner Filadelfo
Fichera. Per il 1882 i lavori erano terminati ed era stato
creato un boschetto, solcato da un viale accessibile alle
carrozze, da una passeggiata pedonale, da un piazzale, e sulla
collinetta nord venne edificato anche un elegante chiosco,
ancor oggi distintivo del parco. L'inaugurazione del nuovo assetto avvenne nel 1883. Divenne
immediatamente uno dei luoghi di diporto più frequentati
della città, teatro di festeggiamenti, di eventi culturali,
mondani e musicali.
|
 |
Villa
Consoli Marano
Via
Etnea, 569/573 - Anno Di Costruzione: 1885 circa Architetto:
Salvatore Giuffrida (attivo 1800/fine) Filadelfo Fichera
(1850-1909) attribuito
La
villa, progettata dal Salvatore Giuffrida su commissione
dell'industriale Consoli Marano, è composta da due corpi
parallelepipedi raccordati da una serra in ferro e vetro. Il
prospetto principale è impostato su un alto basamento a
ricorsi intervallati da listelli orizzontali in pietra bianca.
L'ingresso dell'edificio, rialzato ed accessibile grazia ad
una scala, è collocato all'interno di un arco ribassato posto
sul prospetto principale. Le pareti esterne presentano la
superficie muraria liscia e sono arricchite da un balcone
continuo con ringhiera sul quale si affacciano finestre
riquadrate in pietra da taglio. Nel giardino della villa sorge
un padiglione (Chialet) di fine Ottocento, attribuito dagli
eredi di famiglia all'architetto Filadelfo Fichera, che si
mostra a pianta rettangolare con copertura spiovente, rialzato
ed accessibile mediante una scalinata in marmo. Il prospetto
principale è riccamente decorato da rilievi raffiguranti
scene di caccia, elementi floreali e statue di nudi femminili;
le aperture sono caratterizzate da finestre tripartite ad arco
ribassato con colonnine nell'accordo delle aperture,
riquadrate da semplici cornici in terracotta a listelli. Lo
chalet è circondato per due lati da una grande
terrazza. |
|
 |
Lavori
all'Anfiteatro
Al
centro di piazza Stesicoro si apre una grande trincea che
racchiude alcuni resti dell’anfiteatro romano di Catania.
Alla fine del secolo scorso (come documentano numerose
fotografie) la piazza era completamente chiusa, anzi, nel
luogo ora occupato dallo scavo erano sistemate aiuole
ornamentali. I lavori per riportare alla luce l’anfiteatro
(già conosciuto dagli studiosi di storia catanese) furono
iniziati nel 1904, per volontà del sindaco De Felice che
affidò l’impresa all’architetto Filadelfo Fichera, e si
conclusero nella primavera del 1906. L’opera fu inaugurata
ufficialmente sei mesi dopo e, nel 1907, fu visitata da re
Vittorio Emanuele III che venne a Catania per inaugurare l’Esposizione
Agricola. Il grandioso monumento romano, uno dei più grandi d’Italia,
è nascosto quasi interamente sotto le moderne costruzioni ma
è visibile al di sotto del livello stradale dove si conserva
il corridoio che gira lungo il muro del podio; l’estensione
dell’edificio interessa molte vie che si irradiano dalla
piazza Stesicoro;
|

Francesco
Fichera (Catania, 16 giugno 1881 – 14 agosto 1950) è stato un
architetto e ingegnere italiano.
Figlio dell'ingegnere Filadelfo Fichera, autore del Giardino Bellini
di Catania, conseguì la laurea in ingegneria e si diplomò in
architettura. A partire dal 1914 insegnò presso l'Università di
Catania dove fu docente straordinario, e poi ordinario della cattedra
di Disegno d’ornato e Architettura elementare. All'attività
didattica affiancò lo studio dell'architettura con i suoi scritti su
Luigi Vanvitelli e Giovanni Battista Vaccarini. Inoltre si dedicò
alla libera professione con la realizzazione di numerose opere
pubbliche e private, soprattutto nella sua città natale, Catania.
Allievo di Ernesto Basile, si discosterà presto del liberty con
richiami neo-normanni (cfr. villa Miranda a Catania) per avvicinarsi
ad uno stile più razionale. Ebbe come allievo Rosario Marletta, che
usò tuttavia un linguaggio diverso.
Ha
anche scritto per il teatro Acceddi senza nidu (Uccelli senza nido),
un dramma scritto per la compagnia di Angelo Musco e rappresentato la
prima volta a Milano nell'inverno del 1916.
Il
suo archivio è conservato presso la Biblioteca del Dipartimento di
Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria di Catania.
Principali opere: Palazzo delle Poste a Catania, Palazzo delle Poste a
Siracusa, Villa
Miranda, già del barone Reina dell'Aere a Catania (1908-09) (viale XX
settembre n. 64),
Villa Scannapieco (1909) a Catania, con ampie arcate (via Duca degli
Abruzzi), Villa Simili (1906-08) a Catania (già in viale XX
Settembre, poi Corso Italia), Sport Club (1913) a Catania (già in via
degli Archi), Cinema Olimpia (1913) a Catania, in Piazza Stesicoro,
oggi è sede di un fast-food McDonald’s, Progetto per la Villa La
Ghirlandina (1907, non realizzato) per il pensionato artistico
nazionale a Roma, Cappella Fichera (1915) nel cimitero di Catania,
Campanile (1916-24) della chiesa madre di Viagrande, Cappella Patanè
(1918) nel cimitero di Catania, Istituto tecnico industriale De Felice
(1919-29) a Catania, Istituto tecnico industriale Archimede a Catania,
Palazzo delle Poste (1919-29) a Catania
Palazzo delle Poste (1922-29) a Siracusa, Villa Inga, Lido d'Albaro a
Genova (1924-1927), Cappella Fortuna (1927) nel cimitero di Catania,
Progetto per un Arco di Trionfo ai Caduti (non realizzato) a Palermo,
Garage Musmeci (1928) a Catania (piazza Bovio), Palazzo di Giustizia
(1937-55) a Catania, Villa Majorana (1911-13) a Catania (via Androne
n. 36), con torre esagonale, Villa Mirone Deodato a Viagrande, Palazzo
del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa (1936-38) a
Ragusa, oggi sede della Camera di Commercio, Palazzo Bonaventura a
Giarre, Scuole comunali di Mineo, Clinica Vagliasindi (1911) a Catania
(Piazza Cavour n. 19), Palazzina della Società Elettrica (1911-12) a
Catania (Piazza Trento), Casa Toscano Lopò a Catania, Villa Iole
Musco (1936) a Barriera del Bosco, Catania, progettata per l'amico
Angelo Musco, con statue allegoriche dello scultore Carmelo Florio
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Fichera
|

LE
SUE OPERE PRINCIPALI |
|
 |

|

|
|
I.T.I.
Archimede
Viale Regina Margherita |
Tribunale
di Catania
Piazza G. Verga |
Palazzo
delle Poste
Via Etnea |
|
 |

|
 |
| I.T.C.
De Felice
Piazza Roma |
Garage
Musmeci Piazza
G. Bovio |
Palazzo
Bonaventura Giarre |
|
 |
 |

|
| Casa
Fichera Via
Caronda |
ex
Clinica Vagliasindi Piazza
Cavour |
 |
Villa
Miranda
Viale XX Settembre, 64 - Anno Di Costruzione: (1905-1906) -
Architetto: Francesco Fichera (1881-1950)
Villa Miranda, nota anche come Villa Reina dell'Aere del Conte,
o Villa Dorina, si inserisce in quell'intensa attività edilizia
che caratterizzò l'ambiente architettonico catanese nel primo
ventennio del Novecento. Tipologicamente risponde alla tipica
abitazione gentilizia su due elevazioni nella quale la soluzione
ad angolo è risolta dalla torretta belvedere che si innesta
sulla trabeazione e conferisce leggerezza a tutta la struttura.
Il piano terra è trattato interamente in finto bugnato, mentre
la superficie della dacciata del primo piano si presenta liscia,
rafforzata dal bugnato delle paraste angolari. I prospetti sono
scanditi dall'alternanza ritmica delle aperture, conferendo
all'insieme un effetto chiaroscurale. Alcune aperture sono
sormontate da ghiere di falsi conci, mentre altre presentano
l'arco rinascimentale a raggiera bugnata. Motivi naturalistici a
traforo decorano le cornici delle finestre di tutto l'edificio.
Nel prospetto posteriore è presente una loggia con colonne al
di sopra della quale è la piccola terrazza del piano
superiore. |
|
 |
Palazzina
Energia Elettrica
Piazza
Trento - Arch. Francesco Fichera
«L’edificio,
vincolato il 7 agosto 2008, a pianta regolare, si sviluppa
volumetricamente come un parallelepipedo nel quale la partitura
centrale si mostra leggermente aggettante. Sopra un basamento in
pietra lavica il prospetto presenta al piano terra un bugnato
orizzontale arricchito da formelle color terracotta recanti l’effigie
della Trinacria, mente il piano superiore, dal paramento murario
liscio, è caratterizzato da un corpo centrale arricchito da tre
aperture tripartite con parapetto a balaustra. Fasce marcapiano
color terracotta corrono lungo il perimetro dell’edificio il
cui coronamento è costituito da un terrazzo. Eleganti e
raffinati gli arredi che Fichera disegna in armonia con la
funzione che l’edificio ospita» |
 |
Palazzo
Mirone
Ubicazione: C.so Italia, 147 - Anno di costruzione: 1937 -
Architetti: Francesco Fichera
E’
un esempio sobrio e riuscito dell’evoluzione di un artista
che, partito da premesse e insegnamenti liberty, passa a un’impostazione
dèco per poi adottare un linguaggio moderno e di chiara
intonazione razionalista. Nel corso della nostra passeggiata è
interessante soffermarsi su questa palazzina borghese proprio
per notare l’armoniosa evoluzione stilistica dell’architettura
di Francesco Fichera. Il piano terra dell’edificio risente
ancora degli artifici del gusto decò con i due archi a tutto
sesto che contengono una grande apertura rettangolare. Più
mossi e lineari al tempo stesso il primo e il secondo piano
caratterizzati dal rivestimento a cortina e da vivaci giochi di
pieni e di vuoti creati dalle finestre e dai balconi posti negli
angoli e tesi a svuotare la massa poderosa del cubo. |
 |
Villa
Josè - Musco
Via Leucatia, 47 - Anno Di Costruzione: 1900/inizio scuola di
Francesco Fichera (1881-1950)
Di autore ignoto, villa Josè viene costruita nel primo quarto
del XX secolo come testimonia il "piano topografico della
città e suburbio di Catania" redatto nel 1928. La
prossimità con la coeva Villa Jole e l'analogia di taluni
aspetti tipologici spingono gli studiosi a ritenere la
costruzione opera di allievi del più noto architetto Francesco
Fichera. L'impianto volumetrico dell'edificio è costituito da
due avancorpi laterali simmetrici e da un corpo centrale
arretrato rispetto al filo di facciata, con portale d'ingresso
sormontato da pensiline in ferro battuto, che riprende il motivo
del timpano adottato nelle aperture. Nella parte sommitale, al
centro, è posta una piccola altana con ringhiere e sostegni
verticali in ferro battuto che sorreggono la copertura
riprendendo forme dalla geometria rigorosa. I prospetti,
trattati ad intonaco liscio di color rosa evidenziano l'attenta
proporzione tra la superficie delle aperture e quelle della
facciata. Le cornici marcapiano ed il fregio decorato con
archetti contribuiscono ad equilibrare tra di loro i corpi di
fabbrica. C.S. |
|
|
Casa Lazzara
Via De Felice, 32Anno Di
Costruzione (1919)
Architetto: Francesco Fichera
(1881-1950)
Nel 1919 l'architetto
Francesco Fichera realizza Casa Lazzara. L'edificio dal precoce
tono dèco, appare costituito dall'accostamento di volumi puri -
la pseudo torretta d'ingresso e gli ambienti abitativi - nei
quali la rielaborazione dei repertori Liberty approda ai più
diffusi motivi iconografici del tempo. Nel candore che investe
l'intera facciata si manifesta l'idea tersa e schematica dei
modelli secessionisti; in essa, la linea perde la sua fluidità
per assumere un andamento ripiegato, a ricciolo, evidente sia
nelle lavorazioni del ferro battuto che nel decoro che conclude
l'ampia apertura arcuata e tripartita. Il senso dell'artificio
toglie il respiro naturale delle figure fito ed antropomorfe,
che rimandano al tema dei mascheroni teatrali coronati da
grappoli di frutta tondeggianti- Immancabile la presenza del
canestro di rose che conclude l'ultimo ordine della partitura
d'ingresso ed il ricorso al tema del ventaglio che appare nella
mofologia compositiva del balcone e nel decoro della ritmica
successione delle aperture del piano nobile, casa Lazzara
rappresenta uno dei migliori esempi d'architettura dèco
siciliana, nella quale Fichera riesce a coniugare motivi
iconografici propri dello stile, elementi caratterizzanti la
tradizione locale, come l'uso della pietra lavica e temi propri
del suo repertorio compositivo come la presenza della nicchia.
Rispetto al progetto originario, di cui si conserva uno schizzo
nell'archivio stocico del comune di Catania, si osserva la
sopraelevazione dell'ultimo piano nell'area della terrazza,
intervento che annulla l'originaria spinta verticale della
torretta. privando lo spazio esterno della progettata
"torretta". A.D.
|
 |
Villa
Majorana
Via
Androne, 36 - Anno Di Costruzione (1911-1913) Architetto:
Francesco Fichera (1881-1950)
Costruita
su progetto dell'architetto Francesco Fichera, la villa,
circordata da un giardino con vegetazione mediterranea nasce
come residenza della famiglia del professore Dante Majorana. La
pianta ha uno sviluppo ad L ed i volumi sono articolati seguendo
la morfologia irregolare del lotto nel quale l'edificio è
collocato. L'accesso alla villa avviene mediante un corpo scala
posto lateralmente in posizione asimmetrica. Il perno
dell'edificio è dato dalla torretta angolare a sviluppo
esagonale, decorata da una bordura scanalata che costituisce
l'asse verticale su cui ruota tutto il resto dell'organismo. I
prospetti sono caratterizzati da un sovrapporsi di fasce
orizzontali bugnate ed intonacate, che conferiscono una
soluzione di continuità. In corrispondenza del sottotetto è
presente una cornice filiforme, con al centro formelle quadrate
decorate, che ritroviamo nelle colonne della loggia. All'interno
pregevoli pitture di Salvatore Di Gregorio (1859-1928). R.M.
|

Villa Majorana - Via Androne
(anno di costruzione
1911-1913, autore Francesco Fichera)
Costruita su progetto
dell'architetto Francesco Fichera, la villa, circondata da un
giardino con vegetazione mediterranea, nasce come residenza della
famiglia del professore Dante Majorana.
La pianta ha uno sviluppo ad L e
i volumi sono articolati seguendo la morfologia irregolare del
terreno.
L' accesso alla villa avviene
mediante un corpo scala posto lateralmente in posizione asimmetrica.
Il perno dell'edificio è costituito dalla torretta angolare a
sviluppo esagonale che costituisce l'asse verticale su cui ruota
tutto il resto dell'organismo. I prospetti sono caratterizzati da un
sovrapporsi di fasce orizzontali bugnate e intonacate che
conferiscono all'insieme una soluzione di continuità.In
corrispondenza del sottotetto è presente una cornice filiforme, con
al centro formelle quadrate decorate ,che ritroviamo nelle colonne
della loggia.
All'interno pregevoli pitture di
Salvatore Di Gregorio (1859-1928)
(Descrizione della Soprintendenza
ai beni culturali)
grazie a Milena Palermo per
Obiettivo Catania
https://www.facebook.com/ObiettivoCatania/

Progettò
il palazzo Marano (1908), il negozio Frigerio (1909), il palazzo di
piazza Duca di Camastra, la signorile palazzina del pittore Abate
(1916). Per educazione e formazione fu il più mitteleuropeo degli
architetti catanesi.
L’inaugurazione
della Villa Bellini nel gennaio 1883 portò allo sviluppo edilizio
delle zone circostanti, predisposto dal piano regolatore del Gentile
Cusa per l’espansione del nucleo settecentesco in direzione Nord-Sud
e Est-Ovest, con il prolungamento di viali da realizzarsi con assi
ortogonali. Disegno urbanistico che riprendeva la norma progettuale
del duca
di Camastra, del 1693. Nel piano di Gentile Cusa, il viale Regina
Margherita e le zone adiacenti divennero quartieri residenziali dell’emergente
ricca borghesia che affidava progetti di ville e palazzi ad architetti
allora in auge. Nella Catania che va dalla seconda metà dell’Ottocento
ai primi due decenni del Novecento all’opulenza di industriali,
proprietari terrieri, commercianti, si accompagnava una grande
vivacità culturale, scientifica, artistica, politica.
Tra
i letterati Capuana, Verga, De Roberto, Martoglio. Tra i politici, Angelo Majorana e Giuseppe De Felice. Per il numero di teatri, café
chantant, luoghi pubblici, banche, circoli, negozi, Catania era
definita “la piccola Parigi”. Nel 1905 entrava in funzione il
servizio di tram a trazione elettrica. L’eleganza, il decoro
architettonico della città di arricchiva di opere pubbliche -come la
Stazione ferroviaria (1866), il Teatro Massimo Bellini (1890) - e nell’edilizia
privata, grazie al talento di ingegneri e architetti che operavano con
uno stuolo di pittori, scultori, artigiani. Ricordiamo i protagonisti
più noti dell’esaltante e irrepetibile crescita urbanistica della
Catania del tempo. Il milanese Carlo Sada che si stabilì nella città
etnea nel 1871 per coordinare i lavori del Teatro Massimo Bellini, il
catanese Luciano Nicolosi (1855-1947), l’architetto Francesco
Fichera (1881-1950) assistente di Ernesto Basile, e Paolo Lanzerotti
(1875-1944).

Ex negozio Frigerio - Via
Manzoni/Via Collegiata (foto di Andrea Mirabella)
Negli elementi costruttivi dei menzionati architetti prevalse il
Liberty. Nel novero di questi geniali professionisti si colloca la
figura e l’opera dell’ingegnere Tommaso Malerba (1866-1962). L’ambiente
colto e raffinato della ricca famiglia dell’alta borghesia catanese
in cui nasce fornisce a “Masino”, coccolato primogenito,
importanti stimoli formativi, la possibilità di Malerba, il Genio
dell’Architettura compiere gli studi a Napoli e conseguire la laurea
in Ingegneria Civile, l’opportunità di lunghi soggiorni in Francia
e in Germania dove può cogliere dal vivo codici e tecniche delle
nuove espressioni architettoniche. L’itinerario di studio lo porta a
risiedere a Venezia. L’elegante ingegnere dal portamento austero
accentuato da imponenti baffi “prussiani” è un sensibile cultore
del bello anche nei confronti del gentil sesso. Galeotto è l’incontro
con una giovane donna intenta a dipingere sulle rive del Canal Grande.
E’ la contessina Anna Pilo di Capaci, una bellezza luminosa. Dopo il
matrimonio l’ingegnere fa ritorno a Catania, dove si inserisce nello
studio di Carlo Sada. Rivela il suo talento nelle realizzazioni di
opere autonome e originali come il Palazzo Mazzone in via Umberto, dai
codici gotico-moreschi (1900). Viene insignito nel 1904 della Croce di
Cavaliere della Corona d’Italia con la motivazione di “valoroso
costruttore dei più eleganti palazzi catanesi”. Il riconoscimento
più esaltante giunge in occasione dell’Esposizione Agricola
Catanese del 1907. Il grandioso ma effimero progetto espositivo
ispirato al Liberty diventa banco di prova per gli architetti che vi
parteciparono.
Nel chiosco della ditta Inserra, produttrice di elementi di cemento
armato, il Malerba esalta e utilizza la potenzialità del nuovo
materiale da costruzione con l’eleganza dell’ingresso arcuato e
tripartito, nell’ampia gamma di decorazioni floreali.
L’opera, decorata all’interno dal pittore Alessandro Abate, viene
considerata il capolavoro della mostra.
L’elegante edifico con cappella privata e giardino interno nel quale
Malerba abitò con la moglie, fu impietosamente abbattuto dalle ruspe
per la realizzazione del corso Sicilia. L’anziano ingegnere, vedovo
e senza prole, accudito da una governante, venne sistemato in un
modesto appartamento.
Manteneva un aspetto signorile, baffi copiosi e fluenti, una mente
lucidissima. Si spense serenamente nel 1962 all’età di 96 anni.
Nessun funerale ufficiale, ne nessun
tributo al protagonista di un’epoca.
Erika
Abramo - dalla rivista della Provincia di Catania
http://www.provincia.ct.it/informazioni/la-rivista/sommario/2007/Dicembre/filepdf/23-32.pdf
|
LE
SUE OPERE PRINCIPALI |
|
 |
Palazzo
Mazzone
Via
Umberto I, 83 - Anno Di Costruzione: 1904 circa - Architetto:
Tommaso Malerba (1866-1962)
Edificato
nel 1904 circa il Palazzo Mazzone sorge tra le vie Umberto I e
Grottebianche in una zona di espansione tardo ottocentesca.
Realizzato in pieno eclettismo catanese esso rappresenta una
delle prime esperienze costruttive documentate di Tommaso
Malerba. L'edificio si contrappone su Via Umberto I a casa
Nicotra che Carlo Sada costruisce qualche anno prima e che
progetta a partire dal 1898. La facciata viene liberamente
figurata secondo un originale stile "moresco",
consono al gusto dell'esotico e del meraviglioso utilizzato
maggiormente nelle abitazioni con giardino (Cfr. l'Arena
Pacini di Filadelfo Fichera oggi non più esistente). Il
Malerba accentua il tema del contrasto con le architetture
adiacenti utilizzando un linguaggio ricco di chiaroscuri, di
trafori di archetti, di intrecci, di superfici decorate,
inscenando un paesaggio d'invenzione. La caratterizzazione
stilistica rimane tuttavia decorativa e la tipologia
distributiva dell'edificio è tradizionale. Rilevante la
connotazione ibrida del lessico che il Malerba utilizza per
l'architettura della facciata. Il repertorio formale
eterogeneo dell'apparato decorativo attinge indifferentemente
da più stili accentuando la caratteristica eclettica e
sperimentale del suo autore. La struttura compositiva della
facciata principale è sorretta da una sequenza di pieni e
vuoti costituiti dalla presenza di piccole logge
caratterizzate da un arco polilobato, che seguendo la logica
dell'ordine architettonico, si arricchisce e si slancia mentre
la costruzione cresce fino a raggiungere l'ultimo piano. La
geometria complessiva viene imbrigliata verticalmente da
paraste aggettanti e orizzontalmente da un sistema di
trabeazioni, che marcano i livelli di calpestio, da cornici di
imposta degli archi delle aperture e da una fastoso fascione
di coronamento. L'aggetto dei balconi è della cornice di
coronamento è caratterizzato da mensole a stalattiti
(muquarnas) secondo il tradizionale lessico dell'architettura
araba. I fregi distribuiti sulla facciata interpretano stilemi
ad intrecci sia di tradizione islamica che di tradizione nord
europea secondo la cultura eclettica e anticonformista della
fine dell'Ottocento. |
|
 |
Palazzina
Abate
Via
Carmelo Abate, 12 - Anno Di Costruzione (1915-1918)
Architetto: Tommaso Malberba (1866-1962)
Piccola,
modesta ed appartata, l'abitazione-studio del pittore
Alessandro Abate (1867-1953) realizzata su progetto di Tommaso
Malerba tra il 1915 ed il 1918 è un edificio che al tempo
stesso è residenza cittadina e casa di campagna. In questa
versatile tipologia Malerba sperimenta uno schema compositivo
di facciata formato da una singolare struttura a telaio la cui
modularità costituisce la regola e mette in rilievo le
eccezioni; egli infatti, lasciandosi guidare dalle esigenze
del committente realizza un partito architettonico simmetrico
al piano terra e asimmetrico al piano superiore. Sulla scia di
un'architettura con evidenti riferimenti ai modelli già
sperimentati a Palermo da Ernesto Basile, e che Francesco
Fichera propone in questi anni a Catania (ricordiamo il
Villini Simili del 1915), Malerba realizza la facciata
arricchendola con le incorniciature delle aperture e
impiegando alcune specchiature decorate a stucco; interpreta
inoltre con morbidi profili liberty, di figurazione geometrica
e fitomorfica, le lesene e le incorniciature principali. La
facciata tutta viene elaborata e decorata come se la palazzina
fosse un grande oggetto di arredo, una sorta di teca
strutturata da cornici e specchiature. Ai fianchi del primo
ordine una coppia di lesene binate presenta nel fusto
l'invenzione di un motivo a bugne
raggruppate, esse incrociano la trabeazione del primo ordine
con un altro elemento decorativo singolare. In alto il volume
asimmetrico del corpo di fabbrica viene sottolineato dalla
prosecuzione delle lesene binate che svettano oltre la cornice
sommatale. La geometria elementare delle incorniciature viene
arricchita da elementi plastici che sottolineano i punti più
delicati degli innesti nell'ottica di rendere più vibrante la
sobria apparecchiatura ornamentale. I fregi contenuti nelle
aree circoscritte dalle cornici, si ripetono osservando la
giustapposizione dei piani. Singolare la decorazione nella
trabeazione del piano terreno costituita da elementi in
aggetto regolarmente interrotta dalle cornici verticali e che
accenna al balcone della tradizione. A conclusione
dell'edificio oltre la cornice del secondo piano, caratterizza
la facciata un doppio parapetto: pseudo il primo che si
raccorda con la cornice sottostante, reale quello più in
alto; entrambi ripetono lo schema a telaio del partito
sottostante. |
|
|
|
Palazzo
Marano Giuffrida

Via
Umberto, 272 - er la II Esposizione agricola siciliana
di Catania del 1907, Tommaso Malerba elabora alcuni progetti
dalle caratteristiche forme composite come per esempio il
chiosco dei Fratelli Inserra. Dello stesso periodo è il
progetto per il palazzo Marano Giuffrida di via Umberto.
Sulla scia del liberty Malerba caratterizza la serialità
delle apertura con una sequenza di incorniciature mistilinee
composite. Tradizione e modernismo convivono in una sorta di
esercizio di compenetrazione, di intrecci geometrici
fitomorfici che alludono a schemi ornamentali goticizzanti. E’
il coronamento del finestrone che realizza un inedito
singolare intreccio tra la cornice rettilinea dei piedritti e
quella curvilinea che conclude il finestrone. Il frontone
composito ad intrecci, messo a punto da Malerba per le
aperture, si riferisce ad uno schema già adottato per l‘Esposizione
del 1907 in cui si possono vedere analogie con il progetto
dell’ingresso del villino Deliella di Palermo di cui Ernesto
Basile pubblica un disegno, nel 1902, in “L’arte
decorativa moderna».
|

|

Palazzo
Duca di Camastra Piazza
Duca di Camastra
|
|
|
|

|

LE
SUE OPERE PRINCIPALI |
|
 |
Palazzo
Lanzerotti
Via
Guglielmo Oberdan, 119 - Anno Di Costruzione: 1915 circa -
Architetto: Paolo Lanzerotti (1875-1944)
Tipo
edilizio a pianta regolare, articolato su tre livelli, con
torretta angolare attualmente inglobata in una successiva
sopraelevazione. L'edificio, impostato su un basamento in
pietra lavica, presenta le pareti esterne intonacate
riquadrate da cornici marcapiano, decorate e delimitate da
paraste e ricorsi angolari a bugnato. A piano terra sono
presenti aperture rettangolari tripartite da esili colonnine
riquadrate da semplici cornici, mentre il piano superiore è
caratterizzato da finestre bipartite, con cornici decorate e
scandite da paraste, che si aprono su un balcone delimitato da
parapetto in pietra traforato a motivi romboidali. Aperture
tripartite con archetti a tutto sesto, che rimandano al tema
dell'oggiato, arricchiscono l'ultimo piano
dell'edificio.
|
|

|
Palazzo
Berretta
Via
Etnea 746 -
«Palazzetto, vincolato il 20 novembre 1984, su due livelli
con ingresso
laterale dalla semplice ed equilibrata volumetria. Il portale
d’ingresso è caratterizzato da una cornice bugnata e da una lunetta
arricchita da una decorazione in ferro battuto recante girale e motivi floreali.
Il prospetto, impostato su un basamento in pietra lavica, presenta al piano
terra sobrie finestre archivatrate, mentre al piano superiore vi sono
quattro balconi sorretti da mensole, con ringhiere decorate, le cui aperture
sono sormontate da un frontone triangolare aggettante. Secondo
quando documentato dall’ingegnere Michelangelo Mancini in una
relazione per il Kiwanis, l’architetto Paolo Lanzerotti progetta l’edificio
nella prima metà del novecento».
|
|

|
Villa
Zingali Tetto
Via
Etnea, 742 -
«Costruita su progetto dell’architetto Paolo Lanzerotti come residenza del professore Zingali Tetto, la villa,
dichiarata di interesse storico artistico nel 25 febbraio 1984, si sviluppa su due elevazioni ed è caratterizzata da
una torre belvedere posta ad angolo. L’ingresso principale avviene attraverso un portale bugnato a tutto sesto
mediante il quale si accede all’atrio. Oltre è il giardino
che conserva ancora piante tipiche della tradizione siciliana. Le
finestre a piano terra sono ad arco a tutto sesto con cornice a raggiera, mentre le aperture ad arco ribassato
del primo piano mostrano balconi delimitati da parapetti con balaustrini. Di pari valore compositivo è la pregevole
veranda coperta che si affaccia sul giardino, opera di Salvatore Gregorietti (1870-1952), costituita da una
struttura in ferro e vetri policromi con disegni geometrici e floreali. La villa è di proprietà dell’Università ed è
sede del Museo universitario Casa della Città».
|
|

|
Cinema
Diana
Via
Umberto, 13 - «Il cinema Diana, progettato dall’architetto
Paolo Lanzerotti su commissione del barone Filippo Pancari,
vincolato il 31 marzo 1983, venne inaugurato e aperto al
pubblico il 24 dicembre 1925. L’edificio, in linea con il
filo stradale, si sviluppa su due livelli ed è impostato su
un basamento lavico. La facciata presenta un primo ordine
archivatrato scandito da paraste composite intervallate dalle
aperture dei vani d’ingresso di forma rettangolare, mentre
il secondo ordine è scandito da paraste ioniche ed è
caratterizzato dal motivo della finestra tripartita sormontata
da un timpano triangolare che rinnova il carattere monumentale
dell’edificio. All’esecuzione dell’opera contribuirono
noti artisti in gran parte catanesi, tra cui il professore
Gaetano D’Emanuele per le decorazioni pittoriche. Alla fine
del Novecento l’edificio perde la sua originaria
destinazione d’uso divenendo negozio.
|
|

|
Negozio
Pirelli
Corso
Italia, 93 -
«La composizione dei volumi risulta attenta e articolata. L’edificio, distribuito su due
livelli, presenta un prospetto simmetrico, con facciata centrale curva e due ali laterali con
grandi aperture quadrate. La facciata, priva di ogni applicazione
decorativa, forma lo spazio architettonico con la propria struttura e l’inserimento dei due balconi
contribuisce a collegare le ali del cilindro d’angolo. Caratteristica è la pensilina a
ventaglio che taglia l’edificio nel suo punto d’angolo e
conferisce leggerezza a tutta la composizione, evitando la monotonia di un
prospetto classico»
|
|
 |
Villino
Citelli
Via
Tomaselli, 31 - Anno Di Costruzione: (1904-1907); 1914 -
Architetto: Paolo Lanzerotti (1875-1944), attribuito -
Salvatore Sciuto Patti (1877-1926)
Pur
in assenza di fonti, il progetto del villino del Dottore
Citelli, da adibire a studio e ad abitazione, viene attribuito
all'architetto Paolo Lanzerotti. L'edificio si sviluppa su tre
livelli; si accede mediante una breve scala dal corrimano
sorretto da balaustrini in finta pietra. Il prospetto è
caratterizzato da un apparato decorativo di gusto neo-gotico.
Al piano terra le finestre presentano lunette con rilievi
raffiguranti volti muliebri e figure allegoriche, mentre al
piano superiore si affaccia una loggia centrale tripartite da
colonnine tortili e due balconi con parapetto traforato
decorato da rombi e motivi floreali stilizzati. Corona la
facciata una fascia recante archi inflessi trilobati e
formelle che segna il periodo dell'edificio. Attraverso una
torretta merlata ornata da protomi si arriva alla copertura a
terrazza. Nei restanti prospetti ritroviamo lo stesso partito
decorativo. Nella parte retrostante del villino, tra il
giardino e la via Giovanni Paola si trova il volume della
"rimessa" progettata nel 1914 dall'ingegnere
Salvatore Sciuto Patti. Nel 1962 la villa viene donata dalla
famiglia all'Università degli Studi di Catania. C.S. |
|
 |
 |
 |
|
Villa
Pancari Via
Acque Casse |
Palazzo
Comm. Bruno Ispica
(RG)
|
|
 |
 |
|
ex
BirrariaSvizzera Via
Etnea angolo Piazza Stesicoro.
|
Villa
Bonajuto Corso
Italia
|
VILLINO CITELLI
(Via Tomaselli, anno di
costruzione 1904/1907,autore Paolo Lanzerotti)
Pur in assenza di fonti
documentarie,il progetto del villino del dottore Citelli, da adibire
a studio e abitazione, viene attribuito all'architetto Paolo
Lanzerotti.

L' edificio si sviluppa su tre
livelli ai quali si accede mediante una breve scala dal corrimano
sorretto da balaustrini in finta pietra.
Il prospetto è caratterizzato da
un apparato decorativo di gusto neogotico.
Al piano terra le finestre
presentano timpani con altorilievi raffiguranti volti muliebri e
figure allegoriche, mentre al piano superiore si affacciano una
loggia centrale tripartita da colonnine tortili e due balconi con
parapetto traforato decorato da rombi e motivi floreali stilizzati.
Corona la facciata una fascia recante archi inflessi trilobati e
formelle in terracotta che segna il perimetro dell'edificio.
Attraverso una torretta merlata,
ornata da protomi, si arriva alla copertura a terrazza. Nei restanti
prospetti ritroviamo lo stesso partito decorativo. Nella parte
retrostante del villino, tra il giardino e la via Giovanni Paola,si
trova il volume della rimessa progettata nel 1914 dall'ingegnere
Salvatore Sciuto Patti .
Nel 1962 la Villa viene donata
all'Università degli Studi di Catania dalla famiglia Citelli.
(Descrizione della Soprintendenza
ai beni culturali)
grazie a Milena Palermo per
Obiettivo Catania
https://www.facebook.com/ObiettivoCatania/
All'angolo
fra Viale Libertà e Corso Italia, una volta c'era
Villa D'Ayala, su progetto di Paolo Lanzerotti.

LA TRISTE STORIA DEL CONTE
AYALA,CATANIA
Questo scatto degli anni '30
dello scorso secolo,ritrae Villa Ayala e Villa Simili in Corso
Italia (ad angolo con Viale Libertà).
Villa Ayala fu un'opera dell'Arch.Paolo
Lanzerotti,realizzata nel 1914. Era una dimora fastosa,un vero e
proprio esempio di "Liberty" a Catania,che il Lanzerotti esegui' per
il Conte Saverio Francesco D'Ayala.
La Villa era composta da un piano
terrano e due piani sopraelevati,circondati da un giardino a
verde,che si può scorgere dalla foto postata.
Ma il Conte l'abitò solo per
pochi anni,a causa di evento triste,luttuoso. La Sua unica figlia
mori',a soli quattro anni,accidentalmente.
Cosa successe? La bimba si
arrampicò,purtroppo,nella ringhiera del lucernario,ma perse
l'equilibrio e precipitò nel salone sottostante,morendo,dopo un
tragico volo,sul colpo.
In conseguenza di questo ed
affranto dal dolore,il Conte Ayala vendette tutto e lasciò per
sempre Catania.
Villa Ayala fu abbattuta nel 1958
e al suo posto furono costruiti gli attuali alveari di cemento...




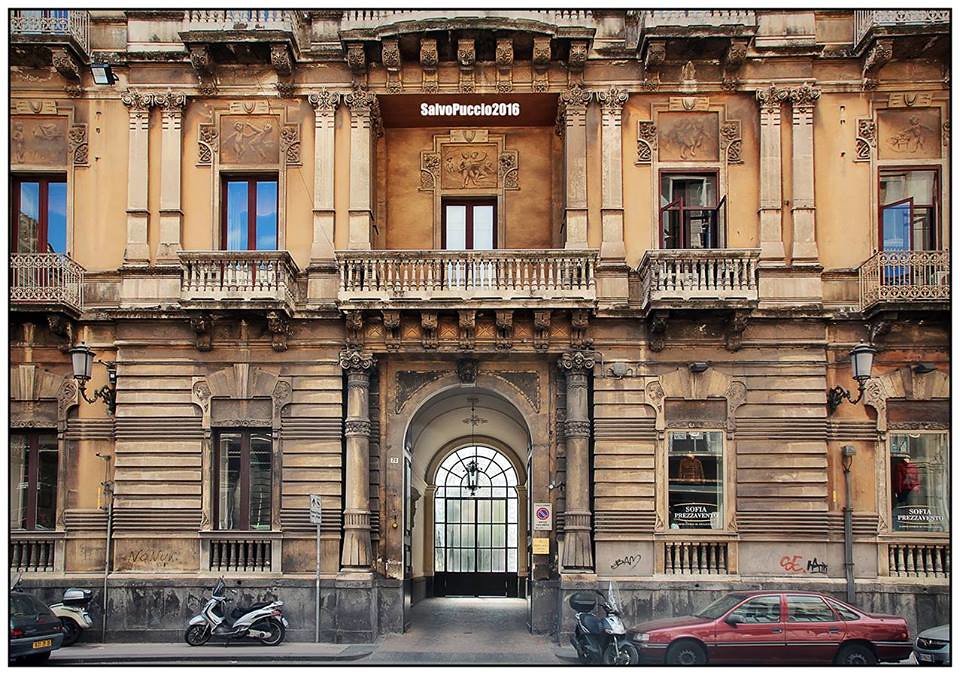
Palazzo Ferrarotto - Viale XX
Settembre, 5 - Mariano Falcini
«Attribuito all’architetto
Mariano Falcini, palazzo Ferrarotto, noto anche come Palazzo Paternò
Landolina, presenta un impianto a corte, articolato volumetricamente
su tre piani conclusi dalla copertura a terrazza. L’accesso
principale sul viale XX Settembre avviene attraverso un grande
portale recante in chiave uno scudo gentilizio coronato. Al piano
terra il prospetto è impostato su un basamento lavico, mentre il
piano mezzano è arricchito da una fascia a bugnato a corsi
orizzontali. Le aperture sono regolari e simmetricamente
distribuite. Il piano nobile è distinto da decorazioni pittoriche a
graffito tra le porte finestre, di maniera vasariana, eseguite del
1874 da Alfonso Orabona (attivo a Catania tra il 1874 e il 1960) e
da Giacomo Salvador. Lo stesso partito decorativo si ripete nella
fascia di coronamento del sottotetto. Il palazzo Ferrarotto venne
ultimato nel 1892.


Viale XX Settembre

 La
Villa Bonajuto,in Corso Italia a Catania, ha vissuto una
storia travagliata. Edificata intorno agli anni '30, su 1000
metri quadrati di terreno, l'abitazione è stata abbandonata
da circa vent'anni. La
Villa Bonajuto,in Corso Italia a Catania, ha vissuto una
storia travagliata. Edificata intorno agli anni '30, su 1000
metri quadrati di terreno, l'abitazione è stata abbandonata
da circa vent'anni.
Diversi tentativi di demolizione da parte della proprietà,
per erigere un palazzo, sono stati vanificati in seguito ad
alcuni provvedimenti giudiziari che hanno decretato la
sospensione dei lavori, in virtù dell'interesse storico del
monumento. La villa, che oggi per un terzo è diroccata, sarà
completamente ristrutturata, preservandone le particolarità
architettoniche. «Con la concessione della Sovrintendenza e
degli enti comunali preposti, la struttura originaria verrà
ricontestualizzata», ha spiegato l'architetto progettista,
Toti Contrafatto. L'interno, attualmente suddiviso in tre
elementi familiari e undici spazi per la servitù, sarà
ridisegnato. Saranno conservati i due piani, mentre nel
cortiletto interno verranno ricavate sei botteghe a uso
commerciale. http://www.unpodituttopertutti.it/index_file/villedicatania.htm
Villa
Bonajuto rinasce dalle proprie ceneri. Ferita rimarginata 27 anni dopo
lo scempio
Pinella Leocata - LA SICILIA Mercoledì 11 Gennaio 2012
Cade il
telone e, come d'incanto, si materializza Villa Bonajuto, bella
com'era 27 anni fa, prima che una benna l'aggredisse devastandola. Le
ruspe entrarono in azione all'alba del 5 giugno 1985 con la rapidità
vorace della speculazione edilizia, con la violenza di chi vuole
piegare, con i fatti, la determinata resistenza degli organi di
tutela. Per anni la sovrintendenza aveva lottato contro il progetto di
costruire un palazzo al posto della villa in stile Decò. Per anni,
senza demordere, si era appellata alle leggi preposte alla
salvaguardia del patrimonio monumentale e paesaggistico e ora che
stava per avere la meglio, superati mille ostacoli e un clima
compiacente verso chi conta, i proprietari della villa tentano il
blitz e danno avvio alla demolizione. Prima che sorga il sole.
Allora l'indignazione dei cittadini e l'intervento tempestivo della
magistratura bloccarono lo scempio e la villa restò a brandelli per
decenni, simbolo insieme della violenza della speculazione e della
forza della legge. Allora la sovrintendenza, l'assessorato regionale
ai Beni culturali e la magistratura decretarono che il danno andava
riparato, che la parte della villa demolita andava riedificata com'era
prima, che l'edificio - progettato dal geometra Domenico Corsaro con
la probabile consulenza stilistica del grande architetto Paolo
Lanzerotti - dovesse ritornare a vivere. La città ha dovuto attendere
lunghi anni e adesso, infine, dopo un lavoro certosino, portato avanti
al riparo degli sguardi, Villa Bonajuto è tornata.
I lavori sono stati condotti sulla base di un primo progetto redatto
nel 2004 dall'architetto Toti Contraffatto e dall'ing. Salvatore
Asero. Nel marzo 2009 l'edificio, di prorietà della famiglia
Bonajuto, e la relativa concessione per i lavori vengono rilevati
dalla Rosline, una società non catanese che si occupa di recupero di
beni architettonici. Come progettisti subentrano l'ing. Maurizio
Erbicella e l'arch. Antonio Iraci.
I primi tre mesi vengono dedicati a ripulire il giardino e le stanze
dell'edificio ricoperti d'immondizia e di erbacce dopo decenni di
abbandono.  Si è poi proceduto ai rilievi materici perché l'opera di
ricucitura presuppone la conoscenza dei materiali usati in precedenza
in modo che quelli nuovi collaborino e non contrastino con questi.
Durante i rilievi i tecnici rilevarono che il progetto di recupero era
stato elaborato sulla base di quello originale che non era stato del
tutto rispettato nella costruzione della villa. Di qui la richiesta,
nel dicembre 2010, di una variante poi autorizzata dalla
sovrintendenza che ha seguito passo passo tutto l'intervento
attraverso l'arch. Giuseppe Sciacca, incaricato dell'alta
sorveglianza. Si è poi proceduto ai rilievi materici perché l'opera di
ricucitura presuppone la conoscenza dei materiali usati in precedenza
in modo che quelli nuovi collaborino e non contrastino con questi.
Durante i rilievi i tecnici rilevarono che il progetto di recupero era
stato elaborato sulla base di quello originale che non era stato del
tutto rispettato nella costruzione della villa. Di qui la richiesta,
nel dicembre 2010, di una variante poi autorizzata dalla
sovrintendenza che ha seguito passo passo tutto l'intervento
attraverso l'arch. Giuseppe Sciacca, incaricato dell'alta
sorveglianza.
«Si è trattato di un lavoro folle - commenta l'ing. Erbicella -
perché abbiamo dovuto ricostruire la parte distrutta, recuperare
quella "morsa" dai mezzi meccanici, e rimuovere gli
interventi di somma urgenza, tampognature comprese, effettuati dalla
sovrintendenza per evitare che l'edificio crollasse. Questo significa
che abbiamo fatto un lavoro certosino di monta e smonta, con notevoli
problemi di sicurezza. Abbiamo fotografato tutto, smontato, catalogato
e rimontato quanto era recuperabile. Così abbiamo fatto per il
torrino che non era più in condizioni di sicurezza. Per quanto
riguarda le parti mancanti abbiamo fatto un'attenta ricerca dei
materiali che meglio si adattano all'esistente.

E non è stato facile
perché siamo dovuti risalire alle cave da cui erano stati prelevati.
Non solo. Per lavorare il materiale lapideo, poiché la pietra risente
del clima, e dunque degli sbalzi di temperatura e di umidità, abbiamo
potuto operare solo in un determinato lasso di tempo. E gli effetti si
possono notare all'angolo di coronamento dove la parte vecchia e
quella nuova sono indistinguibili. La definizione degli interni, che
non presentavano alcuna rifinitura di pregio, è rinviata a dopo, a
quando sarà scelta la destinazione d'uso della villa».
La società è intervenuta anche nel giardino esterno, un'area a forma
di triangolo delimitata dalla villa, da corso Italia e v ia Vecchia Ognina. Qui si è utilizzato il salto di livello tra la strada e la
quota del giardino per realizzare un seminterrato da destinare a spazi
commerciali e un altro livello interrato da utilizzare come deposito.
Il giardino sarà ricostituito a lavori ultimati. Tempo previsto
ancora qualche mese, poi la villa demolita tornerà a far parte a
pieno titolo del paesaggio catanese. Con soddisfazione di quanti amano
la propria città. ia Vecchia Ognina. Qui si è utilizzato il salto di livello tra la strada e la
quota del giardino per realizzare un seminterrato da destinare a spazi
commerciali e un altro livello interrato da utilizzare come deposito.
Il giardino sarà ricostituito a lavori ultimati. Tempo previsto
ancora qualche mese, poi la villa demolita tornerà a far parte a
pieno titolo del paesaggio catanese. Con soddisfazione di quanti amano
la propria città.
http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=92613
A
diffondere lo stile liberty nella città fu un imprenditore di origini
umili, Mario Sangiorgi.
Egli fece realizzare il complesso del teatro-cafè-albergo-ristorante
di via Di Sangiuliano, che ospitò illustri personaggi e diede
prestigio alla città.
L'arch. Giuffrida e il decoratore Florio realizzarono la facciata
eclettica con motivi goticizzanti, barocchi e nouveau. Il pittore
decoratore Salvatore De Gregorio affrescò gli interni con un
repertorio barocco-floreale.
Negli affreschi dominano i toni scuri del rosso bruno, del giallo
ocra, dell'oro degli stucchi, che incorniciano scene mitologiche
insieme a volute floreali. Nella sala che fu il Cafè Chantant è
disegnata una sirena in un rigoglio floreale straordinario.
CORMORANO
LEGAMBIENTE
CULTURA
SICILIA
|
|
Villa Manganelli
Photogallery


Disegnata ad arte e poi costruita,fatta quasi scolpire da Ernesto
Basile...Attraverso le pietre sembra narrare i conflitti fra le due
famiglie che ancora continuano, i processi vinti e persi,gli incendi
dolosi subiti e ormai passati.Le tante ferite che a tratti sembrano
venire fuori dall’intonaco staccato e screpolato sulla facciata
superiore gridano ai passanti indifferenti,attraverso le finestre
tappate con mattoni che come l’urlo che risuona nelle nostre
coscienze d’avanti al dipinto <<il grido>> di E.Munch
senza parole con la loro sola presenza dalle aperture cellofanate
delle torrette e dalle sue finestre scardinate e poi coperte con altri
mattoni, appaiono come bocche chiuse e tappate da mani , bloccate da
una burocrazia presieduta da uomini di potere omertosi che spesso nel
loro susseguirsi ,nella loro massima aspirazione che è quella di
mietere vittime come al tempo dell’inquisizione, anziché occuparsi
della crescita e dello sviluppo della cultura e dell’arte della
propria città...non permettono neanche di parlarne a chi desidera
farlo. Quante memorie ,con qualche sprazzo di lustro,durato poco
,Luchino Visconti gira alcune riprese per il film “Il Gattopardo”.Quanti
travestimenti per sopravvivere alla poca curanza dei suoi diversi
fruitori,alle loro maldestre fattezze,in quanti luoghi si è
trasformata: locali mondani,scuole da ballo,teatri,uffici,studi
professionali,diversi gli usi,diverse le sorti.

Arch.
Ernesto Basile
................ della volta spoglia di tutto. Nel fondo un soffitto in
calcestruzzo...Con rammarico abbassando gli occhi e tuffandosi in quel
blu del fondo della ceramica , un pò annerito di fumo, per guardarvi
dentro in profondità...in un ‘onda di amarezza emerge la
consapevolezza che questa antica Architettura non sarà mai più la
residenza che era stata concepita e disegnata dal Basile , per
coronare l’amore del principe e della principessa che mai potettero
godere di tale dimora... Il tutto ci appare come realtà temporale in
cui lo spazio e il tempo della vita presente sembrano fondersi con
quelli del passato.Sarà come uno spettacolo, una messa in
scena,assistervi significa parteciparvi,per trovarsi in una nuova
disponibilità mentale di riflessione e sogno…L’arte spesso
sopravvive ad eventi straordinari come questa ceramica e l’affresco.

Villa
Cocuzza Del Grado
C.so
Italia, 107 - Anno Di Costruzione: (1903-1908); 1934 - Architetto:
Agatino Atanasio (1872-1946) - Benedetto Caruso (1870-1934) –
attuale proprietà Di Bella
La
villa nota anche come Del Grado, fu progettata tra il 1903 ed il 1908
dall'ingegnere Agatino Atanasio su commissione del signor Salvatore
Cigno. L'ediificio, mostra una volumetria compatta costituita da un
corpo centrale, da quattro torrette con copertura a capanna collocate
agli angoli ed è circondato da un giardino dall'essenze mediterranee.
I prospetti presentano un rivestimento murario dai toni rosei con
ricorsi orizzontali in falso bugnato. L'ingresso dell'edificio,
accessibile grazie ad una scalinata esterna, è posto al di sotto di
una loggia architravata sorretta da una coppia di colonne binate,
opera giustapposta all'originario prospetto nel 1932 su progetto
dell'architetto Benedetto Caruso. La loggia accoglie superiormente il
terrazzo del primo piano, protetto da una balaustra a colonnine, su
quale si affaccia un giardino d'inverno in ferro battuto e vetri
policromi, anch'esso aggiunto in sostituzione della originaria
copertura centrale a cupola. La villa esternamente è deliminata da
una elegantissima ringhiera in ferro battuto di autore ignoto con
motivi "a colpi di frusta", rifatta sul disegno originale.
R.M.


 Con un pò di immaginazione ecco cancellarsi tutti i segni dei
sorprusi subiti e rimettersi al proprio posto i merletti e le perle
ricamate su i suoi abiti strappati e scoloriti ormai spogli e
incantati ,ridisegnarsi ravvivandone i colori e i contorni delle parti
dipinte sulle sue vesti, su quelle rotondità ormai appassite che come
affreschi di volte minacciate dal tempo appaiono scoloriti e
screpolati dall’incuria o addirittura dall’indifferenza di chi
avrebbe dovuto prendersene cura...Il viaggio continua scendendo per i
suoi seminterrati dove la parola Architettura Liberty non esiste più
e semmai fosse esistita non se ne vede più traccia,ma sembrerà di
avvertire dalle mura antiche in pietra lavica , un respiro che evoca
parole come:Essere, Divenire. Sotto l’influsso di un ipnosi
poetica... un’ arcana inquietudine mostra,le dame, i cavalieri,il
principe e la principessa che non hanno potuto danzare il loro
ballo,non hanno mai varcato la soglia della porta della residenza“Castello”e
come in una strana ironia della sorte nessun altro, dopo di loro, ha
trovato pace e lustro e potuto godere della dimora che doveva coronare
un grande amore fino ad adesso non riconosciuto e preservato anche
dopo la loro morte. Forse l’affresco e la formina che hanno
resistito a tutte le varie peripezie desiderano e chiedono fermamente
questo.L’importante non è tanto sapere cosa rappresentano lo stemma
araldico e la formina rettangolare in ceramica da me fotografata...
ma,facendo appello al subcosciente.
Con un pò di immaginazione ecco cancellarsi tutti i segni dei
sorprusi subiti e rimettersi al proprio posto i merletti e le perle
ricamate su i suoi abiti strappati e scoloriti ormai spogli e
incantati ,ridisegnarsi ravvivandone i colori e i contorni delle parti
dipinte sulle sue vesti, su quelle rotondità ormai appassite che come
affreschi di volte minacciate dal tempo appaiono scoloriti e
screpolati dall’incuria o addirittura dall’indifferenza di chi
avrebbe dovuto prendersene cura...Il viaggio continua scendendo per i
suoi seminterrati dove la parola Architettura Liberty non esiste più
e semmai fosse esistita non se ne vede più traccia,ma sembrerà di
avvertire dalle mura antiche in pietra lavica , un respiro che evoca
parole come:Essere, Divenire. Sotto l’influsso di un ipnosi
poetica... un’ arcana inquietudine mostra,le dame, i cavalieri,il
principe e la principessa che non hanno potuto danzare il loro
ballo,non hanno mai varcato la soglia della porta della residenza“Castello”e
come in una strana ironia della sorte nessun altro, dopo di loro, ha
trovato pace e lustro e potuto godere della dimora che doveva coronare
un grande amore fino ad adesso non riconosciuto e preservato anche
dopo la loro morte. Forse l’affresco e la formina che hanno
resistito a tutte le varie peripezie desiderano e chiedono fermamente
questo.L’importante non è tanto sapere cosa rappresentano lo stemma
araldico e la formina rettangolare in ceramica da me fotografata...
ma,facendo appello al subcosciente.

Guardando Villa
Manganelli,pensando al Basile alla sua linea parlante, ispirata, ad un
certo rituale di quel fare tipico dell’ Architettura Modernista
unica e monumentale...l’armonia delle pietre improvvisamente si
dissolvono nella nostra mente per diventare ombre colorate , per
ritornare disegni tracciati dall’ombra proveniente dalla luce in un
giuoco chiaroscurale che ne ridisegna i contorni magici e attraverso
la nostra costante scoperta appaiono in continuo divenire .

Posandovi
lo sguardo non più distratto e ascoltandola con l’ anima in
relazione alla sua anima...sembrerà di risentire il sensuale batter
del ferro,il picchiettio dell’incidere dello scalpellino sulle
pietre, che come un battito di cuore di questa fabbrica risuonerà
dentro di noi e per infine giungere al carezzevole e silenzioso fruire
della matita sui fogli bianchi da disegno del Basile, facendo
emozionare ancora una volta per evocare tutti quei discorsi che la
linea parlante ha in sè, la possibilità della vita, del dare vita.
Fantasmi allusivi i suoi abitanti (il principe e la principessa) Il
braccio che si leva nell’ampio gesto di un saluto del principe tra i
nastri e le braccia dei puttini dell’affresco del Gregorietti.Il
passo lento e felpato , danzante della principessa , immersa fra le
nuvole turchine...della formina in ceramica che in modo indelebile
permangono e sopravvivono a tutto in segno del loro infinito amore.

Il palazzo dell'ex Leonardo
da Vinci fino al 1965-66, poi, a distanza di anni, sede del
Provveditorato agli Studi della provincia di Catania, poi Istituto
Scolastico Savoia, poi, fino al 2012, sede dell'Istituto d'Arte.

Propongo l’adozione a distanza...di architetture e in generale di
tutto quel vasto patrimonio artistico e culturale che come orfani sono
troppo spesso abbandonati e lasciati in balia del tutto... perchè
possano essere realizzate manifestazioni ed eventi che in modo
correlato mettano in evidenza e permettano la raccolta di fondi a
tutela del nostro Patrimonio Artistico e Culturale.
http://tsunamiblog.myblog.it/archive/2011/03/19/a-villa-manganelli-tra-misteri-e-incantesimi-un-amore-indele.html

Villa Manganelli con l'Etna alle spalle
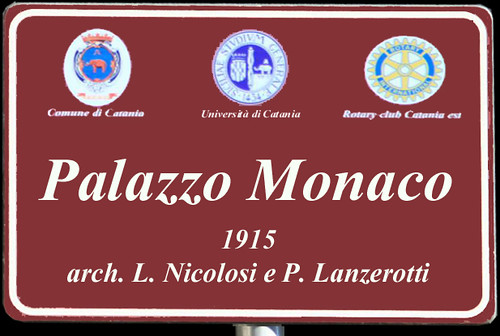 Palazzo
Monaco Palazzo
Monaco
viale XX Settembre 39 - Proprietà attuale:
INPS Uso attuale: sede degli uffici dell’INPS
Anno di costruzione: 1915 ca. Architetto:
Luciano Nicolosi, rifacimenti di Paolo Lanzerotti
Decoratori: Alessandro Abate (decorazioni
pittoriche), Salvatore Gregorietti (decorazioni pittoriche) Palazzo
Monaco si presenta come un volume massiccio vivacizzato più che nel
disegno degli spazi nell’uso degli elementi decorativi: le cariatidi
e i telamoni dello scultore Mario Moschetti, i vivaci inserimenti
fitomorfi in ferro battuto e i frontoni curvilinei spezzati da
volute che cingono i portali. All’interno il ruolo degli elementi
decorativi scultorei e pittorici è ancora più importante: gli
ambienti sono impreziositi dai ferri battuti, dagli elementi in
ghisa, dagli stucchi e soprattutto dai dipinti murari ai quali
lavorò Alessandro Abate, uno dei pittori più richiesti dalla nobiltà
e dall’alta borghesia di inizio Novecento, il palermitano Salvatore
Gregorietti e certamente altri anonimi decoratori.

foto di Salvo Puccio
Le stanze più importanti sono
così animate da un apparato che miscela linguaggi liberty e dèco: le composizioni di figurine femminili e di puttini
di intonazione settecentesca, i paesaggi di gusto orientalista, i
disegni di fiori, nastri, foglie e animali di chiara impronta
liberty convivono con figure geometriche più tipicamente dèco come
il motivo dei dischi e delle onde.Curiosità: I Telamoni derivano dal
mito greco di Atlante che sorreggeva i pilastri del cielo, la
versione al femminile si chiama Cariatide e cioè donna della Caria,
regione dell'Anatolia conquistata dai greci, le cui donne furono
rese schiave per aver favorito i Persiani.
Gli ambienti interni sono
impreziositi da un apparato decorativo che unisce linguaggi liberty
e déco. All’interno
opere di Alessandro Abate (1867-1957), Salvatore Gregorietti
(1870-19529 e sculture di Mario Moschetti (1879- 1960). Nel 1931 il
palazzo viene ceduto all’Inps che vi ha apportato alcune modifiche».

Catania, Viale Jonio
|



VILLA CIGNO COCUZZA
(Corso Italia, anno di costruzione
1903/1908 ,autore Agatino Atanasio)
La villa,nota anche come Del Grado,fu
progettata tra il 1903 e il 1908 dall'ingegnere Agatino Atanasio su
commissione del signor Salvatore Cigno.
L' edificio mostra una volumetria
compatta costituita da un corpo centrale, da 4 torrette con copertura a
capanna collocate agli angoli ed è circondato da un giardino di essenze
mediterranee.
I prospetti presentano un rivestimento
murario dai toni rosei con ricorsi orizzontali in falso bugnato.
L' ingresso, accessibile da una scalinata
esterna, è posto al di sotto di una loggia architravata sorretta da una
coppia di colonne Bonate,opera giustapposta nel 1932 all'originario
prospetto su progetto dell'architetto Benedetto Caruso Puglisi (1870-1934).
La loggia accoglie superiormente il
terrazzo del primo piano, protetto da una balaustra a colonnine ,sul quale
si affaccia un giardino d'inverno in ferro battuto e vetri policromi
,anch'esso aggiunto in sostituzione della originaria copertura centrale a
cupola.
Elegantissima la ringhiera in ferro
battuto di autore ignoto ,con motivi a "colpi di frusta",rifatta dopo la
guerra.
(Descrizione della Soprintendenza ai beni
culturali)
Note e foto di Milena Palermo per
Obiettivo catania
-
https://www.facebook.com/ObiettivoCatania/




|

|
|
Parrocchie
S..S.
CROCEFISSO DEI MIRACOLI
Via
E. Pantano 42 - 95129 Catania tel: 095 531590
S. BERILLO IN S. M. DEGLI AMMALATI
Piazza Bovio 29 - 95131 Catania (CT) tel:
095 530604
S. MARIA DELL'AIUTO
Via Consolato Della Seta 59 - 95121 Catania (CT) tel: 095
345344
SAN
DOMENICO
Chiesa San Domenico?
Via Santa Maddalena, 80
95124 Catania
095 314340
|
-
-
Arena
Adua - Catania (ct) - Largo Carmelo Amendola - 095 7169312
-
Arena
Argentina - Catania (ct) - Via Vanasco 10 - 095 322030
-
Excelsior
- Catania (ct) - via De Felice, 21 - 095 316699
-
Lo
Pò - Catania (ct) - via Etnea, 256 - 095 326210
-
Metropolitan
- Catania (ct) - via S. Euplio, 21 - -
-
Odeon
- Catania (ct) - via F. Corridoni, 19 - 095 326324
INFORMAZIONI
TURISTICHE
Azienda
Provinciale Turismo: sede via Cimarosa, 10 tel. 095 7306222 - 095
7306233
Ufficio
porto: Molo Sporgente Centrale tel. 095 7306209
Ufficio
Stazione Centrale FF.SS.: tel. 095 7306255
Ufficio
Aeroporto: tel. 095 7306266 - 095 7306277
Ufficio
via Etnea, 63: tel. 095 311768
|
-
FARMACIE
-
-
BALSAMO
GIUSEPPE V. Umberto, 125 095-311691
-
BATTIATI
MARILENA V. Umberto, 144 095-321920
-
GUARNACCIA
CONCETTA V. Umberto, 254 095-533945
-
GUARNACCIA
SOSSIO V.le Vittorio Veneto, 133 095-503937
-
INTERNAZIONALE
V. Vincenzo Giuffrida, 141 095-430346
-
MORASCA
MARIA V. Umberto, 155 095-321545
-
PITTARI
V. Torino, 70/76 095-439357
-
ROMA
C.so Martiri della Liberta', 16 095-530003
-
SICILIA
V. Francesco Crispi, 46 095-533998
Croce
Rossa - tel. 7312601 - Croce Verde - tel. 373333 -
493263 - Guardia Medica - tel. 377122 - 382113
|
|





















 Palazzo
Pancari Ferreri
Palazzo
Pancari Ferreri
 Il
loro habitat naturale era la via Etnea, con particolare preferenza al
tratto villa Bellini-piazza Stesicoro, ma il tempo maggiore lo
trascorrevano davanti a Caviezel, il bar-pasticceria ubicato di fronte
al cinema "Sala Roma", che da lì a poco sarebbe scomparso
per far posto all'attuale casermone della Rinascente, e a pochi metri
dall'Hotel CentraI Corona, oggi CentraI Palace. Davanti alle vetrine
della pasticceria svizzera si riunivano in gruppetti di cinque o sei e
lì, dalle undici alle quattordici circa, si svolgeva il quotidiano
rito della "sfurbiciata". Si tagliavano i vestiti addosso a
tutte le donne conosciute e non (tranne le madri e le sorelle,
ovviamente) e si raccontavano, con dovizie di particolari stuzzicanti,
avventure galanti vissute o ... sognate. Con linguaggio coloratissimo,
non proprio da educande o da seminaristi.
Il
loro habitat naturale era la via Etnea, con particolare preferenza al
tratto villa Bellini-piazza Stesicoro, ma il tempo maggiore lo
trascorrevano davanti a Caviezel, il bar-pasticceria ubicato di fronte
al cinema "Sala Roma", che da lì a poco sarebbe scomparso
per far posto all'attuale casermone della Rinascente, e a pochi metri
dall'Hotel CentraI Corona, oggi CentraI Palace. Davanti alle vetrine
della pasticceria svizzera si riunivano in gruppetti di cinque o sei e
lì, dalle undici alle quattordici circa, si svolgeva il quotidiano
rito della "sfurbiciata". Si tagliavano i vestiti addosso a
tutte le donne conosciute e non (tranne le madri e le sorelle,
ovviamente) e si raccontavano, con dovizie di particolari stuzzicanti,
avventure galanti vissute o ... sognate. Con linguaggio coloratissimo,
non proprio da educande o da seminaristi.
































.jpg)


.jpg)












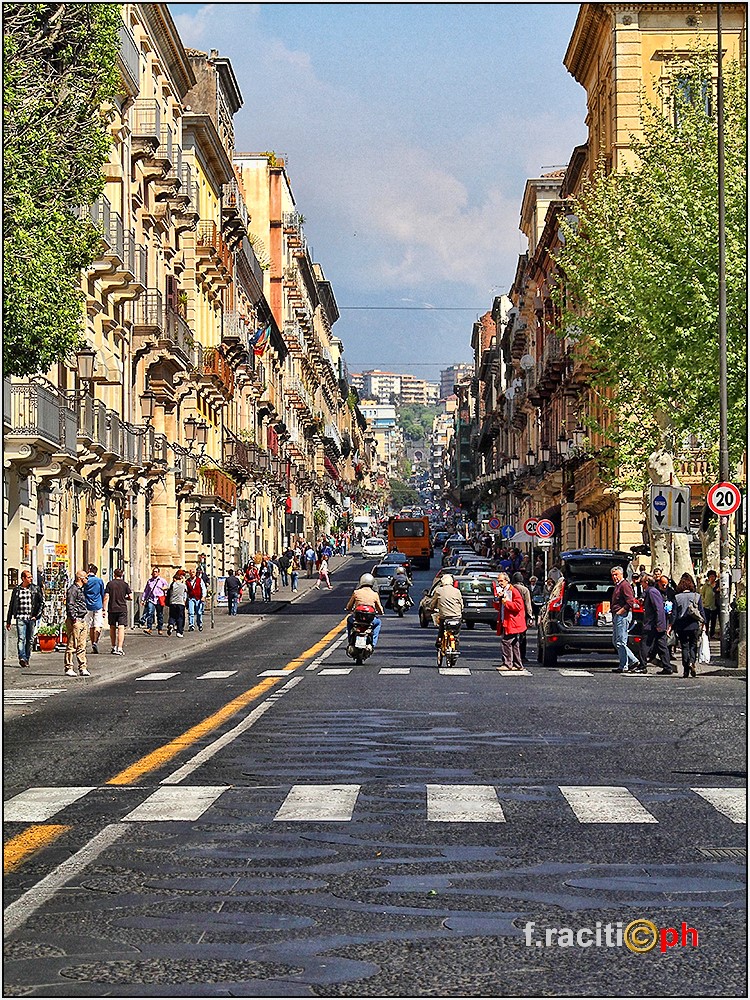
























 ntro una grande vasca nella quale nuotano degli eleganti cigni. Sulla
collinetta che fa da sfondo alla vasca, con un effetto scenografico
molto apprezzabile, è sistemato un grande orologio il cui quadrante è
costituito da piantine sempreverdi. Sopra di esso un calendario, che i
giardinieri modificano ogni giorno, indica mese giorno ed anno.
ntro una grande vasca nella quale nuotano degli eleganti cigni. Sulla
collinetta che fa da sfondo alla vasca, con un effetto scenografico
molto apprezzabile, è sistemato un grande orologio il cui quadrante è
costituito da piantine sempreverdi. Sopra di esso un calendario, che i
giardinieri modificano ogni giorno, indica mese giorno ed anno. usto come i
platani ed enormi ficus magnolia dell'età di centinaia di anni oltre a
numerose altre varietà di pini e di alberi sempreverdi.
usto come i
platani ed enormi ficus magnolia dell'età di centinaia di anni oltre a
numerose altre varietà di pini e di alberi sempreverdi.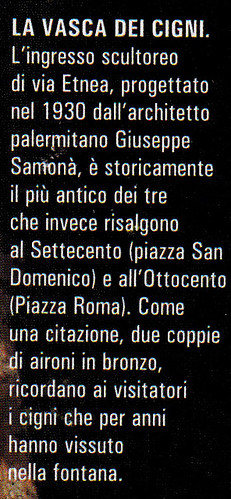 decennio, al suo interno venne inserito un vero e proprio zoo con
voliere ricche di molte varietà di uccelli, anatre, oche e cigni nelle
varie vasche del giardino e pavoni in libertà, rettili e serpenti in
apposite gabbie e varietà di scimmie ed altri piccoli animali, in un
apposito recinto, anche alcuni elefantini tra cui un elefante indiano
donato da un circo di passaggio, come simbolo della città di Catania.
Le difficoltà economiche e una certa dose di insensibilità tuttavia
depauperarono lentamente il prezioso patrimonio zoologico che piano
piano si ridusse a zero e ridussero quello botanico.
decennio, al suo interno venne inserito un vero e proprio zoo con
voliere ricche di molte varietà di uccelli, anatre, oche e cigni nelle
varie vasche del giardino e pavoni in libertà, rettili e serpenti in
apposite gabbie e varietà di scimmie ed altri piccoli animali, in un
apposito recinto, anche alcuni elefantini tra cui un elefante indiano
donato da un circo di passaggio, come simbolo della città di Catania.
Le difficoltà economiche e una certa dose di insensibilità tuttavia
depauperarono lentamente il prezioso patrimonio zoologico che piano
piano si ridusse a zero e ridussero quello botanico.
 Quanti amori e
promesse immaginiamo dentro questo cerchio magico. L'Etna, con il suo
filo di fumo, giganteggia immobile sempre a nord, mentre questo
monumento vegetale vivente, muto testimone delle stagioni, questo
"bene da vivere" che è il Giardino Bellini racconta nuove
storie: se i giovani siciliani la percorrono al ritmo della corsa -
isolati dal mondo nel limbo del proprio Ipod - almeno tre continenti si
danno appuntamento fra i suoi viali profumati di lavanda. Le lingue
straniere si intrecciano fra loro, mentre i più giovani - bianchi, neri
o gialli - hanno già assimilato la sicula cadenza. Un tempo, quello da
"ritrovare" alla Villa Bellini, che lo contiene tutto:
passato, presente e futuro. È memoria collettiva - di un'intera
comunità - e memoria individuale quella singola la singola, e a volte
intimissima, di ognuno di noi, legata com'è alle persone care della
nostra vita e agli istanti intensi trascorsi con loro fra il verde di
questi viali.
Quanti amori e
promesse immaginiamo dentro questo cerchio magico. L'Etna, con il suo
filo di fumo, giganteggia immobile sempre a nord, mentre questo
monumento vegetale vivente, muto testimone delle stagioni, questo
"bene da vivere" che è il Giardino Bellini racconta nuove
storie: se i giovani siciliani la percorrono al ritmo della corsa -
isolati dal mondo nel limbo del proprio Ipod - almeno tre continenti si
danno appuntamento fra i suoi viali profumati di lavanda. Le lingue
straniere si intrecciano fra loro, mentre i più giovani - bianchi, neri
o gialli - hanno già assimilato la sicula cadenza. Un tempo, quello da
"ritrovare" alla Villa Bellini, che lo contiene tutto:
passato, presente e futuro. È memoria collettiva - di un'intera
comunità - e memoria individuale quella singola la singola, e a volte
intimissima, di ognuno di noi, legata com'è alle persone care della
nostra vita e agli istanti intensi trascorsi con loro fra il verde di
questi viali.

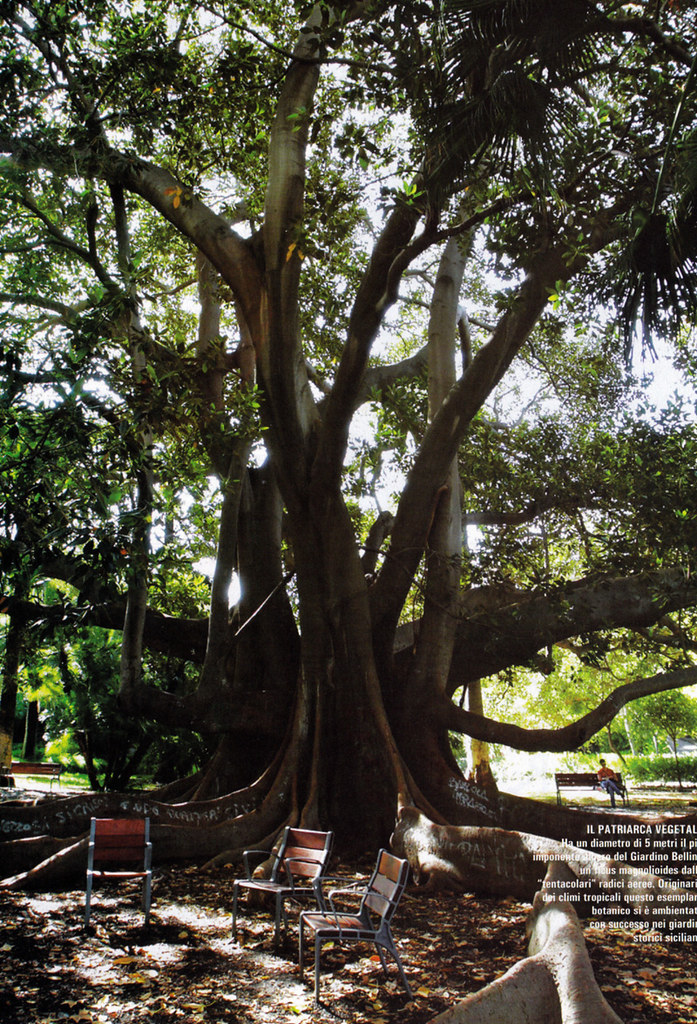






.jpg)



.jpg) LA
FONTANA OTTAGONALE DELL’INGRESSO SUD
LA
FONTANA OTTAGONALE DELL’INGRESSO SUD 

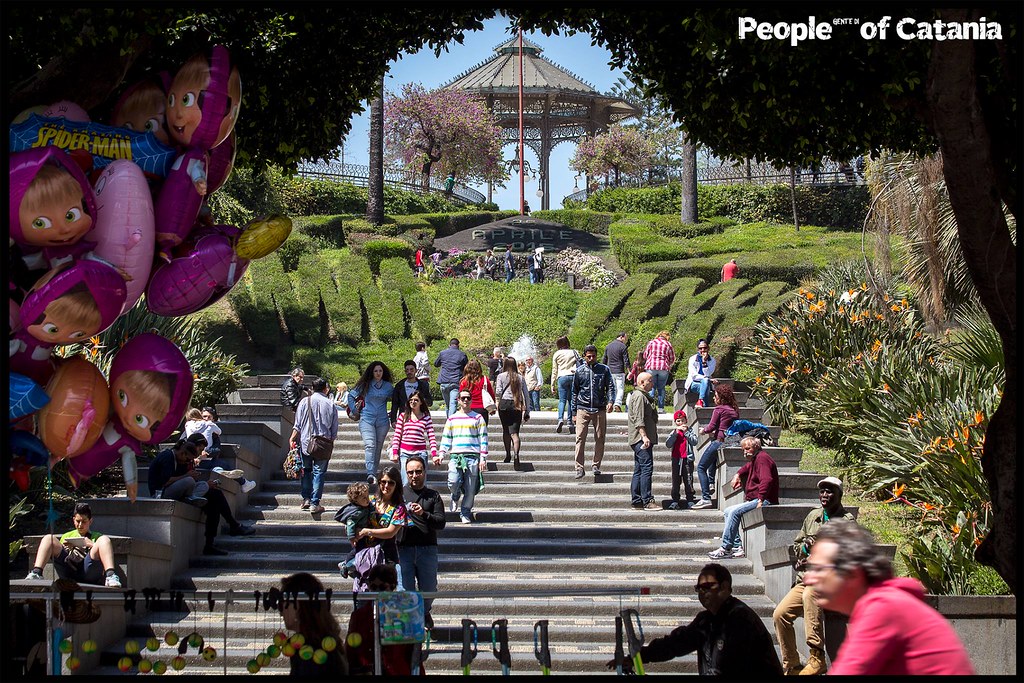





 completamente costruita in legno ripiena di libri,
lasciata all’incuria del tempo con scarsissima manutenzione e nessun
sistema antincendio, come si fa a pensare che un bel giorno non bruci
tutto? no, non può accadere... e se per caso dovesse accadere, certo
non si tratterebbe di un evento calcolato bensì di una disgrazia!
completamente costruita in legno ripiena di libri,
lasciata all’incuria del tempo con scarsissima manutenzione e nessun
sistema antincendio, come si fa a pensare che un bel giorno non bruci
tutto? no, non può accadere... e se per caso dovesse accadere, certo
non si tratterebbe di un evento calcolato bensì di una disgrazia!


 gli
dato anche qualcos’altro per poterlo osannare come rappresentativo del
buon Catanese e per dedicargli ogni cosa, piazze, palazzi, monumenti,
ville, pizze, pasta e torte.
gli
dato anche qualcos’altro per poterlo osannare come rappresentativo del
buon Catanese e per dedicargli ogni cosa, piazze, palazzi, monumenti,
ville, pizze, pasta e torte.



 serate si passano deliziosamente, quando sciami di
signore popolano la villa illuminata fantasticamente e
riccamente". Queste parole possono, ancora oggi, essere
considerate pertinenti; l'atmosfera che si respira nella villa
Bellini è la stessa che animava l'entusiasmo del nostro
scrittore di guide. Nel 1932, l'antico ingresso sulla via Etnea
venne reso monumentale; sempre quell'anno fu innalzato il
cavalcavia sulla via Sant'Euplio e fu realizzata la grande vasca
circolare nella quale vennero messi a dimora alcuni bellissimi
cigni bianchi.
serate si passano deliziosamente, quando sciami di
signore popolano la villa illuminata fantasticamente e
riccamente". Queste parole possono, ancora oggi, essere
considerate pertinenti; l'atmosfera che si respira nella villa
Bellini è la stessa che animava l'entusiasmo del nostro
scrittore di guide. Nel 1932, l'antico ingresso sulla via Etnea
venne reso monumentale; sempre quell'anno fu innalzato il
cavalcavia sulla via Sant'Euplio e fu realizzata la grande vasca
circolare nella quale vennero messi a dimora alcuni bellissimi
cigni bianchi.








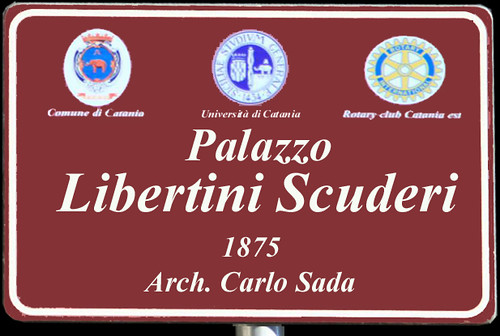 Il
Palazzo Libertini Scuderi fu progettato nel 1875 dal giovanissimo architetto
milanese Carlo Sada (1849-1924). Questi giunse a Catania dapprima come
collaboratore del più anziano arch. Andrea Scala, per progettare e dirigere
i lavori del Teatro Massimo Bellini, ma si rese ben presto autonomo rispetto
al maestro. Divenne progettista di successo, molto richiesto dalle famiglie
catanesi più facoltose, e rimase definitivamente a Catania, fino alla sua
scomparsa. La redazione del progetto per la “Palazzina Raddusa” impegna
l’Arch. Sada per un periodo piuttosto esteso, che inizia nell’aprile del
1875 e prosegue, per la redazione dei disegni esecutivi, fino al 1879.
Il
Palazzo Libertini Scuderi fu progettato nel 1875 dal giovanissimo architetto
milanese Carlo Sada (1849-1924). Questi giunse a Catania dapprima come
collaboratore del più anziano arch. Andrea Scala, per progettare e dirigere
i lavori del Teatro Massimo Bellini, ma si rese ben presto autonomo rispetto
al maestro. Divenne progettista di successo, molto richiesto dalle famiglie
catanesi più facoltose, e rimase definitivamente a Catania, fino alla sua
scomparsa. La redazione del progetto per la “Palazzina Raddusa” impegna
l’Arch. Sada per un periodo piuttosto esteso, che inizia nell’aprile del
1875 e prosegue, per la redazione dei disegni esecutivi, fino al 1879.










 AL PRIMO MAESTRO DELLA DANZA RITMICA, CATANIA
DEDICA UNA STATUA E UNA STRADA
AL PRIMO MAESTRO DELLA DANZA RITMICA, CATANIA
DEDICA UNA STATUA E UNA STRADA 









 Edificato
nel 1904 circa il palazzo Mazzone sorge in una zona di espansione
tardo ottocentesca.
Edificato
nel 1904 circa il palazzo Mazzone sorge in una zona di espansione
tardo ottocentesca. 

















 Palazzo
di Giustizia di piazza G.Verga poiché non poche furono le polemiche
che si scatenarono al momento della sua collocazione.Se oggi noi
tutti possiamo ammirare questa scultura bronzea alta ben 7,50 metri
è solo grazie alla pazienza e perseveranza del grande Sindaco avv.
Luigi La Ferlita che per sedare ogni discussione, dispose la sua
collocazione nel posto in cui era stata destinata.
Palazzo
di Giustizia di piazza G.Verga poiché non poche furono le polemiche
che si scatenarono al momento della sua collocazione.Se oggi noi
tutti possiamo ammirare questa scultura bronzea alta ben 7,50 metri
è solo grazie alla pazienza e perseveranza del grande Sindaco avv.
Luigi La Ferlita che per sedare ogni discussione, dispose la sua
collocazione nel posto in cui era stata destinata.


 SICILIA
- Ville, palazzi e cappelle: dal Liberty al Déco
SICILIA
- Ville, palazzi e cappelle: dal Liberty al Déco
 monumentale alla realizzazione del quale ha
contribuito anche una schiera di decoratori, stuccatori ed ebanisti
che hanno concorso a creare il particolare Liberty catanese e spinto
verso un'innovativa produzione industriale.
monumentale alla realizzazione del quale ha
contribuito anche una schiera di decoratori, stuccatori ed ebanisti
che hanno concorso a creare il particolare Liberty catanese e spinto
verso un'innovativa produzione industriale.











 A Catania tra
gli autori più importanti del Liberty in architettura ricordiamo:
A Catania tra
gli autori più importanti del Liberty in architettura ricordiamo:



















































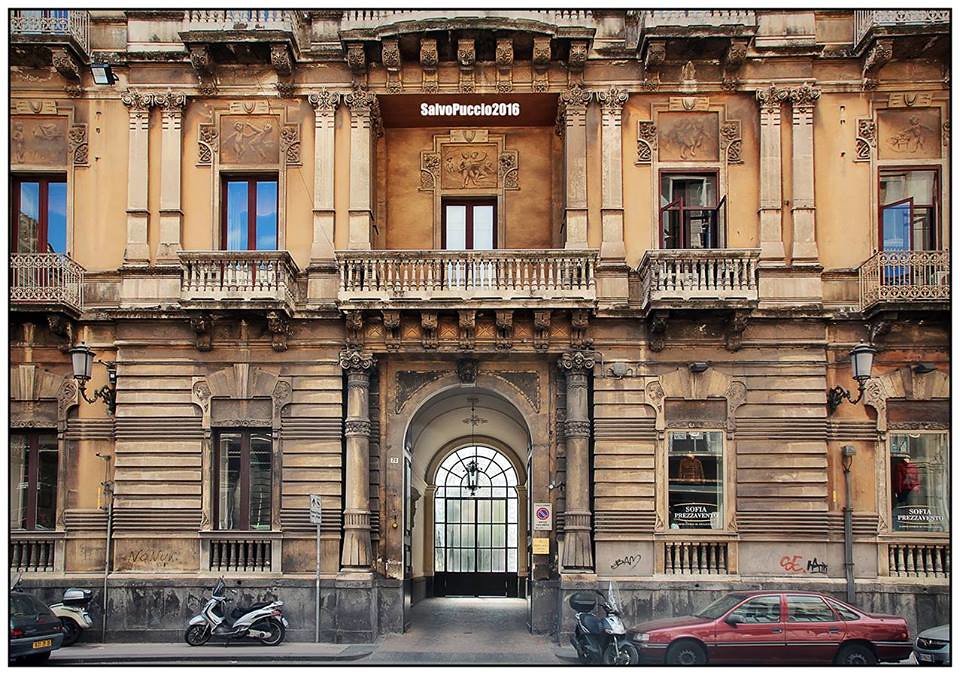



 La
Villa Bonajuto,in Corso Italia a Catania, ha vissuto una
storia travagliata. Edificata intorno agli anni '30, su 1000
metri quadrati di terreno, l'abitazione è stata abbandonata
da circa vent'anni.
La
Villa Bonajuto,in Corso Italia a Catania, ha vissuto una
storia travagliata. Edificata intorno agli anni '30, su 1000
metri quadrati di terreno, l'abitazione è stata abbandonata
da circa vent'anni.
 Si è poi proceduto ai rilievi materici perché l'opera di
ricucitura presuppone la conoscenza dei materiali usati in precedenza
in modo che quelli nuovi collaborino e non contrastino con questi.
Durante i rilievi i tecnici rilevarono che il progetto di recupero era
stato elaborato sulla base di quello originale che non era stato del
tutto rispettato nella costruzione della villa. Di qui la richiesta,
nel dicembre 2010, di una variante poi autorizzata dalla
sovrintendenza che ha seguito passo passo tutto l'intervento
attraverso l'arch. Giuseppe Sciacca, incaricato dell'alta
sorveglianza.
Si è poi proceduto ai rilievi materici perché l'opera di
ricucitura presuppone la conoscenza dei materiali usati in precedenza
in modo che quelli nuovi collaborino e non contrastino con questi.
Durante i rilievi i tecnici rilevarono che il progetto di recupero era
stato elaborato sulla base di quello originale che non era stato del
tutto rispettato nella costruzione della villa. Di qui la richiesta,
nel dicembre 2010, di una variante poi autorizzata dalla
sovrintendenza che ha seguito passo passo tutto l'intervento
attraverso l'arch. Giuseppe Sciacca, incaricato dell'alta
sorveglianza.
 ia Vecchia Ognina. Qui si è utilizzato il salto di livello tra la strada e la
quota del giardino per realizzare un seminterrato da destinare a spazi
commerciali e un altro livello interrato da utilizzare come deposito.
Il giardino sarà ricostituito a lavori ultimati. Tempo previsto
ancora qualche mese, poi la villa demolita tornerà a far parte a
pieno titolo del paesaggio catanese. Con soddisfazione di quanti amano
la propria città.
ia Vecchia Ognina. Qui si è utilizzato il salto di livello tra la strada e la
quota del giardino per realizzare un seminterrato da destinare a spazi
commerciali e un altro livello interrato da utilizzare come deposito.
Il giardino sarà ricostituito a lavori ultimati. Tempo previsto
ancora qualche mese, poi la villa demolita tornerà a far parte a
pieno titolo del paesaggio catanese. Con soddisfazione di quanti amano
la propria città.









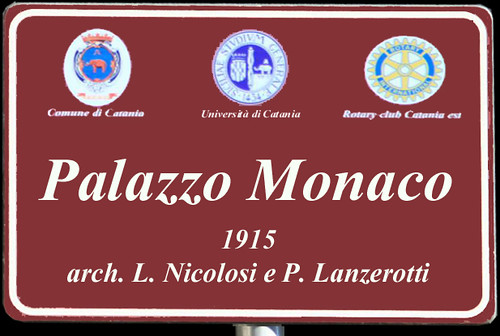 Palazzo
Monaco
Palazzo
Monaco



















